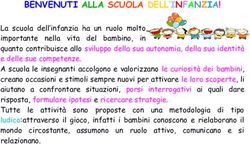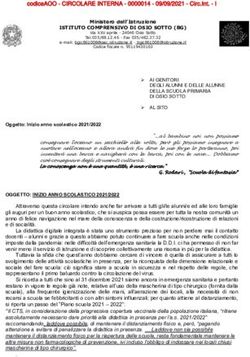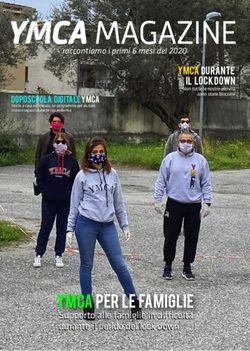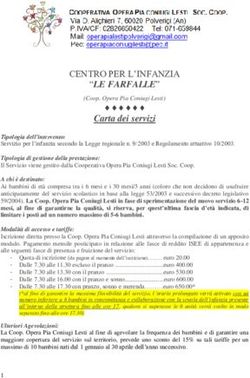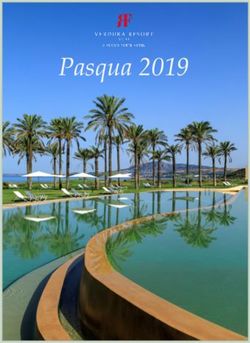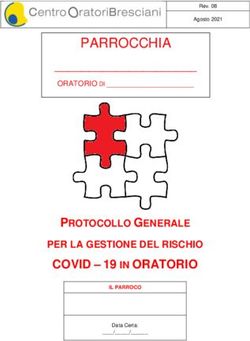4 aprile 2022 IL DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE/IPERATTIVITÀ - Letizia Moretti
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
4 aprile
2022
IL DISTURBO DA DEFICIT
DI ATTENZIONE/IPERATTIVITÀ
Letizia Moretti
Psicologa
Responsabile area scuola Associazione
1 Psicologia InsiemeLE CAUSE • Genetiche: ereditarietà nei parenti maschi. Studi su gemelli omozigoti (80% di probabilità di sviluppare il disturbo) e dizigoti (30%). • Sociali: Ambiente particolarmente svantaggiato che non insegna l’autoregolazione: può rendere ancora più evidenti i problemi • Organiche: Gli studi che hanno preso in esame il flusso ematico cerebrale, hanno riscontrato nei bambini ADHD un’ipoperfusione nelle regioni prefrontali della corteccia, in particolare in quelle aree collegate con il sistema limbico attraverso il nucleo caudato.
… INOLTRE:
I bambini con ADHD non presentano la
consueta asimmetria dei lobi frontali,
ma il lobo frontale destro (che gioca un ruolo
chiave nel controllo dei movimenti volontari, nella produzione del
linguaggio parlato e scritto, nella memoria a lungo termine, nella
gestione dell'attenzione, nella capacità di pianificazione, nella
), è più
programmazione di comportamenti e azioni
piccolo rispetto ai bambini del gruppo di
controllo.Incidenza
• La stima attuale dell'ADHD si aggira tra l'1% e il 5% tra i
giovani.
• La stima attuale è che tra il 30% e il 70% dei bambini con ADHD
continuerà ad avere l'ADHD in età adulta.
• Il numero degli adulti con ADHD potrebbe variare dallo 0.30%
al 3.5% della popolazione adulta.
Associazione Psicologia Insieme OnlusPrognosi
• Solo il 20 % dei soggetti in età adolescenziale ai
quali era stato diagnosticato un ADHD, non
manifesta più i sintomi del disturbo
• Il rimanente 80% dei soggetti, che continuano a
presentare comportamenti di iperattività e
impulsività sono più a rischio di altri di manifestare
condotte antisociali.Negli adulti
• i criteri di inclusione per gli adulti stabilivano che il
soggetto doveva avere quattro delle seguenti
caratteristiche, una delle quali deve risultare
significativa:
1. iperattività motoria persistente dalla fanciullezza
2. deficit attentivo persistente dalla fanciullezza
3. labilità affettiva
4. incapacità a terminare compiti
5. temperamento eccitabile ed esplosivo
6. relazioni interpersonali scadenti o incapacità a
mantenere relazioni nel tempo
7. impulsività
8. insofferenza allo stress
Associazione Psicologia Insieme OnlusLa diagnosi • L’iter diagnostico per l’ADHD è complesso e richiede una elevata esperienza da parte degli operatori clinici. • La diagnosi è appannaggio del neuropsichiatra infantile esperto; tuttavia anche altri operatori della salute mentale dell’età evolutiva con competenze specifiche, come medici e psicologi, possono fare diagnosi di ADHD. • Il test diagnostico specifico utilizzato in Italia per questo disturbo è la BIA; la diagnosi però si basa soprattutto sull’osservazione clinica e sulla raccolta di informazioni fornite da fonti multiple e provenienti da diversi contesti: genitori, insegnanti, educatori.
RACCOLTA INFORMAZIONI DA FONTI MULTIPLE
- Questionari e interviste semi-strutturate per
insegnanti, genitori e bambini (scala SDAI,
SDAG, SDAB, QUESTIONARIO DI
ATTRIBUZIONE);
-Identificare i comportamenti problema;
-Capire insieme ai genitori e agli insegnanti che
idea hanno dei comportamenti-problema: i
comportamenti negativi sono tutti ugualmente
gravi? Perché alcune regole sono tanto importanti
per gli adulti?SDAI , SDAG Gli item delle scale descrivono i comportamenti tipici dei bambini con ADHD. Le scale sono suddivise in due sub-scale: Disattenzione Iperattività/impulsività Per la correzione si sommano separatamente le risposte dispari e quelle pari.
BIA: Batteria Italiana ADHD
Gian Marco Marzocchi, Anna Maria Re, Cesare Cornoldi
Ed. EricksonQUALI SONO LE PROVE INCLUSE NELLA
BIA
• 1. test attenzione sostenuta visiva (CP) e uditiva (TAU);
• 2. test comportamento impulsivo (MF);
• 3. test per la valutazione dei processi di controllo: test delle
ranette (inibizione motoria), test di Stroop (inibizione risposta
prepotente), Completamento Alternativo di Frasi (CAF);
• 4. test di Memoria Strategica Verbale (TMSV).COSA FARE IN PRATICA?
LA FAMIGLIA DEL BAMBINO ADHD
ESERCITAZIONE IN GRUPPO: CERCATE DI RISPONDERE A QUESTE DOMANDE: • Cosa immaginate provi e pensi un genitore di un bambino con ADHD? • Quali le informazioni che andreste a cercare? • Quale sarebbero le cose su cui puntereste in un colloquio con genitori di bambini presunti ADHD che abbia come scopo l’invito ad un accertamento diagnostico? • Quali suggerimenti potreste dare ai genitori per migliorare la gestione dei comportamenti?
Possibili caratteristiche cognitive
delle famiglie del bambino con ADHD
• Attribuzioni disfunzionali
• Incolpare se stessi
• Credenze e aspettative non realistiche
• Locus of control esterno
• Percezione errata
della situazione
• RabbiaPossibili aspetti comportamentali delle famiglie del bambino con ADHD • Rinforzi negativi di comportamenti non corretti; • Pochi rinforzi positivi di comportamenti corretti; • Metodo inefficace di condotta; • Limitato monitoraggio al comportamento del figlio;
L’ambiente: stili educativi inadeguati • Stile ipercritico: elevata frequenza di critiche rivolte al bambino sotto forma di rimproveri. Gli adulti che adottano questo stile educativo, difficilmente notano i comportamenti adeguati del bambino, mentre sono sempre pronti ad evidenziare i suoi errori. • nel bambino paura: di sbagliare,di essere disapprovato, bassa stima di sé.
• Stile perfezionistico: convinzione che il bambino debba riuscire bene in tutto ciò che fa e che il suo valore (e quello dei suoi genitori) sia determinato dal successo che ottiene in varie attività. • Nel B: atteggiamento perfezionistico, che lo porta a temere in modo eccessivo la disapprovazione e la critica qualora non riesca bene in ciò che fa. I bambini educati con questo stile, diventano molto ansiosi quando si cimentano in qualcosa di impegnativo
Stile iperansioso-iperprotettivo. Si manifesta in genitori e/o insegnanti che si preoccupano eccessivamente dell'incolumità fisica del bambino e tendono a proteggerlo in continuazione da ogni minima frustrazione. Nel bambino vengono quindi modellate timidezza e paura trasmettendogli soprattutto queste idee: •i pericoli sono dappertutto e bisogna stare attenti; •se qualcosa è spiacevole o frustrante bisogna evitarlo ad ogni costo; •se accadesse qualcosa di brutto sarebbe terribile; •se qualcosa va storto non si può fare a meno di rimanere sconvolti; •per sopravvivere bisogna assolutamente avere la certezza che le cose vadano bene
PARENT TRAINING Il Parent Training è una tecnica di intervento avente lo scopo di coinvolgere i genitori nel processo educativo, riabilitativo e psicoterapeutico, attraverso l'insegnamento di abilità necessarie per contrastare situazioni familiari problematiche e l'acquisizione di un atteggiamento orientato al problem-solving. (Fabbro, 2004). Nasce negli anni ’70 grazie ai lavori di Hanf : il comportamento del figlio nasce da una complessità e molteplicità di relazioni che si instaurano tra i membri della famiglia sulla base delle reciproche influenze.
OBIETTIVI GENERALI DI UN PARENT TRAINING
• Dare informazioni chiare su che cos’è l’ADHD e le possibili cause a partire da un
aggancio alla loro esperienza
• Analizzare la percezione di auto-efficacia e soddisfazione del genitore (questonari sul
senso di competenza del genitore), nonché la percezione del problema
• Chiarire che l’intervento cognitivo-comportamentale non è una cura dell’ADHD, ma
un insieme di tecniche per gestire meglio
• Favorire la consapevolezza dei pensieri disfunzionali e di quelli funzionali
(questionari cosa penso di mio figlio e come mi comporto con mio figlio)
• Favorire la consapevolezza dei punti di forza e di debolezza del proprio figlio
• Istruire sull’analisi ABC
• Dare informazioni sulle scelte educative che funzionano.
o L’importanza delle regole familiari per la capacità di anticipare
o Il rinforzo positivo e il costo della risposta
o Il tempo privilegiato
o Come gestire i comportamenti negativi
⁻ Distinguere comportamenti gravi da quelli meno gravi
⁻ Ignorare
⁻ Time out
⁻ Conseguenze negativePerché il parent training per l’ADHD? • Prendersi cura di bambini con ADHD può portare i genitori a situazioni di grave stress che rischiano di ripercuotersi negativamente sulle relazioni all’interno della famiglia. • I genitori, di fronte a comportamenti problematici del figlio, si sentono spesso confusi e hanno l’impressione di essere privi di strategie e strumenti utili per stabilire una relazione positiva con il bambino. • Talvolta questo può generare senso di frustrazione, rabbia, colpa e impotenza
Operare in modo sistematico con i genitori nasce da almeno quattro riflessioni: 1) la famiglia è una risorsa importante per cercare di favorire i comportamenti positivi del bambino, soprattutto nell’età prescolare; 2) il lavoro con il bambino a volte non è sufficiente per osservare l’apprendimento di adeguati comportamenti a casa e a scuola; 3) l’istinto materno e paterno, ovvero la disponibilità dei genitori ad affrontare le problematiche sollevate dal figlio con ADHD, non sono sufficienti a modificare i comportamenti iperattivi e/o la disattenzione; 4) la frequente presenza di relazioni disfunzionali dei membri della famiglia con il bambino ne aggravano il suo profilo psicologico.
Obiettivi ➢ fornire informazioni relative al disturbo da deficit di attenzione e iperattività; ➢ fornire gli strumenti per analizzare i comportamenti dei bambini e ragazzi nei vari ambiti di vita (scuola, casa, tempo libero); ➢ favorire la comprensione delle modalità di interazione genitore-figlio e gestire le modalità comunicative; ➢ fornire gli strumenti per la gestione del comportamento disfunzionale del bambino e ragazzo nei diversi ambiti; ➢ favorire l’aumento del livello di concentrazione e della capacità di autocontrollo dei propri figli.
Struttura degli incontri del P.T.
1 COMPRENSIONE DEL PROBLEMA SCAMBIO DI INFORMAZIONI-CONDIVISIONE
DELLE ESPERIENZE
2 PREPARAZIONE AL CAMBIAMENTO VALUTAZIONE E DISCUSSIONE SU
ATTEGGIAMENTI, CREDENZE E
COMPORTAMENTI GENITORIALI
3 COMPLESSITÀ DEL PROBLEMA INTERAZIONE TRA CARATTERISTICHE DEL
BAMBINO, SCELTE EDUCATIVE, SITUAZIONI
4 SCELTE EDUCATIVE CHE FAVORISCONO TECNICHE DI GESTIONE DEL
L’AUTOREGOLAZIONE COMPORTAMENTO DEL BAMBINO
5 INDIVIDUAZIONE DEI COMPORTAMENTI TECNICHE DI GESTIONE DEL
PROBLEMATICI COMPORTAMENTO DEL BAMBINO
6 AMPLIARE IL PROPRIO BAGAGLIO DI TECNICHE DI GESTIONE DEL
STRATEGIE COMPORTAMENTO DEL BAMBINO
7 AGIRE D’ANTICIPO, CON UN PIANO IN TECNICHE DI GESTIONE COGNITIVA DEL
TESTA BAMBINO
8 IL GENITORE COME MODELLO DI TECNICHE DI GESTIONE COGNITIVA DEL
RISOLUTORE ABILE DI PROBLEMI BAMBINO
9 BILANCIO DEL LAVORO SVOLTO REVISIONE DEL LAVORO E PROSPETTIVENello stabilire le regole i genitori
dovranno chiedersi:
• Questa regola e’ necessaria?
• E’ utile?
• Mio figlio la capisce?
• Sa cosa succederà se non la rispetta?
• Riusciamo, io e mio marito, a portarla
avanti in modo coerente?ALCUNI COMPORTAMENTI DA EVITARE • Dare comandi vaghi “Fa il bravo”, “Piantala…” • Dare comandi in forma interrogativa “Ti dispiace mettere via i tuoi giochi?” • Dare troppi comandi contemporaneamente • Ripetere gli stessi comandi senza applicare conseguenze • Minacciare ripetutamente senza applicare conseguenze • Non prestare attenzione ai comportamenti positivi
ALCUNI COMPORTAMENTI DA POTENZIARE • Dare comandi brevi, semplici e specifici • Porsi come modello e supporto per risolvere i problemi • Stabilire e far rispettare delle regole di comportamento: poche, comprensibili e accettate • Dimostrare coerenza nelle gratificazioni e nei contratti comportamentali • Prestare molta attenzione ai comportamenti positivi • Gratificare il bambino subito dopo l’azione • Ignorare i comportamenti lievemente negativi • Non perdere il controllo del ragazzo
A scuola, quale scenario normativo?
STUDENTI CON
DISTURBI EVOLUTIVI
SPECIFICI
DSA, ADHD, DOP, ecc
STUDENTI CON
STUDENTI CON SVANTAGGIO SOCIO-
DISABILITA’ ECONOMICO,
SPECIFICA L.104/92 CULTURALE,
EMOTIVO…
BES
Associazione Psicologia Insieme OnlusPuoi anche leggere