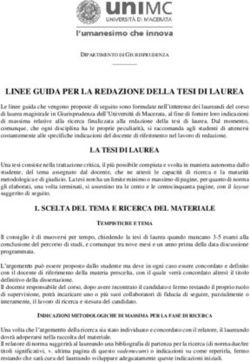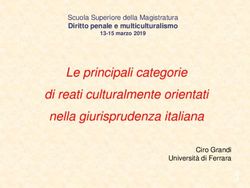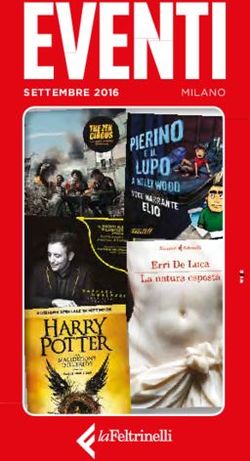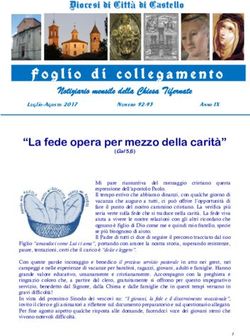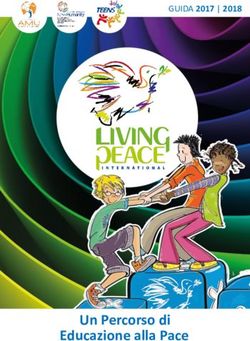UNA FAMIGLIA NOBILIARE VICENTINA - in una repubblica aristocratica del Cinquecento: IL LIGNAGGIO DEI GODI
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Dottorando: Andrea Savio
Mail: andrea_savio@hotmail.it
UNA FAMIGLIA NOBILIARE VICENTINA
in una repubblica aristocratica del Cinquecento:
IL LIGNAGGIO DEI GODI
Breve sintesi della ricerca in corso
La ricerca si prefigge l’obiettivo di delineare il ruolo politico ed economico di una
famiglia aristocratica vicentina, i Godi, nel Cinquecento. La scelta di soffermarsi sulla
dimensione di un lignaggio parte dal presupposto che alcuni problemi di carattere generale
possano essere affrontati e risolti proprio calandosi in ambiti più ristretti e specifici.
Vicenza era stata la città che forse più di altre aveva appoggiato l’Impero nel corso della
guerra di Cambrai. Tale adesione, più che da una vera e propria opposizione a Venezia, era
probabilmente motivata da un radicato senso di autonomia politica; un’immagine che non
appare sostanzialmente diversa da quella di altre grandi città facenti parte dello stato da terra
del Dominio, che si rifletteva verso l’esterno, nella richiesta rivolta al principe perché essa
fosse strettamente osservata, ma che veniva pure enfatizzata, in ambito cittadino nella
rivendicazione della propria sfera giurisdizionale nei confronti del territorio. Questa
concezione favoriva l’eguaglianza dei cittadini patrizi nei diritti e nei doveri nell'ambito di un
sistema politico contraddistinto dalla status e dalla ricchezza. L’esigenza di partecipazione
politica non era espressa tanto dai singoli individui, quanto dal comune, un’idea che
coinvolgeva, in primis, le case più illustri ed antiche del gruppo dirigente vicentino ed
ovviamente quel ceto di giuristi che rinveniva la propria legittimità culturale e giuridica nel
diritto comune imperiale. In quest’ambito la famiglia Godi occupò un ruolo di rilievo che è
testimoniato sia dall’ampiezza del suo patrimonio, che dal ruolo giuridico svolto da alcuni dei
suoi membri nei conflitti e nella vita politica della città.
Dagli estimi cittadini e ancor più dall’imponente archivio famigliare1, si può cogliere
come la dimensione economica e patrimoniale dei Godi rifletta la loro visibilità politica. Il
ritratto che il cronista seicentesco Giacomo Marzari fa di Girolamo Godi rispecchia la
commistione tra onore del lignaggio, splendore delle ricchezze e virtù repubblicane:
«Laico, decorato della equestre dignità fu non pure di belle lettere, ma di generosissimo
e di splendidissimo animo dotato, onde havendo dai fondamenti piantato a Lonedo in Pe di
Monte un Palazzo superbissimo con tutte le cor relative sue alla regia, non prettermesse mai,
mentre visse d’honorare con cortesissime e honoratissime maniere tutti quelli, che per goder
con gli occhi dette rarissime fabbriche e luoghi a quelle pertinenze»2
La ricerca va ad esaminare, da un lato i vari aspetti della vita di un lignaggio
aristocratico, colto nella sua dimensione politica esterna, e dall'altro, le sue relazioni interne:
scelte successorie e matrimoniali, carriere militari ed ecclesiastiche; vita domestica e politica.
Il tutto non intende smarrire il nucleo interpretativo essenziale cioè le relazioni e le tensioni
esistente tra la famiglia e i singoli individui, tra le scelte dettate dalla passione e quelle
determinate dall’interesse e dalle strategie economiche. Più in generale sul problema della
nobiltà durante il Cinquecento si intende mostrare come l’acquisizione di una dimensione
internazionale sia stata contemporanea non ad una crisi, bensì ad un cambiamento profondo
dell’aristocrazia di Terraferma, che ne investì la composizione, ne accrebbe i referenti, ne
arricchì le pratiche sociali e culturali.
1Questa breve relazione, nello schema generale della tesi, va a collocarsi nella sezione
dei Godi “in trasferta” nelle corti italiane. Sulla scorta di alcuni indizi, reperiti tra gli appunti
di differenti cronisti e libri di memorie tardo cinquecenteschi, non tutti interni all’archivio
familiare, si poteva supporre che il 6 marzo del 1590 moriva a Torino Orazio Godi, bandito a
vita dalla Repubblica di Venezia ancora nel 1580. Aveva ucciso il 16 dicembre 1577, vicino
alla villa di famiglia progettata dal Palladio, un membro di una nobile famiglia confinante.
L'omicidio era stato premeditato e il Godi non aveva avuto la possibilità di chiedere
clemenza. In un'unica memoria si narrava, inoltre, che il Godi si era rifugiato in Piemonte alla
corte di Emanuele Filiberto dove da tempo aveva forti aderenze.
2.0 LA FAMIGLIA GODI FUORI VICENZA. TRA REPUBBLICA E IMPERO
2.c LA CORTE DI EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA
Per un ventennio, a partire dalla metà degli anni Trenta del Cinquecento, il territorio
sabaudo fu uno dei teatri in Europa delle operazioni militari intercorse tra Francia e Spagna.
Dal 1536, con l'occupazione da parte delle truppe francesi di quasi tutte le piazzeforti della
Savoia e del Piemonte, il ducato sabaudo sembrava destinato alla naturale scomparsa. Lo
stato a cavaliere delle Alpi, «per metà impigliato nel mondo francese, legato ai Cantoni
svizzeri, affacciato sul mare dalle finestre di Nizza e Villafranca e unito oltralpe alla grande
pianura dell'Italia», definito da Braudel «un mondo a sé»3, rispetto anche alla stessa penisola
per tradizioni e identità molto differenti, era sempre stato difficilmente amministrabile.
L'autorità del principe, già compromessa dalla situazione geografica, era continuamente
limitata e condizionata dal clero, dalla nobiltà e dalle comunità cittadine4. Durante
l'occupazione francese la nobiltà della Savoia, che conservava le strutture dello stato
medievale per ceti, aveva favorito e collaborato fattivamente con i nuovi arrivati. Gli ufficiali
piemontesi, probabilmente per il timore di altri tradimenti d'oltralpe, tentarono, con l'aiuto dei
soldati spagnoli, la riconquista dei propri territori occupati, chiedendo la collaborazione
sopratutto di militari dell'Italia centro-settentrionale. Molti di questi erano professionisti
provenienti dalla terraferma veneta e in particolare da Brescia e Vicenza5. Ad esempio un
giovanissimo vicentino Guido Piovene, paggio nella corte spagnola, familiarizzò con l'infante
Emanuele Filiberto durante le sue brevi apparizioni colà6; lo incontrò nuovamente nel 1547 in
Germania alla corte di Carlo V divenendone uno tra i più fidati confidenti7 e successivamente
suo personale colonnello di campo. Negli anni Settanta del Cinquecento gli fu assegnato il
prestigioso compito di custode della cittadella di Torino. Questo gli fruttò l'invidia del resto
della corte che lo cominciò a disprezzare per essere un forestiero, in quanto non proveniva,
infatti, né dalla Savoia né dal Piemonte.
La vicenda del Piovene non fu un unicum tra i contemporanei8. I maschi delle famiglie
patrizie più facoltose della Terraferma, eccezione fatta per i primogeniti, erano costretti poco
più che bambini ad abbandonare il focolare domestico alla volta delle corti europee di Graz,
Vienna, Madrid, Parigi. All'unico figlio che rimaneva in famiglia, allevato nel segno di una
robusta cultura giuridica, veniva affidato il governo del casato9. Costui diveniva il tutore degli
interessi economici e politici della famiglia, colui che tutti i rami del lignaggio erano tenuti ad
informare rispettosamente in merito a fatti o a situazioni loro occorse negli stati esteri. Nel
caso di inconvenienti capitati ai membri della famiglia doveva garantire protezioni e appoggi.
La nobiltà di Terraferma era sempre stata insoddisfatta nei confronti della Dominante in
quanto era del tutto esclusa sia dalla gestione del potere nella capitale che dall'accesso alle
redditizie cariche vescovili, che il ceto dirigente veneziano aveva monopolizzato10. Tutto ciò
2era bilanciato, specie per le nobiltà di confine, dalla possibilità di affermarsi all'esterno della
Repubblica purché questo non contrastasse con la politica veneziana. Emergere in una corte
estera permetteva ai nobili di Terraferma di affermare il proprio prestigio individuale e
famigliare sia nei confronti delle altre consorterie locali che in rapporto alla stessa
Dominante. Questa d'altronde, nel caso di fallimenti politici ufficiali, poteva sfruttare la
risorsa ufficiosa ed efficace che i cortigiani costituivano. Se questo comportamento dal punto
di vista storiografico era noto per l’ultimo periodo della Serenissima (il Sei o Settecento
durante i quali i valori nobiliari dovettero venire a patti con spirito di servizio e appartenenza
nazionale), per il Cinquecento il problema si pone diversamente anche perché questa mobilità
è stata rivalutata solo nell’ultimo decennio.
IL PRIMO QUINQUENNIO NELLA CORTE DI EMANUELE FILIBERTO A
2.d
TORINO: IL PAGGIO LUDOVICO GODI
Fino alla fine degli anni Quaranta le piccole corti sabaude (oltre alla corte del duca vi
erano delle corti minori dirette da parenti e alti dignitari) avevano un numero di componenti
quantitativamente simile a quella che, di lì a poco, avrebbe attorniato Emanuele Filiberto11.
Le novità del duca sarebbero state la progressiva sprovincializzazione e una crescente
sfarzosità. Se fino a quel momento gli stati italiani ed europei avevano guardato con aria di
sufficienza le corti sabaude, dal 1559 le percezioni cominciarono a cambiare. Il prestigio della
vittoria di Emanuele Filiberto a San Quintino e il suo matrimonio politico con la principessa
Margherita di Valois, che riconsegnò al duca i territori sabaudi conquistati a fatica e difesi per
oltre un ventennio dalla Francia, maturò una nuova speranza nelle famiglie italiane che
potevano accedere ad una corte provvista di una nuova organizzazione12: tra i lombardi i
primi ad introdursi furono i Martinengo13, mentre tra i veneti alcuni membri della famiglia
Godi nel febbraio del 156014.
L'ammissione dei giovanissimi vicentini a corte fu anticipata da colloqui di Pietro Godi,
di solida cultura giuridica e residente quasi stabilmente nella capitale, con l'ambasciatore e
senatore piemontese Claudio Malopera a Venezia e fu caldeggiata dalla famiglia Godi per due
motivi: il primo di questi era legato alla nuova politica veneziana che stava predisponendo,
per la prima volta, un'ambasciata veneta in Savoia (febbraio 1560). Venezia in quel momento
aveva rappresentanti solo presso l'imperatore, i re di Francia, Spagna ed il pontefice. A
Milano e Napoli risiedevano solo segretari: nessun altro stato italiano aveva né ambasciatore
né segretario veneto15. Era probabile che Venezia considerasse il ducato di Savoia come il
principale tra gli stati italiani, dopo quello della Santa Sede. Il 10 febbraio 1560, Emanuele
Filiberto, lo stesso giorno in cui chiamava Ludovico Godi a Torino, desideroso di ristrutturare
le fortezze del suo stato e di innalzarne di nuove, pregò la Dominate di concedergli uno dei
suoi ingegneri più insigni, cioè il cavaliere, anche lui vicentino, Francesco Orologio, o
Orologi. La Repubblica come prova di fiducia e amicizia acconsentì16. Pietro Godi era stato
per oltre un decennio uno dei rappresentanti della città berica a Venezia e risiedeva nella casa
dei vicentini limitrofa a quella dell'ambasciatore del ducato sabaudo. Egli gestiva sopratutto le
problematiche e le cause a favore della sua città nei massimi uffici della capitale. Nel biennio
1559-1560 era praticamente stabile a Venezia perché stava gestendo il problema delle derrate
alimentari a causa della carestia che stava affliggendo la Terraferma, ma in modo particolare
la città di Vicenza.
L'altro motivo, invece, che portò i Godi nei primi anni Cinquanta ad accostarsi alla corte
sabauda, fu il progressivo avvicinamento, successivo ad Agnadello, di larga parte del ceto
dirigente vicentino verso posizioni filo imperiali: Emanuele Filiberto in quanto nipote di
Carlo V era quindi il sovrano italiano che poteva dare maggiori garanzie nei rapporti con la
corona imperiale. Già all'incoronazione di Carlo V a Bologna erano stati presenti tra gli altri i
3vicentini Giangiorgio Trissino e il vescovo Girolamo Bencucci da Schio; successivamente
durante i festeggiamenti nella villa dei conti Sesso a Sandrigo, nel vicentino, l'imperatore
aveva incontrato un ristretto numero di famiglie che lo avevano sempre sostenuto: i Capra, i
Loschi, i Trissino e i Valmarana17. I Godi, se fino al primo decennio del secolo avevano
parteggiato con il capostipite Enrico Antonio in equa misura sia per Venezia che per la Santa
Sede18, dal secondo decennio del Cinquecento cominciarono a muoversi per accedere alle
corti del ducato di Parma e di quello fiorentino. Non trovando alcuna utilità politica, onorifica
ed economica immediata, ritennero plausibile che l'influenza spagnola in Italia sarebbe stata
fondamentale negli anni a seguire. Negli anni Quaranta del Cinquecento i Godi con i
Valmarana erano a capo del partito pro spagnolo e probabilmente proprio per questo motivo
cominciarono a corteggiare sia l'ambasciatore spagnolo19 che quello sabaudo a Venezia. Su
quest'ultimo si concentrarono anche maggiori premure e regali a motivo degli interessi
economici che i Godi avevano a Lione, importante centro economico per i traffici mercantili.
La Savoia e il Piemonte erano vicini alla città di Lione da dove avrebbero potuto agevolmente
controllare il commercio serico proveniente da Vicenza20 e collaborare con altri vicentini che
si erano lì trasferiti nell'ultimo periodo. Un'attenzione, forse esagerata, verso l'ambasciatore
sabaudo che lo stesso Emanuele Filiberto, nel febbraio del 1560, fece notare in una lettera
autografa che scrisse a Pietro Godi, padre di Ludovico, ringraziandolo per la premura nei
confronti del suo ducato21. La lettera di Pietro Godi non si fece attendere. Rispose
cortesemente scrivendo che era stato impressionato dalle avventurose vicende biografiche del
duca a tal punto da sollecitarlo a mandare come servitore il proprio figlio22. L'ammissione da
parte del duca di Ludovico Godi come paggio nella piccola corte di Nizza era per lui un onore
così incommensurabile che da quel momento avrebbe sempre favorito il sovrano perché si
sentiva come uno dei suoi servitori più fedeli. Le strategie della famiglia Godi per questo
primo periodo nella neonata corte sabauda non erano ancora ben delineate, ma dai pochissimi
documenti rimasti sembra che Ludovico frequentasse anche la corte della moglie del duca,
che era separata da quella del marito. Il bilancio dello stato sabaudo era in passivo e per
rimanere a corte molti membri chiedevano prestiti alle proprie famiglie di origine. Per i Godi
sembra che l'aspetto economico sia secondario, anzi nei primi anni Settanta è lo stesso
Ludovico Godi a prestare un'ingente somma di denaro ad Emanuele Filiberto per la
costruzioni di due navi militari.
Tra il 1560 e 1561 Emanuele Filiberto modernizzò alcune fortezze del ducato tra cui
quella della città di Vercelli, città che nel medesimo periodo vedeva l'arrivo dei Micheli,
alcuni mercanti conoscenti di Ludovico Godi, che vi stabilirono delle produzioni di seta,
pannilani, sapone23. In questo primo quinquennio il ritorno per i Godi di onore, visibilità e
potere politico sembra sia limitato solo in Piemonte e quasi nulla traspare nelle cronache
vicentine coeve. Nel medesimo periodo arrivarono prima a Vercelli e poi si trasferiscono a
Torino altri due vicentini coscritti di Ludovico Godi: Celso Negri e Ludovico Poiana24. In un
primo tempo furono paggi di corte, poi si arruolarono come militari nelle guerre contro gli
contro gli ugonotti francesi e gli svizzeri. In questi primi anni Sessanta il duca rinnovò i paggi
di corte cercando di limitare la presenza dei francesi e sopratutto degli spagnoli25.
Alla fine del 1562, Emanuele Filiberto conquistò definitivamente Torino e nella
primavera successiva, per sciogliersi dai vincoli del passato e dai sudditi più riottosi, trasferì
definitivamente la capitale dalla Savoia in Piemonte, da Chambéry a Torino. Fu certamente
una delle idee più avvedute, innegabilmente la più ardita, il capire che una politica nuova
esigeva una capitale nuova: era priva di elementi architettonici essenziali, una reggia per il
principe, degli alloggi per la corte, ma sopratutto una cittadella. Le ambizioni del duca
traspaiono dai nomi degli uomini chiamati a lavorare per lui. Tra gli interpellati, c'era
addirittura il massimo degli architetti italiani, Andrea Palladio, che tra i primi lavori aveva
progettato la villa dei Godi26. Nell'aprile del 1566 Emanuele Filiberto andò a Venezia e qui
4probabilmente conobbe il Palladio. Sulla strada del ritorno si fermò a Vicenza. Qui fu accolto
da una ventina di gentiluomini guidati da lignaggio dei Piovene che lo ospitò nella sua dimora
per qualche giorno. Non si conoscono i cognomi delle illustre casate vicentine che
parteciparono ai festeggiamenti, ma indubbiamente i vicentini presenti erano gli stessi
membri di quei lignaggi aristocratici cittadini che facevano parte della corte torinese27.
1 Per questo lavoro si stanno esaminando le carte provenienti dall'Archivio privato della famiglia Godi
depositato presso la Biblioteca Bertoliana di Vicenza. Questo vasto fondo appena riordinato è senza dubbio
determinante per poter cogliere le tensioni percepite dalla famiglia, anche se certamente filtrate dai vari scarti
archivistici avvenuti nel tempo. L'archivio è costituito da 399 unità archivistiche dal 1091 al 1817 così
suddivise: 162 documenti cartacei e pergamenacei, 153 cartacei di processi, 61 registri, 6 fascicoli e 6
quaderni di carte sciolte. Il materiale è strutturato in diverse serie: gli Istrumenti, piuttosto lacunosa, è
costituita da scritture per lo più riguardanti acquisti, vendite, donazioni, divisioni, livelli, testamenti; i Processi
comprendono i fascicoli relativi alle cause giudiziarie nelle quali la famiglia o i suoi membri compaiono come
attori o controparti; numerosi sono anche i registri di amministrazione conservati descritti appunto nella
sezione Amministrazione; importanti strumenti di corredo alla documentazione sono, infine, i sommari e i
catastici degli istrumenti in XI tomi e il catastico che serve la serie Processi.
2 G. Marzari, La historia di Vicenza, Vicenza s.d., p. 153.
3 F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, trad. it., Torino 1976, 2 voll., II, pp. 1012-
1013 e ripreso anche in P. Merlin, Emanuele Filiberto. Un principe tra il Piemonte e l'Europa, Torino 1995, p.
4-5.
4 A. Barbero, Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano, Roma-Bari 2002, pp. 3-
47; P. Merlin, C. Rosso, G. Symcox, G. Ricuperati, Il Piemonte sabaudo, Storia d'Italia, v. VIII, t. 1, Torino
1994, pp. 3-173
5 Per i rapporti tra la Repubblica di Venezia e il ducato Relazioni di ambasciatori veneti al Senato. Tratte dalle
migliori edizioni disponibili e ordinate cronologicamente, a c. di L. Firpo, v. XI Savoia (1496-1797), Torino
1983, per la parte relativa ad Emanuele Filiberto e a Carlo Emanuele e pp. 11-470 e di A. Segre, Emanuele
Filiberto e la Repubblica di Venezia, in Miscellanea di storia veneta edita a cura della regia deputazione
veneta di storia patria, serie seconda, t. VII, Venezia 1901, pp. 65-513. Per i rapporti tra i militari vicentini e il
ducato sabaudo tra il 1525 e il 1550: A. Magrini, Reminiscenze vicentine della casa di Savoia, Vicenza 1869,
in particolare pp. 6-145. In Piemonte Carlo V si era servito di vicentini nella presa della fortezza di Fossano e
ne aveva affidato la custodia al nobile capitano Pietro (da) Porto. Successivamente il capitano vicentino aveva
respinto altri attacchi da parte dei francesi, guadagnandosi sul campo dal duca di Savoia il grado di colonnello,
aveva ripreso sia Cuneo che Mondovì, ma tentando di recuperare un'altra fortezza perì. Altri militari vicentini
in Piemonte partecipanti agli assedi furono Ludovico (da) Porto, fratello più giovane del suddetto Pietro,
Attilio e Brunoro Thiene, Ippolito (da) Porto, il capitano Angelo Caldogno, Valerio Chiericati, Giovanni
Rustichello e Francesco. L'archivio privato della famiglia Thiene, depositato in parte in biblioteca Bertoliana,
conserva alcune lettere dei sovrani sabaudi nei confronti dei Thiene e dei (da) Porto.
6 A. Magrini, Reminiscenze vicentine della casa di Savoia, Vicenza 1869, in particolare pp. 20-21.
7 Gli eruditi ottocenteschi narrano che il primo giugno 1560 nove galeotte condotte dai pirati calabresi Occhiali e
Manin si diressero verso il porto di Villafranca dove in quel momento Emanuele Filiberto si trovava
casualmente con i suoi più intimi. Guido Piovene organizzò un'imboscata contro i pirati salvaguardando la vita
del duca in: A. Magrini, Reminiscenze vicentine della casa di Savoia, Vicenza 1869, in particolare pp. 21-22 e
42; E. Ricotti, Storia della monarchia piemontese, Firenze 1861-1869.
8 Tra i vicentini, ma non solo, i figli dei Valmarana erano paggi nelle corti di Filippo II già a cinque anni.
L'imperatore nel 1557 aveva provveduto a dare una pensione annua per far studiare nella sua corte i figli dei
Valmarana e dei Nogarola in BCBVi (Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza), Miscellanea Valmarana, Ms.
Gonz.B.4.54 (476). Giorgio Nogarola poi si trasferì stabilmente nella corte di Graz diventando capitano
segreto del re, in F. Dal Cortivo, Leonardo Valmarana, nobile vicentino fra Cinque e Seicento, tesi di laurea,
Università di Padova, a. a. 1988-1989, p. 84.
9 D. Frigo, Il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell’«economica» tra
Cinque e Seicento, Roma 1985.
10 Un esempio di questi scontri istituzionali avvenne a Vicenza nel 1550 quando la famiglia dei da Porto
appoggiata dal consiglio cittadino e facendo leva su un antico privilegio del capitolo della cattedrale riuscì a
far eleggere un suo membro. Pur riuscendo a superare l'iniziale ostilità veneziana, l'elezione venne annullata
dalla Santa Sede. Sulla vicenda G. Mantese, Memorie storiche della chiesa vicentina. Dal 1404 al 1563,
Vicenza 1964, pp. 195-197 e 207-212 e A. Savio, Le lotte tra la Curia e canonici della Cattedrale, «Il
5giornale di Vicenza», 12 ottobre 2008, p. 67 e più in generale G. Del Torre, Patrizi e cardinali. Venezia e le
istituzioni ecclesiastiche nella prima età moderna, Milano 2010. Per un rapporto tra Venezia e le città suddite
C. Povolo, L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento, Verona
1997; C. Povolo, Onore e virtù in una repubblica aristocratica del Cinquecento in Andrea Palladio e
l'architettura della battaglia. Con le illustrazioni inedite delle Storie di Polibio, a c. di G. Beltramini, Venezia
2009, pp. 245-271 e A. Ventura, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento,
Milano 2003.
11 A. Barbero, Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano, Roma-Bari, 2002, pp.
197-256.
12 In realtà in Francia Emanuele Filiberto era accompagnato già da duecento cortigiani riccamente vestiti. Si
veda in P. Merlin, Emanuele Filiberto. Un principe tra il Piemonte e l'Europa, Torino 1995, p. 75.
13 Per i Martinego e in particolare su due personaggi l'uno militare e l'altro ecclesiastico molto influenti nella
corte di Emanuele Filiberto, si veda P. Bianchi, Una riserva di fedeltà. I bastardi dei Savoia fra esercito,
diplomazia e cariche curiali, in L'affermarsi della corte sabauda. Dinastie, poteri, elites in Piemonte e Savoia
fra tardo medioevo e prima età moderna, a c. di P. Bianchi e L. C. Gentile, Torino 2006, p. 337 e P. Cozzo, I
vescovi della transizione. La diocesi di Saluzzo e la politica ecclesiastica sabauda fra Cinque e Seicento, in
L'annessione sabauda del marchesato di Saluzzo, tra dissidenza religiosa e ortodossia cattolica (secoli XVI-
XVIII), atti del XLI Convegno di studi sulla riforma e sui movimenti religiosi in Italia (Torre Pellice-Saluzzo,
1-2 settembre 2001), a c. di M. Fratini, Torino 2004, p. 202. Per altri lombardi si veda in ASTo (Archivio di
Stato di Torino), Camerale Piemonte, Articolo 813-813bis, m. 1.
14 Il primo documento praticamente inedito attestante la relazione tra i Godi e i Savoia è in BCBVi, Archivio
Godi, b. 399, alla data. Una copia fu pubblicata con molte lacune nell’Ottocento, in BCBVi, Gonz.237.14,
Lettere di Savoia a Godi, Vicenza 1871(?), p. 7. Tra i veneti che si fermarono a corte nel primo decennio della
sua costituzione si possono annoverare i padovani Savioli, Bigolini, Zabarella; i vicentini (da) Porto, Bologna,
Poiana e Caldogno; i veronesi Salerni, San Bonifacio e Miniscalchi; i veneziani Melchiorri e Trevisani citati
anche nell'opera del cavaliere don Giovanni Battista Ricci, Istoria dell'ordine equestre de' SS. Mauritio, e
Lazaro, col Rolo de' cavalieri, e comende, Torino 1714, pp. 30-46.
15 In realtà dal marzo del medesimo anno venne mandato anche un segretario a risiedere presso il duca di
Firenze come in ASM ( Archivio di Stato di Mantova), Gonzaga, E. esterni, b. 1680.
16 A. Magrini, Reminiscenze vicentine della casa di Savoia, Vicenza 1869, in particolare pp. 60-75. La presenza
dell'Orologi nel primo quinquennio degli anni Sessanta è confermata dai pagamenti conservati in ASTo,
Sezioni Riunite, Camera dei Conti, Piemonte, Conti generali approvati, art. 86, Ricevidoria, poi Tesoreria
generale del Piemonte, par. 3-Piemonte, Tesoreria Generale, b. 1, n. 134 di 100 scuti d'oro in oro del 15 aprile
1561 e del n. 322 c. 75v di 50 scuti d'oro in oro del 14 giugno 1561; ASV (Archivio di Stato di Venezia),
Senato (Secreta) , Dispacci Rubricari, Savoia (Piemonte), f. E1 1560-1589.
17 Festa a cui avevano partecipato anche i duchi di Ferrara, Mantova e lo stesso Ippolito de Medici. Il rapporto
di primo piano tra Spagna e Vicenza è confermato dalla discontinua presenza dell'ambasciatore in questa città
negli anni successivi come rilevato in ASTo, Venezia Lettere Ministri, m. 1, c. 179.
18 La presenza dei Godi alla corte romana è abbastanza cospicua. Dall'archivio privato le maggiori
testimonianze emergono sopratutto quando i Godi “romani” chiedono ai cugini vicentini prestiti economici
BCBVi, Archivio Godi, b. 21, m. XX, n. 747, 1 gennaio 1475 e BCBVi, Archivio Godi, b. 75, m. LXXV, n.
3153, 4 dicembre 1525. Per le vicende romane si veda anche la voce curata da A. Modigliani su Pietro Godi,
in DBI (Dizionario bibliografico degli italiani), Roma 2001, v. LVII Giulini-Gonzaga, pp. 515-517 e il
manoscritto inedito in BCBVi, Ms. 485 (Godi), cc. 11r-12v.
19 Howard Burns li associa con i Valmarana come i capi del partito prospagnolo vicentino in H. Burns, “Da
naturale inclinatione guidato”: il primo decennio di attività di Palladio architetto, in Storia dell'architettura
italiana. Il primo Cinquecento, a c. di A. Bruschi, Milano 2002, p. 388. Si veda anche BCBVi, Archivio Godi,
b. 39.
20 ASVi (Archivio di Stato di Vicenza), Notarile, Notaio Francesco Bassan, reg. 7178, 25 giugno 1569: Pietro
Godi, padre di Ludovico, riceve lettere di cambio da Lione. Per legami economici tra i vicentini con la città di
Torino e Lione si veda E. Demo, L’anima della città. L’industria tessile a Verona e Vicenza (1400-1550),
Milano 2001.
21 BCBVi, Archivio Godi, b. 399, alla data: «Magnifico signor benchè fossemo certo del amorevole affetion che
vostra signoria ci porta col evidente segno / che n'ha fatto in darci per nostro pagio il suo figliolo qual havemo
a charo, si siamo anche / magiormente confirmato di essa soa buona volontà con la relation che ci ha fatto
l'ambassador / e senator Malopera qual ci ha rifferto le cortesie che gl'ha usate et il desiderio suo / da farci cosa
grata. Onde gli ne restamo con par desiderio di farle cosa grata si come / meglio li fariamo cognoscere se
l'occasion si presentasse. [...] Da Niza il X di fevraro 1560. Il duca di Savoia. Emanuele». Relazioni di
ambasciatori veneti al Senato. Tratte dalle migliori edizioni disponibili e ordinate cronologicamente, a c. di L.
Firpo, v. XI Savoia (1496-1797), Torino 1983, pp. 44-45 (1561?): «Le lettere che gli vengono scritte, le legge
6sua eccellenza sempre sé sola, e molte volte altri che lei non le vede, o le intende, ed a quelle di Spagna
risponde di sua mano. Le lettere d'altri signori le dà o al gran cancelliere o al segretario deputato, e ciò occorre
spesso quattro giorni dopo che l'ha avute, se non più; in modo che se il principe non è quello lui che dica, o
madama sua per gl'avvisi che le vengono, poco può saper di nuovo ambasciatore alcuno che vada in corte; e
ciò tanto più che pochi delli suoi attendono a nuove, conoscendo massime che sua eccellenza non ha piacere
che s'è n'impaccino».
22 BCBVi, Archivio Godi, b. 399, senza data. Il documento anche se manca di elementi cronologici è
evidentemente legato al precedente: «Io ho sempre havuto per natural inclinatione l'animo mio affettionatisi et
devotissimi verso vostra altezza dalla qual mosso procuraj di servirla con la persona di mio figliolo et hora son
obligato maggiormente di haverlo, poi che s'è degnato di accettar esso mio figliolo per suo paggio et però s'io
in qual modo che ho potuto ho dimostrato al signor suo ambassadore et senator il signor Claudio Malopera di
riconoscer questo mio debito et obligatione non era bisogno che sua signoria di ciò ne facesse quella relatione
ch'io vedo che ne ha fatto per sua cortesia et manco meritava io il favor grande ricevuto hora da vostra altezza
con l'humanissima sua lettera che mi fu data, alla qual non dirò altro per risposta, se non che parendomi
hormai di esser nel numero dei suoi più humilissimi servitori in ogni occasione che mi sarà data mi sforzerò
con ogni mio potere dimostrar l'ardentissimo desiderio ch'io tengo in servitio di vostra altezza, alla qual con
ogni humiltà recito infinite gratie poi che si degna haver grata la servitù di mio figliolo».
23 E. Ricotti, Storia della monarchia piemontese, Firenze 1861-1865, l. VI, cap. 3.III, p. 464 del v. II
«introduzione della materie prime al Micheli da Vicenza, perchè stabilisse in Vercelli il lavoro delle moresche,
o avanzi della seta e dei pannilani, e del sapone». Il documento archivistico originario sembra andato disperso
ancora alla fine dell'Ottocento.
24 ASTo, Sezioni Riunite, Camera dei Conti, Piemonte, Conti generali approvati, art. 86. Ricevidoria, poi
Tesoreria generale del Piemonte, par. 3-Piemonte, Tesoreria Generale, b. 3, cc. 281r-v, n. 523: «più livre
cento ottanta pagati di ordine di sovradetto a messer Selcio [è Celso Negri] Vicentino per un suo vestito et un
cavallo a lui dati da sua altezza nel suo uscire di paggio come appare per il mandato il cui tenore è questo. Il
duca di Savoia molto magnifico consigliero di stato et tesoriero nostro general messer Negron di Negro» e
ASTo, Camerale Piemonte, articolo 217, anni 1565-1568, m. 1, «conto che rende il magnifico signor giovanni
ambrosio cattaneo tesoriere della casa di sua altezza dell'anno 1565» c. 68v, «n. 232. Più ha paghato al signor
Celso Vicentino livre trecento per il suo stippendio in virtù d'una parcella dil conseglio di detta casa delli
quindici di luglio 1565 quale debitamente signata ed controlata insieme con la contenta si rimette in camera.
D. 200».
25 Relazioni di ambasciatori veneti al Senato. Tratte dalle migliori edizioni disponibili e ordinate
cronologicamente, a c. di L. Firpo, v. XI Savoia (1496-1797), Torino 1983, p. 40 (1561?): «ha più di
ventiquattro paggi di sangue onorevole, oltre tutti quelli altri poi che occorrono al servizio della casa di un
principe; e in tutta essa casa ho avvertito che non altro che uno spagnolo, che sta nella camera sua e governa li
vestimenti».
26 La probabile chiamata del Palladio è datata tra il dicembre del 1565 e il febbraio del 1566. In quel momento
gli unici vicentini presenti a corte oltre a Guido Piovene erano Celso Negri e Ludovico Godi come in ASTo,
Camerale Piemonte, articolo 217, anni 1565-1568, m. 1, «conto che rende il magnifico signor Giovanni
Ambrosio Cattaneo tesoriere della casa di sua altezza dell'anno 1565» c. 74v «n. 251. Più ha paghato al signor
Ludovico Vicentino gentilhuomo della bocca de Sua Altezza livre trecentoventi per suoi gagi in virtù d'una
parcella del consiglio di detta casa del ultimo di decembre 1565 quale debitamente signata et controlata
insieme con la contenta si rimette in camera. D. 320».
27 A Torino c'erano già stati alcuni contatti tra i Godi e i Piovene come segnalati in ASVi, Notarile, Notaio
Ludovico Piovene, reg. 619, 4 luglio 1565: in una procura redatta a Torino per conto di Guido Piovene
«cappitaneus archibusiorum» si registra che tra i testimoni vi era il residente Ludovico Godi.
7Indice provvisorio
INTRODUZIONE: I GODI IN UNA CITTÀ REPUBBLICANA DELLA
TERRAFERMA VENETA
CAPITOLO I: FAMIGLIA E RAPPORTI DI POTERE. DA NOBILI AVVOCATI A
PADRONI DELLA TERRA TRA IL XV E IL XVI SECOLO
a. La figura di Enrico Antonio Godi (1451-1536)
1.L'avvocatura
2.La vicenda personale durante Cambrai
3.Il ritorno a Vicenza
b. I conflitti tra famiglie
1. Identità famigliare e dinamiche politiche
2. I primi conflitti degli anni Trenta e Quaranta del Cinquecento
3. Gli anni Cinquanta a favore dello schieramento dei Capra contro il clan dei da
Porto
c. Le istituzioni cittadine vicentine con i membri Godi
1. I consigli cittadini e la serrata degli anni Quaranta del Cinquecento
2. I collegi dei notai e dei giuristi nel Cinquecento
3. [Clero secolare e clero regolare]
d. Il contado vicentino
1. L'acquisto progressivo di terra da Enrico Antonio Godi
2. La nomina di vicario e la gestione della clientela rurale nel basso e alto vicentino
3. Le fazioni nobiliari rurali e l'omicidio del dicembre 1577
CAPITOLO II: FUORI VICENZA. TRA REPUBBLICA E IMPERO.
a. I Godi nelle altre città della Terraferma veneta
1.La formazione: l'università di Padova
2.Una presenza continua nella Dominante
b. I Godi nelle corti straniere
1. Itinera mercatorum: Lione, Madrid, Costantinopoli
2. Soldati di Cristo: Vienna e Fiandre
3. In Italia: Roma, Firenze, Parma e Piacenza
c. Nella corte di Emanuele Filiberto
1. L'inserimento nella corte
2. Aiuto economico e militare di Ludovico Godi
3. Ludovico Godi nell'ordine cavalleresco di San Maurizio e Lazzaro
4. L'aiuto del sovrano nel caso del bando di Orazio Godi
5. I Godi supporto agli ambasciatori veneziani a Torino e il collezionismo con i Barbaro
CAPITOLO III: FAMIGLIE E PATRIMONI
a. Gli antenati e il privilegio del sangue
1.Nobiltà e alberi
2.Nobiltà e numero
3.Il ramo sfortunato dei Godi
b. Il potere famigliare
1.Le decisioni patrimoniali
2.Il maggiore dei figli
c. Patrimoni, doti, successioni
81.Il patrimonio
2.Le successioni
3.Le famiglie Godi e i destini femminili: il problema della dote
4.Testamenti femminili e lignaggi
5.Le vedove Godi
CAPITOLO IV: IL MATRIMONIO E LE RELAZIONI DOMESTICHE
a. Fra contratto e consenso
1.Il padre di famiglia: Enrico Antonio Godi
2.Il matrimonio aristocratico
3.Matrimonio tra famiglie alleate e nemiche
b. Dentro la famiglia
1. Affetti e discussioni
c. Famiglie in tribunale
1. Giurisprudenza criminale: i sequestri
2. Cause di giurisprudenza matrimoniale
9Puoi anche leggere