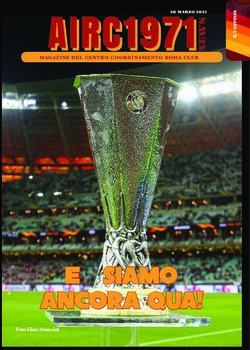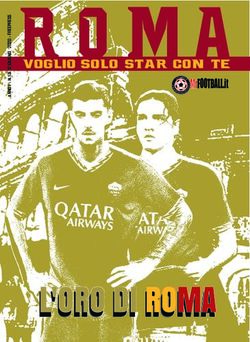"Tutti si deve morire" - LA FILOSOFIA INGENUA COME SINTOMO NELLA DEPRESSIONE SCHIZOIDE - Sergio Caruso
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Sergio Caruso
“Tutti si deve morire”
LA FILOSOFIA INGENUA COME SINTOMO NELLA DEPRESSIONE SCHIZOIDE
contributo al volume:
Morte e amore per la vita, in psicoanalisi,
a c. di M. Bacciagaluppi e G. Signorini, NeP Edizioni, Roma 2017.-2-
Life is a brightly illuminated hall,
with two windows open on a dark night.
And we are little sparrows coming into from the dark,
and flying all the way out – to darkness again.
(antica leggenda anglosassone)1
Esiste la “depressione schizoide”?
Vi sono pazienti genericamente “depressi” – molto vicini a quella condizione che la psicopatologia
psichiatrica d’ispirazione fenomenologica chiama “depressione esistenziale” (Haefner 1954;
Giannini A., Del Carlo-Giannini G. 1963) – i quali tuttavia non integrano esattamente nessuna delle
categorie diagnostiche previste nel DSM per i disturbi depressivi dell’umore. Taluni di loro si
direbbero “schizoidi”, ma non assolutamente nel senso psichiatrico, bensì nel senso psicoanalitico
messo a fuoco da Fairbairn (19401; 19522, pp. 3-27).
In queste persone c’è una perdita del tono vitale e del senso generale della vita, ma questa
condizione non è costante: si manifesta a periodi, più e meno, in maniera altalenante. E per
questo, ma solo per questo, sono stati ravvicinati anche al disturbo bipolare, col quale in verità
hanno poco altro in comune. Per queste situazioni propongo invece l’etichetta di “depressione
schizoide”.
Nel PDM (non nel DSM) si distingue, la classica “depressione introiettiva” dalla “depressione
anaclitica” identificata da Blatt (2004) negli adulti (sulle orme di René Spitz, che già ne aveva
parlato per quanto riguarda i bambini separati dalle madri). A me pare che la depressione
schizoide (di cui sto per proporvi un campione di quattro casi) corrisponda a una sorta di
oscillazione fra le due, caratterizzata com’è da un Sé relativamente dissociato e da un Io integro
che si connette di volta in volta con questa o quella parte di sé.
Richiamo in breve la nozione di «stati schizoidi», elaborata da Fairbairn. I pazienti cui egli si
riferisce a partire dal 1940 (così come quelli di cui parlerò fra poco) non hanno molto a che fare
con le sindromi che nella diagnostica psichiatrica di oggigiorno sono caratterizzate dal prefisso
“schizo”. Non si tratta certo di schizofrenici né di schizoaffettivi (disturbi alquanto seri di natura
francamente psicotica), ma neppure si tratta di pazienti tali da integrare un vero e proprio
disturbo di personalità come quello “schizotipico” o come quello detto appunto “schizoide”. Nulla
a che fare, infatti, con i comportamenti eccentrici e le credenze bizzarre che caratterizzano l’uno,
né con l’elusiva freddezza che caratterizza l’altro. Si tratta di persone normalissime che né
presentano alcunché di strambo né cercano d’isolarsi socialmente. Certo, il loro sentire è spesso in
qualche misura depresso e, talvolta, si direbbero eccessivamente preoccupati e/o
inspiegabilmente adirati (umore e sentimenti che causano loro un disagio soggettivo, più o meno
forte), ma:
– dal punto di vista oggettivo ed esterno, questa alterazione emotiva e affettiva si direbbe avere
una scarsa influenza sul loro modo di comportarsi socialmente (un po’ di più, semmai, nelle
relazioni intime) come pure sulla organizzazione complessiva della loro vita;
– e perfino dal punto di vista soggettivo e interno, il loro sentire assume forme alquanto diverse da
quelle tipiche delle classiche sindromi depressive.
Fairbairn parlava a questo riguardo di un sentimento schizoide di «futilità»: sentimento che
faceva derivare dall’avere, a suo tempo, messo amore in un oggetto che non risponde in maniera
adeguata. Deluso dall’oggetto d’amore, il bambino regredisce su quella che Fairbairn chiama
posizione schizoide (per qualche aspetto simile alla posizione schizoparanoide della Klein e
1
Devo questa citazione alla collega Jennifer Greenleaves, già docente di Storia dell’Africa nella Università di Firenze.-3-
supposta essere egualmente universale),2 vale a dire una posizione dove tanto l’Io quanto
l’oggetto sono scissi e dove abbiamo, pertanto, un Io libidico che spera di avere una storia d’amore
con un oggetto buono e un Io aggressivo che, difensivamente identificato con l’oggetto rifiutante,
attacca invidiosamente tutte le relazioni buone e le squalifica come «false».
E’ difficile oggi credere che questa possa essere una posizione universale, sia pure nella prima
infanzia. Ma direi che possiamo in parte recuperare la spiegazione di Fairbairn, se concepiamo
questo sentimento di futilità non tanto come regressione a una posizione già vissuta da ognuno di
noi, dove il bambino sviluppa due Ego parziali (inconsci) al di sotto dell’Io centrale (conscio),
quanto come conseguenza di un disturbo importante occorso nel legame di attaccamento
madre/bambino (a livello del Sé, più che dell’Io).3
Caratteristiche comuni
Ma ora, basta con la teoria: vengo ai miei quattro casi – tre donne e un uomo – e alle forti
somiglianze che attraverso gli anni ho notato fra loro. Ciò che subito mi colpì furono tre fatti o
caratteristiche condivise. Li definirò per opposizione ad altre caratteristiche ben note per essere
comuni negli stati tipicamente depressivi.
(1) Paura di staccarsi dall’oggetto presente (piuttosto che lutto per l’oggetto perduto):
(2) Un sentimento di futilità stranamente calmo (piuttosto che un qualche grado di evidente
infelicità (dalla tristezza alla disperazione);
(3) Il doloroso pensiero che tutti dobbiamo morire (piuttosto che la paura o il desiderio della
propria morte).
Vediamole una per una.
(1) Tutti e quattro i pazienti erano impelagati in una relazione complicata con qualche partner,
e di norma ciò che provocava la ricerca di un aiuto professionale era una crisi nella
relazione o una separazione molto recente. Vorrei sottolineare questo fatto: una semplice
crisi, seppure non grave, nel rapporto oppure una separazione molto recente, quale che
fosse l’importanza del partner. Ciò significava che la situazione scatenante del malessere
non era tanto la perdita di un oggetto d’amore quanto la “disgiunzione” da esso, la
separazione nel suo farsi, la sensazione di essere “strappato” da qualcosa. Infatti, e
paradossalmente, per quanto terribile fosse nel suo farsi, la separazione, una volta
compiuta, cessava subito di essere importante. In pochi giorni l’oggetto perduto sembrava
perdere la sua “realtà” assumendo piuttosto i colori del sogno. L’umore peraltro restava
vagamente depresso ben al di là dell’episodio.
(2) Per quanto triste o vagamente depresso (anedonico, per essere più precisi), l’umore di
questi pazienti non poteva in alcun modo essere detto disperato, né mai ho trovato in loro
alcuno dei sintomi tipici della depressione maggiore (tranne quel certo senso di
prostrazione, in un caso). Tutti questi pazienti continuavano a funzionare molto bene sia
nel lavoro che, tutto sommato, nella vita sociale. Piuttosto che tristezza o inadeguatezza,
tutti loro dichiaravano come un senso di vuoto, e tutti avevano la sensazione di vivere una
vita “senza senso”. Nessuno di loro manifestava sentimenti particolarmente autocritici, né
2
«In my opinion [...] some measure of splitting of the ego is invariably present at the deepest mental level – or (to
express the same thing in terms borrowed from Melanie Klein) the basic position in the psyche is invariably a schizoid
position» (Fairbairn 1952, p. 8).
3
Secondo Speziale-Bagliacca (2004, pp. 100-101) l’Ego di Fairbairn è piuttosto diverso dall’Ich di Freud. Col termine
Ego egli sembra designare l’intero Sé (Io compreso); pertanto, quando parla di libidinal Ego e aggressive Ego, non
starebbe parlando tanto di strutture delle psiche scisse, quanto di parti di sé dissociate, le quali operano a fianco del
Sé nucleare e al di sotto dell’Io: abbastanza estese e potenti, peraltro, da influenzare il modo in cui l’Io si mette in
relazione con gli oggetti esterni.-4-
alcuno mai manifestò idee di suicidio. Tutti e quattro sembravano stranamente calmi e a
loro agio nella loro infelicità, e del tutto esenti da quel tipo di ansie che spesso si mescolano
ai sentimenti depressivi. Anzi, arrivo a dire che sono, questi quattro pazienti, le persone
meno “ansiose” che mai io abbia trattato!
Quel che più mi ha colpito, tuttavia, è la terza caratteristica:
(3) Tutti e quattro mostravano un singolare atteggiarsi “filosofico”: una certa tendenza a
filosofeggiare sulla condizione umana, la natura del tempo, la vita, la morte. Ancora più
interessante: tre di loro sembravano condividere una comune filosofia imperniata sulla
idea di morte. La sintetizzo così: siccome il tempo è limitato, e tutto deve morire (noi stessi,
le cose che amiamo e forse l’universo stesso), allora non c’è assolutamente niente su cui
uno possa fare affidamento né alcunché cui si possa riconoscere un vero valore; e dunque,
eccoci qui, condannati a vivere una vivere breve, vuota e senza significato.
Sono ragionevolmente sicuro che nessuno di loro aveva mai letto gli scritti freudiani del 1915 e del
1916 – Le Considerazioni attuali sulla guerra e la morte, e Caducità – dove Freud si occupa di
pensieri del genere, a confronto con taluni «filosofi» e con «un famoso poeta» (Rilke). Qualcuno
potrebbe ancora obiettare che potrei averli influenzati io, dato che alla professione di terapeuta
affianco quella di docente di una materia filosofica. Ma posso assicurarvi che, per quanto filosofo
cerchi di essere all’Università, evito accuratamente d’impegnare i pazienti in discussioni filosofiche
nel mio studio, e che anche come terapeuta mantengo un assetto puramente psicoanalitico,
abbastanza alieno da orientamenti che pure grandemente rispetto, come per es. la logoterapia di
Viktor Frankl, che enfatizza l’umana «ricerca di significato» (Frankl 1946).
Devo aggiungere che, diversamente da come farebbe un vero filosofo, questi pazienti
confessavano queste loro idee, che avrebbero preferito non pensare, più che professarle
orgogliosamente. E in particolare questa idea ricorrente della morte come un pozzo senza fondo
dove tutti i significati scompaiono era sentita da loro come fortemente ego-distonica e
tragicamente vera al tempo stesso.
A tutto ciò si aggiunge una quarta caratteristica per così dire estrinseca, che non riguarda la
natura della sofferenza sul versante soggettivo, ma la persona del sofferente:
(4) tutti e quattro i pazienti sono persone altamente scolarizzate, di notevole levatura
intellettuale e di grande o grandissimo talento. Esattamente come le persone più spesso
affette da quella sindrome depressiva che, sul piano puramente descrittivo, gli
psicopatologi chiamano “depressione esistenziale” (Webb 2011). Il che non stupisce,
considerato che per filosofeggiare, sia pure in maniera non professionale, bisogna avere un
minimo di capacità intellettuali e di strumenti culturali.
I quattro pazienti
Non c’è tempo, naturalmente, per approfondire in dettaglio tutti e quattro i casi. Mi limito a farne
un schizzo, con particolare riguardo al ruolo che in ognuno di essi gioca questa ricorrente idea
della morte. I nomi e taluni dettagli sono stati ovviamente cambiati.
Michelangelo, laureando, 23 anni, fissò con me la prima seduta dopo solo otto giorni da quando la
fidanzata l’aveva lasciato: una settimana di separazione era bastata a metterlo in crisi. Il problema
non era tanto di aver perso quella ragazza quanto l’insopportabile senso di vuoto che sentiva nel
trovarsi senza alcuna ragazza: come sospeso nello spazio. Dopo un paio d’anni mi disse di sentirsi
molto meglio: abbastanza bene da interrompere la terapia. A mio parere il nostro lavoro non era
finito, ma disse anche che non se la sentiva più di farsi pagare le sedute dai genitori (né poteva
ancora pagarsele da solo) e lasciò. Ho un forte sospetto che i genitori ne siano stati felici, e non-5- solo per i soldi. Qualche anno dopo si ripresentò: aveva un lavoro ed era felice di potere pagare di tasca sua. La sensazione di vivere in una specie di vacuum non era così forte come prima, ma pure riteneva ancora che la sua vita fosse “vuota”. Benché dall’esterno la si potesse giudicare, a dire il vero, perfino troppo piena: infatti, mi confessò (sono parole sue) di avere una “strana” tendenza a mettersi con due donne per volta; due storie simultanee, l’una indipendente dall’altra. Era la sua assicurazione sulla vita, commentai, pensando alla vicenda precedente. Non era che un modo dire, naturalmente, ma lui subito, “a proposito di vita e di morte”, mi disse di sentirsi molto disturbato da questa coscienza del tempo che passa, e della morte che per tutti si avvicina. Sapeva bene di essere ancora molto giovane e di avere tanto tempo a disposizione, ma ciò che lo turbava non era solo né tanto l’idea di morire lui bensì quella che – prima di lui, con lui o dopo di lui – tutti quelli che conosceva sarebbero morti e che, dunque, nessuno – né lui né altri – avrebbe lasciato tracce nella memoria di alcuno. Ornella, artista, 48 anni, venne anch’ella da me nelle prime fasi di quella che pareva essere una separazione dal suo compagno. Separazione che di fatto non ci fu: era solo una crisi e, dopo anni, stanno ancora insieme. Disse di sentirsi oppressa e vuota al tempo stesso, come se non avesse più tempo per far qualcosa di buono e d’importante nella vita. E più di una volta commentò quanto dolorosa trovasse l’idea della morte. Con le sue stesse parole: “Non si tratta solo della morte mia: è la morte, per sempre, di ogni essere vivente. Perché un giorno la Terra finirà, inghiottita dall’esplosione del Sole. E l’Universo intero poi finirà, condannato com’è a collassare su se stesso oppure, in alternativa, a disperdersi nel nulla, degradato a un miserabile ronzare di raggi gamma, al livello minimo di energia. Così di tutto quello che facciamo non resterà la minima traccia, ed è questo un pensiero che distrugge il significato di qualunque cosa io possa fare”. Eleonora, impiegata, 26 anni, mi fu mandata dal suo psichiatra. Dei quattro era quella più seriamente depressa, nonché l’unica che avesse avuto bisogno di cure anche farmacologiche per affrontare la giornata. Ed era pure, fra loro, quella dalla personalità più convenzionalmente schizoide. A dispetto di ciò non aveva mai perso un sol giorno di lavoro e, nonostante questo senso di fatica che l’affliggeva, trovava il tempo – come Michelangelo! – di frequentare non uno, ma due uomini. La sua vita era accuratamente divisa in compartimenti stagni: i suoi genitori non dovevano sapere che la loro figlia era depressa, tanto meno che fosse in terapia; l’esistenza di un amante era ovviamente tenuta segreta al fidanzato, ma anche alla famiglia; i colleghi di lavoro non dovevano sapere di lei nulla di privato, neppure che avesse un fidanzato, neppure che fumasse (e tutto ciò per nessuna ragione in particolare). Una volta mi disse come visualizzava la vita: “Scintille nel buio, io sono una di loro. Si accendono e si spengono in un breve tragitto di luce, lungo percorsi che non s’incontrano mai. Finché tutto scompare e non resta che il buio. E questo è tutto, ma perché?”. Angela, assistente sociale, 28 anni, mi cercò – così disse – “per sbloccare la mia vita e per sentirmi meno dipendente dagli altri”. Il suo caso è un po’ differente: diversamente dagli altri tre non mi disse mai che, siccome tutti si deve morire, allora niente ha senso. Non con queste parole, almeno. Forse non era abbastanza depressa per esprimersi così. Il modo come formulò il suo malessere, tuttavia, era egualmente “filosofico” e perfino più sottile: riguardava infatti la natura del tempo e del valore. L’idea era questa: per essere sicuri che qualcosa vale la pena, ci vuole tempo; ma il più delle volte quando l’abbiamo capito, il tempo per farlo è scaduto; dunque, di fatto non può mai esserci nulla di bello che ci coinvolga. Questa la filosofia da cui chiedeva di essere liberata. Di questi casi, due hanno già raggiunto una conclusione che reputo soddisfacente. Eleonora ha smesso dopo cinque anni di lavoro comune e, per quanto non si possa dire immune da qualunque
-6-
problema, direi che è uscita dallo stile di vita congelato con cui viveva all’inizio. Angela ha smesso
dopo sei anni e più volte, da quel momento, mi ha scritto: per augurarmi buone feste, ma anche
per manifestare la sua gratitudine. La fine della seconda tranche di lavoro con Michelangelo è
vicina (dopo quattro anni) e si preannuncia come una buona fine. Con Ornella siamo ancora al
lavoro, ma posso dire (dopo tre anni) che si tratta di un ottimo lavoro, che lascia bene sperare.
Ho espresso queste valutazioni non solo e non tanto per la soddisfazione di esibire un qualche
successo terapeutico, ma anche e sopra tutto per attestare che la depressione schizoide – se esiste
come sindrome a sé stante, come io credo che sia – può essere curata; e che essa risponde bene
alla psicoterapia psicoanalitica (nella fattispecie: vis-à-vis, due volte alla settimana, in ognuno di
questi casi).
Non c’è tempo purtroppo per approfondire le storie cliniche di ciascun caso. Mi limito qui a
continuare il ragionamento sugli aspetti generali.
Altre caratteristiche comuni ai quattro casi
Ci sono infatti nei quattro casi altre caratteristiche comuni , che rispettivamente riguardano:
(A) la vita e la storia del paziente;
(B) la psicoterapia.
(A) Caratteristiche comuni nella vita e nella storia dei pazienti diagnosticabili come “depressione
schizoide”.
(5) Tutti e quattro descrivevano il genitore dello stesso sesso con espressioni del tipo “un uovo
gigante”, “un muro liscio”, come per dire: un oggetto che non risponde e a cui non è possibile
attaccarsi da nessuna parte.
(6) Al tempo stesso, proprio verso il genitore dello stesso sesso, tutti i pazienti confessavano
un certo grado di avversione e spesso una sorta di antico disgusto.
(7) C’era stata nell’infanzia di tutti una certa qual tendenza – più che edipica – a idealizzare il
genitore dell’altro sesso, seguita da un’amara delusione quando lui/lei risultava non
combaciare con l’immagine idealizzata.
(8) In tutti ho riscontrato la fantasia di essere o di essere stati il legame fra padre e madre, e
l’unica ragione per cui due persone così diverse potevano essere rimaste insieme.
(9) Tutti questi pazienti raccontavano di essersi sentiti per anni come fossero vissuti dentro
una “bolla di vetro” (espressione usata da 3 su 4) o come dentro una “armatura” (espressione
usata da una).
(10) Almeno 3 su 4 riferivano episodi minori di depersonalizzazione/derealizzazione, e tutti
riportavano un ricorrente senso di “falsità” relativo al loro stesso sentire e alle loro stesse idee,
come se non fossero capaci di convalidare alcuna verità interiore.
(B) Caratteristiche comuni nella psicoterapia
(11) Anche qui, nessun particolare segno di ansia, nemmeno nel raccontare le difficoltà della
vita quotidiana.
(12) Tutti e quattro, dopo un periodo più o meno breve di diffidenza, svilupparono verso di me
un transfert intensamente e costantemente positivo.
(13) Tutti loro, qualcuno con sua grande sorpresa, si rivelarono degli straordinari sognatori (al
ritmo medio di più di un sogno a seduta). Naturalmente ciò può dipendere dal mio stile di
lavoro e dall’importanza che annetto ai sogni. Ma facendo salve le differenze con altri pazienti
che anche con me sognavano meno, mi colpiva come questi quattro fossero felici di scoprire-7-
quante cose c’erano in realtà dentro quello che credevano il loro “vuoto” interiore, e quanti
significati nella presunta “insignificanza” della loro vita.
13.1. Tre di loro (le femmine) mi hanno portato talora dei sogni visualmente
bidimensionali, cioè “visti” come se uno guardasse un quadro oppure uno schermo
oppure una carta geografica dall’alto. Ciò che mi fa pensare alla identificazione adesiva di
Bick (1968) e Meltzer (1974): unico rapporto possibile con un oggetto materno che non
risponde a tono e non è vissuto come avente un suo mondo interno.
13.2. Tre su quattro mi hanno portato sogni dove il paziente cerca di camminare su una
qualche superficie non affidabile, tipo sabbia o una rete sospesa. Insomma: un terreno
che non ha una vera consistenza.
13.3. Molti altri sogni riguardavano situazioni di guerra e specialmente esplosioni.
13.4. Molti altri sogni riguardavano porte o cancelli, col paziente fermo sulla soglia, né
dentro né fuori. Ciò che mi fa pensare alla rappresentazione onirica di un attaccamento
ambivalente/resistente).
(14) In tutti si riscontrava una forte sensibilità alle regressioni profonde. Tre su quattro
reagirono con calde lacrime di grata commozione ad alcuni interventi miei che interpretavano i
loro sentimenti in termini di bisogni ed emozioni (positive ma anche negative) del bambino
piccolo: interventi che io temevo all’inizio essere ovvi e scolastici, ma che risultavano invece per
loro inaspettati e “veri”. Infine:
(15) per tutti loro il punto di svolta della psicoterapia coincise con la meravigliosa “scoperta”
che il mondo esisteva indipendentemente da loro e, sopra tutto, che gli altri significativi della
loro vita hanno anche loro motivazioni e conflitti, e che dunque il loro umore non dipende per
intero dal paziente. Con le parole di uno di loro: «non sono più obbligato a ricreare il mondo
tutte le volte che mi sveglio la mattina».
Riguardata dal punto filosofico, si direbbe – questa benefica scoperta – una sorta di conversione
dall’idealismo estremo dell’esse est percipi (Berkeley) al sano realismo del “senso comune” (Reid).
Ma dal punto di vista psicoanalitico c’è di più: mi riferisco alla ritrovata «fede in O» di cui parla
Bion, dove la Tigre interiore (colui che pensa) e quella esteriore (la Cosa stessa) s’incontrano e si
riconoscono della stessa natura (Bion 1970, trad. it. p. 112). Dove, diremo così, l’esistenza umana e
la sussistenza delle cose assumono una comune consistenza e una medesima “verità”: senza che vi
sia più bisogno di opporre la realtà dell’Io alla evanescenza del mondo (derealizzazione) o la realtà
di questo alla evanescenza di quello (depersonalizzazione). Col che si rende possibile quel
momento evolutivo – d’insight, ma egualmente e nello stesso tempo, potremmo dire. di outsight!
– che Bion chiama «trasformazione in O», cioè quel tipo di rielaborazione non solo cognitiva né
solo emotiva dell’esperienza che rinnova l’esistenza del soggetto e lo fa crescere (perché lo mette
in contatto con parti precedentemente inesplorate e inutilizzate di sé: Bion
L’idea cosmica della morte universale: che cosa non è
Certo, di tutte le caratteristiche comuni fra questi pazienti, quella che più fa impressione è una
certa qual maniera “filosofica” di concepire la morte e di parlarne con insistenza: siccome c’è la
morte, ed è universalmente presente, niente ha senso. Una concezione – va pur detto – laica e
tragicamente moderna, che va ben al di là del Trionfo della Morte caro agli artisti del medioevo.
Perché dalla iconografia medioevale traspare una qualche consolazione (di ordine teologico e
perfino di ordine sociale: contadini e baroni sono uguali di fronte alla morte), mentre il pensiero
dei miei laicissimi pazienti del XXI secolo appare letteralmente “inconsolabile”.-8- Naturalmente non intendo affatto negare che la «construction of meaning in the face of mortality» (Nouel 2007) sia un problema affettivo ed effettivo, se non anche il problema per eccellenza. In particolare, ma non solo, per le persone irreligiose. Ed è vero che solo da poco, finalmente, la psicoanalisi e la psicologia clinica hanno intrapreso con esso un serio confronto (Hoffmann 1998; Schoenewolf 2006; Tomer, Eliason, Wong 2007). Ma questo problema, salvo il caso particolare di più giovani malati terminali. emerge nella maggioranza delle persone – e non così drammaticamente! – di norma intorno ai 65 anni: all’inizio dello Stadio 8 di Erikson (1959, 1982), l’ultimo del ciclo di vita, tipicamente caratterizzato dal conflitto integrity/despair a fronte di un bilancio che sta per chiudersi. Ed è un problema che trova di norma un qualche tipo di soluzione personale. Al contrario, i pazienti cui sto parlando erano tutti all’inizio della psicoterapia piuttosto giovani e fisicamente sani; in tre casi su quattro, poco più che ventenni! Nulla a che fare con la praeparatio mortis delle persone anziane o dei pazienti terminali. Eppure proprio quello, il non-senso della vita a cospetto della morte, pareva essere il loro principale problema: tragicamente privo di soluzione. Non perché temessero la perdita di sé nel prossimo futuro, ma perché temevano la perdita del mondo ora. Alcuni autori affermano che una reazione blandamente depressiva al pensiero che tutti gli esseri viventi devono morire è un ingrediente normale della condizione umana. Altri arrivano a dire che la “depressione esistenziale” di Häfner può essere una fase della vita attraverso cui si perviene a un livello di funzionamento e di autocoscienza più elevato (Berra s.d.). Sarei del tutto d’accordo se solo fosse chiaramente precisato che tale “fase” non dev’essere necessariamente presente nella vita di tutti e che tanto meno essa appare normale nelle persone giovani. Per quanto mi riguarda, non l’ho mai trovata altro che in persone affette da una qualche forma di sofferenza da cui non parevano saper uscire da soli. Pertanto, continuo a ritenere che questo tipo di rimuginazione sulla morte sia un sintomo (e che poco abbia a che fare con un’autentica filosofia della morte, seppure svolta en amateur). Un sintomo in ogni senso, tecnico e non: non solo perché costituisce “qualcosa da decifrare”, ma perché costituisce “qualcosa di cui liberarsi”, come i pazienti stessi sentivano e chiedevano. Un sintomo, dunque. Ma che genere di sintomo? Questa immagine della morte come estinzione di ogni significato –è chiaro, ma voglio sottolinearlo – non c’entra niente né con la paura di morire nella quale spesso ci s’imbatte trattando taluni disturbi d’ansia e taluni disturbi psicotici da un lato, né d’altro canto col desiderio di morire che spesso troviamo nelle depressioni maggiori. Non c’entra con la paura di morire, perché non si accompagna con l’immaginazione di un pericolo imminente né dà luogo ad alcuna manifestazione di panico. I pazienti di cui parlo erano, ricordiamolo, fin troppo tranquilli; ciò che li caratterizzava era semmai una più sottile seppure ben contenuta angoscia di sprofondare nel nulla, che cercava nella immagine della morte “le parole per dirlo”. Meno che mai questa insistenza sulla universale ineluttabilità della morte c’entra col desiderio di morire del depresso grave, perché non comporta una disperazione intollerabile tale da volerle porre subito fine; semmai , una sorta di sordo dolore al pensare che la vita cui siamo condannati altro non sia che una insensata attesa della fine. Inoltre, per tutti i pazienti in questione – giova ricordarlo – ciò che fa problema non è la propria morte, ma la morte in generale, la morte in quanto tale: il fatto che tutti gli esseri umani devono morire e più generalmente parlando il fatto che – tempus vorax! – tutti gli esseri animati e inanimati, tutte le occasioni e tutte le memorie, sono condannate a sparire nel nulla. Ed è proprio l’enfasi su questa “universalità” che conferisce ai loro pensieri di morte un sapore vagamente “filosofico”. Ogni singolo paziente sapeva benissimo che di non essere che uno/una fra tutti. E ognuno di loro era abbastanza lucido da capire esserci qualcosa di “patologico” in questi pensieri dal momento che, benché veri, essi non risultano disturbare più di tanto la vita
-9-
della stragrande maggioranza delle persone. Si percepivano dunque, come dire? sfortunati, per il
fatto di sentirsi, molto più degli altri, obbligati a ripensare troppo spesso questa amara verità.
Ho parlato di “ossessione” e di “sentirsi obbligati”. Allora: non sarà che questa dolorosa idea
della morte universale si possa puramente e semplicemente considerare come la manifestazione
di un Disturbo Ossessivo-Compulsivo? La risposta è: no. Si tratta in effetti di una idea ricorrente,
ma non così persistente: si fa strada nei pensieri (e nelle associazioni) del paziente quando questi
si sente peggio o di malumore per altri motivi. E certamente concorre a farlo sentire peggio
ancora; ma – diversamente da quanto accade con l’ideazione autenticamente ossessiva del DOC –
nessuno di questi pazienti l’ha mai identificata come la “causa” del suo disagio e nessuno è venuto
in terapia per questa ragione. Non è come con i pazienti ossessivo-compulsivi, che non hanno
finito di mettersi a sedere per il primo colloquio e già ti dicono: “vede, dottore, dovunque mi trovi
continuo a pensare che il soffitto mi sta per crollare addosso. Lo so che non è vero, ma non posso
fare a meno di pensarlo. E questo stupido pensiero mi produce un’ansia tremenda”. La dolente
idea della scomparsa finale di tutti e di tutto non è così. Non è uno “stupido pensiero”, è una
serissima credenza. Ed emerge dopo settimane, a volte dopo mesi, come se il paziente dovesse
essere sicuro che l’analista non la troverà troppo strana.
Questa osservazione ci porta all’ultima ipotesi, quella in un certo senso più “drammatica”:
voglio dire, l’ipotesi che l’emergere di una idea di morte siffatta abbia la natura di un delirio
psicotico. Di questo avviso sembra essere Émile Cioran – il filosofo rumeno che ha dedicato molti
scritti all’argomento del pessimismo estremo e per così dire “cosmico” – quando parla di un
«delirio metafisico» che consiste nel vivere all’interno di una teoria della vita in generale, anziché
semplicemente vivre sa vie. Teorie del genere, secondo il pensatore rumeno, sono pseudo-filosofie
che conducono l’esistenza in un vicolo cieco di domande senza risposta (Cioran 1949, trad. it. p.
147).
Va pur detto, tuttavia, che Cioran non è uno specialista della salute mentale, ma
essenzialmente uno scrittore che volentieri indulge alla metafora: il solo fatto che nella sua prosa
un certo atteggiarsi assuma il nome di delirio non garantisce in alcun modo che quanto da lui
osservato vada inteso come un delirio psicotico nel senso tecnico della psichiatria e della
psicologia clinica. Del resto, i deliri psicotici non sono domande senza risposta, semmai il contrario:
risposte senza domanda. Basta pensare a certe rivelazioni ad personam che lo schizofrenico
paranoide dichiara di avere ricevuto e alle quali non intende rinunciare per nessuna ragione. Nel
caso nostro, invece, il fatto cui le credenze dei pazienti alludono (che tutti si debba morire) non ha
proprio nulla d’irragionevole né di bizzarro; ciò che la stragrande maggioranza non condivide non è
la fattuale verità del destino di morte che tutti ci attende, ma il significato emotivamente
disturbante, al limite devastante, che tale verità assume nella mente dei pazienti.
Di che natura è questa singolare idea della morte universale
In verità, questa singolare idea cosmicheggiante della morte universale a me pare piuttosto
l’inverso del delirio: una sorta di “antidelirio”. La paradossale certezza che non ci sono certezze.
Nei deliri psicotici c’è un potente senso di chiarezza: un certo contenuto è come rivelato al di là
di ogni dubbio. Nel nostro caso troviamo lo stesso senso di chiarezza, generalmente espresso con
immagini di eguale potenza, magari prese in prestito dalla filosofia, dalla poesia o dalla scienza.
Michelangelo, l’unico paziente maschio, sembrava Berkeley quando diceva che in definitiva tutto il
mondo, analista compreso, poteva prendere forma solo nelle sue percezioni e dunque sarebbe
scomparso con lui. Eleonora si figurava le vite umane come esili fiammelle che si accendono e si
spengono nel buio, senza incontrarsi mai, finché rimane tutto solo nero. Ornella si rifaceva alla
termodinamica per dire che, col crescere dell’entropia, alla fine di tutto l’universo non sarebbero- 10 -
rimasti che raggi gamma. Ma in tutte queste figurazioni – all’inverso del delirio psicotico – ciò che
con chiarezza e certezza si rivela non è tanto un contenuto positivo, quanto un contenitore
negativo: un non-mondo che destabilizza. fragilizza e annulla tutti i significati, lasciandoci senza
più nulla di solido che valga la pena conoscere e volere.
Quindi, in un certo senso Cioran ha ragione: c’è in effetti una sorta di delirio o di fantasia
paradelirante nel pessimismo cosmico, ma è quello che chiamerei un “delirio negativo”. Una
fantasia diurna, se vogliamo; ma non tanto “innocente”. Paradelirante anche nel senso che
conferisce al paziente questo (doloroso) sentimento di unicità, che veniva talvolta confessato più o
meno così: «tutti devono morire, e tutti lo sanno, ma sembra che io sia l’unico che davvero capisce
ciò che questo vuol dire veramente».
Considero questa rappresentazione del mondo una variante negativa di quello che Meltzer
chiama «delirio di chiarezza nell’insight». Meltzer [1976] lo considera la riattivazione di una
fantasia inconscia che nasce dalla identificazione proiettiva del bambino con una qualche parte del
genitore interno: come insediarsi all’interno della testa materna o del seno materno per
condividerne l’onniscienza o l’onnipotenza. Questi pazienti sono assai frustranti per l’analista
perché, qualunque interpretazione gli si offra, reagiscono come se… ovvio, già lo sapevo! Nel
nostro caso abbiamo forse lo stesso tipo d’insediamento nel “mondo interno dell’oggetto
interno”, solo che la testa e/o il seno materni sono percepiti come… vuoti. E questo senso di vuoto
viene proiettato sul mondo esterno (nel quale siamo realmente “insediati”), talvolta pure sulle
interpretazioni dell’analista. Come l’equivalente di una accusa, che riecheggia nel presente da un
passato lontano. Come se il paziente dicesse: “Perché non riesco a trovare nulla di solido su cui
stare sicuro [la madre] o a cui potermi appoggiare [un padre]?”.
In termini bioniani l’idea cosmica della morte universale rispecchia la «trasformazione in
allucinosi» del «terrore senza nome» che deriva da una catastrofe antica. Quella di un bambino
che viveva emozioni intense e difficili da capire e non trovava aiuto per dar loro un senso.
Contenuti senza un contenitore. E quindi la sensazione di perdersi in uno spazio senza confini
(Grinberg, Sor, Tabak de Bianchedi 1975, p. 57). In quel terrore possiamo rintracciare l’origine
remota di questo mortifero sentimento del Nulla di cui stiamo parlando.
La “trasformazione in allucinosi” non è la stessa cosa dell’allucinazione, né la stessa cosa del
delirio nel senso psichiatrico di questi termini. Si manifesta alla coscienza con percezioni di
estrema vividezza, sensoriale o ideativa, ma non necessariamente inficia l’esame di realtà. Nel
nostro caso abbiamo una trasformazione ideativa: la vivida percezione del Nulla! Quell’eterno
Nulla che circonda la nostra avventura temporale e che ci aspetta per inghiottirci. Però,
attenzione: siccome nessuno dei quattro pazienti è psicotico (neppure Eleonora), tutti loro sono
riusciti a fare (del terrore senza nome) una ulteriore trasformazione: di carattere, diremo così,
proto-simbolico. E ciò, facendo ricorso alla più ovvia delle immagini del nulla: la morte (come pure
l’oblìo, l’oscurità, la fine del mondo). Col risultato, non da poco, in trasformare questo Nulla in
Qualcosa. Qualcosa di cui si può parlare e che può essere evacuato con le parole. Qualcosa, per di
più, di vagamente “filosofico”: tale da poterne parlare in una maniera socialmente accettabile.
Come le fantasie inconsce, la fantasia conscia della morte universale assolve a funzioni
difensive. Segnatamente:
1. Serve a esportare fuori di sé, nel mondo esterno, un complesso di emozioni che altrimenti
susciterebbero il panico; aiuta dunque a mantenere la calma. Vediamo all’opera qui una
peculiare specie d’identificazione proiettiva, dove l’oggetto proiettato è una sorta di non-
oggetto: il seno che non c’è, il padre che non aiuta, le orecchie che non ascoltano, la bocca
che non risponde.
2. Nelle sue formulazioni verbali, sta come a metà strada fra diniego e razionalizzazione.
Infatti, spostando quel complesso presente di emozioni proprie nel futuro comune, essa- 11 -
permette di pensare: “non sono io che sto sprofondando nel nulla ora: si tratta di un
destino che riguarda tutti e tutto, e non c’è niente da fare”.
3. Essa inoltre garantisce al paziente un certo qual senso di superiorità: la soddisfazione di
sentirsi così profondo e così forte da comprendere l’insostanzialità del Tutto, per quanto
doloroso sia questo pensiero. Questa soddisfazione offre una compensazione narcisistica
che lenisce il senso d’impotenza sottostante e, nel contempo, aggiunge al sintomo un
vantaggio secondario.
Tali funzioni difensive conviene analizzarle tutte – di volta in volta, secondo come si presentano –
ma con estrema cautela. Starei per dire con un surplus di empatia e di umana partecipazione, visto
che la condizione umana è ciò di cui si parla: per evitare che le nostre interpretazioni siano
fraintese come critiche. Ma senza mai – assolutamente – mettersi a filosofeggiare col paziente:
sarebbe una collusione con le difese intellettuali e impedirebbe la «regressione benigna» (Balint
1968, trad. it. pp. 270 ss.) di cui questo tipo di paziente ha grande bisogno.
Osservazioni conclusive
E’ quello che ho cercato di fare con i pazienti in questione. L’idea cosmica di morte universale da
ciascuno di essi portata è stata analizzata e rianalizzata più e più volte, ogni volta a un livello
diverso e/o da un punto di vista diverso – intesi con ciò i classici «punti di vista» della psicoanalisi
(topico, economico, genetico, dinamico e strutturale) e non certo i punti di vista di questo o quel
filosofo. E ogni volta per mezzo del materiale emerso nel frattempo, esattamente come si fa con le
fantasie e con i sogni. Grazie a questo lavoro l’evocazione della morte ha gradatamente perduto
forza e frequenza.
Voglio aggiungere che analizzare la funzione difensiva dell’idea non basta. Per risolvere questo
vissuto bisogna anche affrontare, a un certo punto, l’angoscia da cui l’idea difende. Occorre cioè
che il paziente sia messo in condizione di capire che la catastrofe cosmica di cui parla, la sparizione
di tutto, non sta nel futuro, ma nel passato: insomma, che è già successa. E che nonostante tutto
siamo ancora qui, a parlarne, all’interno di una relazione sicura: nella quale è possibile stare, alla
quale è possibile appoggiarsi.
Il lavoro con questi pazienti è piuttosto lungo (nei miei casi da tre a sette anni), ma può dare
ottimi risultati.4
Bibliografia
Balint, M. (1968), The Basic Fault: Therapeutic Aspects of Regression. Trad. it. in: Balint M. e Balint. E., La Regressione, Milano:
Raffaello Cortina Editore, 1983.
Berra, L.E. (s.d.). La depressione esistenziale: tra patologia e normalità. Ma/Rivista on line di filosofia applicata, 3:
http://www.fabbricafilosofica.it/MA/03/05.html
Bick, E. (1968). The Experience of Skin in Early Object Relations. International Journal of Psychoanalysis, 49, pp. 484-486. Trad. it..
L’esperienza della pelle nelle prime relazioni oggettuali. In: Bonaminio, V. & Iaccarino, B. (a c. di), L’osservazione diretta del
bambino, Torino: Boringhieri, 1984, pp. 70-89.
4
Prima di essere ripresentata, con le altre relazioni riunite nel presente volume, al seminario di Ravenna in memoria
di Romano Biancoli (nella mattinata del 5 giugno 2010), questa relazione fu presentata per la prima volta – in inglese,
col titolo «Naïve philosophy as a symptom in schizoid depression» – al 51st Meeting of the AAPDP, «Listening and
doing. Treatment of the mind and the brain» (San Diego, CA: US Grant Hotel, 17-20 maggio 2007). Tutti I diritti,
dell’originale come della traduzione, appartengono all’Autore.- 12 -
Bion, W.R. (1965). Transformations: Change from Learning to Growth, W. Heinemann Med. Bks. Ltd., London. Trad. it.
Trasformazioni. Il passaggio dall’apprendimento alla crescita, Armando; Roma ,1973.
Bion, W.R. (1966). Catastrophic Change. The Scientific Bulletin of the British Psychoanalytic Association, 5, 1966. Poi in Bion (1970),
cit. infra: Ch. 12: Transformations of Container-Contained. Nuova trad. it. in: Il cambiamento catastrofico (e altre conversazioni
1971-75), a c. di F. Corrao. Loescher: Torino, 1981.
Bion, W.R. (1970). Attention and Interpretation. A Scientific Approach to Insight in Psychoanalysis and Groups. London: Tavistock
Publications. Trad.it. Attenzione e interpretazione, Roma: Armando, 1990.
Blatt, S. (2004). Experiences of Depression: Theoretical, Clinical, and Research Perspectives. Washington (DC): American
Psychological Association.
Cioran, E. (1949). Précis de decomposition. Paris: Gallimard. Eng. trans. A Short History of Decay, New York: Arcade Publishing, 1998.
Trad. it. Sommario di decomposizione, Adelphi: Milano, 1996.
Erikson, E.H. (1959). Identity and the Life Cycle. Selected Papers. New York: International Universities Press.
Erikson, E.H. (1982). The Life Cycle Completed: A Review. New York: W.W. Norton & Company. Ext. version, with a New Chapter by
Joan Erikson: ibidem, 1997. Trad. it. I cicli della vita. Continuità e mutamenti, Roma: A. Armando, 1999.
Fairbairn, W. R. D. (1940). Schizoid Factors in the Personality. Poi in: Psychoanalytic Studies of the Personality (Ch. I), London:
Routledge & Kegan Paul, 1952. Trad. it. Studi psicoanalitici sulla personalità, Boringhieri, Torino 1970.
Frankl, V. (1946). Trotzdem Ja zum Leben sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Wien: Verlag für Jugend und Volk,
1959. Eng. trans. Man’s Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy, Boston: Beacon Press. Trad. it. Uno psicologo nei
lager, con prefaz.di G. W. Allport, G. B. Torellò e G. Marcel, Edizioni Ares: Milano 2009.
Freud, S. (1915). Zeitgemässe über Krieg und Tod. Imago, 4(1), ss. 1-21. Eng. trans. Thoughts for the Times on War and Death, SE,
14, pp. 275-297. Trad. it. Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte, OSF, 8, pp. 123-145.
Freud, S. (1916). Vergänglichkeit. In: Das Land Goethes, Stuttgart: Berliner Goethe-Bund. Eng. Trans. Transience, SE, 14, ss. 305 ff.
Trad.it. Caducità, OSF, 8, pp. 173-176.
Giannini, A., Del Carlo-Giannini G. (1963). Considerazioni psicopatologiche sulla “depressione esistenziale” di Häfner. Rivista di
Patologia Nervosa e Mentale, 84 (marzo), pp. 100-116.
Grinberg L., Sor D., Tabak de Bianchedi E. (1975). Introduction to the Work of Bion, Strath Tay (Perthshire, UK): Clunie Press. Trad. it.
Introduzione al pensiero di Bion (nuova edizione), Milano: Raffaello Cortina Editore, 1993.
Häfner, H. (1954), Die existentielle Depression. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, 191, 5 (Sept.), ss. 351-364.
Hoffmann, I. (1998). Ritual and Spontaneity in the Psychoanalytic Process. Hillsdale-London: The Analytic Press.
Meltzer, D. (1974). Adhesive Identification. In: Meltzer D., Sincerity, and Other Works, ed. by A. Hahn, London: Karnac, 1994, pp.
335-350. Trad. it. L’identificazione adesiva. In: Meltzer D., La comprensione della bellezza, Torino: Loescher, 1981, pp. 24-43.
Meltzer, D. (1976). The Delusion of Clarity of Insight. International Journal of Psychoanalysis, 57, 141-146. Poi in: Claustrum. An
Investigation of Claustrophobic Phenomena, London: The Roland Harris Education Trust, 1992. Trad. it. Claustrum, Uno studio
dei fenomeni claustrofobici, Roma: Raffaello Cortina Editore, 1993, pp. 76-90.
Nouel, G. (2007). Construction of Meaning in the Face of Mortality. In: Tomer, Eliason, Wong (2007), infra.
PDM Task Force (2006). Psychodynamic Diagnostic Manual. Silver Spring (Md): Alliance of Psychoanalytic Organizations.
Speziale-Bagliacca, R. (2004). Ubi maior. Il tempo e la cura delle lacerazioni del Sé. Roma: Astrolabio.
Schoenewolf, G. (2006). The Death Trauma and Its Consequences. Nel sito philica.com, Article No. 26.
Tomer, A., Eliason G.T., Wong P., Eds. (2007). Existential and Spiritual Issues in Death Attitudes. Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum.
Webb, J.T. (2011), Existential Depression in Gifted Individuals. Nel sito Supporting the Emotional Needs of the Gifted,
http://sengifted.org/existential-depression-in-gifted-individual/Puoi anche leggere