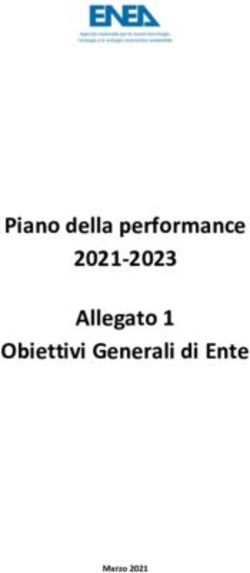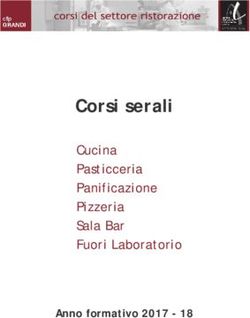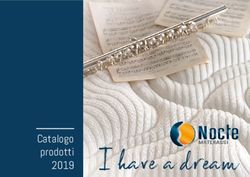TECNICA INNOVATIVA CONTRO I TERREMOTI
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
TECNICA INNOVATIVA
CONTRO I TERREMOTI
Tra i sistemi di controllo passivo per la protezione sismica
delle strutture, l’isolamento alla base (Bis) permette di raggiungere
risultati soddisfacenti con apprezzabili ricadute sui costi complessivi
di D. Cancellara Sommario Il confronto con il medesimo edifi-
– Dottorando in Ingegneria La tecnica dell’isolamento sismico alla cio concepito a base fissa, consente di
delle Costruzioni
base (Base Isolation System - BIS) rap- evidenziare i notevoli vantaggi che la
L. Sgariglia* presenta una delle tecniche innovative tecnica dell’isolamento alla base per-
Ingegnere di controllo strutturale e in partico- mette di raggiungere nei riguardi del-
lare rientra tra i sistemi di controllo la risposta sismica della struttura con
Lavoro presentato passivo per la protezione simica delle apprezzabili ricadute sui costi della
dal Prof. Ing. Mario Pasquino
strutture. Nella presente nota, tale tec- struttura stessa.
Ordinario di Scienza
delle Costruzioni nica viene applicata ad un edifico in
c.a. fortemente irregolare in pianta, Parole chiave
* Dipartimento di Ingegneria adottando gli eurocodici (EC0; EC2; Isolamento sismico, irregolarità in
Strutturale EC8) come normative di riferimento pianta, eurocodici
Facoltà di Ingegneria - Napoli
così da apprezzarne le analogie e le
differenze con la normativa sismica Descrizione dell’edificio
nazionale (NTC 2008). L’edificio oggetto di studio è carat-
terizzato da un piano terra adibito
ad attività commerciali, da
3 piani destinati ad attività
residenziali e da un sottotet-
to abitabile. L’accesso ai vari
piani è consentito mediante
la scala disposta in posizione
pressoché centrale, realizza-
ta con trave a ginocchio, e da
un ascensore.
La forma dell ’edif icio
è ad L con lati disuguali e
con dimensione massima in
pianta in direzione X pari a
24,00m e in direzione Y pari
a 19,00m. L’altezza dal pia-
no stradale fino alla linea di
colmo della copertura è di
16,80m. Il primo livello ha
una altezza di interpiano
pari a 4,00m mentre i livel-
li superiori al primo, han-
no un’altezza di interpiano
pari a 3,20m. La copertura
presenta un’altezza massima
di 3,20m in corrispondenza
della linea di colmo ed una
altezza minima in corrispon-
denza della linea di gronda
Fig. 1: il 2° lotto della Variante di San Donà di Piave pari a 1,60m.
INGEGNERI Ordine di Napoli
53Fig. 1 – Modello ottimizzato con l’ausilio di una Modellazione dell’edificio alla non coincidenza tra il centro di
parete (135x30) in sostituzione del pilastro 13. La modellazione della struttura è uno massa C M è il centro di torsione CR .
degli aspetti più importanti e delicati Per ovviare a tale inconveniente, non
per la valutazione della risposta sismi- volendo stravolgere interamente ciò
ca della struttura stessa. A tal riguar- che rappresenta l’organismo strut-
do, le norme raccomandano partico- turale si è deciso di introdurre nella
lare attenzione nel descrivere in modo struttura a base fissa (BF), una parete
adeguato la distribuzione delle masse disposta in direzione Y sul lato sini-
e delle rigidezze considerando, laddo- stro dell’edificio in sostituzione del
ve necessario, il contributo di elementi pilastro 13, in modo da ottimizzarne
non strutturali. Il software utilizzato il comportamento dinamico. Nella
per lo studio dell’edificio è il SAP2000 struttura a base isolata (BI) invece, il
v.10.0.7. disaccoppiamento dei modi di vibra-
Lo studio delle forme modali, ha zione, viene raggiunto calibrando op-
messo in luce uno spiccato accoppia- portunamente le rigidezze orizzontali
mento tra i modi di vibrazione, legato degli isolatori.
Tabella 1. Raggi di torsione in direzione Y e raggi giratori delle masse
Piano ls [m] r k,y [m] r k,y /ls [m]
1 9,45 9,18 0,97
2 9,41 8,93 0,94
3 9,41 8,88 0,94
4 9,12 8,91 0,97
5 9,14 8,91 0,97
54 N. 1/2009 - INGEGNERIA STRUTTURALEL’introduzione della parete nell’edi-
ficio BF, consente di ottenere dei modi
di vibrazione puri, ma non nell’ordine
corretto (il secondo modo è torsiona-
le) poiché l’edificio, oltre ad essere ir-
regolare in pianta, in quanto privo di
assi di simmetria, è classificato secon-
do l’EC8 a comportamento “torsiode-
formabile”. Tale definizione è dovuta
al mancato rispetto della condizione
per la quale i raggi di torsione ad ogni
piano e per ogni direzione di ingres-
so del sisma siano maggiori dei raggi
giratori delle masse: r x,y > l s.
Si sottolinea che, anche le NTC 2008 [*]
utilizzano i raggi di torsione come di-
scriminante per classificare le strutture traverso il fattore di struttura q.
torsiodeformabili. La limitazione del- Il fattore q quindi, ha il compito di
la norma sismica italiana risulta però, ridurre le azioni sismiche sulla strut-
meno gravosa: r x,y > 0,8 . l s. Secondo la tura che dovrà però, essere in grado
normativa italiana la struttura sarebbe di subire delle escursioni in campo
stata classificata come torsiorigida, con plastico (progetto per capacità).
tutti i vantaggi che ciò determina, co- In funzione della tipologia strut-
me il valore del fattore di struttura più turale, della classe di duttilità, della
alto e quindi relative azioni sismiche regolarità in elevazione e del tipo di
più basse. rottura attesa, si determina il fattore
di struttura q. Nel caso in esame, vo-
Struttura a base fissa lendo progettare in DCH e, essendo
L’edificio oggetto di studio, risulta es- la struttura regolare in elevazione ma
sere ubicato in un sito caratterizzato con comportamento torsiodeformabi-
da una accelerazione di riferimento al le, il fattore di struttura è pari a: q=3,0.
suolo ag, pari a 0,25g, mentre dall’esa- In figura si osserva lo spettro elastico
me stratigrafico è stato possibile sta- e lo spettro di progetto in condizioni
bilire l’appartenenza del suolo alla di SLU: [*]
categoria “tipo B” . L’EC8, a differenza della normativa
In base alle caratteristiche del suo- italiana utilizza come azione sismica
lo, è stato possibile definire il fattore di riferimento ai fini della verifica
di amplificazione S, ed i valori caratte- allo stato limite di danno (SLD), lo
ristici dello spettro di risposta elastico spettro di risposta elastico. Le nor-
T B, TC , T D che per tipologia di suolo B mative italiane (NTC 2008 e OPCM
e spettro “Type 1” sono pari a: 3431), considerano invece, ai fini di
detta verifica, uno spettro ridotto ot-
Tabella 2. Valori caratteristici tenuto da quello elastico scalato per
dello spettro di risposta elastico un fattore 2,5. In questo modo si ot-
per categoria di suolo B. tiene uno spettro rappresentativo di
eventi sismici, che hanno un periodo
Categoria S TB TC TD di ritorno T R di 72 anni, ovvero, una
suolo
probabilità di superamento PF in 50
[adimen.] [sec] [sec] [sec] anni del 50%.
B 1,20 0,15 0,5 2,0 L’EC8 però, nella verifica a SLD che
si esegue confrontando gli scorrimenti
Per il calcolo delle sollecitazioni, angolari di piano con valori limite for-
e quindi per la verifica degli elemen- niti dalla stessa norma, non prescrive
ti strutturali, si utilizza lo spettro di di utilizzare semplicemente i “drift“
progetto per SLU. L’adozione di tale di piano che si ottengono dall’anali-
spettro, conduce a considerare le ca- si, bensì prescrive di moltiplicare tali
pacità dissipative della struttura, at- “drift” per un fattore 0,4. Poiché le
INGEGNERI Ordine di Napoli
55Fig. 2 – Verifica in condizioni di SLD in direzione X e Y, struttura BF.
analisi sono lineari, questo equivale cedere viene definito dalle norme come
a scalare lo spettro di un coefficiente il metodo “normale” per investigare la
1/0,4=2,0. Quindi anche l’EC8 im- risposta sismica delle strutture.
plicitamente tiene conto di un evento In aggiunta all’eccentricità effetti-
sismico con periodo di ritorno più va, dovrà essere considerata un’eccen-
basso di 475 anni (SLU), utilizzando tricità accidentale, spostando il centro
però un coefficiente di riduzione 2,0 di massa di ogni piano i, in ogni dire-
invece che il coefficiente 2,5 dettato zione considerata, di una distanza pa-
dalle norme italiane. La verifica a SLD ri a +/- 5% della dimensione massima
secondo l’EC8, risulta essere legger- del piano in direzione perpendicolare
mente più penalizzante. all’azione sismica.
L’analisi della struttura viene esegui- La combinazione dei modi, al fine del
ta con il metodo della analisi modale calcolo di sollecitazioni e spostamenti
con spettro di risposta, su modello tri- è stata effettuata con la tecnica CQC
dimensionale. Questo metodo di pro- (Combinazione Quadratica Completa),
Fig. 3 – Inviluppo del dia-
gramma del momento e distinta
di armatura, travata 1006-1007-
1008-1009-1010
56 N. 1/2009 - INGEGNERIA STRUTTURALEFig. 4 – Inviluppo del
taglio sollecitante e
distinta di armatura
della travata 1006-1007-
1008-1009-1010
in quanto non è rispettata la regola se- Si vuole qui ricordare che la regola
condo la quale tutti i modi di vibrazione di combinazione del 30%, è una regola
devono differire almeno del 10%. empirica, che tende a minimizzare l’er-
Per quanto concerne la combina- rore rispetto alla combinazione SRSS,
zione delle componenti dell’azione si- che ha invece un fondamento teorico.
smica (EC8 4.3.3.4 Combination of the I due metodi, forniscono dei risultati
effects of the components of the seismic molto simili qualora si analizza la sin-
action), l’EC8 consente di procedere gola sollecitazione e in particolare, per
in due modi: le travi (soggette prevalentemente ad
un regime flessionale) i risultati sono
1. Combinare i risultati (sollecita- molto prossimi. Nei pilastri, soggetti
zioni, spostamenti, drift di pia- a presso flessione deviata, l’SRSS for-
no, ecc…) dell’azione sismica, nisce l’inviluppo della regola al 30%
applicata separatamente lungo e per tale motivo l’SRSS risulta essere
due direzioni orizzontali orto- troppo conservativa.
gonali, con la tecnica SRSS (Ra- Di seguito si riportano i risultati
dice Quadrata della Somma dei delle verifiche a Stato Limite di Danno
Quadrati). (SLD) e la distinta di armatura della
2. Combinare i valori massimi della travata 1006-1007-1008-1009-10010.
risposta sismica ottenuti in cia- Come si può osservare, la verifica a
scuna delle due azioni orizzon- SLD è rispettata a tutti i piani, risul-
tali ortogonali applicate separa- tando lo scorrimento angolare infe-
tamente, sommando ai massimi riore al valore massimo di normativa
ottenuti per l’azione sismica ap- (5‰ per edifici aventi elementi non
plicata in una direzione, il 30% strutturali di materiale fragile colle-
dei massimi ottenuti per l’azione gati alla struttura).
sismica applicata nell’altra dire-
zione: Struttura a base isolata
EDdx "+" 0,30EEdy L’aumento di deformabilità conseguen-
0,30EDdx "+" EEdy
te all’introduzione degli isolatori porta
dove il simbolo “+” sta ad indi- il periodo proprio del sistema struttu-
care che deve essere “combinato rale (isolamento-sovrastruttura) in una
con”. zona dello spettro a bassa accelerazione
(periodi dell’ordine di 2-3 sec). Di con-
Nel nostro caso si è deciso di pro- seguenza, le accelerazioni prodotte dal
cedere utilizzando la seconda possi- sisma sulla struttura isolata risultano
bilità, che sembrerebbe essere quella drasticamente ridotte rispetto a quelle
più accreditata in ambito scientifico. che si avrebbero sulla struttura a base
Utilizzando la regola del 30%, si ot- fissa, al punto che la struttura può es-
tengono 32 combinazioni di carico, sere progettata per resistere a terremoti
in quanto vi sono 8 coppie di azio- violenti senza che subisca danni agli
ni orizzontali, da moltiplicare per le elementi strutturali.
quattro possibili posizioni del centro Come è noto, la normativa non ri-
di masse. chiede che le strutture “tradizionali”
INGEGNERI Ordine di Napoli
57Tabella 3. Caratteristiche geometriche e meccaniche del sistema di isolamento impiegato. resistano ad un evento sismico vio- co, riducendole con un fattore 1,5. In calcolano assumendo un fattore di lento senza danneggiarsi, ma si affi- virtù della linearità delle analisi que- struttura q unitario. da alla loro “duttilità” e al criterio di sto equivale a considerare un fattore “gerarchia delle resistenze” affinché di struttura q=1,5. Il fattore q è molto La fase di progettazione del sistema abbiano un danneggiamento diffuso contenuto poiché la richiesta di dut- di isolamento alla base, prevede in- e controllato. tilità per la sovrastruttura è minima, nanzitutto la scelta della tipologia di Ciò non vale, almeno in parte, per dovendo esibire un comportamento isolatori ed in secondo luogo la defini- le strutture dotate di isolamento si- molto prossimo a quello elastico. zione delle caratteristiche di rigidezza smico alla base, per le quali si ritiene Sistema di isolamento: il sistema di e capacità dissipativa del sistema di che in presenza di un evento sismico isolamento deve essere progettato per isolamento. Nel nostro caso si è scel- anche di elevata intensità, la struttura rimanere in campo elastico e quindi il to di utilizzare isolatori elastomerici esibisca, con buona approssimazione, fattore di struttura q si assume pari ad alto smorzamento (HDRB – High un comportamento elastico. Si pro- all’unità. Inoltre la normativa impo- Damping Rubber Bearings) prodotti cede ad analizzare le varie parti che ne di incrementare gli spostamenti dalla ALGASISM. Dopo aver effettua- compongono il sistema strutturale: di progetto del 20% utilizzando un to una serie di confronti (in termini Sovrastruttura; Sistema di isolamen- fattore g = 1,2. di tagliante globale e spostamento to; Sottostruttura. Sottostruttura: deve essere veri- massimo richiesto dagli isolatori) si Sovrastruttura: la normativa im- ficata considerando le forze ed i mo- è deciso di fissare il “periodo target” a pone di verificare gli elementi che menti trasmessi dal sistema di iso- 2,5sec e lo smorzamento a ζ=10%. compongono la sovrastruttura, con- lamento oltre alle forze d’inerzia ad La soluzione adottata per il siste- siderando le sollecitazioni provenienti essa direttamente applicate. Le forze ma di isolamento, è quella di sistema dall’applicazione dello spettro elasti- di inerzia direttamente applicate si “misto” che prevede l’utilizzo di iso- 58 N. 1/2009 - INGEGNERIA STRUTTURALE
Fig. 5 – Inviluppo del dia-
gramma del Momento e
distinta di armatura per la
travata 1006-1010 (edifico
a base isolata).
Fig. 6 – Inviluppo del Ta-
glio sollecitante e distinta
di armatura per la travata
1006-1010 (edifico a base
isolata).
latori elastomerici in combinazione elementi in campo elastico. Quanto ficazione o schema semplificato che
con isolatori a scorrimento. In par- precisato è stato recepito dalla nor- invece, risulta essere necessario quan-
ticolare come isolatori elastomerici ma, infatti essa assume un fattore di do si vuole rispettare la metodologia
è stato adottato il dispositivo HDS.E struttura per la sovrastruttura quasi del “Capacity Design”.
600, mentre come isolatore a scorri- unitario (q=1,5) ed inoltre dichiara In Figura 5 e Figura 6 si riporta la
mento è stato adottato il dispositivo esplicitamente che gli elementi strut- distinta di armatura della medesima
ALBAPOT PNm. turali, dovranno essere progettati in travata 1006-1007-1008-1009-1010 già
Dimensionato e verificato il sistema DCL (classe di duttilità bassa secon- analizzata per la struttura a base fissa
di isolamento, si è passati alla verifica do l’EC8) seguendo le indicazioni ed e in Figura 7 la verifica allo SLD.
della sovrastruttura in condizioni di i dettagli costruttivi dell’EC2. E’ uti-
SLD e SLU. La verifica a SLD, nell’im- le osservare che la classe DCL corri- Confronti
postazione generale, non presenta sponde, secondo le NTC 2008, ad una La strategia dell’isolamento sismico,
alcuna differenza tra la struttura a progettazione in zona non sismica e grazie allo “shift” del periodo proprio
base fissa e la struttura a base isolata, quindi devono essere ignorate tutte le di vibrazione del sistema strutturale,
mentre per la verifica in condizioni prescrizioni e i dettagli costruttivi che consente una forte riduzione del taglio
ultime, vi sono delle differenze non mirano al rispetto della gerarchia del- totale agente alla base della struttura
trascurabili. Infatti, poiché la sovra- le resistenze. Tale modo di procedere, in elevazione e, conseguentemente
struttura ha un comportamento facil- consente al progettista di utilizzare le una riduzione dei taglianti di piano
mente assimilabile ad un corpo rigido sollecitazioni provenienti dalla analisi ai vari livelli. Ciò, determina dei bene-
su base isolata, le sollecitazioni che in- globale della struttura (decisamente fici sul comportamento globale della
teressano gli elementi strutturali sono modeste grazie all’azione di “filtro” struttura, sia in condizioni di SLD sia
molto basse, tali da far rimanere gli degli isolatori), senza nessuna ampli- in condizioni di SLU.
INGEGNERI Ordine di Napoli
59Fig. 7 – Verifica in condizioni di SLD in
direzione X e Y, struttura BI.
Tabella 4. Taglio di piano nella struttura a BF e a BI e riduzione percentuale.
Piano Base Fissa Base Isolata Riduzione Riduzione
n° TX [kN] TY [kN] TX [kN] TY [kN] Dir.X [%] Dir.Y [%]
Isolamento – – 1411 1430 – –
1 3207 3824 1058 947 67% 75%
2 2686 2819 873 834 67% 70%
3 2181 2449 647 609 70% 75%
4 1487 1654 401 373 73% 77%
Copertura 1020 1059 268 221 74% 79%
Come si è già avuto modo di osser- il corretto ordine dei modi di vibra-
vare, in condizioni di SLD, lo scorri- zione, garantendo i primi due modi
mento angolare per la struttura a base traslazionali ed il terzo torsionale.
isolata è addirittura minore dell’1‰, Tale tipo di comportamento dinami-
differentemente dal caso della strut- co, consente un più uniforme impe-
tura a BF che presenta valori prossimi gno dei pilastri, evitando quindi che
al 4‰. Ambedue le verifiche allo SLD i pilastri periferici vengano caricati
sono soddisfatte (i valori sono infe- inutilmente per effetti di rotazione de-
riori al limite massimo pari al 5‰ gli impalcati. Per evidenziare quanto
fissato dall’EC8), ma la struttura a detto, vengono proposti in forma di
base isolata, esibirà sicuramente un grafici e di tabelle, la distribuzione
comportamento deformativo migliore del taglio tra i vari elementi resisten-
rispetto a quella a base fissa. ti (telai), in corrispondenza del primo
Dal confronto delle due struttu- livello dell’edificio.
re, si nota che in condizioni di SLU, È interessante notare come nella
la riduzione del taglio ai vari livelli, struttura a BF, per effetto dell’azio-
oscilla da un minimo del 69% ai piani ne sismica in direzione Y, il telaio Y1
bassi in direzione X ad un massimo (telaio contenete la parete) e i telai Y3
del 79% in copertura in direzione Y e e Y4 (telai contenenti le travi a ginoc-
possiamo affermare che mediamente chio del corpo scala), risultano essere
la riduzione di sollecitazioni è circa maggiormente sollecitati. Il telaio Y2
del 70% (Tabella 4). Tale riduzione, risulta essere poco caricato ai vari li-
come si vedrà in seguito, consente un velli, in quanto presenta gli elementi
forte risparmio del quantitativo di resistenti secondo il lato debole ri-
armatura da dover utilizzare per la spetto alla direzione di ingresso del
sovrastruttura. sisma. I restanti telai, Y5 e Y6 assor-
L’isolamento alla base, ha consen- bono una aliquota minore del taglio
tito il completo disaccoppiamento e globale, in quanto in essi vi è un nu-
60 N. 1/2009 - INGEGNERIA STRUTTURALEmero inferiore di elementi resistenti
come conseguenza della forma ad L
dell’edificio.
Il diverso impegno dei telai, tende
a uniformarsi nel caso di struttura a
BI, per la quale, l’azione sismica si ri-
partisce in modo più omogeneo tra i
vari elementi strutturali verticali. Tale
circostanza è facilmente verificabile,
analizzando la pendenza dei dia-
grammi nelle figure seguenti. Men-
tre nella struttura a BF i diagrammi
del tagliante di piano, presentano una
pendenza significativa, in quelli rela-
tivi alla struttura a BI, l’andamento
del diagramma del tagliante di piano
presenta pendenze decisamente mi-
nori.
Per quanto riguarda l’azione sismi-
ca in direzione X invece, si ha che i
telai X1, X2 e X3 assorbono un’aliquo-
ta maggiore del tagliante di piano ed
ai telai X4 e X5 è affidata la restante Fig. 8 – Distribuzione dei tagli di piano sui vari telai che compongono l’edificio: Piano 1.
aliquota. Anche in questo caso, ciò si
verifica a seguito del maggior nume-
ro di elementi resistenti nei primi tre
telai, circostanza sempre legata alla
forma ad L dell’edificio. Tale com-
portamento della struttura, si ripete
a tutti i livelli e indistintamente nella
struttura a BF e in quella a BI
Di seguito si riportano i quantita-
Fig. 9 – Quantitativo
tivi di armatura impiegati per le travi d’acciaio impiegato
ai vari piani, e il risparmi che si otten- nella progettazione
gono con l’isolamento: delle travate per la
Discorso analogo può essere rivolto struttura BI e BF.
ai pilastri, osservando che gli effetti
dell’isolamento, in termini di rispar-
mio di armatura, saranno maggiori ai
piani bassi e tenderanno a diminuire
al crescere del numero dei piani.
Ricordiamo che per la struttura a
BI sono state considerate due soluzio-
ni per armare i pilastri, una rigoro-
samente rispettosa delle prescrizioni
Fig. 10 – Risparmio
di normativa (soluzione 1), ed un’altra d’armatura ai vari
pur sempre rispettosa della normati- piani nelle travi utiliz-
va, ma guidata anche dall’esperienza zando il sistema a
che ha portato a disporre l’armatura base isolata
longitudinale in modo più uniforme
lungo il perimetro della sezione (so-
luzione 2).
In Figura 13 si riporta il quantitati-
vo di acciaio impiegato ai vari livelli
nei diversi casi analizzati, mentre in
Figura 14 si evidenzia il risparmio
d’armatura.
INGEGNERI Ordine di Napoli
61Utilizzando la soluzione 1 si ottiene e delle centine degli archi di riva; con
un risparmio a tutti i livelli di circa particolare attenzione all’evoluzione
il 70%. Volendo invece utilizzare la del già menzionato quadro fessurati-
soluzione 2, si ha un risparmio più vo della pila 4, che era stata all’uopo
contenuto, ma comunque del 60%. strumentata ed oggetto di rilevazione
Sia utilizzando la soluzione 1 (rispet- continua “in diretta”.
tosa della norma) sia utilizzando la Ottenuti confortanti risultati in
soluzione 2 (rispettosa dalla norma e merito all’efficacia degli interventi di
dettata anche dall’esperienza), l’iso- consolidamento predisposti, si è pro-
lamento sismico consente una forte ceduto alla sigillatura delle lesioni.
riduzione del quantitativo d’acciaio Ultimata la fase di varo, si proce-
da dover impiegare. deva in ultimo alla definizione di im-
Successivamente alla definitiva portanti aspetti di finitura dell’opera:
operazione di solidarizzazione della parapetti, sistemazione dell’impian-
campata centrale si procedeva all’ul- to di smaltimento acque in modo da
timazione della soletta e, in fasi suc- minimizzarne l’interferenza con i
cessive e con gli opportuni controlli prospetti dell’opera e, soprattutto, la
del caso, alla rimozione dei sostegni definizione del piano colore.
Fig. 11 – Distinta di armatura della pilastrata 1012-5015, Fig. 12 – Distinta d’armatura della pilastrata 1012-5015, edifi-
edificio a base fissa (Vista YZ) cio a base isolata (Vista YZ) – (soluzione 2)
62 N. 1/2009 - INGEGNERIA STRUTTURALELa scelta dell’acciaio Fe510 per
la carpenteria metallica, infatti, ha
comportato da un lato la necessità di
proteggere la struttura mediante un
ciclo di verniciature multistrato preso
a prestito dalla cantieristica navale:
dall’altro la conseguenza di dover
scegliere, attraverso il colore del ri-
vestimento, il “vestito” definitivo del
ponte.
Una scelta coraggiosa e inconsue-
ta, che dopo iniziali perplessità ha in-
contrato anche un grande favore del
pubblico, ha portato alla valorizza-
Fig. 13 – Quantitativo di acciaio impiegato nella pilastrata ai vari livelli
zione dell’aspetto slanciato dell’opera
attraverso una alternanza di bianchi
puri e neri puri: bianchi i fusti delle
pile, i profili delle velette, il parapetto,
l’interno delle asole delle pile; neri i
prospetti e l’intradosso, con una fe-
lice scelta di satinatura che, durante
il giorno, genera affascinanti effetti
cangianti (fig. 23, 25).
I lavori hanno proceduto celermen-
te sino fine del 2007, culminando nella
cerimonia di apertura al traffico av-
venuta il 21 gennaio 2008.
La straordinarietà dell’opera e
l’attenzione allo spirito del luogo ove
essa sorge, là dove si attestò il fronte Fig. 14 – Risparmi d’armatura nella pilastrata conseguente all’utilizzo dell’isolamento
della Grande guerra nel 1917 e venne
combattuta la battaglia del Piave che
preparò la vittoria del 1918, hanno struttura, di fronteggiare eventi si-
indotto la direzione lavori a proporre smici anche d’intensità elevata, senza
l’intitolazione dell’opera ai Granatie- che si verifichino danneggiamenti alle
ri di Sardegna, protagonisti di eroici parti strutturali e con minimi o ad-
fatti d’arme in quei frangenti. dirittura assenza di danneggiamenti
Di seguito si riporta il costo totale alle parti non strutturali.
dell’armatura per la sola sovrastrut- Il costo dell’isolamento viene in
tura ed il risparmio che si ottiene uti- buona parte compensato dalla ridu-
lizzando l’isolamento alla base. Come zione di armatura necessaria per la so-
si può osservare, l’impiego dell’isola- vrastruttura e quindi, con riferimento
mento alla base, consente di dimezza- al costo di costruzione, può asserirsi
re il costo dell’armatura. che la progettazione con isolamento
sismico alla base risulta economica-
Conclusioni mente non gravosa.
La strategia dell’isolamento sismico Inoltre, un’analisi economica com-
alla base per strutture intelaiate in pleta dovrà tener conto non soltanto
c.a., è la tecnica di mitigazione del ri- del costo di costruzione, ma anche del
schio sismico che qualsiasi progettista costo relativo alla manutenzione e alla
dovrebbe prendere in considerazione riparazione nel corso della vita utile
nella sua pratica professionale. Con- dell’opera, a seguito di eventi sismici
sente di regolarizzare il comporta- con periodo di ritorno paragonabile
mento dinamico per la maggior parte alla stessa vita utile della struttura. In
degli edifici che per le loro caratteri- tale ottica l’adozione dell’isolamento
stiche intrinseche dovrebbero essere sismico alla base appare un investi-
considerati irregolari. Consente alla mento senz’altro vantaggioso.
INGEGNERI Ordine di Napoli
63– Isolamento sismico: valutazioni eco-
nomiche – Atti del XII Congresso Na-
zionale ANIDIS “L’Ingegneria Sismica
in Italia”, Pisa, Italy, 2007.
[14] Albanesi S., Carboni F., Albanesi T.
- Ruolo delle murature leggere portate
nel comportamento sismico di strutture
intelaiate in cemento armato - ANIDIS,
XI Congresso Nazionale “L’ingegneria
sismica in Italia”, Genova 2004.
[15] Biondi S., Colangelo F. e Nuti
Fig. 15 – Costo totale dell’armatura per i diversi casi analizzati.
C. - La risposta sismica dei telai con
tamponature murarie, CNR-Gruppo
Nazionale per la Difesa dai Terremoti
- Roma, 2000.
[16] Ghersi A. – La regolarità strut-
turale nella progettazione di edifici
in zona sismica – Atti del convegno
tecnico-scientifico “Problemi attuali
di Ingegneria Strutturale”, dal volume
omonimo, CUEN, Napoli, 2000.
[17] D. Cancellara, M. Pasquino – Val-
utazioni sull’incrudimento di isolatori
HDRB per edifici isolati alla base –
Fig. 16 – Risparmio monetario sull’armatura
XXXVI Convegno Nazionale AIAS
(Associazione Italiana per l’Analisi
Bibliografia ca degli edifici – IUSS Press, Pavia, delle Sollecitazioni), 2007
[1] A. K. Chopra – Dynamics of Struc- 2004. [18] Ordinanza del Presidente del Con-
tures – Prentice Hall, 2000. [9] G. Serino – Passive and Active siglio n. 3431 del 03/05/2005 – Ulteriori
[2] R. Clough, J. Penzien – Dynamics of Structural Control in Earthquake En- modifiche ed integrazioni all’ordinanza
Structures – McGraw-Hill, 2004. gineering – Lecture Notes of TEMPUS del Presidente del Consiglio dei Minis-
[3] J. M. Kelly, F. Naeim – Design of JEP 3008 intensive course, Ljubljana, tri n. 3274 del 20 marzo 2003 – G.U.
Seismic Isolated Structures: from theory 1995. 10/05/2005, Serie Generale 107, Sup-
to practice – John Wiley & Sons, Inc., [10] A. De Luca, G. Faella, F. Portioli – plemento Ordinario 85.
1999. Modellazione di dispositivi elastomerici [19] Decreto Ministeriale, 14/01/2008
[4] J.M. Kelly – Earthquake-resistant ad alto smorzamento – Atti del con- – Norme Tecniche per le Costruzioni
Design with Rubber – Sprinter-Verlag, vegno nazionale: “Protezione sismica – GU n. 29 del 4/2/2008 - Suppl. Or-
Berlin and New York, 1997. dell’edilizia esistente e di nuova edifi- dinario n. 30.
[5] J. M. Kelly – Base Isolation: Linear cazione attraverso sistemi innovativi”, [20] UNI EN 1990 – Eurocode - Basis
Theory and Design – Earthquake spec- Napoli, 2000. of structural design – CEN, European
tra, Volume 6, No. 2, May 1990. [11] L. Rosati, S. Sessa – Caratteriz- Committee for Standardization 2002.
[6] Edward L. Wilson – Three-Dimen- zazione ed impiego degli sviluppi della [21] UNI EN 1992-1-1 – Eurocodice
sional Static and Dynamic Analysis of risposta sismica di modelli strutturali - Progettazione delle strutture di cal-
Structures, A Physical Approach With lineari – Atti del XII Congresso Nazi- cestruzzo, Parte 1-1: Regole generali e
Emphasis on Earthquake Engineering – onale ANIDIS “L’Ingegneria Sismica regole per gli edifici – UNI, Ente Na-
Computers and Structures, Inc., terza in Italia”, Pisa, Italy, 2007. zionale Italiano di Unificazione, No-
edizione, Gennaio 2003. [12] E. Cosenza, B. De Risi, L. Di Sarno, vembre 2005.
[7] M. Dolce, D. Cardone, F.C. Ponzo, C. Mascolo, M.R. Pecce – Isolamento [22] UNI EN 1998-1 – Eurocode - De-
A. Di Cesare – Progetto di edifici con sismico di una struttura ospedaliera – sign of structures for earthquake re-
isolamento sismico – IUSS Press, Pavia, Atti del XII Congresso Nazionale ANI- sistance, Part 1: General rules, seismic
2004. DIS “L’Ingegneria Sismica in Italia”, actions and rules for buildings – UNI,
[8] L. Petrini, R. Pinho, G. M. Calvi Pisa, 2007. Ente Nazionale Italiano di Unificazi-
– Criteri di progettazione antisismi- [13] G. Buffarini, P. Clemente, A. Satta one, Marzo 2003.
64 N. 1/2009 - INGEGNERIA STRUTTURALEPuoi anche leggere