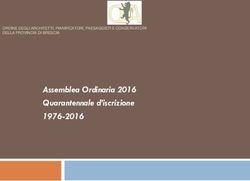Riconoscere pietre dell'edilizia storica: le e - Amazon S3
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Riconoscere le pietre
dell’edilizia storica: le
rocce sedimentarie e
metamorfiche
Nell’ultimo articolo abbiamo imparato a riconoscere le rocce
magmatiche più comuni negli edifici storici italiani e inoltre
come classificare la pietra dal punto di vista sia scientifico
che commerciale. Qui di seguito invece esamineremo le rocce
sedimentarie e metamorfiche, molto utilizzate come materiale
da costruzione e per scopi ornamentali.
Le rocce sedimentarie: genesi,
caratteristiche e tipologie
Le rocce sedimentarie sono costituite dalla compattazione di
sedimenti, cioè di materiali incoerenti di varia natura come
sabbia, pietrisco e ghiaia trasportata dal vento o dai fiumi;
gusci di crostacei e molluschi o infine sali minerali
disciolti nell’acqua. Le loro caratteristiche sono dunque
molto etoregenee. In base al processo di formazione
distinguiamo infatti:
1. Le rocce clastiche, formate da frammenti di rocce
preesistenti di varia natura e dimensioni (detti
clasti), da scheletri e gusci di organismi viventi
(bioclasti) oppure da entrambi;
2. L e r o c c e d i o r i g i n e c h i m i c a , g e n e r a t e d a l l a
precipitazione sul fondo dei sali disciolti nell’acqua
di mare o da un fenomeno molto simile alla formazione
delle stalattiti;
3. Le rocce organogene, prodotte dal semplice accumulo e
compattazione dei resti di organismi animali o vegetali.Photogallery Foto 1 - Banco di arenaria gialla in cui si nota anche la presenza di conchiglie fossili. Foto di Alessandro Ticci Chiudi Foto 2 - Particolare di un’edicola votiva in arenaria gialla Chiudi Foto 3 - Pieve romanica di Sant’Apollinare a Pavullo nel Frignano (Modena): particolare di una muratura ed elementi decorativi di pietra serena. Foto di Alessandro Ticci Chiudi Arenaria gialla – È una rocca clastica formata dalla compattazione di antiche sabbie di varia composizione con granulometria compresa tra 2 e 0,006 millimetri (scheletro sabbioso). Si caratterizza per il suo colore variabile da beige chiaro a ocra intenso e può contenere fossili di conchiglie bivalve o altri molluschi (Foto 1). È tipica dell’architettura storica di molte regioni come l’Emilia o la Toscana: grazie alla sua grande abbondanza e facilità di lavorazione veniva impiegata come materiale da costruzione o per la realizzazione di statue, colonne, capitelli, bassorilievi e modanature (Foto 2). Ha una resistenza meccanica da scarsa a media ma risulta vulnerabile agli agenti atmosferici e in particolare all’erosione causata dal vento, ai cicli di gelo e disgelo e alle piogge acide. Manifesta un degrado caratteristico con disgregazione e polverizzazione, erosione, scagliatura e crosta nera. Pietra serena – È una varietà di arenaria grigia con grana da medio-fine a grossolana, tessitura omogenea con minute pagliuzze dorate dovute alle scaglie di mica e colore variabile dal grigio-azzurro al color ferro; macchie o
venature giallastre svengono invece considerate un difetto e rendono la pietra scadente (Foto 3). Si estrae da numerose cave ubicate in Toscana. Non è lucidabile ma può essere ben levigata. A differenza dell’arenaria gialla ha un’ottima resistenza all’usura ma risulta vulnerabile alle intemperie e in particolare all’erosione causata dal vento e ai cicli di gelo e disgelo. Manifesta il degrado caratteristico dell’arenaria. Nell’architettura storica in particolare della Toscana era molto utilizzata come materiale da costruzione, per la realizzazione di soglie, davanzali, gradini e pavimentazioni esterne e stradali e per la costruzione di elementi ornamentali come modanature o bassorilievi: Filippo Brunelleschi la utilizzò in molti suoi edifici come la Cappella Pazzi o lo Spedale degli Innocenti insieme all’intonaco bianco. Approfondimenti Costruzioni storiche in muratura Sara Vallucci, Enrico Quagliarini, Stefano Lenci Il volume offre dati e indicazioni utili per analizzare i meccanismi di danno, valutare la sicurezza degli edifici, progettare interventi di miglioramento sismico su edifici esistenti, intervenire su tutti gli elementi della struttura. È corredato da casi ed esempi applicativi di interventi
realizzati che lo rendono un riferimento per ingegneri e per tutti i tecnici che devono progettare interventi secondo la normativa antisismica. Wolters Kluwer Acquista su shop.wki.it Pietra d’Istria – Si tratta di una roccia calcarea microcristallina a struttura compatta, scarsa porosità e colore bianco che con l’esposizione agli agenti atmosferici si ingrigisce leggermente. Originaria appunto della penisola istriana, era già utilizzata dagli antichi Romani come materiale da costruzione (il Ponte di Tiberio a Rimini è ad esempio interamente di questa roccia); mentre dal Medioevo divenne uno dei materiali caratteristici dell’architettura di Venezia e del Veneto, del Trentino e di altre zone limitrofe. Viene impiegata come materiale da costruzione, per la realizzazione di modanature ed elementi decorativi o – finemente macinata – come inerte degli intonaci a marmorino. Calcare ammonitico – Noto impropriamente come “marmo di Verona”, si tratta di una roccia sedimentaria calcarea di deposito chimico, formatasi per la precipitazione del calcare sul fondo del mare. Deve il suo nome alla presenza di numerosi fossili di ammoniti, molluschi simili a chiocciole vissuti tra 400 e 65 milioni di anni fa con diametro da 5 fino a 40-50 cm. Si caratterizza per una tessitura a noduli irregolari che spiccano su uno sfondo più scuro in tono su tono (Foto 4). Se ne conosco sei varietà: bianca, rosa, rossa, gialla o più raramente verde e viola. È utilizzata come materiale da costruzione (ad esempio nel Duomo di Modena), per il rivestimento di facciate (San Petronio a Bologna) o l’esecuzione di statue, vasche, fontane e pavimentazioni interne ed esterne.
Foto 4 – La diverse varietà del calcare ammonitico: bianco (con ammonite gigantesca), rosa, rosso (con ammonite), viola, giallo e verde Pietra della Lessinia – Detta anche pietra di Prun o scaglia veneta, si estrae principalmente sui Monti Lessini tra le provincie di Verona, Trento e Vicenza. È una roccia calcareo-marnosa di cui esistono tre varietà: bianca, rosa e rossa. Ha una struttura nodulare poco definita e un reticolo di sottilissime venature o lesioni scure (Foto 5); può inoltre contenere ammoniti, sebbene più piccole e meno definite di quelle presenti nel calcare ammonitico. È tipica dell’edilizia storica di Veneto, Trentino e – su scala minore – Emilia Romagna: i suoi usi sono gli stessi del calcare ammonitico, di cui è talvolta (impropriamente) considerata una versione più meno pregiata. Pietra alberese – È un calcare marnoso ad alto contenuto di carbonato di calcio, grana medio-fine e colore grigio chiaro con ampie venature o zone giallastre (Foto 6). Tipico della Toscana, è localmente impiegato come pietra da costruzione o per la produzione di calce. Calcare cavernoso (pietra da torre) – Roccia calcarea diffusa
in Umbria e Toscana di colore bianco-grigiastro, grande porosità e struttura vacuolare con cavità medio-grandi (Foto 7). È tipica degli edifici medievali della Toscana e in particolare di Siena, in cui veniva impiegata per la costruzione delle caratteristiche murature in conci squadrati con disposizione a filaretto. Travertino – Costituisce l’esempio più caratteristico di roccia calcarea di deposito chimico, perché si crea in corrispondenza di sorgenti e cascate con un fenomeno molto simile alla formazione di stalattiti e stalagmiti (Foto 8). Si riconosce facilmente per la sua tipica tessitura porosa con molteplici piccole cavità ravvicinate. Numerose varietà si possono lucidare. Il suo colore più comune è il bianco, ma si conoscono anche travertini rosa, rossi, gialli, grigi, neri e marrone (Foto 9). Le qualità migliori, con cavità di piccole dimensioni, hanno una buona resistenza meccanica ed alle intemperie. Venne impiegato su larga scala già dagli antichi Romani per la costruzione di murature ed edifici, la realizzazione di elementi ornamentali e la produzione di calcina: è perciò tipico dell’edilizia storica di molte zone d’Italia.
Foto 7 – Siena, Palazzo Piccolomini: particolare di una muratura in pietra da torre (calcare cavernoso). Foto di Alessandro Ticci
Foto 8 – Grotte di Labante (Castel d’Aiano, Bologna): un affioramento naturale di travertino bianco di recente formazione Foto 9 – Alcune varietà di travertino, dal sito dell’azienda Marmi ZEM di Enrico Ziche Brecce – Sono rocce sedimentarie formate dalla compattazione
di ghiaie di varia natura con clasti a spigoli vivi. Si tratta dunque di materiali estremamente eterogenei per colore, forma e dimensioni dei clasti, aspetto estetico e uso in architettura: le varietà più pregiate, con splendidi contrasti di colore, sono infatti utilizzate come pietra ornamentale per la realizzazione di pavimenti, rivestimenti, lapidi, altari e balaustre negli edifici in stile barocco e rococò (Foto 10); mentre il lombardo Ceppo di Grè, di colore grigio e molto resistente, è diffuso anche come materiale da costruzione. Puddinghe – Simili alle brecce, si caratterizzano per i clasti rotondeggianti (Foto 11). Abbastanza rare, sono impiegate soprattutto come materiale ornamentale. Onice o alabastro – Chiamato dagli antichi romani marmor alabastrum, si tratta di una vera e propria pietra semipreziosa traslucida caratterizzata da una vasta gamma di colori e venature. Dal punto di vista petrografico è classificato come onice calcareo. Estremamente pregiato per i suoi bellissimi colori, se ne conoscono due applicazioni principali: – nelle chiese bizantine e romaniche, prima dell’introduzione delle vetrate policrome, per il tamponamento delle piccole finestre: allo scopo si utilizzava una varietà italiana di colore ambrato (Foto 12); – negli edifici in stile barocco e rococò come materiale ornamentale per la realizzazione di rivestimenti parietali in grandi lastre (Foto 13). Pietra paesina – Costituita da calcare compatto e argilla, deve il proprio nome alle tipiche venature irregolari che ricordano un paesaggio. Si trova quasi esclusivamente in Toscana e si caratterizza per una palette di toni neutri che comprende varie sfumature di bruno e di marrone, rosso ruggine, giallo ocra, grigio e nero (Foto 14).
Foto 10 – Cattedrale di San Pietro a Bologna: alcuni esempi di brecce ornamentali
Foto 11 – Due esempi di puddinghe, dal sito dell’azienda Marmi ZEM di Enrico Ziche
Foto 12 – Esempi di finestre tamponate con lastre di alabastro
Foto 13 – Cattedrale di San Pietro a Bologna: lesena con rivestimento parietale in lastre di onice
Foto 14 – Esempio di pietra paesina, dal sito PietraPaesina.it dei collezionisti Lorenzo e Pierluigi Gallerini Il suo uso in architettura è poco comune e riguarda soprattutto la realizzazione di tavoli e rivestimenti parietali. Le rocce metamorfiche: genesi, caratteristiche e tipologia Come dice il loro nome, le rocce metamorfiche derivano dalla trasformazione di altre rocce, sedimentarie o magmatiche, in seguito all’esposizione ad alte pressioni e temperature. Questo processo avviene generalmente nelle profondità della crosta terrestre ed allo stato solido, cioè senza la fusione del materiale, perché in caso contrario si verificherebbe la produzione di magma con conseguente formazione di rocce magmatiche. Minerali diversi producono ovviamente rocce metamorfiche diversificate per composizione, aspetto e struttura. Marmo – Si origina dalla trasformazione delle rocce calcaree
in seguito all’esposizione ad alte pressioni e temperature. Il processo provoca la ricristallizzazione del carbonato di calcio in un mosaico di cristalli di calcite o dolomia, e inoltre la completa cancellazione della tessitura e dei fossili presenti nella roccia originaria. Il marmo si caratterizza dunque per una struttura marcatamente cristallina con grana da fine a grossolana, una certa trasparenza e lucentezza e un’alta variabilità cromatica; la presenza di impurità di vario tipo genera invece un’ampia gamma di venature. Esistono dunque numerose varietà di marmo (Foto 15): tra quelli italiani sono considerati di particolare pregio lo statuario di Carrara, bianco (Foto 16) o con sottili venature scure (Foto 17), il marmo rosa di Candoglia, il serpentino o marmo verde di Prato e infine il marmo giallo della montagnola senese. Viene utilizzato sia come materiale da costruzione, ad esempio nelle chiese in stile romanico pisano e fiorentino, sia come materiale ornamentale per la realizzazione di statue, tarsie policrome, mosaici ed elementi di rivestimento. Gneiss – Si tratta di una roccia metarmofica generata dalla trasformazione a grande profondità e allo stato solido, per effetto dell’aumento di pressione e temperatura, di rocce magmatiche come il granito. Presenta un aspetto differente (rispettivamente con sottili striature ondulate e parallele tendenzialmente bianco-nere e una struttura cristallina simile al granito – Foto 18) in base al verso di taglio. Viene utilizzato soprattutto come pietra da rivestimento e pavimentazioni.
Foto 15 – Alcune varietà di marmo colorato, dal sito dell’azienda Marmi ZEM di Enrico Ziche
Foto 16 – Duomo di Siena: particolare di una muratura con epigrafe in marmo bianco di Carrara. Foto di Alessandro Ticci
Foto 17 – Buonconvento (Siena), Palazzo Pretorio: lapidi con stemmi in marmo venato bianco di Carrara. Foto di Alessandro Ticci
Foto 18 – Il gneis nelle sue due giaciture Ringraziamenti Si ringraziano le aziende Marmi ZEM di Enrico Ziche e i collezionisti Lorenzo e Pierluigi Gallerini per l’uso delle fotografie. Bibliografia – Pietre e marmi antichi. Natura, caratterizzazione, origine, storia d’uso, diffusione, collezionismo, a cura di Lorenzo Lazzarini, CEDAM
Puoi anche leggere