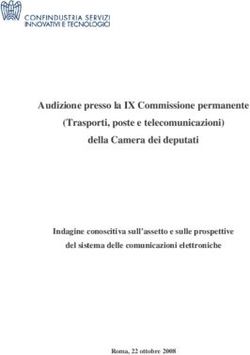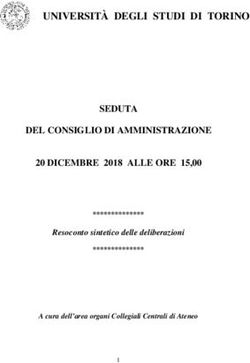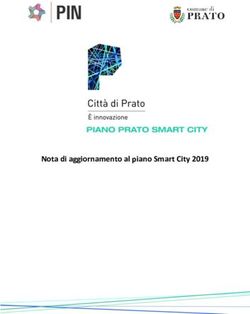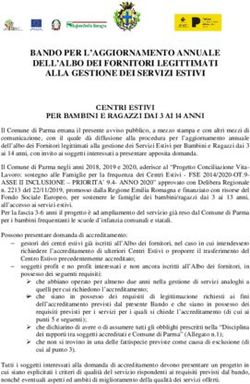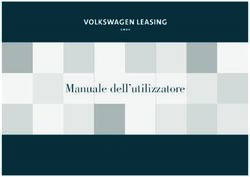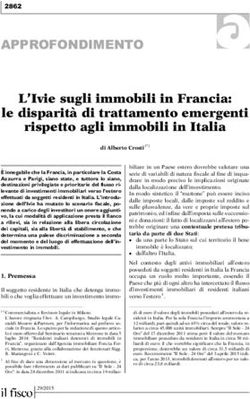NGN2: la parte Metro NGN2
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
OPM 10-07-2008 9:15 Pagina 3
NGN2
NGN2:
la parte Metro
MARIO BIANCHETTI L’articolo descrive le architetture, i protocolli ed i servizi presenti oggi sulla
GIOVANNI PICCIANO rete OPM (Optical Packet Metro) e quelli previsti nel prossimo futuro.
LUCIANO VENUTO La crescente importanza che i segmenti di rete di accesso, metropolitano
e regionale rivestono nel panorama globale delle telecomunicazioni, in virtù
dei nuovi servizi introdotti e della migrazione su rete a pacchetto di servizi
già trasportati su reti di accesso e metropolitane a circuito, concentra su
questi segmenti di rete una cospicua parte degli effort per l’innovazione e
l’ottimizzazione tecnico-economica delle infrastrutture di rete.
1. La rete OPM colli di routing OSPF e BGP) oppure MPLS a
seconda della configurazione effettuata. I due
A partire dal 2005 Telecom Italia ha avviato la livelli di apparati sono denominati livello Metro e
realizzazione di una rete di aggregazione in tec- livello Feeder.
nologia Ethernet e IP allo scopo di ottimizzare la Gli apparati di livello Metro sono installati nei
raccolta del crescente numero di apparati distri- PoP del backbone OPB e sono collegati ad esso
buiti nelle centrali ed in sede cliente aventi inter- (Edge router) con collegamenti a 10 Gbit/s. Gli
faccia di rete Ether net. In particolare è stata apparati di livello Feeder sono invece installati
avviata la realizzazione di 30 distinte reti che si nelle centrali principali della stessa area metropo-
sviluppano a partire dai PoP (Point of Presence) litana e regionale ed hanno la funzione di raccolta
della rete OPB (Optical Packet Backbone) e si e aggregazione del traffico dagli apparati cliente
diffondono a livello metropolitano e regionale rag- e dalla rete di accesso.
giungendo le principali centrali presenti nell’area I collegamenti tra gli apparati del livello Metro
di competenza. e del livello Feeder sono tutti realizzati con flussi
L’architettura attuale della rete OPM è struttu- 10 Gigabit Ethernet che garantiscono una quan-
rata su due livelli di apparati Multilayer Switch tità di banda adeguata al trasporto dei vari tipi di
(figura 1) in grado di trattare i flussi di traffico a servizio che si avvalgono della rete OPM per il
livello Ethernet (IEEE 802.1), IP (mediante proto- trasporto tra cliente e PoP della rete di backbone.
NOTIZIARIO TECNICO TELECOM ITALIA › Anno 17 n. 2 - Agosto 2008 3OPM 10-07-2008 9:15 Pagina 4
BIANCHETTI › PICCIANO › VENUTO • NGN2: la parte Metro
L’apparato posto in sede
cliente (CPE ADSL) consente l’ac-
HE ceso ai servizi Video, con una con-
OPB BTV nessione al Set Top Box (decodifi-
IP/MPLS BB catore dei segnali video), l’accesso
Backbone
IP Edge ai servizi di navigazione Internet e
3G ai servizi Voce (VoiP).
Mobile
VOD Core La connessione tra la suddetta
Network CPE ADSL ed il DSLAM Ethernet
è attualmente di tipo ATM con
GTWB
banda minima in downlink pari a
circa 5 Mbit/s.
Metro/Regional
Metro I flussi dei canali Broadcast
OPM TV (BTV) sono trasmessi dal cen-
Regional tro di distribuzione dei servizi
Area xWDM video broadcast (Head End)
GbE Feeder verso il backbone OPB. I sud-
GTWA
detti flussi vengono quindi distri-
buiti attraverso il backbone OPB
a tutti gli apparati Metro apparte-
ATM
nenti alle 30 MAN OPM presenti
UMTS/
HSxPA IMA nxE1
xDSL
sul territorio nazionale attraverso
l’uso di Protocolli IP Multicast.
Dagli apparati Metro i flussi BTV
Access
BUSINESS vengono quindi distribuiti a tutti
Residential
g l i a p p a r a t i F e e d e r. C i a s c u n
Triple Play Feeder replica poi gli stessi
canali verso tutti i DSLAM
ATM = Asynchronous Transfer Mode MPLS = MultiProtocol Label Switching
BB = BackBone OPB = Optical Packet Backbone Ethernet ad esso collegati.
BTV = Broadcast TeleVision UMTS = Universal Mobile Telecommunications I DSLAM Ethernet sono
GbE = Gigabit Ethernet System
GTW = Gateway VOD = Video On Demand quindi in grado di elaborare le
HE = Head End xDSL = x Digital Subscriber Line richieste provenienti dai disposi-
HSxPA = High Speed x Packet Access xWDM = x Wavelength Division Multiplexing
IMA = Inverse Multiplexing for ATM tivi del cliente ed inviare, attra-
verso il collegamento in rame
ADSL, un canale BTV per volta
FIGURA 1› Architettura della rete OPM. (nel caso di collegamenti
ADSL2+ è eventualmente possi-
L a re a l i z z a z i o n e d e l l a re t e
OPM è stata avviata con lo scopo
iniziale di raccogliere i DSLAM
Head
(Digital Subscriber Line Access End Server
Multiplexer) con interfaccia VOD
Ethernet utilizzati per la fornitura Server
dei servizi Triple Play (Voce, Video VOD
e High Speed Internet) alla clien- Switch L2
tela residenziale, e quello a ten-
Sede cliente
dere di diventare la nuova infra-
Switch L2
struttura di raccolta a livello TV
metropolitano e regionale per tutti
If GbE
i nuovi servizi a pacchetto con OPB
accesso da rete fissa e mobile. STB
CPE
Nei successivi paragrafi sono DSLAM
ADSL
L2, L3 L2, L3
illustrate le modalità con cui la Metro Feeder PC
rete raccoglie alcuni dei principali
servizi oggi offerti da Telecom
Italia.
ADSL = Asymmetric Digital Subscriber Line IPTV = Internet Protocol Television
CPE = Customer Premises Equipment OPB = Optical Packet Backbone
1.1 Servizi Triple Play DSLAM = Digital Subscriber Line Access STB = Set Top Box
Multiplexer VOD = Video On Demand
GbE = Gigabit Ethernet
La figura 2 descrive l’architet-
tura di rete implementata per la
for nitura dei servizi triple play FIGURA 2› Architettura di rete per i servizi Triple Play.
attraverso la rete OPM.
4 NOTIZIARIO TECNICO TELECOM ITALIA › Anno 17 n. 2 - Agosto 2008OPM 10-07-2008 9:15 Pagina 5
BIANCHETTI › PICCIANO › VENUTO • NGN2: la parte Metro
bile ricevere più canali contemporaneamente nazionale ha indotto l’autorità per le telecomunica-
grazie ad una maggiore disponibilità di banda zioni a richiedere all’operatore principale (“incum-
sulla tratta in rame). bent”) la condivisione delle proprie infrastrutture di
I canali VoD (Video on Demand) sono invece rete con altri operatori di telecomunicazione OLO
trasmessi dai Server VoD presenti in ciascun PoP (Other Licensed Operator). In questo contesto è
OPB. La rete OPM veicola le richieste di ricezione stato definito un servizio denominato “Bitstream”,
di un dato contenuto VoD generate dal Set Top la cui finalità è appunto quella di raccogliere il traf-
Box presente in sede cliente fino ai suddetti server fico di clienti dell’OLO, ubicati all’interno di un’area
che quindi provvedono ad inviare, in modalità uni- metropolitana e regionale servita dalla rete di
cast, un flusso di dati, relativo al contenuto video Telecom Italia, e consegnarlo in un unico punto di
prescelto, dedicato al cliente che ne ha fatto richie- presenza (PoP) della rete dell’OLO, nel quale sono
sta. Anche in questo caso il traffico VoD è trattato presenti gli apparati di rete (NAS, videoserver, PE)
dagli apparati Feeder e Metro a livello IP. necessari allo stesso OLO per offrire i servizi di
Il traffico relativo a servizi di accesso ad internet connettività.
e voce è invece trattato dagli apparati Metro e Sono state definite due tipologie principali di
Feeder solo a livello 2 (switching Ethernet). Sono servizio bitstream con raccolta e consegna tramite
infatti configurate alcune VLAN dirette dai DSLAM la rete OPM:
Ethernet agli apparati BRAS (Broadband Remote • una modalità che consente la raccolta del
Authentification Server) che trattano il traffico traffico proveniente da apparati di accesso
cliente a livello IP effettuandone l’autenticazione e (tipicamente DSLAM con interfaccia Ethernet)
consentendone l’accesso al servizio. di proprietà dell’OLO e consegna in un PoP
dell’OLO stesso;
1.2 Servizi di rete privata virtuale per clientela • una seconda modalità che prevede la raccolta
“business” del traffico relativo ai clienti dell’OLO attestati
su un apparato di accesso di Telecom Italia
La rete OPM è anche utilizzata per la fornitura (DSLAM Ethernet) e consegna un PoP dell’OLO
di servizi a clientela Business, tipicamente servizi stesso.
di accesso alle Reti Private Virtuali (VPN). In figura 3 è illustrata una rappresentazione
Le VPN posso essere realizzate a livello 2 schematica del servizio Bitstream, con raccolta
(Ethernet) o a livello 3 (IP/MPLS). del traffico dei clienti OLO su DSLAM di Telecom
Nel caso di VPN a livello 2 il servizio è offerto Italia, offerto su una generica MAN OPM. I clienti
definendo su OPM una specifica VLAN su cui dell’OLO sono attestati su un DSLAM Telecom
instradare il traffico relativo alla VPN del cliente. Italia ed il PoP dell’OLO è connesso alla MAN
Tutte le sedi del cliente facenti parte della VPN OPM mediante un apparato, di proprietà e compe-
sono attestate sulla medesima VLAN. La rete di tenza gestionale Telecom Italia, denominato “Kit di
Telecom Italia non entra nel merito degli indirizzi IP consegna” (KdC), installato presso la sede del PoP
degli apparati cliente il cui piano di indirizzamento OLO. I pacchetti generati dai clienti OLO sono
può essere quindi del tutto autonomo. incapsulati dal DSLAM su VLAN dedicate, univo-
Nel caso di VPN a livello 3 il servizio è offerto che per DSLAM e per OLO, instradate dalla rete
attraverso l’uso di apparati di livello 3 (router) posti OPM verso l’apparato KdC. Il KdC effettua fun-
nei PoP della rete OPM denominati
PE (Provider Edge). Ciascuna sede
cliente facente parte della VPN è
connessa ad un PE attraverso una
connessione Ethernet (VLAN), tra
tutti i PE coinvolti è quindi configu-
10 GE
rata una VPN IP/MPLS attraverso il PoP OLO X
PoP OLO Y
backbone OPB che garantisce i Nodo Feeder VLAN
collegamenti tra i PE posti nei vari VLAN y1
Cisco 7609 x1 x2 x3
PoP. Gli indirizzamenti IP degli GE GE
apparati del cliente possono GE GE
VLAN y1
VLAN x2
VLAN x3 OLO X GE
OLO Y VLAN x1 GE
essere anche in questo caso decisi
autonomamente dai clienti stessi,
sebbene le relative subnet devono
essere annunciate ai PE di clienti clienti clienti clienti
OLO X OLO Y OLO X OLO Y
Telecom Italia utilizzando il proto-
collo di tipo BGP.
VLAN x1 VLAN y1 VLAN x2 VLAN x3
GE = Gigabit Ethernet
1.3 Servizi Bitstream OLO = Other Licensed Operator
PoP = Point of Presence
VLAN = Virtual LAN
La necessità di creare nel mer-
cato delle telecomunicazioni un
regime di concorrenza tra i diversi FIGURA 3› Servizio Bitstream con raccolta del traffico OLO su DSLAM di Telecom Italia.
operatori presenti sul territorio
NOTIZIARIO TECNICO TELECOM ITALIA › Anno 17 n. 2 - Agosto 2008 5OPM 10-07-2008 9:15 Pagina 6
BIANCHETTI › PICCIANO › VENUTO • NGN2: la parte Metro
zioni di controllo del rispetto dei parametri di traf- il rapporto tra overhead e traffico diminuisce
fico contrattualizzati, attuando le funzionalità di fino a circa il 6%, concatenando 10 celle su una
“policing” in caso di traffico eccedente i valori sta- trama Ethernet. Sulla rete OPM si utilizza la fun-
biliti. Il trasporto su rete OPM è effettuato con zionalità di cell concatenation per i PVC ATM
algoritmi e protocolli di tipo L2 ethernet. provenienti dai Nodi B che trasportano traffico
La connettività punto-punto tra il DSLAM ed il per navigazione internet da terminali radiomobili
KdC rende compatibile questo servizio, analoga- UMTS-HSDPA.
mente al traffico voce ed internet verso i BRAS
descritto nel par. 1.1, con il trasporto Ethernet over 1.4.1 Sincronizzazione
MPLS; su nuove installazioni di DSLAM su MAN
NGN2 sarà probabilmente in futuro utilizzato que- L’apparato Gateway A, oltre a svolgere le fun-
sto tipo di trasporto. zioni di mapping e demapping del traffico ATM su e
da trame Ethernet, fornisce ai Nodi B della rete
1.4 Servizio di backhauling del traffico da rete mobile
Telecom Italia è stato uno dei primi operatori
ad utilizzare un’architettura di trasporto del traf- RNC
fico UMTS utilizzando un’infrastruttura di rete STM-1
Ethernet quale è OPM. Gateway B
La soluzione adottata, (figura 4), si basa sul
trasporto di flussi di traffico ATM della rete
U T R A N - U M T S Te r r e s t r i a l R a d i o A c c e s s GBE
Network - (tra i Nodi B e RNC) mediante due
apparati denominati “Gateway A” e “Gateway B”
che effettuano le funzionalità necessarie di inter- METRO
lavoro tra i protocolli ATM e Ethernet.
In particolare i suddetti due apparati
Gateway svolgono la funzione di mappaggio
delle celle ATM su trame Ethernet, utilizzando 10 GBE
pseudowire MPLS (PWE3) per l’incapsulamento
ATM over Ether net come previsto nel docu- FEEDER
mento (IETF RFC4717). La MAN OPM trasporta
il traffico proveniente dai Gateway, utilizzando GBE
esclusivamente protocolli e tecniche di swit- Gateway A
ching tipo Ethernet ed è totalmente trasparente
alla segnalazione utilizzata per instaurare il tun-
nel MPLS utilizzato per il trasporto degli pseu- Nodo B
ATM IMA MxE1
HSDPA
dowire.
Gli apparati Gateway attualmente installati ATM = Asynchronous Transfer Mode
consentono di mappare una o più celle ATM su HDSPA = High Speed Downlink Packet Access
IMA = Inverse Multiplexing for ATM
una trama Ethernet. Il mappaggio di una cella RNC = Radio Network Controller
per trama è particolarmente indicato per tutte le STM = Synchronous Transfer Mode
componenti del flusso dati UMTS particolar-
mente sensibili alle variazioni di latenza, in que-
FIGURA 4› BackHauling UMTS/HSDPA.
sto caso infatti la cella ATM è incapsulata su
uno pseudowire, imbustata su una trama
Ethernet e quindi trasmessa. Questa metodolo-
gia presenta però lo svantaggio di disottimizzare UMTS/HSDPA il clock necessario alla sincronizza-
l’utilizzo dei mezzi trasmissivi, in quanto per il zione della cella. La sincronizzazione di tutte le
trasporto di una singola cella ATM (53 bytes) si celle con un clock affidabile e preciso, di qualità
trasmettono sui link 86 bytes. Volendo dare una conforme agli standard utilizzati per la sincronizza-
stima numerica approssimativa del rapporto tra zione delle reti SDH, è di fondamentale importanza
overhead e payload, si può dire che questo per la gestione delle comunicazioni radiomobili:
metodo presenta un rapporto overhead/traffico errori sul clock di pochissime parti per milione
totale pari a circa il 39% 1 . L’utilizzo della funzio- impediscono ai terminali di comunicare corretta-
nalità di cell concatenation consente di mappare mente e di portare a termine le procedure di mobi-
n celle ATM su un'unica trama Ethernet, per cui lità tra diverse celle. Ciascun Gateway A è con-
nesso ad una sorgente di clock a 2048 kHz, nor-
(1) malmente si connette l’ingresso di sincronismo
In realtà il calcolo effettivo di tale numero varia in funzione dell’apparato all’uscita del segnale di sincronismo
del fatto che l’overhead ATM (5 bytes) sia trasmesso intera- di un ADM SDH o, meglio, di un SASE di centrale. I
mente, parzialmente o non sia trasmesso. Ciò dipende dalla flussi E1 in uscita dal Gateway A sono quindi gene-
trasmissione su uno stesso pseudowire di celle aventi tutte lo rati localmente sul Gateway A in base al clock pro-
stesso identificativo di VP/VC o con stesso VP e diverso VC. veniente da una rete sincrona e, di conseguenza,
6 NOTIZIARIO TECNICO TELECOM ITALIA › Anno 17 n. 2 - Agosto 2008OPM 10-07-2008 9:15 Pagina 7
BIANCHETTI › PICCIANO › VENUTO • NGN2: la parte Metro
presentano la qualità richiesta. Come si vedrà nel determinare lo scarto di pacchetti e quindi la per-
seguito dell’articolo, i Nodi B con uscite in Gigabit dita di traffico. Allo scopo di proteggere in questi
Ethernet, non avendo alcuna connessione E1 da casi il traffico maggiormente pregiato, è necessa-
cui prelevare il sincronismo, devono risolvere il pro- rio che gli apparati siano in grado di classificare il
blema della sincronizzazione utilizzando soluzioni traffico, ossia distinguere i vari flussi in base ai
alternative. servizi trasportati, e decidere di conseguenza a
quali di questi dare una maggiore priorità di inoltro
1.5 Gestione della Quality of Service (QoS) e per quali procedere con lo scarto in caso di con-
gestione di un link. Sulle reti in tecnologia Ethernet
La rete OPM, come descritto nei precedenti il traffico è classificato in base al valore dei 3 bit
paragrafi, trasporta traffico generato da applica- del campo user priority (IEEE 802.1p), del campo
zioni tra loro molto diverse, in particolare: Tag Control Information (IEEE 802.1Q) di seguito
• navigazione internet (Alice) da DSLAM IP; definiti con il nome di COS (Class Of Service). Una
• video diffusivo (multicast) IPTV; possibile strategia di classificazione del traffico è
• video “On Demand” (unicast); quella di assegnare ai servizi trasportati valori di
• traffico da rete UMTS-HSDPA; COS (Class Of Service) crescente al crescere del-
• servizi di connessione dati per clientela SOHO l’importanza del traffico. Una volta assegnato il
(Small Office Home Office) con accesso da relativo COS ai diversi tipi di flussi dati in transito,
DSLAM IP; è necessario che gli apparati applichino sulle
• s e rvizi di c onne ssione da ti per cl i en tel a i n t e r f a c c e d i re t e l e n e c e s s a r i e p o l i t i c h e d i
Business Corporate con accesso GbE tramite gestione del traffico.
terminazione dedicata (TIR);
• traffico Voce;
• servizi Wholesale. 3. Evoluzione della rete OPM
Come è possibile immaginare, i servizi elencati
sono tra loro estremamente diversi per quanto La rete OPM è la rete di raccolta ed aggrega-
riguarda i requisiti fondamentali per il trasporto zione di Telecom Italia, su cui, in prospettiva, con-
ossia: vergeranno tutti i servizi offerti dall’Azienda. Allo
• ampiezza di banda; scopo quindi di soddisfare i diversi requisiti di tra-
• variazioni del tempo di latenza tra i vari pac- sporto legati ai differenti servizi che nel prossimo
chetti (jitter); futuro saranno offerti alla clientela, la rete OPM
• perdita media di pacchetti (Packet loss). subirà un’evoluzione progressiva che ne consen-
Allo scopo di garantire requisiti di trasporto tirà di superare gli attuali limiti e potenziare le pro-
soddisfacenti per i diversi servizi si adottano due prie caratteristiche di scalabilità, flessibilità e affi-
principali strategie: dabilità.
• continuo monitoraggio della quantità di traffico Nel seguito si evidenziano le maggiori sfide fun-
che attraversa ciascun link della rete OPM allo zionali e tecnologiche che OPM dovrà sostenere.
scopo di effettuare i necessari ampliamenti di
rete prima che si verifichino condizioni di con- 3.1 I limiti dell’attuale architettura di OPM
gestione;
• trattamento differenziato del traffico apparte- Con il progressivo dispiegamento della nuova
nente ai diversi servizi con diversi valori di prio- rete di accesso di Telecom Italia, NGN2, le aree
rità di forwarding all’interno di tutti gli apparati metro di OPM, specialmente quelle di Roma e
della rete OPM. Milano, dovranno raccogliere ed aggregare un gran
Il monitoraggio continuo del grado di occupa- numero di accessi in multi tecnologia, dalle solu-
zione di tutti i collegamenti della rete OPM garanti- zioni FTTx di NGN2 a quelle dei DSLAM IP. Questi
sce che le situazioni di congestione in rete si pos- accessi dovranno essere trasportati selettivamente
sano verificare con una probabilità estremamente da OPM verso gli apparati di Edge IP di Telecom
ridotta. Qualora questa eventualità debba verifi- Italia stessa, cioè verso gli apparati PE (Provider
carsi, il trattamento differenziato del traffico assi- Edge), RA (Router di Accesso), BRAS, … , per i
cura che i servizi più pregiati non risentano della propri clienti o verso il dominio di rete degli
situazione di congestione e che gli apparati prov- OLO/SP (Other Licensed Operator/Ser vice
vedano a scartare esclusivamente traffico di più Provider). Si evidenziano quindi due principali punti
bassa priorità. di attenzione in merito alle soluzioni di rete e alle
funzionalità rese disponibili dalla tecnologia, uno
relativo alla QoS e l’altro relativo alla scalabilità dei
2. Possibili meccanismi di gestione della priorità servizi punto-punto.
in reti Ethernet La condivisione di una medesima infrastruttura
di rete tra più SP (Service Provider) e tra servizi
Il monitoraggio della banda impegnata sui link aventi differenti requisiti di QoS richiede la disponi-
trasmissivi non è in grado di garantire che in casi bilità di soluzioni evolute di QoS con elevata selet-
particolari di aumento improvviso del traffico in tività e scalabilità. Livelli di selettività crescenti
uscita ad una data interfaccia di rete non si verifi- consentono di passare dalla “semplice” differenzia-
chino situazioni di congestione che potrebbero zione della priorità di trattamento dei diversi servizi
NOTIZIARIO TECNICO TELECOM ITALIA › Anno 17 n. 2 - Agosto 2008 7OPM 14-07-2008 8:31 Pagina 8
BIANCHETTI › PICCIANO › VENUTO • NGN2: la parte Metro
(voce, video e dati) alla selettività
per SP fino alla gestione selettiva
della QoS tra le differenti classi o
HE
tra i flussi dei clienti del SP stesso. OPB BTV
IP/MPLS BB
Livelli di maggiore selettività sulla
IP Edge
QoS richiedono un’adeguata sca-
labilità delle funzionalità di tratta- VOD
3G/4G Mobile
Backbone
mento differenziato del traffico Core Network
(marking, scheduling, policing,
shaping). Senza spingersi a livelli GTWB
Metro/Regional OPM
troppo specialistici, sono richiesti
Regional Area Enhanced
meccanismi per differenziare il DWDM
Delivery Kit
traffico trasportato in rete e per- Basic
10GbE
Delivery Kit
metterne un diverso trattamento in OLO b OLO a
GbE
termini prestazionali, adeguato alle CWDM
differenti esigenze di connettività
Bth GbE
richieste dai servizi finali. GbE
Passando ai requisiti di scalabi- GTWA NGN2 Access
lità per i servizi unicast (punto- FTTE/ GPON
ATM FTTCab FTTB/FTTCab
punto), la numerosità degli accessi UMTS/ IMA nxE1
HSxPA FTTH
NGN2 e le articolate situazioni di xDSL
VDSL2
raccolta a livello di Edge IP per gli Access BUSINESS
OLO possono portare rapidamente Residential
in crisi il “budget” di VLAN-ID Triple Play Residential
Triple Play
gestibili a livello di area metro
(circa 4000 VLAN ID configurabili ATM = Asynchronous Transfer Mode HSxPA = High Speed x Packet Access
come dallo standard IEEE 802.1Q). BTV = Broadcast TeleVision MPLS = MultiProtocol Label Switching
CWDM = Coarse Wavelength Division Multiplexer NGN2 = Next Generation Network 2
Anche soluzioni di tipo Stacked DWDM = Dense Wavelength Division Multiplexer OLO = Other Licensed Operator
VLAN previste dallo standard IEEE FTTB = Fiber To The Building OPB = Optical Packet Backbone
FTTCab = Fiber To The Cabinet OPM = Optical Packet Metro
802.1ad (QinQ) non risolvono il FTTE = Fiber To The Enclosure VDSL = Very high bit-rate Digital Subscriber
problema. La soluzione adottata GbE = Gigabit Ethernet Line
GPON = Gigabit Passive Optical Networks VOD = Video On Demand
da Telecom Italia per i servizi di HE = Head End UMTS = Universal Mobile Telecommunications
connettività punto-punto prevede System
l’incapsulamento delle trame
Ethernet in MPLS (EoMPLS, frutto
FIGURA 5› Architettura di rete OPM2.
degli standard IETF dei gruppi di
lavoro Pseudo-wire Emulation
Edge-to-Edge, PWE3).
Il ricorso ad EoMPLS e quindi, in estrema sin- 3.2.1 La scelta del modello di servizio
tesi, alle funzionalità di MPLS, oltre che risolvere
la criticità sulla scalabilità del numero della VLAN, Uno degli snodi decisionali più importanti per
potrà abilitare, in futuro, altre interessanti funzio- l’ingegnerizzazione di OPM2 è stato quello della
nalità proprie della suite di protocolli MPLS quali il scelta del modello di servizio.
Fast ReRouting (FRR), per ridurre i tempi di ripri- Telecom Italia ha optato per un modello di ser-
stino in caso di guasto, ed il Traffic Engineering vizio multilayer su tecnologie mature e supportate
(TE) per ripartire in maniera controllata il traffico dai principali costruttori. Il modello di servizio pre-
tra i link. vederà l’adozione di soluzioni:
• EoMPLS2 per servizi punto-punto;
3.2 OPM2 • L2 o VPLS per servizi any-to-any;
• IP per servizi Video.
I limiti della rete OPM evidenziati nel paragrafo pre- La scelta non è stata banale, in quanto molto
cedente saranno superati grazie ad un’evoluzione vincolante in termini di flessibilità tecnologie, costi,
strutturale e funzionale della rete di raccolta ed capacità di aggregazione e trasporto di tutti i ser-
aggregazione metropolitana. Il primo passo è stato vizi offerti da Telecom Italia.
quello di definire il modello di servizio e le soluzioni Nel modello di servizio adottato da Telecom
di rete per le varie classi di servizi veicolati sull’e- Italia, l’elemento più importante è l’adozione di
voluzione di OPM, convenzionalmente nota come MPLS. L’introduzione di MPLS, infatti, vincolerà la
OPM2 (figura 5). Tale evoluzione si caratterizza, da futura evoluzione di OPM2 verso questa suite di
un punto di vista strutturale, per una maggiore protocolli. Maturità e supporto di MPLS, sia a
capillarità di copertura geografica e, da un punto di livello di costruttori che di standard, giustificano
vista funzionale, principalmente dall’introduzione di
soluzioni EoMPLS, una gestione semplificata degli (2)
identificativi VLAN e dall’attivazione di soluzioni di Sui vantaggi portati dall’evoluzione di EoMPLS (scalabilità
QoS evolute. VLAN_ID, FRR, TE guasti) si veda il par. 3.4).
8 NOTIZIARIO TECNICO TELECOM ITALIA › Anno 17 n. 2 - Agosto 2008OPM 14-07-2008 8:31 Pagina 9
BIANCHETTI › PICCIANO › VENUTO • NGN2: la parte Metro
questo orientamento che capitalizza anche la note- Feeder minimizza l’impatto sull’utenza di un ipo-
vole esperienza acquisita in Telecom Italia sul tetico guasto di apparato: concentrare sui Feeder
backbone OPB, dove sono state pionieristicamente l’incremento di accessi attesi in ambito NGN2,
introdotte diverse soluzioni basate su MPLS, per il porterebbe a situazioni potenzialmente perico-
trasporto della voce sul backbone IP (MPLS-TE e lose, come numero di clienti impattati, in caso di
FRR link protection). guasto di nodo, evento poco probabile seppur
Le alternative all’adozione di tecniche MPLS non impossibile.
maggiormente previste dagli operatori nel resto del Ultimo vantaggio conseguito con l’introduzione
mondo e quindi analizzate anche da Telecom Italia dei Remote-Feeder è quello di una maggiore spe-
sono state: cializzazione delle macchine: i Feeder possono
• Stacked VLAN (QinQ): prevede l’utilizzo di una essere prevalentemente dedicati a funzioni di
doppia etichetta di identificazione delle VLAN. transito verso l’Edge IP, mentre sui Remote-
Questa tecnica ha il vantaggio di superare il Feeder, aventi il ruolo di aggregazione dell’ac-
limite di circa 4000 VLAN configurabili per cia- cesso, possono essere concentrate le funziona-
scun apparato della rete, lasciando la gestione lità, e relative schede, di aggregazione e gestione
del traffico governata da protocolli semplici selettiva dei servizi.
tipici delle reti Ethernet;
• T-MPLS: è un derivato dell’MPLS, non usa le 3.4 Vantaggi offerti dall’utilizzo di EoMPLS
funzionalità di livello 3 IP, eliminando tutti gli
elementi di rete necessari al trasporto del traf- EoMPLS è una soluzione di incapsulamento di
fico IP di segnalazione e migliorando i processi trame di livello 2, in particolare Ethernet, su un
di OAM; circuito virtuale (Virtual Circuit, VC), altrimenti
• PBB/PBB-TE: è un sottoinsieme della racco- detto PseudoWire (PW), gestito dal piano di con-
mandazione IEEE Provider Backbone Bridging trollo MPLS, come mostra la figura 7. Quando una
(802.1ah) Trasforma le reti Ethernet, per propria trama Ethernet arriva all’interfaccia logica origine
natura connectionless, in reti di trasporto dello PW viene incapsulata e trasportata all’in-
Ethernet connection oriented , creando delle terno dello PW fino all’interfaccia logica destina-
connessioni Ethernet virtuali punto-punto, di zione o di terminazione dello PW. La soluzione è
backbone. u n a p a r t i c o l a re i s t a n z a d e l l o s t a n d a rd I E T F
Pseudo Wire Emulation Edge-to-edge (PWE3,
3.3 Ampliamento della copertura tramite R-Feeder RFC 4448: Ethernet over MPLS).
L’ i n c r e m e n t o d e l n u m e r o d e g l i
accessi attesi in ambito NGN2 detterà PE/RA BB-NAS
Business
l’evoluzione architetturale delle reti Residential
OPM con la relativa espansione verso
la periferia della rete d’accesso.
Saranno remotizzate ulteriormente le
funzioni di concentrazione del traffico, GE GE
con l’aggiunta di un ulteriore livello di
L2/L3 switching collegato al livello Metro Metro
Feeder attuale; ciò si tradurrà in una
10 GE
maggior capillarità di OPM tale da
accrescer ne la copertura geografica
per mezzo di apparati più vicini ai Feeder Feeder
clienti.
L a soluzione sc e lta pre ve derà di GE GE
aggregare il traffico locale raccolto in una
determinata centrale tramite un apparato
Mini-Feeder
di concentrazione remota (Remote-
Feeder) installato nella stessa centrale e
collegato al Feeder di riferimento. Tale
soluzione risulterà globalmente più van- CPE
CPE
taggiosa di quella con trasporto tramite Mini-DSLAM
rete SDH o WDM del traffico, proveniente CPE Residential
dalle varie sorgenti presenti nell’area di Business customers ADSL2+
customers ADSL2+ CPE
raccolta della centrale, direttamente al
Feeder di riferimento. BB = BroadBand
CPE = Customer Premises Equipment
Come mostrato in figura 6 i Remote- DSLAM = Digital Subscriber Line Access Multiplexer
GE = GigabitEthernet
Feeder saranno attestati in doppio allo NAS = Network Access Server
strato gerarchico superiore.
Oltre a garantire la migliore soluzione
economica per accrescere la capillarità FIGURA 6› Introduzione dei R-Feeder.
di OPM, l’inserimento dei Remote-
NOTIZIARIO TECNICO TELECOM ITALIA › Anno 17 n. 2 - Agosto 2008 9OPM 10-07-2008 9:15 Pagina 10
BIANCHETTI › PICCIANO › VENUTO • NGN2: la parte Metro
• introdurre funzionalità di Traffic
Engineering (MPLS-TE) per distri-
buire in maniera controllata il traf-
VLAN PW MPLS-LSP fico tra i link;
• migliorare le possibilità di dia-
gnosi dei guasti e supervisione
(segnalazioni sullo stato degli
pseudowire).
MPLS LSP MPLS LSP
PW PW 3.5 Evoluzione delle funzionalità
802.1q 802.1q 802.1q 802.1q di QoS
ETH ETH ETH ETH ETH ETH È attualmente allo studio l’op-
portunità di far evolvere le funziona-
lità di gestione della qualità del ser-
10 GbE
vizio utilizzate nelle MAN OPM
GE GE attraverso meccanismi di QoS
gerarchica (Hierarchical QoS, H-
LSP-MPLS
QoS). Questi meccanismi possono
PW
essere implementati utilizzando HW
di nuova generazione in grado di
VLAN garantire un significativo incremento
del numero di code disponibili sulle
GbE = Gigabit Ethernet VLAN = Virtual LAN
porte di uscita degli apparati, anche
PW = PseudoWire ETH = Ethernet diverse migliaia, e funzionalità di
LSP = Label Switched Path MPLS = MultiProtocol Label Switching
accodamento gestite in HW.
Un possibile miglioramento della
FIGURA 7› Pila protocollare di EoMPLS. gestione della QoS può essere
offerto dall’introduzione di ulteriori
livelli di scheduling in corrispondenza
delle interfacce di uscita degli appa-
Uno PW Ethernet è quindi lo strumento per il rati, e quindi di meccanismi noti con il termine “QoS
trasporto di trame Ethernet/802.3 su una rete gerarchica” (figura 8 nel caso di soli 2 livelli di schedu-
MPLS. Lo PW consente ai Service Provider di emu- ling). Ad esempio con questi meccanismi le trame pos-
lare l’offerta di servizi Ethernet, tipicamente di tipo sono essere classificate (e quindi accodate) non più
pto-pto, su una rete MPLS. esclusivamente in base al valore di COS, bensì anche
La principale ed immediata giustificazione del- in base ad altri parametri, per esempio il VLAN ID. Nel
l’introduzione di EoMPLS sta proprio nella possibi- caso descritto in figura 8 sono presenti, in corrispon-
lità di superare i limiti di scalabilità in termini di denza all’interfaccia di uscita, due livelli di scheduling:
numero di VLAN gestibili in ogni istanza di OPM. il livello superiore (child) potrebbe ad esempio consen-
Una stima della penetrazione dei servizi raccolti da tire di differenziare il trattamento dei flussi con diverso
OPM nel prossimo futuro porta a ipotizzare un valore di COS nell’ambito della stessa VLAN, mentre il
numero di VLAN ID necessari nell’ordine delle livello inferiore (parent) potrebbe poi differenziare il trat-
decine di migliaia, sicuramente non gestibili, utiliz- tamento del traffico appartenente alle diverse VLAN.
zando protocolli basati esclusivamente su swit-
ching Ethernet IEEE 802.1Q (limite di circa 4000
VLAN ID). La tecnologia PW offre tipicamente solu-
zioni in grado di gestire decine di migliaia di PW
per scheda e, dato che il mapping VLAN-PW è 1 a
1, si riesce a gestire un equivalente numero di
VLAN ID per scheda. Un ulteriore margine in ter-
W2,1
mini di scalabilità è dato dalla funzionalità di “VLAN
W2,2
W2,1
W1,1
W1,2
W2,2
Local significance”, che consente l’utilizzo del
medesimo identificativo di VLAN su porte differenti CHILD LEVEL
della stessa scheda.
Oltre al superamento dei limiti di scalabilità, l’in- W2
troduzione di EoMPLS, potrà consentire a Telecom W1
Italia, in futuro, di capitalizzare le funzionalità Wk PARENT LEVEL
offerte dalla suite di protocolli MPLS per: Wx,y = queue Weight
• introdurre funzionalità di FRR per ridurre i tempi
di recovery a seguito di guasto. Dalle protezioni
assicurate dalla famiglia di protocolli STP
(ordine di secondi), con l’introduzione delle tec- FIGURA 8› QoS gerarchica.
nologie di FRR si tende ai 50 ms;
10 NOTIZIARIO TECNICO TELECOM ITALIA › Anno 17 n. 2 - Agosto 2008OPM 10-07-2008 9:15 Pagina 11
BIANCHETTI › PICCIANO › VENUTO • NGN2: la parte Metro
I nuovi apparati oggi disponibili sul mercato Per poter separare le componenti di traffico dati
consentono di definire diversi livelli di scheduling è necessario installare presso la sede del nodo B
(fino a 5 o oltre) e quindi di effettuare potenzial- un apparato, denominato Minigateway A che
mente una classificazione molto fine dei flussi fino separa i PVC dati e li incapsula in MPLS, facendo
all’ipotetica gestione differenziata dei singoli flussi transitare le relative connessioni su collegamenti
cliente. Chiaramente maggiore è la granularità di ADSL2+ attestati su un DSLAM IP e terminati sul
differenziazione dei flussi, maggiore risulta la com- gateway B. I PVC che trasportano il resto del traf-
plessità gestionale della rete e dei servizi. fico sono instradati dal Minigateway A verso un
Gateway A su collegamenti ATM-IMA-E1 nella
modalità “tradizionale”.
4. Backhauling UMTS: evoluzione Il trasporto dati su ADSL2+ consente di aumen-
tare la banda in downlink sul singolo doppino in
La diffusione dei servizi HSDPA (High Speed rame fino a 20 Mbit/s e fino ad 1 Mbit/s in uplink.
Downlinik Packet Access) e HSUPA (High Speed L’utilizzo dell’ADSL2+ si adatta bene ad un tipo di
Uplink Packet Access) richiede la necessità di trasmissione dati prevalentemente asimmetrico
garantire una sempre maggiore banda ai clienti come la navigazione Internet e consente di sfrut-
connessi alla rete 3G tramite terminali di accesso tare in maniera molto efficiente la capacità di tra-
mobili. Analogamente, reti mobili di 4 a genera- sporto del portante in rame. Come visibile in figura
zione punteranno sempre più sull’offerta di una 9, inoltre, le tratte ADSL2+ sono ridondate ed il
crescente disponibilità banda. Sarà pertanto protocollo di segnalazione RSVP, utilizzato per la
necessario incrementare significativamente la segnalazione dei tunnel MPLS tra il Minigateway A
banda dei collegamenti di raccolta (backhauling) ed il Gateway B, consente di reinstradare i flussi
dei siti radiomobili verso la rete Core, prevedendo dati in caso di guasto su uno dei due link. Questa
soluzioni architetturali diverse da quelle adottate soluzione consente, quindi, di incrementare la
attualmente. banda a disposizione del nodo B fino a 35-40
Le possibili alternative attualmente allo studio Mbit/s in downlink, sacrificando però la banda in
prevedono collegamenti di raccolta dei siti radio- uplink (max 2 Mbit/s) e quindi i servizi di tipo
mobili realizzati mediante: HSUPA. Il pregio principale di questa soluzione
• collegamenti in fibra ottica; consiste nella sua economicità in quanto non
• c o lle ga m e nti c he sfrutta no l a tecn o l o g i a richiede, nella maggior parte dei casi, installazione
ADSL2+; di nuovi portanti in rame o fibra ottica fino al sito
• collegamenti che sfruttano la tecnologia VDSL2 radiomobile.
o GPON.
4.2 Backhauling in dei Nodi B in fibra ottica
4.1 Trasporto dati su linee ADSL2+
I costruttori di reti radiomobili stanno mettendo
Una prima, parziale, evoluzione del modello di a punto soluzioni di trasporto delle informazioni tra
trasporto UMTS-HSDPA attualmente in uso in Nodi B e RNC non più basate su ATM. I limiti di
Telecom Italia consiste nella separazione logica e scalabilità delle reti ATM, le difficoltà di operare
fisica dei PVC ATM, che trasportano i dati relativi incrementi di banda su reti di accesso in rame e la
alla navigazione Internet da terminale (tipicamente necessità di utilizzare apparati Gateway di interla-
traffico HSDPA) dal resto dei PVC, che trasportano voro tra il mondo ATM e quello IP/Ethernet hanno
la voce. Una esemplificazione di questo modello è indotto gli operatori ed i costruttori di apparati a
presente in figura 9. rendere disponibili apparati di rete radiomobile,
Nodi B e RNC, dotati di
interfacce Ethernet e proto-
Traffico HSDPA colli IP per il trasporto del
eventualmente
anche HSUPA/A-DCH* Mode METRO traffico. I vantaggi introdotti
DSLAM
F m 10 GE
sono rappresentati dalla
Mini G
NxE1 GTW A ADSL GE GTW disponibilità di interfacce in
IMA copper grado di gestire collega-
Metro/Feeder
2xE GTW STM-1 menti con banda decisa-
1
copper RNC mente più elevata (teorica-
Traffico voce, SHDSL GE mente fino a 100 Mbit/s), la
videochiamata, dati R99, 10 GE
segnalazione, O&M, eventualmente semplificazione delle reti
HSUPA/A-DCH su architettura tradizionale grazie all’eliminazione dei
A-DCH = Associated Dedicated CHannel HSUPA = High Speed Uplink Packet Access protocolli ATM e quindi dei
ADSL = Asymmetric Digital Subscriber Line IMA = Inverse Multiplexing for ATM relativi apparati, migliore
DSLAM = Digital Subscriber Line Access RNC = Radio Network Controller
Multiplexer SHDSL = Symmetrical Highspeed DSL affidabilità delle tratte in
GE = Gigabit Ethernet STM = Synchronous Transfer Mode accesso dai Nodi B alla rete
GTW = GateWay
dovuta alle caratteristiche
qualitative delle trasmissioni
FIGURA 9› Trasporto su ADSL del traffico dati. ottiche. L’introduzione delle
reti UMTS “Full IP” obbliga
NOTIZIARIO TECNICO TELECOM ITALIA › Anno 17 n. 2 - Agosto 2008 11OPM 10-07-2008 9:15 Pagina 12
BIANCHETTI › PICCIANO › VENUTO • NGN2: la parte Metro
gli operatori a riprogettare interamente le
reti di backhauling, ridefinire i modelli di
servizio e le architetture di rete. Telecom NodeB
Italia ha da tempo avviato un progetto
Remote
pilota di rete UMTS Full IP.L’architettura GE Feeder METRO
della rete di backhauling è rappresentata
10 GE
in figura 10. Fibra nuda GE GE
10GE
A diffe re nza de lla soluzion e di
backhauling di Nodi B in tecnologia ATM Sede SGU 10GE
OPM
RNC
non sono presenti flussi PDH E1 dai quali
il nodo B possa prelevare il clock a 2048 GE
GE = Gigabit Ethernet 10 GE
Khz necessario per sincronizzare il OPM = Optical Packet Metro
RNC = Radio Network Controller
segnale radio. Possono essere ipotizzate SGU = Stadio di Gruppo Urbano
le seguenti soluzioni:
• si porta comunque un flusso E1 in
rame al nodo B con l’unico scopo di
FIGURA 10› BackHauling Nodi B con interfaccia ottica.
trasportare il segnale di sincronismo.
Questa soluzione, pur essendo effi-
cace, obbliga il mantenimento della
tratta E1 in doppino, dei modem SHDSL e di presente nel cabinet e i modem VDSL2 installati
tutta l’operatività necessaria alla loro realizza- presso i Nodi B.
zione e manutenzione, di conseguenza non è
ritenuta la migliore;
• il segnale di sincronismo potrebbe essere rica- 5. Cenni sulle funzionalità di Video Admission
vato da sistemi radio tipo GPS. Questa solu- Control
zione pur essendo tecnicamente fattibile è di
difficile realizzazione pratica ed aggiunge l’ope- Uno dei dilemmi ricorrenti nella fase di proget-
ratività ed i rischi di malfunzionamento della tazione della rete è rappresentato dalla defini-
parte delegata al recupero del segnale GPS; zione dell’opportuno dimensionamento dei singoli
• il clock dei Nodi B è agganciato a quello collegamenti tra apparati della rete OPM, suffi-
dell’RNC a sua volta connesso ad un segnale di ciente a salvaguardare la rete da fenomeni di con-
riferimento. La sincronizzazione dei clock dei gestione. Le soluzioni che si possono adottare in
Nodi B avviene mediante segnalazione in banda questi casi vanno dal sovradimensionamento
sui link Ethernet tramite l’uso di protocolli pro- della capacità dei link rispetto al traffico di picco
prietari o standard. Quest’ultima rappresenta cer- stimato (garantendo opportuni margini), all’intro-
tamente la soluzione più conveniente dal punto di duzione in rete di meccanismi di controllo degli
vista tecnico in quanto non richiede l’installazione accessi ai servizi. Nel caso di trasporto su OPM
e la manutenzione di apparati accessori. prevalentemente di servizi voce o dati (internet e
servizi business) la gestione di una congestione di
4.3 Backhauling dei Nodi B con soluzioni VDSL2 qualche link può facilmente essere risolta attra-
al Cabinet verso i meccanismi di accodamento differenziato
del traffico (in base alla priorità). Nel caso in cui il
La soluzione con il trasporto da nodo B a rete traffico relativo ai servizi video dovesse invece
OPM, effettuato con l’architettura descritta in figura diventare preponderante nella rete OPM, i mecca-
11, è concettualmente analoga a quella con nodo B nismi di accodamento differenziato (eventual-
connesso direttamente in GbE al Feeder.
In questo caso il nodo B genera traffico
su un interfaccia Ethernet elettrica invece
che su un’interfaccia ottica. L’interfaccia
Ethernet è attestata su un modem VDSL2
ed il traffico trasportato in rame fino NodeB
Eth Remote
all’ONU connesso al Feeder mediante Cabinet con
collegamento GbE. Un vantaggio di que- ONU VDSL2 Feeder METRO
VDSL2
sta soluzione è rappresentato dalla con- copper GE
10 GE
GE
centrazione di più Nodi B su una stessa 10 GE
Sede SL
porta GbE del Feeder, consentendo un 10 GE OPM
GE = Gigabit Ethernet RNC
migliore sfruttamento della banda. Un ONU = Optical Network Unit
Sede SGU
ulteriore vantaggio è rappresentato dalla OPM = Optical Packet Metro GE
RNC = Radio Network Controller
possibilità di utilizzare per la connessione SGU = Stadio di Gruppo Urbano
10 GE
all’ONU parte della rete di accesso in VDSL = Very high bit-rate Digital Subscriber Line
rame, evitando di realizzare i lavori neces-
sari per collegare in fibra ottica i Nodi B.
La soluzione ha come svantaggio la FIGURA 11› BackHauling Nodi B soluzione VDSL2 al Cabinet.
necessità di installare e mantenere l’ONU
12 NOTIZIARIO TECNICO TELECOM ITALIA › Anno 17 n. 2 - Agosto 2008OPM 10-07-2008 9:15 Pagina 13
BIANCHETTI › PICCIANO › VENUTO • NGN2: la parte Metro
mente anche di tipo gerarchico) potrebbero non della rete. Una possibile soluzione prevede il
risultare sufficienti. ricorso al protocollo di segnalazione RSVP, che
Nei casi in cui si dovessero verificare conge- consente di:
stioni dovute all’eccessiva richiesta di servizi video, • verificare la disponibilità di risorse di banda
sarebbe indispensabile ricorrere a meccanismi lungo i percorsi della rete OPM dalle piat-
selettivi di scarto di traffico relativi ai singoli flussi taforme di servizi video erogatrici degli stream
video richiesti dai clienti, ossia decidere di inter- sino ai nodi di attestazione dei ricevitori dei
rompere il servizio a pochi clienti, salvaguardando flussi (tipicamente Feeder e Remote-Feeder,
la qualità del servizio per la maggior parte di essi. attualmente con esclusione dei DSLAM IP, OLT);
In alternativa si potrebbe ricorrere a meccanismi in • “prenotare” le risorse con opportune riserva-
grado di prevenire la richiesta eccessiva di banda zioni di banda secondo le richieste contenute
per servizi video, realizzando funzionalità di con- nelle sessioni RSVP.
trollo degli accessi a tali servizi. In tal modo, ogni richiesta di admission control
Risulta quindi importante per gli operatori di per un dato flusso video è identificata da una
rete studiare la possibilità di introdurre funzionalità segnalazione RSVP veicolata lungo il medesimo
di Video Admission Control (VAC) che, sulla base percorso dei flussi dati.
dello stato di occupazione delle risorse di rete, Anche nella modalità On-Path occorre comun-
regolino l’accettazione di ogni nuova richiesta di que mantenere un legame con le piattaforme appli-
canali video. In caso di indisponibilità di banda, la cative di erogazione del servizio e ciò può essere
richiesta di fruizione del nuovo canale non è soddi- ottenuto attraverso opportuni meccanismi di inter-
sfatta; la funzionalità di VAC evita così che la con- faccia fra le piattaforme IPTV, sistemi centralizzati
gestione che si instaurerebbe, tentando di soddi- di AC e le funzioni RSVP in rete.
sfare anche la richiesta di servizio video aggiun-
tivo, generi una perdita di pacchetti che potrebbe 5.2 Admission Control Off-Path
degradare la qualità di servizio percepita da un ele-
vato numero di clienti. Nelle soluzioni VAC “Off-Path”, la verifica della
Telecom Italia segue da tempo la standardizza- disponibilità di risorse di rete e l’accettazione della
zione e gli sviluppi di soluzioni di Video Admission nuova richiesta sono demandate ad un piano di
Control che al momento appaiono più promettenti. controllo centralizzato, gestito secondo il modello
È possibile distinguere tra: TISPAN dalla funzione RACS, altresì responsabile
• Scenario Push, nel quale il VAC si basa su una del Policy Management (PM). Il RACS, con un
richiesta esplicita del livello applicativo alla opportuno dialogo con gli elementi di rete, costrui-
piattaforma di controllo; sce e mantiene aggiornato un modello di rete
• Scenario Pull, nel quale il VAC si basa sulla descrivente topologia e stato di occupazione delle
segnalazione di rete, che è intercettata dai nodi risorse, e utilizza questo database per verificare la
di rete e convogliata sulla piattaforma di con- disponibilità di risorse all’arrivo di richieste specifi-
trollo. che provenienti dalla funzione applicativa.
In entrambi gli scenari, inoltre, il meccanismo di Quando soluzioni di VAC saranno mature in ter-
VAC può essere classificato come: mini di standardizzazione ed implementazione tec-
• On-Path, se il piano di controllo è distribuito sui nologica e funzionali ai servizi offerti, l’operatore di
nodi di rete coinvolti nel passaggio dei flussi rete, attraverso esse, potrà garantirsi una maggiore
dati; efficienza rete a parità di qualità percepita dai
• Off-Path, se il piano di controllo è centralizzato clienti.
ed è basato sulle informazioni topologiche rac-
colte in rete. Tale soluzione, dunque, si basa su
una modellizzazione della rete, che deve risul- 6. Conclusioni
tare accurata, anche in termini di adattamento e
reazione ai guasti. In questo articolo sono state descritte architet-
Le fasi logiche del controllo, indipendentemente ture, protocolli e servizi disponibili sulla rete
dalla famiglia di soluzioni che lo implementa, sono: Optical Packet Metro e le relative evoluzioni previ-
• verifica della disponibilità di risorse di rete, pos- ste per lo scenario NGN2. Le sfide che NGN2 pone
sibilmente e2e, per l’accettazione di una nuova ad OPM, relativamente alla scalabilità della rete ed
richiesta video (accesso ad un canale broadcast alla capacità di gestire selettivamente i servizi
TV o ad un VoD); offerti, saranno adeguatamente governate con l’a-
• accettazione o meno della nuova richiesta in dozione di un modello di servizio multilayer e con
funzione dell’esito del passo precedente; l’introduzione di funzionalità evolute di QoS.
• segnalazione all’utenza del motivo dell’even-
tuale rifiuto (opzionale).
5.1 Admission Control On-Path
Nelle soluzioni VAC “On-Path”, l’acquisizione mario.bianchetti@telecomitalia.it
dello stato di impegno delle risorse di rete e il con- giovanni.picciano@telecomitalia.it
trollo delle stesse è demandato totalmente ai nodi luciano.venuto@telecomitalia.it
NOTIZIARIO TECNICO TELECOM ITALIA › Anno 17 n. 2 - Agosto 2008 13OPM 10-07-2008 9:15 Pagina 14
BIANCHETTI › PICCIANO › VENUTO • NGN2: la parte Metro
— ACRONIMI
AdC Area di Centrale STM Synchronous Transfer Mode
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line TE Traffic Engineering
ATM Asynchronous Transfer Mode UMTS Universal Mobile Telecommunications System
BRAS BroadBand Remote Access Server UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access
BTV Broadcast Television VAC Video Admission Control
CoS Class of Service VDSL Very high bit-rate Digital Subscriber Line
CoQ Class of Quality VLAN Virtual LAN
CPE Customer Premises Equipment VLAN-ID VLAN Identifier
CWDM Coarse Wavelength Division Multiplexer VPLS Virtual Private LAN Service
DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer VPN Virtual Private Network
DWDM Dense Wavelength Division Multiplexer VOD Video On Demand
EoMPLS Ethernet over MPLS WDM Wavelength Division Multiplexing
FTTB Fiber To The Building
FTTCab Fiber To The Cabinet
FTTE Fiber To The Enclosure
FRR Fast Re Routing
GPON Gigabit Passive Optical Networks
HSDPA High Speed Downlink Packet Access
HSUPA High Speed Uplink Packet Access
IETF Internet Engineering Task Force
M a r i o B i a n c h e t t i si è laureato in
IMA Inverse Multiplexing for ATM Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di
LAN Local Area Network Torino nel 1989. Nello stesso anno è entrato
in Azienda dove si è inizialmente occupato di
LSP Label Switched Path aspetti di progettazione e dimensionamento
MAN Metropolitan Area Network reti con particolare riguardo verso la tematica
MPLS MultiProtocol Label Switching di Network Traffic Management. Ha
partecipato alle attività di standardizzazione
MPLS-TE MPLS Traffic Engineering internazionale sulla tematica NTM,
NAS Network Access Server coordinando Study Group ITU e lavori in
ambito NMGD (Network Management Development Group). Dal
NGN2: Next Generation Network 2 2005 è responsabile del progetto di Innovazione della rete OPM
OLT Optical Line Termination di Telecom Italia.
OLO Other Licensed Operator
ONU Optical Network Unit
OPB Optical Packet Backbone G i o v a n n i P i c c i a n o si è laureato in
OPM Optical Packet Metro Ingegneria Elettronica presso l’Università La
NP Network Provider Sapienza di Roma, dove ha inizialmente
lavorato partecipando a progetti di ricerca per
PBB Provider Backbone Bridge la progettazione delle prime reti radiomobili di
PBB-TE PBB-Traffic Engineering terza generazione. Dal 1996 opera nell’area
Network della Direzione Generale di Telecom
PBT Provider Backbone Transport Italia dove fino al 2002 ha curato le attività di
PE Provider Edge industrializzazione dei sistemi di gestione per
PSTN Public Switched Telephone Network le reti di trasporto (SDH e WDM) e
successivamente ha coordinato le attività di industrializzazione
PW Pseudo Wire degli apparati per reti metropolitane e regionali in tecnologia
PWE3 PW Emulation Edge-to-Edge xWDM, Ethernet, IP e MPLS. Dal 2006 è responsabile della
funzione Wireline Access Engineering con il compito di assicurare
PIM-SSM Protocol Independent Multicast-Source Specific le attività di ingegnerizzazione della rete di accesso e di
Multicast aggregazione metro-regionale di Telecom Italia.
QoE Quality of Experience
QoS Quality of Service
RA Router d’Accesso L u c i a n o V e n u t o si è laureato in
RACS Resource and Admission Control System ingegneria elettonica presso l’università degli
studi di Pisa nel 1998. Dopo una prima
RFI Request For Information esperienza lavorativa presso ST
RNC Radio Network Controller Microelettronics quale ingegnere addetto alla
linea di produzione di transistor bipolari e MOS
RSVP Resource reSerVation Protocol di potenza, è stato assunto in Telecom Italia
SHDSL Symmetrical Highspeed DSL direzione rete Sud 2 nel cui ambito ha
ricoperto il ruolo di responsabile del gruppo
SLA Service Level Agreement System Administrator. Dal 2001 lavora presso i
SNMP Simple Network Management Protocol settori di ingegneria di rete dove si è occupato di
SP Service Provider industrializzazione di apparati SDH. Dal 2006 è inserito nel gruppo
di industrializzazione delle reti e servizi relativi alle reti OPM.
Attualmente sta seguendo i progetti di evoluzione di OPM in ottica
NGN2 e di “backhauling” della rete UMTS con accesso “Full IP”.
14 NOTIZIARIO TECNICO TELECOM ITALIA › Anno 17 n. 2 - Agosto 2008Puoi anche leggere