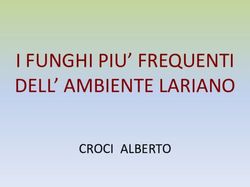MUSCARIA Etnografia di un fungo allucinogeno - Giorgio Samorini - Giorgio Samorini Network
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Giorgio Samorini
MUSCARIA
Etnografia di un fungo allucinogeno
Prefazione di Francesco FestiTitolo | Muscaria. Etnografia di un fungo allucinogeno Autore | Giorgio Samorini ISBN 979-12-20398-26-8 © 2022 Tutti i diritti riservati all'Autore Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta senza il preventivo assenso dell'Autore Youcanprint Via Marco Biagi 6 – 73100 Lecce www.youcanprint.it info@youcanprint.it
Indice Prefazione di Francesco Festi 1 Introduzione 3 Aspetti preliminari 7 Notizie generali sull'agarico muscario 7 Urina, renne e mosche 14 La “mortalizzazione” dell'Amanita muscaria 19 L'Amanita in Siberia Lo sciamanesimo siberiano 46 Il paradigma eliadiano della “purezza sciamanica” 49 Aspetti linguistici 63 La fase preistorica 67 La fase pre-sovietica 77 La repressione sovietica dello sciamanesimo 82 La fase post-sovietica 95 L'Amanita fra i Koriaki 109 L'Amanita fra i Ciukci 130 L'Amanita fra i Khanty 150 L'Amanita fra altre etnie siberiane e asiatiche 171 L'Amanita in Europa 191 L'Amanita nelle Americhe 197 Appendice I – L'Amanita muscaria a Markovo 213 Appendice II – Renne e funghi 217 Bibliografia 224
Alla memoria degli sciamani siberiani degli anni 1930-1940
Prefazione
Francesco Festi
Sono trascorsi 65 anni da quando i coniugi Wasson pubblicavano
Mushrooms, Russia and history, testo fondamentale per la conoscenza
dei funghi psicoattivi e del loro uso tra le culture tradizionali: la
messe di documenti e suggestioni riportati nel lavoro e riguardanti
l’Amanita muscaria, oltre ai funghi allucinogeni mesoamericani, ne
fanno a buona ragione uno dei principali pilastri fondanti di quella
che sarebbe poi diventata l’odierna etnomicologia. Ulteriore
materiale, fino ad allora poco o nulla conosciuto tra gli studiosi
occidentali, venne pubblicato da R. Gordon Wasson circa 10 anni
dopo nel suo Soma. Divine mushroom of immortality, in particolare nei
capitoli dedicati all’uso di A. muscaria in Siberia.
Se si deve riconoscere a Wasson il grande merito di avere dato
stimolo alla ricerca scientifica, documentale e sul campo, riguar-
dante i funghi psicoattivi, è altresì da imputargli l’avvio di una
corrente di “studi” difficilmente conciliabili con un serio approccio
all’argomento. Nei succitati testi, ma anche nei successivi, egli si
lasciò andare a ipotesi certamente affascinanti, ma spesso fantasio-
se e comunque indimostrabili, basate per lo più su interpretazioni
“creative” delle poche informazioni disponibili. Ciò diede la stura
ad una lunga serie di pubblicazioni, per lo più in ambito new age ma
che talvolta ebbero come autori anche accademici o sedicenti tali,
che, nella migliore tradizione complottista, cercavano (e trovavano)
indizi e suggestioni dell’uso di funghi psicoattivi in ogni epoca
storica, in ogni parte del mondo ed in ogni cultura. Fra tutti si può
citare John Allegro e la sua strampalata tesi dell’identità Gesù -
Amanita muscaria.
Una caratteristica di questi lavori, ma anche di pubblicazioni più
rigorose sull’agarico muscario, è stata quella di riferirsi sostanzial-
mente ai documenti già riportati da Wasson e da pochi altri,
1certamente complice la barriera linguistica verso le pubblicazioni in
lingue slave e la difficoltà oggettiva a contattare i popoli coinvolti
fino alla caduta dell’Unione Sovietica. A partire dagli anni ’90, a
fronte di una recuperata liberazione dal giogo sovietico, sono
invero ripresi studi etnologici ed antropologici sull’uso dell’agarico
muscario tra le popolazioni siberiane, ma ancora, soprattutto per
ragioni linguistiche, le ricerche originali sono rimaste al di fuori dei
principali circuiti scientifici occidentali.
Questo libro colma dunque una lacuna che si trascina dagli albori
dell’etnomicologia, offrendo una panoramica mondiale, dettagliata
e rigorosa, dei dati etnografici riguardanti l’agarico muscario.
Giorgio Samorini, con l’impostazione strettamente scientifica che
gli è propria fin dalle sue prime pubblicazioni, fa esclusivo riferi-
mento ai documenti originali, ribaltando la diffusa abitudine di ri-
portare informazioni di seconda mano. È un’esposizione analitica
dei dati che hanno carattere di affidabilità, contrappuntata dalla
critica motivata delle purtroppo numerose cadute di stile nelle
pubblicazioni di settore, senza indulgere in voli pindarici, ricerca di
significati reconditi o deviazioni di pensiero lungo improbabili vie
secondarie.
Non si tratta però solo di una distaccata, rigorosa, neutrale
enunciazione di informazioni. Sullo sfondo è evidente uno schema
non dichiarato, un filo rosso che lega l’intera attività editoriale di
Giorgio Samorini: l’evidenza di un rapporto antico e naturale tra
essere umano e vegetali (e funghi) psicoattivi, un rapporto evolu-
tivo scientificamente dimostrabile, che si può negare solo rinun-
ciando alla razionalità e alla consapevolezza, negando i fatti e
nascondendosi dietro giudizi morali e preconcetti contrari ad ogni
procedimento euristico.
2Introduzione
Muscaria è il “nickname” con cui oggigiorno viene denominata
l'Amanita muscaria, conosciuta anche come agarico muscario, il fungo
con il cappello rosso cosparso di macchie bianche, il fungo delle fia-
be e il fungo allucinogeno per eccellenza.
Sino agli inizi del XX secolo l'utilizzo di questa fonte inebriante
era diffuso nel contesto delle pratiche sciamaniche siberiane. Gli
antropologi del periodo sovietico lo diedero per estinto, e non senza
una certa esultanza, poiché merito di una campagna di “de-sciama-
nizzazione” dei gruppi nativi, internamente al progetto di una loro
“russificazione” e sovietizzazione.
La progettazione di questo libro ha preso spunto dall'acqui-
sizione di una serie di documenti etnografici, diversi dei quali pub-
blicati in russo, estone e altre lingue nordeurasiatiche, che testimo-
niano la sopravvivenza dell'impiego dell'agarico muscario presso
almeno alcune popolazioni siberiane. L'analisi della documentazio-
ne post-sovietica ha anche messo in luce una triste storia di perse-
cuzioni etniche, con la deportazione ed eliminazione fisica degli
sciamani nel contesto delle “purghe” degli anni '30-'40.
Un altro motivo che mi ha portato a stendere questo libro è
basato sulla constatazione di quanto l'agarico muscario sia un fungo
maltrattato, sia in natura che nella letteratura. Maltrattato nei
boschi, dove viene ridotto in pezzi dai raccoglitori di funghi mange-
recci con una rabbia che tradisce reconditi motivi psicologici, di cui
propongo qui una plausibile spiegazione suggerita da uno scrittore
russo, come si vedrà nel paragrafo “Il trauma di Verbnikov”.
Da oltre un secolo l'agarico muscario è maltrattato nella lettera-
tura, da quella scientifica a quella pseudo- e fanta-scientifica. Consi-
derato ingiustamente un fungo mortale, così mortale che v'è chi
addirittura ha messo in dubbio la realtà del suo impiego tradiz-
ionale come fungo inebriante poiché troppo in contraddizione con
le tesi “mortalizzanti”, da alcuni decenni si osserva una produzione
editoriale di bassa qualità, che classifico in tre filoni letterari: 1)
3studi eccessivamente speculativi, dove si pretende di individuare
tracce di conoscenze e culti dell'agarico muscario fra le antiche
popolazioni eurasiatiche sulla base di deboli se non quando insus-
sistenti elementi presi dalla letteratura mitologica, religiosa ed eso-
terica; un insieme di studi inutili, che non fanno altro che offuscare
i confini della seria ricerca etnomicologica; 2) tesi fanta-etnomico-
logiche, che vedono come “padre” fondatore gli scritti di John Alle-
gro (per questo definibili anche “tesi allegriane”), dove vengono
spacciate per vere notizie frutto della fantasia e sono proposte
fantasmagoriche distorsioni interpretative dei dati. Le motivazioni
di questa produzione letteraria si basano su malcelate rabbie per la
soppressione ad opera dei poteri secolari religiosi occidentali dei
culti in cui erano impiegate le fonti visionarie, e sul desiderio di
arrecare danni alle religioni monoteistiche attraverso metodi
scandalistici. Questo tipo di letteratura è fortunatamente marginale
e alla seria etnomicologia non procura più quei danni d'immagine
che furono arrecati dal lavoro di Allegro, il cui messaggio scanda-
listico fu soggetto a un'immeritata amplificazione mediatica; 3) tesi
cospirazionistiche, fra le quali cito quelle che vedrebbero tutto il
lavoro di Gordon Wasson – il padre della moderna etnomicologia –
frutto della volontà della CIA. Prodotte dalla “scuola” ideologica
cospirazionistica statunitense, sono testi che si possono cestinare
senza remore.
Questi filoni letterari non devono essere confusi con la seria
etnomicologia. Dopo il “colpo basso” causato da Allegro (per molti
anni nel mondo accademico l'etnomicologia venne associata
all'affaire Allegro, un fatto di cui sono stato testimone durante la mia
gioventù, al punto che di fronte agli accademici esitavo a presentar-
mi come un etnomicologo), l'etnomicologia scientifica è finalmente
riuscita ad acquisire una meritata credibilità.
Un compito che mi sono dato nella stesura di questo libro è stato
quello di delimitare i confini della seria etnomicologia, e per questo
motivo il mio testo è costellato di appunti critici. Chiedo al lettore
uno sforzo di accettazione di questo livello critico della mia
esposizione, non essendo dettato da un volgare amore per la pole-
mica, ma dal'esigenza di delimitare ciò che è serio da ciò che non lo
è, in un argomento così offuscato e bistrattato quale è la storia del-
4l'agarico muscario.
Per questo stesso motivo non ho potuto fare a meno di affron-
tare in maniera critica, anche severa, il pensiero e gli scritti di un
Mircea Eliade, e perfino di colui che considero un mio “padre cultu-
rale”, Gordon Wasson. Sebbene restino indiscutibili i meriti di Was-
son nell'aver fondato il moderno campo d'indagine dell'etnomicol-
ogia, e gran parte del suo esteso lavoro sia sicuramente valido, in
diverse occasioni egli ha travalicato i confini metodologici con for-
zature di dati e licenziosità interpretative che mi sono sentito in
obbligo di correggere se non quando di rifiutare.
Fra i meriti di Wasson va annoverato il paziente lavoro di raccol-
ta dei documenti relativi all'impiego tradizionale dell'agarico mu-
scario in Siberia, ch'egli tradusse dal russo, tedesco, finlandese e
altre lingue e che pubblicò in inglese nel 1968, rendendoli acces-
sibili all'audience mondiale degli studiosi. Il lavoro che qui presento
può essere considerato un'integrazione di quello di Wasson, dove
presento documenti antichi che non erano stati accessibili a questo
studioso, e documenti che hanno visto la luce nei tempi successivi.
In questo libro, che va considerato un trattato di etnomicologia, ho
limitato lo studio agli aspetti etnografici, storici e filologici, cioè ai
dati reali che testimoniano l'impiego tradizionale dell'agarico mu-
scario, sia antico che moderno, principalmente in Siberia, ma anche
in altre parti dell'Asia, in Europa e nelle Americhe. Ho escluso dalla
trattazione le ipotesi meramente speculative, pur essendo alcune di
queste meritevoli di attenzione, quali l'ipotesi di Wasson che
identifica il soma vedico con l'agarico muscario.
Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza l'interazione con
diverse persone. Fra i russi, ringrazio il micologo Mikhail Vishnevs-
ky dell'Università Statale Lomonosov di Mosca; il giornalista e scrit-
tore Alexander Mauysuryan di Mosca; lo storico Nikita Bashnin,
dirigente dell'Archivio Storico di San Pietroburgo.
Ringrazio il collega tedesco Markus Berger, conoscitore di quella
barocca scrittura che è l'alt-Deutsch, l'ungherese Edvin Balazs, il
traduttore italo-russo Aleksandr Peretti e l'amico italiano Luca
Pasquali.
Per l'acquisizione della letteratura che ho consultato, fondamen-
5tale è stato poter usufruire di diversi portali e archivi web, di cui
ringrazio gli ideatori e gestori. In particolare, i portali russi prlib.ru,
booksite.ru e libgen.rs; il portale francese gallica.bnf.fr, i portali
internazionali es1lib.org e archive.org.
Un particolare ringraziamento ad Alexandra Elbakyan, ideatrice
del portale sci-hub.
Infine, un ringraziamento al ritrovato amico Francesco Festi,
botanico del Museo Civico di Rovereto con cui negli anni '90 ho
avuto il piacere di lavorare su diverse ricerche, e che mi ha onorato
della prefazione del presente libro, oltre ad avere effettuato una
paziente revisione del manoscritto.
G.S., Maiorca, marzo 2022
6Puoi anche leggere