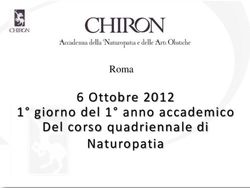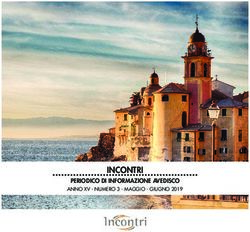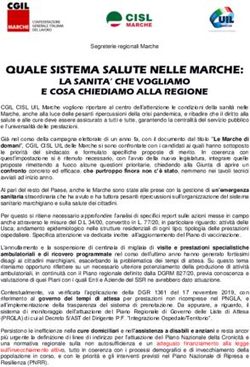Marcel Proust: intrecci, metamorfosi, contaminazioni
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Marcel Proust:
intrecci, metamorfosi,
contaminazioni
Reggio Emilia, 27 e 28 ottobre 2022
Aula L0.5 ‘‘Artigianelli’’ - Dipartimento di Educazione e Scienze Umane
Palazzo Baroni - viale Timavo 93, Reggio Emilia
Comitato scientifico
Annamaria Contini, Marco Piazza, Federico Montanari, Ruggero Ragonese
Comitato organizzativo
Sofia Sandreschi de Robertis, Alice Giuliani, Lorenzo Manera
Con il supporto di:Prof. Gérard Bensussan
gerard.bensussan@sfr.fr
Titre: Levinas lit Proust
Résumé: Levinas a très tôt lu Proust, et quelques autres classiques de la littérature française. Il y a
même appris le français. La conférence examinera la question de l’altérité telle que Levinas en
rencontre d’innombrables traces dans la Recherche, en particulier dans l’amour d’Albertine, génitif
objectif et subjectif. Ce que le philosophe y trouve, c’est que l’Autre n’y est pas visé dans une fusion
avec le Même, à jamais impossible, mais qu’il traverse la subjectivité éthique dans une « lutte avec
l’insaisissable ». C’est ainsi le réel lui-même qui est repensé, et chez Proust, et chez Levinas,
comme ce qui demeure irréductiblement autre, ou pour toujours extérieur.
Prof. Patrick Bray
p.bray@ucl.ac.uk
Titre: Marcel morcelé: Proust et la répétition dans l’art
Résumé: Dans La Prisonnière, le narrateur explique à Albertine la nature de la vérité de l’art comme
une fonction de la répétition. En comparant ce passage fameux à un autre passage similaire, quand
le narrateur écoute Odette qui joue du piano (dans À l’ombre des jeunes filles en fleur), on va pouvoir
analyser comment la répétition et la relecture (par Marcel ou par le lecteur) crée du sens en alternant
l’habitude et la sensation. À travers des lectures de Roland Barthes et de Gilles Deleuze, ainsi que
les écrits théoriques sur l’art de Proust lui-même, on voit que La Recherche de Proust nous force à
la morceler, à la relire même dès la première lecture, et à nous ressouvenir en la (re)lisant. Si “vrai”
texte proustien il y a, il se trouve dans la comparaison continuelle de l’ordre chronologique du récit
et les retours constants (dans le texte, dans nous-mêmes) pour contempler la composition de ce
(dés)ordre.
Prof. Marco Piazza
marco.piazza@uniroma3.it
Titolo: Proust realista? Così credeva Joan Sacs
Abstract: La poetica proustiana è stata definita volta volta idealista (Raimond, Milly), prospettivista
(Auerbach) o relazionista (Curtius) per sottolineare il suo scarto rispetto al realismo ottocentesco di
un Balzac. L’oscuro e completamente obliato critico catalano Joan Sacs, uno degli pseudonimi del
pittore-caricaturista-narratore e critico artistico e letterario Feliu Elias i Bracons (1878-1948), nei
primi anni Trenta era convinto che dietro la poetica idealista della Recherche si celasse il “realismo”
di Proust. Per quanto un po’ rudimentale nell’ argomentazione, l’interpretazione di Sacs coglie con
acume alcuni elementi salienti dell’epistemologia proustiana, che, nel suo sovvertire il regime delle
abitudini per sondare le regioni dell’inconscio, configura una sorta di “transrealismo” (Candido) che
guarda con simpatia tanto alla tecnica pittorica dell’impressionismo (Crémieux) quanto a quella
fotografica della stereoscopia (Shattuck).
Prof. Stefano Poggi
stefanopoggipoggi@gmail.com
Titolo: Una strada assolata e una piccola finestra: Proust e la prospettiva
Abstract: Nella penombra dell’atelier di Elstir, a Balbec, il visitatore, in una assolata giornata estiva,
getta lo sguardo sulla luce che inonda una strada polverosa, intravista nell’apertura di una piccolafinestra spalancata. È lo sguardo di un momento, perché, poi, tutta la sua attenzione andrà alle
cattedrali e alle marine del grande artista. È uno sguardo fuggevole. Non è quello, oramai velato,
con cui gli occhi di Bergotte morente si posano sul petit pan de mur jaune della Veduta di Delft. Ma
è uno sguardo rivelatore. Rivelatore, ancora una volta, del debito di Marcel Proust nei confronti di
John Ruskin.
Dott.ssa Sofia Sandreschi de Robertis
sofia.sandreschi@uniroma3.it
Titolo: «Scatola 3, bobina 5»: Proust e il Krapp di Beckett
Abstract: La Recherche conta, fra i suoi numerosi e celebri ammiratori, anche Samuel Beckett. Nel
1931, Beckett pubblica un saggio dal titolo laconico – Proust – e, per primo, rileva criticamente il
potere che l’abitudine detiene nell’economia della Recherche. Più di venti anni dopo, scrive una
pièce brevissima, L’ultimo nastro di Krapp (1958), dove ancora risuona, seppur implicitamente, l’eco
proustiana. L’ipotesi di questo tardivo ritorno a Proust è stata avanzata da Ackerley (2009), ma,
mentre la letteratura critica incentrata sul Proust di Beckett è abbastanza sviluppata, manca ad oggi
un vero e proprio dibattito a questo proposito.
La pièce del ’58 ruota attorno a due temi fondamentali nell’opera proustiana – la memoria e l’identità
dell’io – che qui vanno in scena grazie alla mediazione tecnologica di un registratore. Krapp registra
i suoi ricordi più recenti e riascolta quelli più antichi: l’andamento della memoria e il tentativo di
ricomporre un’identità divengono così processi esteriori, o meglio esteriorizzati.
Se l’ipotesi di Ackerley può essere in qualche modo confermata, devono esserne però discusse le
conseguenze. Non si tratta infatti di esporre un’estetica – in continuità o in contrasto con quella
esposta ne Il tempo ritrovato; se Beckett, nel saggio del ’31, si era posto nei confronti di Proust con
l’atteggiamento del critico, nel ’58 invece lo affronta in un corpo a corpo, nei panni del drammaturgo.
Dott. Andrea Nicolini
andrea.nicolini.uni@gmail.com
Titolo: Il risvolto del pensiero. Sul rapporto tra filosofia e letteratura
Abstract: L’intento del mio intervento è quello di analizzare i rapporti tra letteratura e filosofia a partire
dal saggio Proust et les signes dove Deleuze sembra dividere in modo fermo le due discipline.
Secondo Deleuze, diversamente dalla filosofia, il cui intimo sforzo di afferrare la verità la conduce
ad elaborare un sistema teso ad evitare ogni sorta di contraddizione, la letteratura non pratica alcuna
astrazione razionale, andando invece a dar voce a tutte quelle contraddizioni che contraddistinguono
e sostengono ogni emozione umana. Ciononostante, è importante sottolineare come sia proprio
Deleuze ad affermare che la verità non è qualcosa che un soggetto disincarnato può trovare nel
mondo. La verità, afferma infatti il filosofo, è l’effetto di una “violenza sul pensiero”, una violenza che,
dall’esterno, colpisce il soggetto costringendolo a pensare. Per il filosofo, il pensiero non è l’atto di
una volontà libera, ma è l’effetto del nostro essere al mondo come un corpo già da sempre
compromesso con la contingenza dettata dalle sue emozioni. Da qui l’importanza che Deleuze
attribuisce ai segni. I segni sono infatti le ferite che il tempo lascia sulla vita di un essere umano
accendendo in lui il bisogno di comprendere cosa si cela dietro quelle stesse ferite. In questo senso,
decifrare i segni significa certamente approcciarsi alla verità, ma ad una verità che non ha nulla a
che fare con quell’istanza fondazionalistica tipica di un certo sapere filosofico che, separando il
soggetto dal mondo, ne ha fatto una pura istanza conoscitiva. La verità̀ di cui parla Deleuze emerge
al contrario proprio da una confusa e passionale commistione col mondo e trova la propria raison
d'être a partire da quella inalienabile comunione tra il pensiero di un soggetto e il mondo entro cui
questi si muove dando corpo alle proprie emozioni. La divisione tra filosofia e letteratura che Deleuze
sembrava in un primo momento sostenere viene dunque problematizzata dal concetto di veritàofferto dal filosofo stesso – un concetto grazie al quale egli esprime la necessità di superare le
astrazioni del cogito per istituire un nuovo modo di fare filosofia.
Ciò che è interessante sottolineare in relazione al rapporto tra filosofia e letteratura è che non
solamente Deleuze, ma tutti i filosofi francesi che hanno lavorato su Proust – sia che siano
riconducibile al cosiddetto post-strutturalismo francese, o che lo precedano, come nel caso di
Bataille e Merleau-Ponty – sono impegnati nel disvelare come la dimensione di contingenza legata
alle emozioni, ben lungi dall’essere estranee al cogito, lo strutturi come un cogito di carne e sangue,
come un cogito che abita il mondo e lo influenza tanto quanto ne viene influenzato. Questo
ribaltamento nel concepire il pensiero – che non rappresenta solo un cambio di stile ma una svolta
nello stile del pensiero – è stata definita da Paul Ricoeuer in Soi-même comme un autre, “cogito
brisé” ossia quel cogito che si frantuma proprio per dar voce alle contingenze emotive da cui il cogito
stesso emerge.
Al di là delle differenze che separano i filosofi appartenenti alla tradizione del cogito spezzato, ciò
che li unisce sotto il segno di Proust sembra essere proprio il fatto che per loro non è più possibile
fare filosofia se non attraverso una deriva letteraria. Una volta abbandonate le aspirazioni
oggettivistiche che separano il pensiero dal mondo dal quale emerge, la tradizione del cogito
spezzato si apre infatti a quelle infinite e frammentarie contingenze che solo la letteratura sa cogliere
cosi bene. Come ha efficacemente sottolineato Vincent Descombes in Proust. Philosophie du
Roman, il valore della letteratura si basa infatti proprio sulla straordinaria capacità di rappresentare
la ricchezza e la diversità dei fenomeni concernenti la vita umana. La letteratura è in grado di
mostrare quei fenomeni particolarmente elusivi come le passioni, i sentimenti, le relazioni
intersoggettive, che sfuggono alla concettualizzazione tipica della filosofia. Affermando chiaramente
questi aspetti dell’esperienza, la letteratura li mette sotto gli occhi del pensiero, e mostrandone
l’importanza, li salva dall’oblio di un pensiero disincarnato.
Da questa prospettiva, appare evidente come la letteratura non sia solo un valido strumento nelle
mani del filosofo, ma sia il rovescio della filosofia stessa. Filosofia e letteratura non sono altro che il
concavo e il convesso dello stesso pensiero incarnato. Sulla scorta della tradizione del cogito
spezzato, intento del mio intervento è dunque mostrare come la divisione tra filosofia e letteratura
debba essere abbandonata in vista di un modo differente di fare filosofia, un modo in grado di
cogliere anche quelle contingenze che intessono la stoffa dell’esistenza e che solo la letteratura sa
cogliere nella loro vibrante contraddittorietà.
Dott. Ludovico Monaci
ludovico.monaci@phd.unipd.it
Titre: Proust sociolinguiste de la violence verbale: « toutes les injures imaginables » de la
Recherche
Résumé: Les études qui ont été consacrées aux idiolectes et aux sociolectes des personnages de
la Recherche n’ont pas suffisamment attiré l’attention sur les manifestations de violence verbale.
Pourtant, comme ils sont dépeints « au cours de leur vie normale et quotidienne » (LE BIDOIS 1939,
198), les personnages proustiens recourent souvent à l’injure et à la médisance1. La « sociologie
romanesque » (HENRY 1983, 128) de la Recherche offre un échantillon représentatif des attitudes
conversationnelles et comportementales que, sur la base de leur appartenance à une « caste »
(RTP, I, 16, 20-21 ; III, 415) ou à un « groupement humain » (RTP, II, 544), les « membres du corps
social » (RTP, II, 664) peuvent assumer dans un contexte agonal. Dans une perspective à la fois
synchronique (centrée sur les étapes génétiques d’un épisode romanesque) et diachronique
(centrée sur l’évolution diégétique du récit), on tracera les tendances sociodiscursives des êtres de
papier principaux, à savoir ceux qui sont tour à tour les responsables, les victimes ou les témoins
d’un acte de violence verbale : « Ce retournement de l’insulte marque la réversibilité toujours
possible des rôles, qui suivent un mouvement de rotation » (DUVAL 2004, 320). Notre objectif est
1On appelle « injure » toutes les attaques verbales directes, où les propos sont tenus « en face » de la victime,
et « médisance » toutes les attaques verbales indirectes, où un énoncé est proféré « dans son dos ».celui de montrer que les insultes, les invectives, les injures et les médisances ne sont pas seulement
un instrument d’agression, mais qu’elles sont aussi le miroir de la mentalité, des peurs, des codes
et des systèmes de valeurs d’un individu, d’« une ethnie sociale » (BARTHES 2020, 172) et, plus en
général, d’une civilisation et d’une époque. Cette intervention s’inscrit dans le premier axe de
propositions (« la contamination […] entre différents champs disciplinaires ») : en particulier, à
travers une approche qui relève à la fois de la sociologie et de la linguistique pragmatique, on se
concentrera notamment sur les « stimulations » que Marcel Proust offre « au débat contemporain »
en matière de « la conception de l’individu et de la société ».
Prof. Federico Montanari
federico.montanari@unimore.it
Titolo : ‘Essere sensibile ai segni’. Conoscenza e verità nel Proust di Deleuze: ipotesi per un
Proust spinozista
Abstract: Lo scopo di questo paper è di ripartire dal ben noto e classico studio di Deleuze, Proust e
i segni. Di riprendere la tesi e, se possibile, "rilavorare", questa lettura di Proust. Sappiamo che,
come per molti altri libri di Deleuze, quello su Proust possiede uno dei caratteri tipici del filosofo:
quello di un “fare irruzione” in campi, in apparenza non propri, non direttamente appartenenti al
campo della filosofia. Talvolta suscitando, perlomeno in un primo momento, la reazione irritata degli
storici della letteratura o dei critici. Ma quali punti crediamo sia importante riprendere e riattualizzare
del lavoro di Deleuze? Da un lato vogliamo concentrarci sulla valutazione generale dell’opera di
Proust: come è noto, Deleuze insiste su un punto fondamentale che riprende direttamente da Proust,
che infrangeva perlomeno allora un luogo comune. La Recherche è un grande lavoro "non sulla
memoria ma sulla conoscenza", e addirittura di una “verità”: attraverso la percezione, e la
stratificazione di diverse tipologie di segni. Dunque, cercheremo in primo luogo di riprendere queste
mappe e tipologie dinamiche. Ma anche, in secondo luogo, di formulare un’ipotesi: chiederci se il
lavoro di Deleuze su Proust sia un lavoro anche di “rifondazione”, in anticipo sui tempi, di una
semiotica; e legata, forse, ad una filosofia che, come noto, sta al centro dell’opera di Deleuze, quella
di Spinoza.
Dott. Ruggero Ragonese e Prof.ssa Emanuela Piga Bruni
ruggero.ragonese@unimore.it
emanuela.pigabruni@unimercatorum.it
Titolo: Segni di Proust. Visioni, previsioni e revisioni
Abstract: Quelquefois l'avenir habite en nous sans que nous le sachions, et nos paroles qui croient
mentir dessinent une réalité prochaine (À la recherche du temps perdu - Tome 3 - Le Côté de
Guermantes).
Un centenario è sempre l’occasione, spesso la scusa, per fare un punto, per mettere in prospettiva
un autore e un’opera. Questo vale a maggior ragione per Proust la cui vita stessa, sia nel mito
posteriore sia nella realtà biografica, si è snodata in un continuo rispecchiamento con i suoi testi. In
questo senso, la Colomba pugnalata di cui ci parla Piero Citati, scomparso proprio in questo anno
proustiano, resta forse l’immagine più affascinante del dilemma proustiano, capace di mettere a
fuoco (in un modo volutamente non accademico) questa particolare e ragionata ‘confusione’ fra
storia personale e storia narrativa. A partire da testi come quello di Citati e dalle revisioni critiche sul
concetto di autorialità (Genette, De Man) proveremo a tracciare un percorso articolato del modo in
cui Proust ci ha fatto segno post mortem. Se il portato di un autore nella cultura che gli succede è
ravvisabile sempre (qualsiasi opera di fatto è oggetto di letture, riletture, e fonte di modelli e
mitizzazioni), nel caso dello scrittore della Recherche si ravvisa un passaggio ulteriore che rende
l’anniversario del 2022 non scontato. L’opera proustiana in qualche modo si allunga in unatemporalità extratestuale. Nel perimetro peritestuale, fra l’opera e le sue successive revisioni, si
inserisce un dispositivo estetico che ne regola lo spazio di lettura. Proust si fa paradossalmente
regola, si organizza come meccanismo replicabile, dissemina la sua dimensione biografica in un
modello universale. Un HyperProust (Gidding 2002) che non si esaurisce in un perimetro
intratestuale, ma trasborda oltre i limiti del testo in modo metodico, traducendosi non tanto nella
semplice citazione, ma in un percorso di inferenzialità semiotica.
Prof.ssa Marisa Verna e Prof.ssa Antonella Marchetti
marisa.verna@unicatt.it
antonella.marchetti@unicatt.it
Titolo: Percezione, memoria autobiografica e sé: il naso di Proust
Abstract: Questo contributo rappresenta una prima sistematizzazione di uno studio più vasto
sull’olfatto nella Recherche proustiana, in cui ci concentreremo in modo particolare sulla relazione
fra olfatto e memoria nella scrittura di Marcel Proust. Infatti, se è noto che il tempo costituisce il perno
intellettuale e il motore estetico del romanzo proustiano, meno nota è l’importanza dell’olfatto
nell’operazione di conservazione della memoria, il cui risultato (la reminiscenza, o memoria
involontaria) va molto oltre il banale recupero di un ricordo e la sua traduzione “nostalgica” in una
prosa poetica. Più stabile di altri tipi di memoria, dotata di un carattere edonico ed emotivo molto
forte (Jean-Yves et Marc Tadié, 1999) la memoria olfattiva viene usata da Proust per liberare
“l’essenza dell’io” (Serça 2022), permettendo al narratore della Recherche di superare la
frammentazione del sé sperimentata lungo tutta la narrazione (Jean-Marc Devaud 2022).
L’intuizione di Proust rispetto al ruolo dell’olfatto nella cognizione del reale e nel recupero della
memoria si colloca in rottura rispetto alla cultura a lui contemporanea, che vede nell’olfatto il più
primitivo dei sensi, “inutile” (se non dannoso) in un’umanità evoluta. Nella prima parte dell’intervento
analizzeremo alcuni passaggi del romanzo, in cui l’olfatto sembra trovati all’origine stessa della
vocazione letteraria del narratore, il bandolo “triviale” del cammino spirituale dell’arte. Nella seconda
parte presenteremo una serie di ricerche in ambito psicologico, neuropsicologico e psicobiologico
che avvalorano, dall’osservatorio di un altro vertice disciplinare, la succitata rottura operata dalle
intuizioni proustiane rispetto alla cultura contemporanea all’Autore, fornendo una serie di evidenze
sperimentali interessanti in relazione al tema “olfatto e memoria”. Verranno citati alcuni ambiti di
indagine particolarmente cruciali. Un primo ambito riguarda il ruolo comparativo dell’olfatto rispetto
agli altri sensi nel sollecitare memorie autobiografiche in termini sia di capacità evocativa sia di
intensità dei ricordi evocati (Toffolo et al., 2012; de Bruijn, Bender, 2018; Ernst et al, 2021). Un
secondo ambito concerne la natura “antica” vs “recente” delle memorie olfattive rispetto alle altre
memorie sensoriali (Willander, Larsson, 2008). Un terzo ambito è relativo al nesso tra stimoli olfattivi,
ippocampo e memoria episodica (Baudry, 2020). Un quarto ambito ha rilevanza clinica. Alcuni studi
hanno infatti evidenziato due tipi di fenomeni: da un lato, gli effetti benefici esercitati sul sistema
immunitario dalla secrezione di determinate molecole, conseguente all’esperienza di memorie
emotive autobiografiche a valenza positiva olfattivamente mediate (Matsumaga et al., 2013;
dall’altro la funzione dell’olfatto come fattore protettivo rispetto ai deficit di memoria associati ad
alcune patologie neurodegenerative e rispetto alla sintomatologia depressiva che spesso
accompagna sia questo tipo di patologie sia la recente patologia del Long Covid (Guedj et al., 2021).Puoi anche leggere