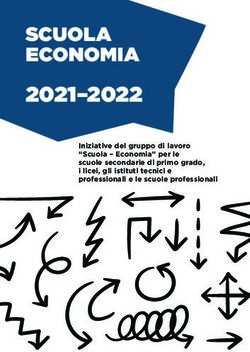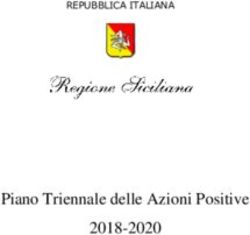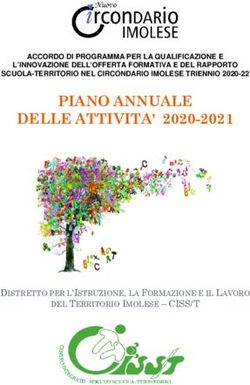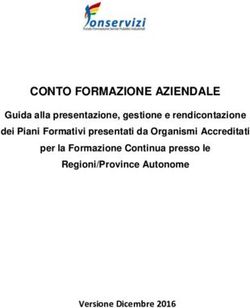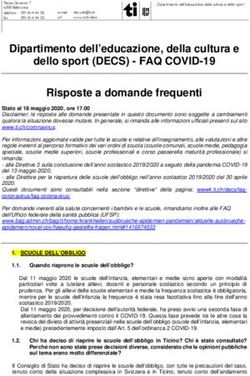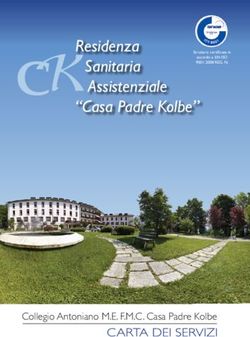CCV-MB - il "SISTEMA TLC" - CORSO DI FORMAZIONE 1 LIVELLO BASE - della protezione civile in Lombardia - Protezione civile Monza
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
CORSO DI FORMAZIONE 1°LIVELLO BASE
CCV-MB
il “SISTEMA TLC”
della protezione civile in Lombardia
Page 1 1
Relatore: Giancarlo COSTA - Presidente CCV-MBPresentazione del CCV-MB
• Il Comitato di Coordinamento Volontari di Protezione Civile della
Provincia di Monza e Brianza nasce nel 2010 dopo il distacco dalla
Provincia di Milano, dopo un cammino parallelo dal 2007 al 2009.
•Raggruppa la totalità delle OOV della Provincia con finalità di P.C. e
conta 42 organizzazione con un totale di oltre 940 volontarie e
volontari.
•È composto dall’Assemblea delle Organizzazioni di Volontariato e
dall’Esecutivo composto da 7 componenti provenienti dalle
Organizzazioni, ed espressioni delle Associazioni e deidiGruppi
Il sistema nervoso un efficace
Comunali: Presidente, Vice Presidente, Segretario,soccorso
e 4 consiglieri
è basato sulla
comunicazione, e questa avviene
anche attraverso la RADIO
Page 2Presentazione del CCV-MB
Art. 1 - Istituzione del Comitato di Coordinamento del
Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Monza e
Brianza
•È istituito, quale organismo istituzionale, il Comitato di
Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Provincia
di Monza e Brianza, di seguito indicato con la sigla CCV-MB, ai
sensi dell’art. 1 punto 1 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e
successive modifiche ed integrazioni, della Legge 11 agosto 1991,n.
266 e successive modifiche ed integrazioni, e Regolamento
Regionale vigente.
•Il Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile
Il sistema nervoso di un efficace
della Provincia di Monza e della Brianza è composto dalle sole
soccorso è basato sulla
Organizzazioni (Gruppi Comunali, Intercomunali ed Associazioni) di
comunicazione, e questa avviene
Volontariato di Protezione Civile, operanti nel territorio della
anche attraverso la RADIO
Provincia di Monza e Brianza e iscritte alla sezione provinciale di
Monza e Brianza dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione
Page 3
Civile.Presentazione del CCV-MB
Art. 2 Funzioni del Comitato di Coordinamento
•Il CCV-MB, nel rispetto della vigente normativa, rappresenta e
gestisce gli interessi diffusi a tutela del Volontariato di Protezione
Civile.
•Valorizza e qualifica l’attività del Volontariato;
•incrementa i rapporti di collaborazione fra le componenti del
volontariato e fra queste e gli Enti territoriali;
•promuove e sostiene la costituzione e lo sviluppo
dell’associazionismo con finalità di Protezione Civile anche
collaborando con realtà extraterritoriali ed extraregionali;
•propone alla Provincia di Monza e Brianza o aglinervoso
Il sistema enti competenti
di un efficace
corsi di formazione e di aggiornamento per il Volontariato;
soccorso è basato sulla
•acquisisce e valuta le indicazioni e comunicazione,
le proposte, die particolare
questa avviene
rilevanza, formulate dalle Organizzazioni di Volontariato;
anche attraverso la RADIO
Page 4Presentazione del CCV-MB
Art. 2 Funzioni del Comitato di Coordinamento
•rappresenta le esigenze delle Organizzazioni di Protezione Civile,
presso le sedi competenti, in relazione alle finalità di Protezione
Civile;
•al fine della predisposizione dei piani di Protezione Civile, può
concorrere ad evidenziare i principali rischi sul proprio territorio;
•assicura la propria collaborazione alle iniziative ed alle attività
disposte dall’Amministrazione Provinciale in materia di Protezione
Civile coordinando le organizzazioni di volontariato;
•Coordina su delega della Provincia di Monza e Brianza le
organizzazioni di volontariato nelle operazioni di soccorso
Il sistema nervoso e
di un efficace
superamento dell’emergenza; soccorso è basato sulla
comunicazione, e questa avviene
anche attraverso la RADIO
Page 5Presentazione del CCV-MB
Art. 2 Funzioni del Comitato di Coordinamento
•Coordina su delega della Provincia di Monza e Brianza la Colonna
Mobile Provinciale e le sue componenti volontaristiche.
•promuove la costituzione di una rete di comunicazione tra le
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile operanti sul
territorio provinciale con le modalità indicate, per le proprie
competenze.
•partecipa - ove possibile - alle attività di previsione, prevenzione,
soccorso ed al superamento dell’emergenza nel territorio
provinciale ed extra provinciale;
•fornisce assistenza alle Organizzazioni di volontariato
Il sistema nella
nervoso di un efficace
gestione delle pratiche relative all’Albo. soccorso è basato sulla
comunicazione, e questa avviene
anche attraverso la RADIO
Page 6Presentazione del CCV-MB
Art. 3 Rapporti della Provincia di Monza e Brianza con il CCV-
MB
•Il CCV-MB in accordo con la Provincia, promuove procedure
operative d’intervento e di attivazione, definisce metodologie di
gestione e di coordinamento fra gli Enti, le Strutture operative, gli
Organismi Istituzionali e le Organizzazioni stesse per sviluppare
sinergie fra tutte le componenti del sistema di Protezione civile;
•La Provincia di Monza e Brianza assegna al CCV-MB l’utilizzo di
una sede, con appropriate dotazioni di ufficio, per l’espletamento
delle attività di gestione del CCV-MB e ne assicuranervoso
Il sistema la funzionalità e
di un efficace
l’operatività. soccorso è basato sulla
comunicazione, e questa avviene
anche attraverso la RADIO
Page 7Presentazione del CCV-MB
Art. 3 Rapporti della Provincia di Monza e Brianza con il CCV-
MB
•La Provincia di Monza e Brianza assicura, in accordo con il CCV-
MB, la formazione di base e specialistica dei volontari iscritti alle
Organizzazioni che compongono il CCV-MB e stabilisce le modalità
e le verifiche per il mantenimento dello status di operatività delle
Organizzazioni, fondamentale requisito per poter essere impegnate
nelle attività previste dalla normativa vigente.
•La Provincia di Monza e Brianza assicura ai componenti
dell’Esecutivo del CCV-MB un’adeguata preparazione
Il sistema nervoso ditecnico-
un efficace
professionale, facendosi promotore presso gli Enti competenti
soccorso di sulla
è basato
corsi specifici per la formazione dei quadri del volontariato,
comunicazione, e questa avviene
finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui attraverso
anche al precedente
la RADIO
articolo 2.
Page 8Presentazione del CCV-MB
Art. 3 Rapporti della Provincia di Monza e Brianza con il CCV-
MB
•La Provincia di Monza e Brianza, mette a disposizione dei
componenti dell’Esecutivo del CCV-MB spazi, locali, automezzi ed
attrezzature, previa autorizzazione del Direttore del settore della
Provincia di Monza e Brianza, autorizzando i volontari alla guida
degli automezzi, copertura assicurativa.
•La Provincia di Monza e Brianza assicura la copertura finanziaria
per esercitazioni e corsi di formazione programmati, organizzati e
preventivamente concordati con il Direttore della Protezione
Il sistema Civile.
nervoso di un efficace
Regolamentato da apposita procedura operativa soccorso è basato sulla
comunicazione, e questa avviene
anche attraverso la RADIO
Page 9Le Radiocomunicazioni
Il sistema nervoso di un efficace
soccorso è basato sulla
comunicazione, e questa avviene
anche attraverso la RADIO
Page 10Obiettivo di questo incontro •SAPERE COSA E’ UNA RADIO E A COSA SONO LE RADIOCOMUNICAZIONI •CAPIRE COME AVVENGONO E CONOSCERE LE CRITICITA’ NELLE COMUNICAZIONI RADIO IN EMERGENZA E •SAPER GESTIRE LE COMUNICAZIONI NELLA CATENA DI COMANDO E CONTROLLO E CAPIRE A COSA SERVONO •AVERE CHIARO L’USO DELLO STRUMENTO NELL’INSIEME DEL SISTEMA ED IL PERCHE’ DEL SUO UTILIZZO •CONOSCERE GLI STRUMENTI E I MEZZI A DISPOSIZIONE Page 11 Formazione AVPC Cesano M. - G.Costa
Le Radiocomunicazioni •LA RADIO E’ INTESA COME UN DISPOSITIVO IN GRADO DI TRASMETTERE E DI RICEVERE SEGNALI AUDIO PER MEZZO DI ONDE ELETTROMAGNETICHE •LA RADIO SOPPERISCE AL COLLEGAMENTO FISICO TRA DUE O PIU’ PERSONE PER COMUNICAZIONI •OVVIA CONSEGUENZA IMMEDIATA AGLI EVENTI CALAMITOSI E’ IL REPENTINO COLLASSO DEI SISTEMI DI TLC CLASSICI – TELEFONO E GSM Page 12
Cosa Sono? •Le radiocomunicazioni, sono comunicazioni effettuate utilizzando “onde radio”, cioè onde elettromagnetiche di lunghezza d’onda superiore al millimetro, come mezzo di collegamento tra due o più stazioni. •Un sistema di radiocomunicazione, è composto da una o più stazioni trasmittenti, che provvedono a generare una corrente avente una determinata frequenza (onda o freq. Portante), a modularla (variando ampiezza, frequenza, fase), e ad inviarla nello spazio, per mezzo di un dispositivo chiamato antenna. •Una o più stazioni riceventi, provvedono a captare l’onda con un antenna, a selezionarla fra tutte le altre presenti contemporaneamente, ad amplificarla e a demodularla, cioè ad estrarre dall’onda modulata, l’informazione che essa trasportava per renderla utilizzabile. Page 13
Come Avvengono? •Esistono diversi modi di propagazione delle onde radio, attraverso la ionosfera per quanto riguarda le “ONDE CORTE” (H.F.) ovvero High Frequency, e in modo pressochè rettilinei detti a portata ottica per quanto riguarda le “ONDE CORTISSIME” (V.H.F. - U.H.F. - S.H.F.) •I segnali emessi dalle stazioni radio in V.H.F. su frequenze assegnate dal Ministero delle Comunicazioni, dietro concessione a pagamento, sono per la loro caratteristica di propagazione, limitate sia dagli ostacoli che dalla curvatura terrestre. • Infatti la portata massima teorica del collegamento fra due stazioni situate in terreno pianeggiante, dipende essenzialmente dalla quota delle rispettive antenne in portata ottica. Page 14
Come Avvengono?
Il traffico radio può essere effettuato in diversi modi
IN FONIA E IN TRASMISSIONE DATI:
•fonia - ovvero parlando attraverso un microfono
•rtty - ovvero inviando dati codificati attraverso un p.c. ed un modem
•sstv - ovvero inviando e ricevendo immagini a scansione lenta
•via cavo tramite rete internet
•via satellite
Page 15 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaCome Avvengono? •La portata teorica approssimata ha, a causa dell’intervento di vari fenomeni, connessi con la propagazione delle onde (riflessioni, diffrazioni, rifrazioni), che permettono ai segnali di raggiungere a volte anche zone nascoste oltre l’orizzonte ottico. • La portata utile del collegamento radio diretto su terreno pianeggiante risulta in media di: •25 km per le stazioni fisse •15 km per le stazioni veicolari
Come Avvengono?
•Nelle città, si possono avere forti variazioni di segnale anche fra punti situati a brevi
distanze. Il fenomeno è dovuto alla presenza di costruzioni in cemento che riflettono
in vario modo i segnali, i quali raggiungono l’antenna con fase diversa.
•I collegamenti nelle zone urbane o industriali, possono risultare difficoltose per la
presenza di disturbi radiolelettrici di natura impulsiva, generati dagli autoveicoli,
macchine utensili, etc. che per la loro natura provocano un “mascheramento” dei
segnali più deboli.
SEGNALE 2
SEGNALE 1
RICEVITORE
Page 17 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaCome Avvengono?
•LE STAZIONI RIPETITRICI: per incrementare il raggio d’azione delle stazioni radio, si
impiegano le stazioni radio ripetitrici, che, se ubicate in posizione elevata, possono ricevere,
amplificare e ritrasmettere i segnali provenienti anche da stazioni lontane, la copertura della
stazione varia dalla quota dell’impianto, e dalla conformazione orografica, su terreno piano, la
portata è circolare e si calcola in R=3.57 x H. Le stazioni ripetitrici, consentono di migliorare le
comunicazioni tra i portatili, nelle valli oltre ad aumentare la distanza di collegamento
1000 m.
c
a 15 km b d
113 km 113 km
Page 18 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaCome Avvengono?
Tutte le stazioni radio fisse, mobili e portatili che si trovano dentro l’area di
copertura del ponte radio, possono comunicare tra loro e formano una maglia.
Di regola, ad ogni maglia è assegnato un solo canale radio, che raddoppia quando
funziona in ponte radio, essendo possibile utilizzare anche l’isofrequenza per
comunicazioni a breve raggio
Master semiregionale
Provincia D
Submaster provinciale
Provincia D
Submaster
Satellite
Provincia B
Provincia B
Provincia C
Provincia A
Provincia C
Provincia A
Page 19 Formazione AVPC Cesano M. - G.Costa
SEMIREGIONECome Avvengono e Perchè 1. Informare sulla situazione. 2. Trasmettere la sintesi dei bisogni e dei mezzi disponibili o impiegati. 3. Ricevere le informazioni e le disposizioni dalle autorità superiori e da chi ci coordina. 4. Pianificare e gestire le operazioni Page 20 Formazione AVPC Cesano M. - G.Costa
COME AVVENGONO?
RETE RADIO TLC RETE COMUNICAZIONI
Attraverso una moltitudine di
CENTRO OPERATIVO
strumenti tecnologici che
contribuiscono a rendere semplici le
comunicazioni , anche con
conoscenze minime
Page 21 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaLe Comunicazioni Page 22 Formazione AVPC Cesano M. - G.Costa
Le Comunicazioni
I mezzi utilizzati sono di tre tipi:
· Mezzi umani: operatori specializzati che abbiano acquisito conoscenza
dei mezzi tecnici e delle procedure, radioamatori per la parte di loro competenza.
· Mezzi telefonici: centraline di campagna e collegamenti alla rete
telefonica, telefoni veicolari, telex, fax interfono, cellulari gsm e satellitari.
Mezzi radioelettrici: radio con frequenze che permettano un contatto
tra il posto di comando avanzato operativo e la catena di comando: COC – COM –
CCS - (frequenze VHF-UHF-HF satellite).
Page 23 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaLe Comunicazioni I vantaggi dei sistemi radio sono: • indipendenza da sistemi centrali che possono andare in avaria • i terminali radio facilmente sostituibili • modesti costi di realizzazione e di attivazione • linea sempre aperta con l’interlocutore • possibilità di comunicazione circolare a più utenti (broadcasting) • condivisione delle informazioni (tutti gli utenti di una rete radio hanno accesso alle medesime informazioni) Page 24 Formazione AVPC Cesano M. - G.Costa
Le Comunicazioni
I mezzi di telecomunicazione, e in particolare i mezzi di trasmissione radioelettrica,
costituiscono il sistema nervoso della catena dei soccorsi. Permettono
all’informazione di circolare e sono indispensabili per trasmettere le disposizioni.
La buona funzionalità dei sistemi di comunicazione, trasmissione ed informazione,
costituisce la piattaforma organizzativa sulla quale costruire un efficace apparato di
sicurezza locale.
Con l’avvento della telefonia mobile, internet, la trasmissione dati in digitale,
molti hanno ritenuto che la radio fosse uno strumento obsoleto.
E si sbagliavano!
Qualunque sia la distruzione provocata dall’evento eccezionale, bisognerà stabilire
nel più breve tempo possibile i collegamenti tra il Posto di Comando Avanzato
(UCL) e le retrovie (COM) e successivamente dal PCA verso la zona avanzata con
le squadre impegnate.
Per stabilire i collegamenti, il PCA dovrà essere impiantato in prossimità della zona
di intervento,
Page 25 con idonee attrezzature e posto
Formazione AVPC Cesano in
M. - sicurezza.
G.CostaLe Comunicazioni
·
Uno dei problemi principali nella comunicazione è l’errata trasmissione
delle informazioni, cui si aggiunge, nella fase dell’emergenza, il rischio
della “Babele delle informazioni”.
Ci sono delle tecniche specifiche volte
a contenere la probabilità del verificarsi di tali problemi
“La comunicazione è il processo consistente nello scambio di messaggi,
attraverso un canale e secondo un codice, tra individui e sistemi” .
Comunicazione dal latino communicare, accomunare, rendere
partecipe,
è un processo di trasmissione delle informazioni e di costituzione della
realtà intersoggettiva. (vale a dire…portare a conoscenza altri soggetti)
Page 26 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaLe Comunicazioni Il risultato Page 27 Formazione AVPC Cesano M. - G.Costa
Le Comunicazioni Il risultato NOTA LEGISLATIVA: Non tutti gli apparati radiotrasmittenti liberamente in vendita sono, all'atto pratico, di libero utilizzo, compreso quelli radioamatoriali. Esistono precise distinzioni che vanno fatte onde evitare che si acquisti, incautamente, un apparato il cui uso è riservato ad altri servizi. E' scontato che per utilizzare qualunque tipo di apparato radioelettrico è necessario avere una autorizzazione o una concessione (a seconda dei casi) rilasciata dei vari Ispettorati Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico. Se si utilizzano questi apparati in maniera abusiva, si incorre nelle medesime sanzioni previste per l'uso degli apparati amatoriali: sequestro dell'apparato, sanzione amministrativa di diverse migliaia di euro, denuncia penale all'Autorità Giudiziaria. Page 28 Formazione AVPC Cesano M. - G.Costa
Le Comunicazioni Tra gli operatori in situazioni di emergenza fondamentali sono le COMUNICAZIONI RADIO , suddivisibili in tre categorie: - terra terra : tra gli operatori che operano sul terreno; - terra aria : tra chi opera a terra ed i mezzi aerei (elicotteri, aerei antincendio); - aria aria : tra gli equipaggi dei mezzi aerei. Limitiamoci a quelle terra terra. Queste, da un punto di vista tecnico, si suddividono in : - isoonda, da apparecchio radio direttamente ad altro apparecchio radio, utilizzando un’unica frequenza (da qui il termine isoonda), possibile solo se gli apparecchi si trovano nei reciproci raggi di azione (distanza non eccessiva e assenza di ostacoli, quali colline , boschi fitti, costruzioni, ecc.); - tramite ponte radio (radio trasmittente, stazione ripetitrice posta in genere su una sommità del terreno, radio ricevente), dove la stazione ripetitrice usa due frequenze, una per la ricezione e l’altra per la trasmissione. Page 29 Formazione AVPC Cesano M. - G.Costa
Le Comunicazioni
Ogni apparecchio radio ha vari canali di
trasmissione, ciascuno dei quali
ha una propria frequenza.
Prima di iniziare l’intervento i componenti della
squadra sintonizzano le loro radio sullo stesso
canale di trasmissione (isoonda) o su quello del
ponte radio.
Nelle comunicazioni isoonda tutti i componenti del
gruppo possono parlare ed ascoltare
contemporaneamente, la qual cosa è utile
nell’ascolto, ma nel parlare va evitato il
sovrapporsi delle voci.
Page 30 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaLe Comunicazioni
Il ponte radio invece permette solo una
comunicazione per volta; può essere
ascoltata da tutti ma per parlare bisogna aspettare
il proprio turno.
Le comunicazioni radio sono monodirezionali, cioè
o si trasmette o si ascolta; nelle comunicazioni
telefoniche, invece (così come nei dialoghi tra
persone vicine) si può parlare ed ascoltare
contemporaneamente.
Per entrare nella trasmissione si preme,
sull’apparecchio radio, il tasto PTT (push to talk o
press to tansmitt); se si è in isoonda si può
cominciare a parlare subito dopo il segnale di
invito a trasmettere;
bisogna invece aspettare 1 – 2 secondi se si
passa tramite il ponte, perché ci si agganci a
Page 31
quest’ultimo.
Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaLe Comunicazioni
Chi chiama, sempre tenendo premuto il tasto
PTT, pronuncia il codice radio del soggetto
con cui intende parlare
(meglio ripeterlo due volte),
Poi comunica il proprio codice.
Il destinatario risponde “Avanti” ed il codice
del trasmittente.
Si attiva il dialogo.
Al termine di esso entrambe gli interlocutori
pronunciano la parola “Chiudo” o “Fine” e la
trasmissione viene interrotta.
Page 32 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaLe Comunicazioni Inoltre è opportuno che : -tono ed intensità delle voce siano costanti; - la distanza bocca microfono non cambi, per cui se è necessario girare la testa il microfono deve effettuare lo stesso movimento (meglio adottare cuffia di ascolto munita di prolungamento con microfono stabile vicino la bocca); - la velocità del parlare non superi le 100 parole al minuto ma, se il messaggio deve essere trascritto dal destinatario, non più di 40; - i numeri vengano trasmessi per cifra, separatamente (es. 315; tre, uno cinque) 6. Per cui codificazione, vocalizzazione, parafrasi, concetti generali della teoria della comunicazione sopra enunciati, li ritroviamo declinati ed adattati alle esigenze della comunicazione radio nell’emergenza. Page 33 Formazione AVPC Cesano M. - G.Costa
Le Comunicazioni
Ogni operatore termina il proprio messaggio con la parola cambio, con la
quale invita il corrispondente a parlare a sua volta, l’ultima frase della
comunicazione termina invece con la parola fine, è la dichiarazione che da quel
momento la frequenza è lasciata libera alle altre comunicazioni.
· Ogni interlocutore, deve attendere qualche istante prima di parlare in modo
da lasciare uno spazio fra una frase e l’altra in caso di inoltro di chiamate urgenti
secondo la procedura successivamente descritta.
· È bene ricordare sempre che la cortesia e l’educazione sono le regole
basilari delle comunicazioni, al di sopra di tutte le regole internazionali.
· Quando invece ci si trova a operare in territorio di intervento di
maxiemergenza per catastrofe, calamità o assistenza particolare a manifestazioni,
tutte le periferiche devono essere coordinate da un’unica centrale operativa
solitamente mobile e dislocata in prossimità del teatro d’azione.
·
Page 34 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaLe Comunicazioni Nel caso in cui la Centrale Operativa inoltri un messaggio a tutte le periferiche contemporaneamente per un avviso o un ordine di servizio, tutti gli operatori daranno conferma di ricezione, uno dopo l’altro in ordine crescente numerico o alfabetico, evidenziando eventuali difficoltà nella ricezione stessa, al termine delle conferme, la centrale interpella singolarmente gli operatori chiarendo i dubbi relativi. Queste regole sembrano severe e complesse, ma nell’emergenza, l’ordine non è mai sufficiente. Se non si segue un coordinamento preciso, a capo in poco tempo si crea la confusione totale, nella quale tutti parlano e nessuno riesce più a capire né il mittente, né il destinatario del messaggio, a scapito dell’intero intervento. Nel primo soccorso le comunicazioni hanno un significato molto più ampio della semplice trasmissione via radio. Page 35 Formazione AVPC Cesano M. - G.Costa
Le Comunicazioni
Nelle comunicazioni radio in emergenza si usano alcuni termini specifici:
AVANTI - ho ricevuto la chiamata, parla;
IN ASCOLTO – ti sto ascoltando;
RICEVUTO – ho recepito il messaggio e ne ho compreso il contenuto,
non va ripetuto;
AFFERMATIVO – invece di “sì” (troppo breve, potrebbe non essere
percepito);
NEGATIVO – invece di “no”;
INTERROGATIVO – ho fatto una domanda, aspetto una risposta;
CHIUDO o FINE– non ho altro da dire, interrompo la comunicazione;
SE NON C’E’ ALTRO – l’interlocutore che vuole chiudere il colloquio
afferma
Page 36 “chiudo” e aggiunge Formazione
“se nonAVPCc’èCesano
altro”, per sapere se l’altro non
M. - G.Costa
vuole continuare; questi, o prosegue a parlare o risponde “chiudo”.Le Comunicazioni Le chiamate devono riguardare il servizio e devono essere effettuate rispettando il codice professionale e il linguaggio radio; quindi quando usate la radio: •Non cercate di trasmettere se altri soccorritori stanno utilizzando il canale o il centralinista vi sta parlando. •Parlate nel microfono con voce normale ad almeno dieci centimetri di distanza dallo stesso. •Mantenete un tono senza enfasi ed esprimetevi con calma. •Parlate chiaramente, sforzandovi di pronunciare ogni parola in modo distinto. Nel caso che una parola sia di difficile comprensione via radio scanditela (Spelling) lettera per lettera usando il codice fonetico internazionale: Page 37 Formazione AVPC Cesano M. - G.Costa
Le Comunicazioni •Evitare l'impiego di codici e abbreviazioni a meno che non facciano parte del sistema operativo e siano sicuramente compresi dalla persona che riceve il messaggio. •Attendere di aver ricevuto il messaggio completo dal trasmettitore, non cercate di intromettervi per poter parlare. •Non usate espressioni gergali o termini sconvenienti. •Evitate i nomi propri dei coinvolti e del personale quando possibile, ma fare riferimento al numero identificativo. •La gentilezza è data per scontata nella trasmissione via radio; non utilizzate termini come "per piacere", "grazie", "ciao" e così via. •Se non comprendete qualcosa chiedete alla persona di ripetere; non fate finta di aver capito ciò che vi è stato detto se in realtà il messaggio non è stato chiaro. Page 38 Formazione AVPC Cesano M. - G.Costa
Le Comunicazioni
Per ricordare meglio
•Prima di premere il tasto per la trasmissione pensate a ciò che volete dire.
•Attendere di aver ricevuto il messaggio completo dal trasmettitore, non
cercate di intromettervi per poter parlare.
•Formulate delle frasi complete.
•Non usate un termine di cui non conoscete il significato.
•Esprimete i fatti con calma, evitando di enfatizzare.
Page 39Le Comunicazioni Convenzioni internazionali, (NATO, ICAO, IARU) definiscono modalità comuni per le comunicazioni: • terminologia • alfabeto fonetico per la pronuncia delle singole lettere e numeri • modi e protocolli tecnici per la standardizzazione delle canalizzazioni degli apparati e la distribuzione di utilizzo delle frequenze nello spettro radio Page 40
L’alfabeto fonetico ICAO -NATO
A Alfa J Juliet S Sierra
B Bravo K Kilo T Tango
C Charlie L Lima U Uniform
D Delta M Mike V Victor
E Eco N November W Whisky
F Fox-trot O Oscar X X-ray
G Golf P Papa Y Yankee
H Hotel Q Quebec Z Zulu
I India R Romeo
Page 41 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaLa trasmissione dei numeri
• i numeri che esprimono centinaia o migliaia, vengono espressi in
conformità dell’esempio seguente:
500=cinque cento 2300=due mila tre cento
• un numero che non esprime centinaia o migliaia, viene trasmesso
pronunciando una per una le cifre che lo compongono, esempi:
2385= due tre otto cinque 550= cinque cinque zero
•Le ore vengono espresse con quattro cifre, ad esempio:
Le nove e venti del mattino = 09:20 zero nove due zero
Le nove e venti della sera = 21:20 due uno due zero
In merito alla comprensibilità di ricezione è in uso una scala in quinti il
cui minimo (1/5 = un quinto) indica estrema difficoltà di ricezione e
comprensione, ed il massimo (5/5 = cinque quinti) corrisponde al
“ricevuto
Page 42
forte e chiaro” Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaLe Comunicazioni
REGOLE FONDAMENTALI
Ricordati che chi riceve il tuo messaggio non è
sul posto e non può vedere e percepire quello
che tu dai per scontato
Tu sei gli occhi, le orecchie ed il naso della
sala operativa
(es: fa freddo, piove, c’è odore di gas, serve luce, i soccorritori sono stanchi)
Page 43 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaLe Comunicazioni
IL TRIAGE dell’INFORMAZIONE
Una volta recati sul luogo dove è in atto l’emergenza per descrivere via radio
alla sala operativa la reale situazione.
La descrizione dell’evento è d'estrema importanza per chi dovrà gestire
l’emergenza:
più precise ed immediate saranno le informazioni, meglio il direttore
dell’emergenza avrà chiaro il quadro della situazione e agirà di conseguenza.
Può sembrare banale, ma gli strumenti primari per questa attività sono carta e
penna:
•Annotare la descrizione del luogo (frazione, km autostradale indirizzo)
•Prestare attenzione anche ai particolari della zona e della sede stradale per
segnalare i passaggi per i mezzi pesanti ecc.
•Descrivere il tipo di evento: terremoto, scoppio, alluvione, crollo, incidente
Page 44 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaLe Comunicazioni
IL TRIAGE dell’INFORMAZIONE
• cercare di capire e conoscere il numero delle vittime coinvolte e la loro
gravità
• controllare se vi sono pericoli collaterali, per esempio liquidi tossici o nocivi,
cavi elettrici sospesi o danneggiati, materiali con etichette o pannelli di
pericolo
• pianificare il percorso per gli eventuali mezzi di soccorso
•Ricordarsi sempre “quando”, ovvero l’ora di quando è avvenuto l’evento
Page 45 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaLe Comunicazioni
IL TRIAGE dell’INFORMAZIONE
E’ importante ricordare di trasmettere il messaggio o l’eventuale richiesta di
soccorso cercando di non tralasciare i dati fondamentali; un metodo
efficace, come riferimento, è quello di ricordare le famose 5 W del
giornalismo inglese.
Who = Chi I dati trasmessi
What = Che cosa dall’operatore
dovranno,
Why = Perché / Come rispondere a
Where = Dove queste 5 basilari
domande.
When = Quando
Page 46 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaLe Comunicazioni
QUANDO? / DOVE? / COSA? / CHI? / COME ?
Non è necessario che siano esposte nell'ordine
Il messaggio di richiesta soccorso non deve contenere
suggerimenti di carattere operativo se non dettati da competenza specifica.
Ricordarsi che le informazioni inutili occupano la frequenza e
creano confusione in chi riceve il messaggio
Discernere sempre le supposizioni dai fatti reali
e comunicare
SOLO I FATTI di cui si è a conoscenza
Page 47Le Comunicazioni
IL TRIAGE dell’INFORMAZIONE
• CHI
•Due veicoli si sono tamponati con contusioni per i passeggeri, è presente in
posto la Polizia Locale
•COSA
•Un autoarticolato ha perso il carico sulla sede stradale che risulta interrotta
nei due sensi di marcia
•DOVE
•Bovisio Masciago, strada statale 35 Superstrada Mi-Meda tra le uscite 7 e 8
•QUANDO
•Alle ore 15,00 odierne
•PERCHE’
•Sulla sede stradale vi erano parti del carico dell’autoarticolato
•COME
•Si raggiunge dalla viabilità secondaria provenienza Bovisio ingresso 8
direzione Milano
Page 48 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaLe Comunicazioni – Raccomandazioni d’uso La prima raccomandazione è di non interloquire mai tra postazione e postazione, ma fare sempre riferimento alla sala operativa di coordinamento. Solo se la stazione capomaglia o la sala operativa lo autorizza, si possono intraprendere comunicazione cosiddette “punto” “punto” tra gli operatori Se si rimane costantemente in ascolto si ha la consapevolezza di quello che sta succedendo e quindi si può evitare di chiedere informazioni su argomenti che sono già noti in quanto portati a conoscenza tramite altri interventi paralleli. Page 49 Formazione AVPC Cesano M. - G.Costa
Le Comunicazioni – Raccomandazioni d’uso La seconda raccomandazione è ricordarsi sempre che la ricetrasmittente non è un telefonino cellulare che squilla quando qualcuno ci chiama. La radio non va abbandonata ma tenuta sempre a portata di mano in modo da ascoltare tutto quello che succede e quindi poter rispondere immediatamente ad una chiamata. I segnali radio vengono riflessi, attenuati e schermati dagli ostacoli fisici, costruzioni, muri o manufatti in metallo, quindi bisogna ricordarsi di usare le radio possibilmente in campo aperto e di non toccare con le mani l’antenna, tenendola verticale. Page 50 Formazione AVPC Cesano M. - G.Costa
Le Comunicazioni – Raccomandazioni d’uso La terza raccomandazione è quella non trasmettere utilizzando il microfono esterno e l’apparato agganciato alla cintura, il rendimento della radio può diminuire fino all’80%. Lo stesso vale anche quando ci si trova all’interno di un mezzo o di un edificio e si utilizza una ricetrasmittente portatile, il rendimento può dimezzarsi. Quindi per l’utilizzo in isoonda per comunicazioni tra i componenti della squadra o tra le squadre “in vista” tecnicamente possono essere effettuate con tale modalità, ma per il collegamento tra punti diversi o il collegamento via ripetitore, è conveniente portarsi in campo aperto. Ricordate che la posizione dell’antenna è importante, è più efficace una buona antenna ben posizionata che 100 watt di potenza. Page 51 Formazione AVPC Cesano M. - G.Costa
Le Comunicazioni Page 52 52
La Rete Radio TLC della Provincia
3 RIPETITORI DIGITALI =
6 FREQUENZE UTILI
=
COM 1
DIR 1 12 DIRETTE
RIP 2
DIR 12
CMP
DIR 11 COM 2
RIP 12 DIR 3
DIR 17 RIP 4
DIR 13
S.O.P.
UNIFICATA
COM 5
DIR 9 COM 3
RIP10 DIR 5
DIR 16 RIP 6
DIR 14
COM 4
DIR 7
RIP 8
DIR 15
Page 53La Rete Radio TLC della Provincia
COM 1
COLONNA
MOBILE COM 2
SALA OPERATIVA
UNIFICATA
COM 5 COM 3
COM 4
Page 54La Rete Radio TLC della Provincia
COM 1
COLONNA
MOBILE
SALA OPERATIVA
UNIFICATA
COM5 COM 3
COM 4
Page 55LE RETI RADIO
Esigenza e infrastruttura
L'organizzazione del servizio di comunicazioni in fonia di Protezione Civile prevede la suddivisione del territorio
nazionale in 21 Centri Regionali (CR), a 18 dei quali è dato il controllo di due semiregioni convenzionalmente
denominate A e B. Per ogni semiregione devono essere disponibili due distinti vettori di comunicazione, il canale
istituzionale (IST) ed il canale dedicato al volontariato (VOL). Per la Regione autonoma della Valle d’Aosta e per le
Province autonome di Bolzano e Trento il controllo è solo per un canale istituzionale e un canale dedicato al
volontariato.
Page 56 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaLE RETI RADIO
Esigenza e infrastruttura
Complessivamente sul territorio esisteranno quindi 78 vettori radio, le cui frequenze sono allocate secondo un
piano nazionale che utilizza solo 16 canali (limitando quindi la quantità di frequenze riservate) opportunamente
distribuiti sul territorio (per evitare interferenze tra zone adiacenti).
Pertanto è necessario predisporre un sistema di trasporto per la connessione del DPC con i singoli CR. Ciascuna
connessione CR/DPC dovrà trasportare trasmissione, ricezione e criteri (PTT e Squelch) dei quattro canali
regionali. Per esigenze di comunicazione dati (tipicamente traffico radio, localizzazione, etc.) dovrà essere inoltre
assicurata la connessione LAN/WAN tra i sistemi di interconnessione del DPC e i sistemi presenti nel CR,
compatibilmente con le politiche di sicurezza di ciascuna Regione o Provincia autonoma e del Dipartimento di
Protezione Civile.
Page 57 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaLE RETI RADIO
Esigenza e infrastruttura
La Centrale Operativa del CR (C.O./CR) dovrà pertanto essere realizzata tenendo conto del requisito prioritario di
consentire la gestione centralizzata dei vettori radio da parte degli operatori locali e all'occorrenza (tipicamente per
eventi di tipo “C”), da parte degli operatori della Centrale Operativa del DPC (C.O./DPC) tramite idoneo sistema di
interconnessione ed integrazione.
È di fondamentale importanza che il sistema di interconnessione sia omogeneo tra le regioni/province autonome
per normalizzare l'impiego degli apparati su scala nazionale, minimizzare gli impatti logistici e manutentivi, e
soprattutto ridurre i tempi di intervento da parte della C.O./DPC in caso di emergenza.
Page 58 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaLa Rete Radio TLC della Provincia
DMR NXDN NXDN
Features
Icom Kenwood
Channel Capacity 2channel with 1 repeater 1 channel 6.25Khz 1 channel 6.25Khz
$ Infrastructure cost Low Mid High
Multisite Yes - IP-Site Connect No Yes –trunk mode only
Audio Vocoder AMBE+2™ AMBE+2™ AMBE+2™
Accessories Impres audio and energy No Impress No Impres
Battery life +40% extra No Improvements No Improvements
GPS Integrated in Radio Need RSM Need RSM
Applications 20 available (more than 120 No Zetron console
availability licensed partners)
Conventional/Trunk Conventional / Conventional/ Both
Page 59 Capacity plus (Mid 09) Single site trunkIl Sistema DMR come standard comune Page 60
Il Sistema DMR come standard comune MOTOTRBO è un sistema Radio Professionale Digitale a due vie in una piattaforma che combina il meglio delle radiocomunicazioni con la tecnologia digitale Page 61
Il Sistema DMR come standard comune
Messaggi di Testo Radiolocalizzazione Dispatch System
ALARM
Emergenza Telemetria / Dati Segnalazione Campo
Page 62Il Sistema DMR come standard comune
Chiarezza nella comunicazione anche a grande distanza in assenza di fruscio e disturbi
Digital Analog
Excellent
Audio quality
Coverage
Minimal Acceptable Audio Quality
Poor
Strong Signal Strength Weak
Comparazione tra i sistemi analogico e digitale
Page 63 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaIl Sistema DMR come standard comune Page 64 Formazione AVPC Cesano M. - G.Costa
Lo standard adottato Page 65 Formazione AVPC Cesano M. - G.Costa
Lo standard adottato Page 66 Formazione AVPC Cesano M. - G.Costa
Lo standard adottato Page 67 Formazione AVPC Cesano M. - G.Costa
Il Sistema DMR come standard comune
Roip, benefici e vantaggi
Radio over IP (Radio tramite protocollo Internet), acronimo RoIP,
è la specializzazione del VoIP verso le comunicazioni radio bidirezionali.
La tecnologia RoIP permette di instaurare, su una rete che utilizza il
protocollo IP, una comunicazione tra un terminale radio e altri nodi, che
possono essere:
radio,
apparati telefonici tradizionali,
telefoni VoIP,
applicazioni su computer (tra cui i cosiddetti telefoni software),
altri apparati di comunicazione accessibili mediante rete IP.
Page 68Il Sistema DMR come standard comune
Roip, benefici e vantaggi
Esistono ulteriori aspetti, di particolare rilievo nei contesti in cui la
tecnologia Radio Over IP è applicabile, che risentono in modo
straordinariamente positivo del suo impiego:
Convergenza IP per le reti radio. I vari Enti che operano per mezzo
di reti radio adottano standard di comunicazione ed apparati differenti,
spesso non compatibili nonché con una copertura territoriale limitata.
Grazie al ROIP, le comunicazioni radio possono essere distribuite
sulla rete IP indipendentemente dagli standard radio adottati e ciò
consente la comunicazione all’interno del proprio ente o tra enti
diversi, anche tra località geografiche molto distanti tra loro.
L’integrazione con il VOIP consente di far convergere sulla medesima
infrastruttura anche la gestione delle comunicazioni cellulari,
telefoniche e satellitari permettendo di estendere anche su tali reti le
comunicazioni radio.
Page 69 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaIl Sistema DMR come standard comune
Affidabilità.
La rete IP instrada il traffico su percorsi alternativi in modo naturale ed
automatico e ciò aumenta sensibilmente l’affidabilità del servizio.
L’elevato grado di scalabilità consente di allestire con rapidità ed
economia singoli punti di accesso per aumentare la capacità di
servizio e distribuirla in punti non serviti.
Delocalizzazione.
La possibilità di distribuire la comunicazione radio praticamente in
ogni punto dove esiste un telefono o un PC collegato alla rete,
consente di realizzare sale radio delocalizzate ed interconnesse, in
grado di dirigere le comunicazioni verso presidi distribuiti sul territorio.
Page 70 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaIl Sistema DMR come standard comune
Efficienza.
La convergenza IP delle comunicazioni radio consente di utilizzare, a
costi ridotti, servizi ed applicazioni che agevolano e migliorano il lavoro
degli operatori. Grazie al ROIP, gli operatori sulla rete IP comunicano
contemporaneamente con più reti radio e realizzano all’occorrenza
network interoperabili locali o distribuiti. La rete ROIP mette in contatto, in
modo del tutto trasparente, gli utenti in campo con altri utenti, siano essi
attestati su reti radio diverse o dislocati in punti raggiungibili grazie alla
connettività IP. Le dotazioni di apparati radio esistenti possono essere
utilizzate senza modifiche.I sistemi possono comunicare
automaticamente agli operatori la presenza di un collega ed il canale di
comunicazione al momento utilizzabile per raggiungerlo; attivare la
comunicazione con un semplice click di un mouse e trasferirla su una rete
radio collegata.Comunicare con semplicità, economia, in qualsiasi
contesto ed indipendentemente dagli strumenti e tecnologie in uso
migliora le capacità di cooperazione e la sicurezza degli operatori.
Page 71 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaIl Sistema DMR come standard comune
Freq 2
Analog Channel
Freq 2
MOTOTRBO Radio
Legacy Analog Radio
Analog & Digital mode
(or MOTOTRBO Radio
Analog mode)
MOTOTRBO Repeater
2-slot operation
Legacy Analog Repeater
(or MOTOTRBO Repeater
Analog mode)
User selects between Digital Repeater mode or
Analog Direct / Analog Repeater mode MOTOTRBO Radio
Analog & Digital mode
Page 72
Architettura del Sistema
Modo Ripetitore – Interoperabilità Analogico - DigitaleIl Sistema DMR come standard comune Page 73
Il Sistema DMR come standard comune
Channel = Frequency 1
Time slot = 1
Note: “Private Call” is also
known as “Individual Call”. • È possibile effettuare chiamate private da
esclusivamente tra le due radio che sono
in comunicazione senza che nessun altro
in ascolto le possa decodificare e quindi
ricevere
Target Radio
Radio ID = 001
Radio Alias = Tim
• Le chiamate private non hanno un codice
di criptazione ma uno standard peculiare
che non può essere intercettato se non
viene registrata la radio nel gruppo o nella
rete e quindi aumentano la privacy delle
comunicazioni.
Transmitting Radio
Radio ID = 002
Radio Alias = Bill
Page 74Il Sistema DMR come standard comune
Channel = Frequency 1
Time slot = 1
Group List: TG_1
Rx Group List contains = TG_1
Gruppo Digital Call è un modo per consentire ai
gruppi di condividere un canale senza distrarre e
disturbare altri utenti radio.
Sia la trasmissione e la radio ricevente deve
essere sullo stesso canale logico (frequenza e
fascia oraria).
Tra due utenti radio non è possibile l’ascolto se
sono sullo stesso canale logico (frequenza e
fascia oraria), ma su diversi gruppi.
Transmitting Radio
Radio ID = 002
Radio Alias = Bill
Page 75Il Sistema DMR come standard comune
GRUPPO 1
Attraverso il sistema
capacity plus, si mettono in
GRUPPO 2 rete tutti i ripetitori
assegnandoli al gruppo
indipendentemente dalla
frequenza di sintonia, ed
ogni operatore senza
GRUPPO 3
cambiare il canale può far
chiamata al gruppo
indipendentemente dalla
frequenza in cui sta
GRUPPO 4 operando
Rest Channel
Page 76 GRUPPO 5Il sistema nazionale e regionale delle TLC Page 77 Formazione AVPC Cesano M. - G.Costa
LE RETI RADIO
ch 05 - ch06
ch07 - ch08
ch09 - ch10
ch11 - ch12
ch13 - ch14
ch15 - ch16
ch17 - ch18
ch19 - ch20
Protocollo d’intesa per la concessione di frequenze radio tra il Ministero
delle comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della protezione civile. (G.U. del 26 ottobre 2002, n. 252)
Page 78LE RETI RADIO
ORGANIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE DELLE CONNESSIONI
B V T
V T L
A /IS
B/ /IS O
A
L
/
O
CR
…
CR CR
... 2
A/IST
CR CR A/VOL
DPC DPC B/IST
... 1
B/VOL
CR CR
3 …
CR
...
B/ B/ O T
/V IS
V IST L
A A/
L
O
Page 79 Formazione AVPC Cesano M. - G.CostaSKIPLEXNET LE RETI RADIO
CH SEMI REGIONE 1
CH SEMI REGIONE 2
CH IST PROVINCIA “A” CH IST PROVINCIA “N”
CH VOL PROVINCIA “A” CH VOL PROVINCIA “N”
SAT SAT
SAT
RADIO RADIO
RADIO
PABX PABX
PABX
S.O. S.O.
PROVINCIA “A” S.O. PROVINCIA “N”
REGIONALE
Page 80 PSTN
Formazione AVPC Cesano M. - G.Costail sistema nazionale e regionale delle TLC
Nel mondo
Il Garec ha definito un piano di frequenze da utilizzare durante le comunicazioni in emergenza
nelle 3 Regioni IARU.
Il piano aggiornato secondo le modifiche apportate nel convegno mondiali di Tokyo 2009
prevede:
In Italia
Rete d’emergenza in fonia tra Sala operativa del Dipartimento e Di.Co.Mac.
•7.045/6990
•3.643.5
Rete delle Prefetture
•Fonia 7.045-3.643
•PSK31 6.990-3.580
REGIONE1 REGIONE 2 REGIONE 3
3.760 3.750/3.985 3.760
7.060/7.110 7.060/7.240/7.290 7.060
14.300 14.300 14.300
18.160 18.160 18.160
21.360 21.360 21.360
Page 81 81Page 82
Page 83
Architettura preliminare del sistema EmerSATUtilizzo integrato delle Reti Emergenziali Satellitari e Terrestri Page 84
il sistema nazionale e regionale delle TLC
Dorsale nazionale satellitare attuale
Page 85il sistema nazionale e regionale delle TLC
Telefonia IP
Accesso ad
Internet e servizi
p.a.
Applicazioni di
E-Learning PABX
LAN
Telefonia
tradizionale
INTERNET Video-conferenza
LAN
Intranet
Page 86
Architettura di Accesso Satellitare HB6HB6
Centro Operativo Mobile
Regione Lombardia
Sale Operative C.C.S.
C.O.M. Sale Operative
PROVINCIALI PREFETTURE Sala Operativa
C.N.VV.F. Sala Operativa
D.P.C.
Regione Lombardia
Page 87il sistema nazionale e regionale delle TLC
SKIPLEXNET
CH SEMI REGIONE 1
CH SEMI REGIONE 2
CH IST PROVINCIA “A” CH IST PROVINCIA “N”
CH VOL PROVINCIA “A” CH VOL PROVINCIA “N”
SAT SAT
SAT
RADIO RADIO
RADIO
PABX PABX
PABX
S.O. S.O.
PROVINCIA “A” S.O. PROVINCIA “N”
REGIONALE
Page 88 PSTNil sistema nazionale e regionale delle TLC
Centro
Operativo
REGIONE
LOMBARDIA Centro di Controllo
TELESPAZIO - Lario
Back-up
Sistema Carrellato delle Reti
REGIONE LOMBARDIA
Terrestri
CCS Prefetture e
SO Province
Celle TETRA
Temporanee
Page 89il sistema nazionale e regionale delle TLC
• Sistema di di centralizzazione COMCenter completo di postazioni multifunzionali
radio-telefoniche integrate che consentiranno le connessioni con le strutture di
comunicazione
• Piattaforma informatica EMMA (oggi in uso presso le CO 118 lombarde) renderà
disponibili le funzionalità e le procedure operative per la gestione dei Contact
Center dell’Emergenza e delle problematiche di Pronto Intervento
• Componente rete TETRA della Sicurezza
• Apparati di Supervisione
Reti Simulcast e Reti Reti Simulcast Reti Simulcast altre
CO PC e CO Reti Raccordo Radio Forze di Polizia
Simulcast
Amministrazioni Simulcast e Telematico PL (VVF, CFS, PS, Pol.
Altre Reti Tetra prov.li
e CO 118 Pen.) e AIPO
Comune, ATM CO AIB
SCN
Nuova Rete
TETRA Sicurezza
SCN LAN WAN
IP
AVL
XCO-2020
PABX Sistema Informativo Componente
ComCenter VoIP Postazione
PSTN Gestionale Supervisione
multifunzionale
Page 90 90
Composizione della nuova CO regionale Interforzeil sistema nazionale e regionale delle TLC
SISTEMA FASE 1
SITO DI DORSAL E
TRATTA IN PONT E RADIO PL URICANAL E
ANELLO NORD
TRATTA IN PONT E RADIO PL URICANAL E
ANELLO SUD
CENT RALE OPERATIVA REGIONAL E: PL e PC
RIPETITORE SAT ELLITE DELLA PROT EZIONE CIVILE STAZZONA
POIRA
SONDRIO EDOLO
RIPETITORE MASTER DELLA PROTEZIONE CIVILE
TAMBIONE
GIUMELLO APRIC A
CH 9
CH 13 PASPARDO
BISBINO
GREMALTO
CORNIZZOLO
SITI RETE SITI RETE CAMPO DEI FIORI
LO MBARDIA LO MBARDIA
BARRO
OVEST EST BALDO
CURNO
CORNIZZOLO GREMALTO
CAMPO dei FIORI BALDO
POIRA
PIRELLI
VIGNATE
MILANO
VIA T AR AMELLI
LODI
PAVIA PORTO MANTOVANO
S.COLOMBANO
CREMONA
Page 91 91il sistema nazionale e regionale delle TLC
Aggiornamento Sostituzione di tratte
tratte PR (24) monocanale con PR (29)
Anello Nord:
capacità 64MBps
Anello Sud:
capacità 16MBps
Nuove tratte
(19)
CO regionale Interforze
sull’anello e
collegamento in dorsale
delle CO regionali
Page 92 92
La nuova Dorsale regionaleil sistema nazionale e regionale delle TLC
STAZIONI
SRB RIPETITRICI
CH ISTITUZIONI SIMULCAST
E VOLONTARI
ISTITUZIONI E VOLONTARI
Rete Uso tratte monocanale solo RETE
RETE SEMIREGIONALEOVEST
SEMIREGIONALE OVEST
provinciale per la Provincia di Sondrio SRB CH ISTITUZIONI
STAZIONI E VOLONTARI
RIPETITRICI SIMULCAST
ISTITUZIONI E VOLONTARI
ESTRETE
Sondrio M. DELLA NEVE RETE SEMIREGIONALE
SEMIREGIONALE EST
Nessun ricorso PREMADIO
SRB CH ISTITUZIONI E VOLONTARI
S. CATERINA STAZIONI RIPETITRICI SIMULCAST
a tratte MOTTA
RETE SONDRIO
ISTITUZIONI E VOLONTARI
BORMIO 3000
monocanale SRB ESISTENTI
AMMODERNAMENTO DA
CIGOLINO SASSO PRAVADINA
PRIMOLO
ALTO MONOCANALE A PLURICANALE
TIRANO
NOVATE VAL MASINO TRASFORMAZIONE DA SATELLITE A
MEZZOLA MASTER
TRIVIGNO
C.O. 118 CARNALE
STAZZONA PIANTEDO SONDRIO RETE SONDRIO MONOCANALE
CONNESSIONI
VAL CAVARGNA EDOLO UHF 450MHz
PELLIO
APRICA UHF 450MHz ININPONTE
MONOCANALE
CONNESSIONI
CONNESSIONI PONTERADIO
RADIO
(LOC MOLZANO) GRANDOLA MOIA
PIANCAVALLO POIRA SACCO MALGA DORSALEREGIONALE
DORSALE ALTA FREQUENZA
SOMMAFIUME TAMBIONE
M. MARZIO LAGO NERO
Completamento reti CAPANNA
BRUNO GIUMELLO
TORCOLA
PASPARDO
semiregionali EST e PIGRA
BOBBIO
M. ORSA M. PORA
OVEST (CH VOL e IST)
M. MOTTARONE
C.O. 118
LECCO
CESPEDOSIO
CAMPO
M. BISBINO M. CORNIZZOLO RONCOLA M. CAVALLO Riutilizzo
DEI FIORI C.O. 118
COMO M. GOI
M. BARRO M. RENA
completo dei siti
C.O. 118 MANIVA
VARESE
CARATE
M. CANTO
MERATE
MARESANA
M. GREMALTO
(LOC DOSSO DEI GALLI) già in uso alla
M. BALDO
LONATE
BRIANZA
DESIO CASATENOVO
C.O. CFS
CURNO
COLMETTA
Regione (20)
SEMINARIO SELVA
POZZOLO
PIANA
C.O. 118 MONZA C.O. 118 BERGAMO
S. GERARDO M. MADDALENA S. ZENO
NMS da CO PERO C.O. 118 MILANO
NIGUARDA
(LOC BALDO PRADA)
AREU
NIGUARDA
PIZZAMIGLIO C.O. 118 BRESCIA
Riutilizzo dei siti
Interforze VEDETTA
C.O. Interforze MI
(ROSELLINI)
PIRELLI
VIGNATE
già in uso alla
MAGENTA
C.O. Polizia Municipale
S. BABILA CASSINA CREMA Regione (70)
DE PECCHI
ROZZANO CAMPAGNOLO
MELEGNANO SORESINA
VIGEVANO
PORTO
C.O. 118 MANTOVANO
S. ANGELO LODI CODOGNO
LODIGIANO
C.O. 118 MANTOVA
C.O. 118 PIADENA
Ampliamento entro PAVIA
POLICLINICO
S. COLOMBANO
C.O. 118 CREMONA
primavera 2012 AL LAMBRO CASALPUSTERLENGO
MONTALTO PIEVE DI CORIANO
SUZZARA
CASALMAGGIORE
Possibilità
Realizzazione 11 CO Fornitura 167
riconfigurazione in
93 Amministrazioni nuove stazioni
Pagereti provinciali 93
SERRA DEL MONTE M. CALENZONE
provincialiil sistema nazionale e regionale delle TLC
Fornitura 17 PAVIA SONDRIO EST
nuove stazioni M. DELLA NEVE
PREMADIO LECCO SONDRIO OVEST
COMO BERGAMO
S. CATERINA
VARESE BRESCIA NORD
MOTTA
BORMIO 3000
BRESCIA SUD
Trasformazione di 18
stazioni da monocanale CIGOLINO
PRAVADINA MASTER STAZIONE DI
GIUNZIONE
a pluricanale VAL MASINO
PRIMOLO TIRANO CANE’
MASTER
SECONDARIO STAZIONE NODALE
NOVATE TRIVIGNO
MEZZOLA SATELLITE DI GIUNZIONE
STAZZONA CARNALE
CONNESSIONI STAZIONE
EDOLO MONOCANALE INTERNODALE DI
VAL CAVARGNA CONTROLLO DSP
UHF 450MHz
DEI FLUSSI
POIRA APRICA
PELLIO
(LOC MOLZANO) GRANDOLA PIANTEDO MALGA
MOIA
PIANCAVALLO SACCO TAMBIONE STAZIONE ESISTENTE
M. MARZIO SOMMAFIUME
LAGO NERO
CAPANNA GIUMELLO PASPARDO AMMODERNAMENTO STAZIONE
PIGRA
BRUNO
TORCOLA CONNESSIONI IN P.R.
CAMPO
BOBBIO DORSALE REGIONALE
DEI FIORI CESPEDOSIO M. PORA
M. ORSA NUOVA CONNESSIONE
CAMAROZZI
M. BISBINO
M. CORNIZZOLO RONCOLA MONOCANALE
M. CAVALLO
UHF 450MHz
M. RENA
M. MOTTARONE M. BARRO MANIVA
M. GOI MONTEVECCHIA MARESANA M. BALDO
COLMO
M. CROCE M. GREMALTO
C.O. CFS
CURNO
LONATE
POZZOLO
COLMETTA
SELVA
M. MADDALENA PIANA Riutilizzo
NMS da CO completo dei siti
Interforze, CO C.O. Interforze MI
PIRELLI già in uso alla
VIGNATE
CFS Curno (ROSELLINI)
Regione
ROZZANO
VIGEVANO
PORTO
MANTOVANO
C.O. 118 PIADENA
PAVIA
POLICLINICO S. COLOMBANO
AL LAMBRO C.O. 118 CREMONA
MONTALTO
CASALMAGGIORE
SERRA DEL MONTE
M. CALENZONE
Page 94 94il sistema nazionale e regionale delle TLC
Page 95 95
Lo scenarioil sistema nazionale e regionale delle TLC Page 96 96 Predisposizione all’interoperabilità assicurata dalla CO Interforze
Grazie per l’attenzione
…domande?
Page 97Puoi anche leggere