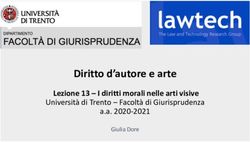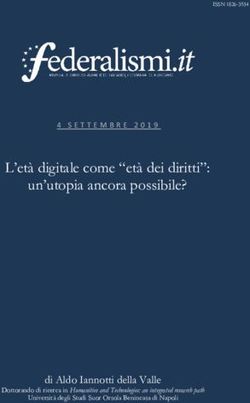La Street Art musealizzata tra diritto d'autore e diritto di proprietà
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
DOTTRINA
La Street Art musealizzata tra diritto d'autore e diritto di
proprietà
Fonte: Giurisprudenza Commerciale, fasc.5, 1 OTTOBRE 2017, pag. 781
Autori: Francesca Benatti
Sommario: 1. Premessa: delimitazione dell'ambito di applicazione di questo studio.
— 2. Le caratteristiche della fattispecie artistica «Street Art» giuridicamente
rilevanti. — 3. Inquadramento delle opere di Street Art nella legge sul diritto
d'autore. — 4. La fattispecie acquisitiva dei diritti d'autore sulle opere di Street Art:
quali differenze rispetto alla Public Art? — 5. La realizzazione delle opere di Street
Art in luogo pubblico: rinuncia o licenza dei diritti d'autore? Una prima conclusione.
— 6. Rapporto tra la creazione in luogo pubblico dell'opera e la sua prima
pubblicazione. — 7. Il problema del conflitto con il proprietario: una seconda
conclusione a favore della priorità del diritto d'autore rispetto al diritto di proprietà.
— 8. Estensione dei diritti morali. — 9. Estensione dei diritti patrimoniali. — 10. Sul
distacco e sul restauro delle opere di Street Art. — 11. Una terza conclusione:
l'inesistenza di spazi di utilizzazioni libere delle opere di Street Art da parte dei
musei. — 12. Conclusioni.
1. Premessa: delimitazione dell'ambito di applicazione di questo studio. — Il
giurista che voglia affrontare il rapporto esistente tra la Street Art e il diritto d'autore
deve necessariamente confrontarsi con due operazioni preliminari. Innanzitutto,
quella di definire i confini del fenomeno tutelato dal diritto d'autore: mi riferisco in
particolare al fenomeno artistico (1) che consiste nella realizzazione di opere nello
spazio urbano (uno spazio pubblico non convenzionale, diverso dagli spazi ufficialiquali musei e gallerie) con l'uso di vari mezzi espressivi (vernici, bombolette spray, stencil, sticker, poster, mosaici, installazioni luminose, ecc.) e sui supporti più disparati (quali muri, saracinesche, centraline elettriche, cassonetti, treni, ecc.) accomunati dall'essere di proprietà altrui. Fenomeno che nulla condivide con il c.d. «vandalismo grafico» (2) con cui troppo spesso viene confuso e da cui deve necessariamente essere tenuto distinto. Ericailcane e Blu, Bologna, 2015 Foto: Schicchi Vandalismo grafico a Bologna Foto: H.A. La seconda consiste nel chiarire a cosa riferisca il termine di «Street Art», spesso utilizzato come sinonimo di Graffiti, Writing, Urban Art, Public Art, ecc., che invece denotano fenomeni differenti (3). Il termine è interpretato ai fini di questo scritto nell'accezione specifica di arte spontanea (non commissionata), comprende il Writing, mentre esclude il riferimento ai Graffiti (scritte murali rilevanti per il mondo dell'arte non tanto come fenomeno artistico quanto forma di comunicazione sociale (4)). Tale accezione si conforma alla definizione formulata dalla dottrina artistica (5) secondo cui «Street Art consists of self-authorized pictures, characters, and forms created in or applied to surfaces in the urban space that intentionally seek communication with a larger circle of people. Street Art is done in a performative and often site-specific, ephemeral, and participatory way. Street Art is mostly viewed online. It differs from Graffiti and Public Art». Questa definizione sarà inoltre utilizzata in questa sede come base dell'inquadramento della Street Art nella legge sul diritto d'autore. Esempio di Writing: Dado, Elementi Sotterranei, 2012 Fonte: http://www.elementisotterranei.net/?artist=dado
Esempio di Graffito Fonte: http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/foto/graffiti-scritte-scienze- politiche-1.976652 La Street Art manifesta la sua rilevanza oltre che nel campo artistico anche in quello giuridico. Sempre più spesso si assiste ad operazioni di “stacco” delle opere dai muri ai fini personali di sedicenti collezionisti o di vendita nel mercato dell'arte o di esposizione nei musei. La consapevolezza del valore acquisito da talune opere in virtù della reputazione dei loro autori ha iniziato un processo di decontestualizzazione delle opere stesse che rischia di snaturare questa forma d'arte. Tale decontestualizzazione non è stata sin qui sempre lamentata dagli artisti. Il presente scritto vuole indagare non tanto le ragioni di tale inattivismo, quanto piuttosto il tipo di tutela che il diritto d'autore appresta a questo genere di opere. Per fare ciò inquadra preliminarmente la fattispecie artistica «Street Art» evidenziandone le specificità che hanno un rilevo anche giuridico. La realizzazione (i.e. permanente esposizione) in un luogo pubblico è individuata come elemento caratterizzante e differenziale delle opere di Street Art rispetto alle opere figurative tradizionali, in merito alla quale si pongono tre questioni. La prima è se la realizzazione dell'opera in un luogo pubblico denoti uno stato di “abbandono dell'opera” (o di abdicazione totale ai diritti esclusivi). La seconda è se autorizzi il proprietario del supporto a forme di disposizione materiale e giuridica dell'opera. La terza è se la realizzazione/esposizione di opere d'arte contemporanea in luogo pubblico costituisca un caso specifico di utilizzazione libera di queste opere o, in caso contrario, se esistano spazi (e quali) per le utilizzazioni libere di tali opere da parte dei musei che siano divenuti titolari di un diritto di esposizione al pubblico sull'opera medesima. Il supporto e la rilevanza che assume per le opere di Street Art in quanto opere ad esemplare unico di natura effimera (destinate cioè alla distruzione), verrà esaminato per testare la tenuta del tradizionale principio secondo cui il mezzo di esteriorizzazione dell'opera non influisce sulla disciplina applicabile. Le questioni giuridiche accennate verranno esaminate nella prospettiva di
quell'orientamento dottrinale (6) che ha dimostrato come il diritto d'autore reagisca alla materialità dell'opera, configurandosi come insieme di regole applicabili in maniera diversa a seconda che si riferiscano a opere ad esemplare unico o plurimo. L'orientamento citato interpreta come non adatto alle opere ad esemplare unico il sistema tradizionale del diritto d'autore redatto nella prospettiva del Gutemberg Model prevalentemente inteso secondo l'archetipo del diritto esclusivo di fabbricazione di copie e di rappresentazione ideato per le opere a esemplari plurimi. Per ciò riconosce in capo all'autore di opere ad esemplare unico l'esistenza di diritti patrimoniali nuovi in quanto funzionali alla fruizione dell'opera quali: il diritto di accesso all'opera, diritto di esposizione (7) e il diritto di seguito (8). 2. Le caratteristiche della fattispecie artistica «Street Art» giuridicamente rilevanti. — Le caratteristiche artistiche delle opere di Street Art, evinte dalla definizione sopra citata, che hanno un rilievo giuridico, sono le seguenti: il fatto di essere opere a) accessibili a chiunque; b) site-specific; c) ephemeral. La prima caratteristica delle opere di Street Art riguarda il loro essere condivise (9), cioè accessibili a chiunque per via della loro realizzazione in uno spazio pubblico. La portata giuridica di questa caratteristica artistica si inquadra nell'ambito del rapporto tra diritto d'autore e utilizzazioni libere, dal momento che il primo è stato interpretato come «elemento fondamentale di una dialettica tra i diritti accordati agli autori delle opere e i diritti di libera utilizzazione riconosciuti alla collettività» (10). In questa dialettica, tuttavia, il diritto d'autore si è trasformato da diritto che trova la sua giustificazione ultima nell'interesse della collettività alla promozione e diffusione della cultura (11), fondato sui requisiti di antindustrialità, in quanto diretto a tutelare l'autore contro all'editore (12), a tecnica di protezione degli investimenti connessi alla realizzazione delle opere (di cui è esempio emblematico la tutela del software e delle banche dati) (13). Il fenomeno della Street Art deve dunque essere valutato in questa prospettiva che consente «la riaffermazione del primato degli autori e del loro diritto di controllare la circolazione delle opere, decidendo se e in che modo utilizzarla o farla utilizzare» (14). Fenomeno che pare inquadrarsi nel solco tracciato dal precedente fenomeno dell'Open Source che per primo vide primeggiare la figura dell'autore e il suo ruolo decisionale sulla gestione dell'opera (15) in una prospettiva del diritto d'autore già definita come «hegeliana, cioè di continuo superamento di se stessa» (16). La Street Art rappresenta nel mondo dell'arte quello che il software Open Source ha rappresentato nel mondo
informatico: un atteggiamento di ribellione (e quindi di rottura) all'eccesivo controllo sulla gestione dell'opera da parte degli intermediari professionali (gallerie d'arte e musei, nell'uno; software houses, nell'altro). Street artists e hackers si smarcano dagli intermediari preferendo avvalersi della condivisione delle loro opere come strumento di pubblicità e di affermazione sul mercato (17) e allo stesso tempo stimolo alla creazione di nuove opere (18). Essi condividono non solo motivazioni patrimoniali, ma anche ideologiche: entrambi predicano la c.d. «cultura del dono» (19) come contrapposta alla cultura dello scambio che privilegia l'esclusiva quale incentivo alla creazione e alla diffusione della cultura. La similitudine di questi fenomeni ne suggerisce una lettura comune. La dottrina (20) d'altro canto ha già dimostrato la capacità del fenomeno Open Source di estendersi anche alle opere non software (opere letterarie, artistiche, musicali, ecc.) tutelate dal diritto d'autore, tanto da aver coniato l'espressione «mondi Open Source» (21). La riconduzione della Street Art ai mondi Open Source produce una serie di conseguenze sul piano giuridico. Una prima, è la modifica della disciplina prevista dalla legge sul diritto d'autore per le opere figurative ad esemplare unico; una seconda, è la modifica delle regole di condivisione pensate per i software ed applicate ad opere di natura diversa come quelle appartenenti al campo dell'arte (22). La seconda caratteristica è la natura «site-specific» delle opere di Street Art, che secondo la dottrina artistica (23) riveste due accezioni diverse: può denotare l'opera come «collegata direttamente ad uno spazio» (accezione propria del Writing) o come «specificamente collocata in un luogo» (accezione tipica della Street Art). Nella prima accezione, lo spazio/luogo non è solo il muro (o altro supporto come i treni, ecc.) ma «deve essere ricondotto alla dimensione più ampia della città e venire letto secondo una doppia valenza: come contesto geografico e come luogo ideale [...] la realtà urbana che circonda il muro su cui si dipinge diviene vincolo espressivo perché influenza l'azione del writer, il quale a sua volta contribuisce ad arricchire e modellare la situazione» (24). Nella seconda accezione, i parametri in funzione dei quali l'opera è creata sono vari. Innanzitutto, le caratteristiche specifiche della superficie su cui lavora, che non è uno spazio neutrale come potrebbe essere la tela da pittura; le specificità del luogo in cui l'opera viene realizzata: sia che si tratti di un muro di piccole o grandi dimensioni, in un sito dismesso o in un luogo disabitato in contrapposizione a un luogo abitato, una parete interna o una parete esterna, sia che si tratti di un supporto non murale (quali i treni, gli autobus, o le carrozze della metropolitana). A ciascuna di queste
superfici corrispondono tipologie esecutive ben precise che partono proprio da una specifica collocazione spaziale, determinante sulle scelte compositive dell'effetto globale come sui particolari. Non rileva solo la qualità materiale del supporto; ma anche quanto quest'ultimo influisca sulla collocazione del pezzo. Un esempio di un'opera definibile site-specific nella prima accezione è dato dall'immagine di Writing riportata a pagina 783; un esempio della seconda accezione è l'opera dell'artista Blu realizzata sulla facciata di un ex ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli (si veda la pagina seguente): l'opera rappresenta un uomo verde, con gli occhi vuoti, che urla mentre si strappa la maglia da carcerato (l'idea dell'urlo è trasmessa dalla corrispondenza della bocca con una finestra spalancata); o ancora una delle Maiden realizzate da Banksy a Londra nel 2007: in questo caso il pezzo, che rappresenta una critica alla borghesia, non avrebbe senso se l'immagine della cameriera fosse collocata in uno spazio mobile, poiché la finzione di tridimensionalizzazione ottenuta con la tecnica del trompe l'oeil si realizza solo se rapportata ad uno spazio fermo come un muro (25). L'essere site-specific incide sui diritti patrimoniali d'autore ed anche sui diritti morali, estendendo l'ambito di applicazione di entrambi. Blu, Napoli, 2016Fonte: streetartnews.net Banksy, Londra, 2007Fonte: trendylife.it La terza caratteristica della Street Art è la sua natura effimera, cioè temporanea, perché i fenomeni atmosferici (il vento, il sole e la pioggia) a cui le opere sono esposte le distruggono lentamente. La loro durata è variabile, ma il loro destino è certo: la distruzione dell'opera come fenomeno naturale della sua esistenza (26). Questa natura si riflette sul piano dei diritti d'autore: incide sulle modalità di utilizzazione economica della Street Art, che si avvale della riproduzione fotografica o videografica dell'esemplare originale e della sua trasmissione online come mezzi privilegiati di diffusione (27) dell'opera ma anche di testimonianza documentale della sua stessa esistenza.
3. Inquadramento delle opere di Street Art nella legge sul diritto d'autore. — Le opere di Street Art potrebbero essere ricondotte alla categoria delle «opere delle arti figurative», per così dire classiche, individuate dal legislatore nell'art. 2 n. 4 l.a. che comprende «le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia». La validità di tale inquadramento è tuttavia messa in dubbio da quattro argomenti. Il primo, costituito dalla natura di disciplina artistica autonoma riconosciuta dalla dottrina artistica (28) al Writing, secondo cui non deve essere ricondotto alla pittura o alla scultura, ma considerata «disciplina a parte», analogamente a quanto accadde in passato per l'incisione o la fotografia. La definisce in particolare come «metodo pittorico e concettuale che si origina dalla combinazione della scrittura grafica del proprio nome con il disegno» (29) che caratterizza per la presenza di tre elementi «luogo, soggetto e tecnica» che qualifica come «inscindibili» e «fondamentali per il costituirsi del Writing come disciplina» (30). Chiarisce a tal fine che il mondo dell'arte riconosce l'esistenza di una nuova disciplina artistica al darsi di tre elementi: nuovi soggetti, nuova tecnica, nuovo supporto; e ne rileva l'esistenza nel Writing: il nuovo soggetto sono le lettere, la grafia, la calligrafia (31), il font (32); la nuova tecnica è l'uso della vernice spray; il nuovo supporto è il muro «che non è più il muro come nel 1600 o nel 1400, ma che diventa il concetto di strada»: si parla di supporto-luogo, nel senso che il muro rileva non solo di per se stesso ma anche in quanto contestualizzato in un luogo che è la strada. L'interpretazione come disciplina artistica autonoma esplicitamente elaborata per il Writing è implicitamente estesa alla Street Art, pur configurandosi come un'attività artistica ontologicamente diversa. Diversi sono gli atteggiamenti che motivano l'artista nell'approccio alle due discipline: il Writing è autoreferenziale; la Street Art è comunicazione sociale (33). Analoga è tuttavia la sussistenza dei tre elementi che configurano l'autonomia di una disciplina. Il secondo argomento, che a mio parere suggerisce un inquadramento della Street Art in una categoria autonoma rispetto a quella delle opere figurative “classiche”, si desume dalla rilevanza che il supporto materiale riveste per queste opere, già definite come site-specific: in particolare rileva il legame del supporto scelto dall'artista per la rappresentazione dell'opera con l'ambiente circostante. L'emblema del riconoscimento legislativo di questa rilevanza è rappresentato dalle opere dell'architettura: Are (34) precisava che «l'architettura, come fatto tecnico e come arte del costruire, realizza l'ambiente in cui l'uomo vive ed opera e così non
solo la sua abitazione, ma il luogo dove egli lavora, sia esso fabbrica od ufficio, il tempio dove prega, la strada in cui viaggia ecc.». La Street Art non realizza l'ambiente, ma lo trasforma: è un'arte «in grado di trasformare il paesaggio urbano in un paesaggio underground che vibra dei messaggi della strada» (35). Non si vuole qui sostenere che le opere di Street Art rientrano nella categoria delle opere dell'architettura, ma che condividono con esse l'esistenza di un legame dell'opera con l'ambiente in cui vengono realizzate. Tale analogia permette di estendere alla Street Art la conclusione secondo cui «non devono quindi confondersi con [...] altre opere figurative, quadri, statue, bassorilievi e simili che non si identificano con l'ambiente nel suo complesso, ma ne costituiscono un ornamento dotato di concettuale autonomia, anche quando l'oggetto sia incorporato stabilmente nella costruzione» (36). La stessa consapevolezza che indusse il legislatore a separare le opere dell'architettura dalla categoria delle opere figurative prevedendone una categoria specifica, dovrebbe animare la separazione delle opere di Street Art. Il terzo argomento è costituito dalla natura effimera delle opere di Street Art: ossia dalla natura temporanea dell'opera e dunque dall'abbandono della perennità come componente indissociabile dell'opera ad esemplare unico. Si tratta di una tipologia di opere dell'arte contemporanea ontologicamente diversa dalle opere figurative tradizionali perché la breve esistenza dell'opera è parte della «poetica» degli artisti che realizzano le opere in contesti pubblici nella consapevolezza del loro assoggettamento a fenomeni atmosferici, all'incuria della gente, al degrado degli ambienti, all'eventuale demolizione del supporto, ecc. Il quarto argomento è suggerito dall'inoperatività nel nostro ordinamento, a differenza del sistema inglese, del principio del cosiddetto «prior qualification approach», secondo cui un'opera dell'ingegno per poter accedere alla tutela del diritto d'autore deve essere ricondotta ad una specifica categoria (37). Tuttavia ciò non esclude che nel diritto italiano, come in altri (tedesco e francese) vi sono sempre state specifiche categorie di opere dell'ingegno a cui corrispondono specifiche tutele delle categorie stesse. De iure condendo, mi pare che la Street Art stia configurando una nuova categoria di opere dell'ingegno qualificabile in termini di «opere effimere dell'arte visiva». Tale riconoscimento non troverebbe ostacoli sul piano legislativo data la natura esemplificativa dell'elenco delle opere tutelate dal diritto d'autore contenuto nell'art.
2 l.a.. Tale categoria si dovrebbe connotare di due elementi. L'uno, l'inclusione in questa nuova categoria di tutte le opere delle «arti visive» anche diverse da pittura, scultura, ecc., come ad esempio le installazioni urbane, che siano ad esemplare unico. L'uso del termine di opere di «arte visiva» anziché di «arte figurativa» rispecchierebbe in campo giuridico il cambiamento della terminologia usata nel settore artistico che ritiene il riferimento all'«arte figurativa» (38) non più rappresentativo di ciò che attualmente costituisce una «opera d'arte» (39). Questo cambiamento è d'altro canto già stato recepito sul piano giuridico dagli ordinamenti che hanno una tradizione legislativa in materia di diritto d'autore più recente rispetto a quella continentale: come l'ordinamento americano che tutela «a work of visual art» (40) e intitola “Visual Artist Right Act” (c.d. VARA) il documento con cui introduce per la prima volta nel 1990 una tutela dei diritti morali specifica per l'autore di questa tipologia di opera (41). L'altro, la specificazione che si tratti di opere «effimere»: ciò permetterebbe di estendere il suo ambito di applicazione a tutte le opere ad esemplare unico la cui natura effimera dipende non solo dalla contestualizzazione del supporto in un ambiente pubblico (si pensi a tutti i casi di Public Art quali la Land Art, la Beach Art, alle installazioni urbane di diverso genere, ecc.), ma anche dalla natura effimera dello stesso supporto dell'opera (per esempio, il corpo umano nella Tatoo Art o nella Body Art, la sabbia nella Sand Art, ecc.). La natura effimera di un'opera ad esemplare unico ne influenza il regime dei diritti di utilizzazione economica. Le opere di Street Art, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, sono tutelate in quanto creative, cioè se posseggono l'attitudine ad agire nell'animo delle persone (42) appagandone il sentimento estetico o il bisogno di conoscenza. La creatività riflette la personalità dell'autore, che organizzando le linee e i colori in una visione d'insieme conferisce originalità alla creazione artistica (43). È il criterio utilizzato dal legislatore per identificare le opere che accedono alla tutela autorale e di cui si limita a fornire un'elencazione meramente esemplificativa. Due sono gli aspetti della creatività che rilevano ai fini della tutela: il suo grado di intensità; l'oggetto su cui si esprime. Il primo è l'aspetto più controverso: la dottrina e la giurisprudenza (44) hanno a lungo dibattuto se sia sufficiente una creatività semplice oppure se sia necessaria una creatività qualificata, avendo alla fine optato per la prima soluzione. Il secondo, è l'oggetto su cui si esprime: cioè la forma dell'opera (45). Nelle opere di Street Art la forma coincide con il supporto materiale o per le sue caratteristiche specifiche o per il contesto in cui si trova: la
rilevanza giuridica del supporto è connessa alla loro caratteristica ontologica di essere site-specific. Il supporto, quale ad esempio il muro di un palazzo (ma analogo discorso vale per tutti gli altri tipi di supporto), è parte non solo della forma esterna, cioè della forma con cui l'opera appare nella sua versione originaria nella combinazione di linee, colori e volumi, di cui le caratteristiche della superficie muraria diventano parte integrante; ma anche della forma interna recando «il segno della personale conformazione data dall'autore alla materia trattata». Anche il contesto pubblico in cui si trova il supporto (46) costituisce un connotato imprescindibile di tali opere. Il supporto, grazie ad alcune sue caratteristiche o all'ambiente in cui si trova, contribuisce a rendere l'opera creativa e quindi ad attribuirle quel carattere di novità oggettiva (o originalità) che le permettono di avere accesso alla tutela. 4. La fattispecie acquisitiva dei diritti d'autore sulle opere di Street Art: quali differenze rispetto alla Public Art? — La realizzazione delle opere di Street Art pone un problema di appartenenza dei diritti d'autore sull'opera stessa (47). Il titolo originario di appartenenza è indiscutibilmente rappresentato dalla creazione dell'opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale (art. 6 l.a.): la prestazione creativa è ad un tempo a) fatto costitutivo dei diritti patrimoniali e morali riconosciuti dall'ordinamento e b) titolo della loro appartenenza originaria all'autore. Non rileva ai fini dell'attivazione della tutela che la creazione sia frutto di un'attività illecita. La questione dell'illiceità dell'opera di Street Art è irrilevante dal punto di vista tanto contenutistico quanto formalistico, non incidendo sul perfezionamento della fattispecie costitutiva dei diritti d'autore (48). L'illiceità di uno o più tra gli atti della fattispecie costitutiva dei diritti d'autore non ne pregiudica il perfezionamento: la dottrina (49) afferma pacificamente che «i diritti d'autore nascono anche quando la creazione ovvero (a fortiori) la pubblicazione dell'opera realizzino qualsiasi altro tipo di illecito civile o penale diverso dalla violazione di un diritto d'autore altrui». Diversa è la fattispecie acquisitiva dei diritti sulle opere commissionate, che non identificano il fenomeno artistico chiamato Street Art ma il c.d. «muralismo» o Public Art (50). In tali situazioni i diritti si trasferiscano ad un terzo fin dal momento della creazione, per effetto di un negozio concluso anteriormente alla creazione. La fattispecie più frequente è la realizzazione delle opere in base a rapporti di lavoro autonomo con cui un soggetto commissiona ad un autore la creazione di una o più
opere in virtù di contratti d'opera (51). Talvolta il committente esplicita i diritti di utilizzazione che intende acquistare e i fini per cui li acquista in documenti scritti: ad esempio, nel testo di bandi di concorso aperti agli artisti, che assumono la forma di «concorsi per idee (52) e realizzazione delle opere» ai fini di riqualificazione estetica di quartieri degradati; oppure nei documenti che formalizzano progetti istituzionali che intendono valorizzare il Writing e la Street Art come discipline artistiche riconosciute a livello internazionale attraverso la realizzazione di opere murali di dimensioni monumentali (il primo esempio in Italia è stato il progetto «Frontier — La linea dello stile» del Comune di Bologna (53)), in cui gli artisti sono “chiamati” a realizzare l'opera direttamente dai curatori del progetto. Daim, Bologna, 2012 — Frontier — La linea dello stile Gomez, “Melodia del sogno e della realtà”, Forlì, 2016 Fonte: Pinterest Altre volte invece l'opera viene realizzata in virtù di un accordo che non ha forma scritta (54): l'accordo verbale fa sorgere maggiori problemi di ordine probatorio; nonché il problema dell'applicabilità della norma che impone di provare per iscritto il trasferimento dei diritti di utilizzazione (art. 110 l.a.). In entrambi i casi (accordo scritto o verbale) si potrebbe porre un problema di interpretazione di volontà contrattuale in merito alla ripartizione dei diritti patrimoniali sull'opera stessa. Il criterio cui ricorrere è quello di individuare gli interessi delle parti: autore e committente. Il committente pubblico si presume che sia interessato ad assicurarsi il diritto esclusivo di utilizzare l'opera per i propri fini specifici ed eventualmente per progetti futuri. Analogo interesse potrebbe muovere il committente privato che sia un'associazione culturale. Si differenzia quindi il caso in cui il committente privato sia il titolare del diritto di proprietà del bene su cui richiede venga realizzata l'opera di Street Art, che si presume non intenda acquisirne il diritto di riproduzione o quello di diffusione, ma che voglia semplicemente vedere realizzata l'opera sul proprio bene (55). Lo svolgimento dell'operazione ermeneutica di individuazione degli interessi delle
parti è coadiuvata dal ricorso ai principi generali, quali: il principio dell'indipendenza dei diritti trasmessi (art. 19 l.a.) (56); quello della non trasmissibilità dei «futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori» (art. 119 l.a.) (57); dell'obbligo della forma scritta ad probationem (art. 110 l.a.); infine, il principio del trasferimento del diritto limitato all'oggetto e allo scopo del contratto (la c.d. Zweckübertragungstheorie) (58). Problema diverso e ulteriore è poi quello di stabilire quando e mediante quale meccanismo i diritti (trasferiti) di utilizzazione economica dell'opera sorgono in capo al committente: la dottrina (59), in assenza di una norma di legge di carattere generale, parla di attribuzione diretta ed immediata in capo al committente dei diritti patrimoniali connessi alle finalità che intende perseguire (e comunque sempre nei limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto) ma in virtù di un atto negoziale precedente (e, dunque, a titolo derivativo), e al momento in cui l'opera viene ad esistenza. La committenza infine può rivestire le caratteristiche delle fattispecie disciplinate dall'art. 11 l.a. (60): cioè di opere create e pubblicate sotto il nome e per conto e a spese delle amministrazioni dello stato, delle province e dei comuni; oppure di enti privati che non perseguano scopo di lucro, salvo che non sia intervenuto un diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate. La dottrina prevalente (61) riconosce nella norma il riferimento ad opere dell'ingegno create nell'adempimento di una prestazione di lavoro subordinato o di un contratto di lavoro autonomo a favore di questi enti. Interpreta la locuzione «sotto il loro nome» evidenziandone due profili: uno sostanziale e l'altro formale (62). Da un lato, costituisce una sorta di rafforzamento dell'esigenza che l'opera sia creata e pubblicata «per conto» dell'ente, riconducibile ad una assunzione di responsabilità di un'opera espressamente richiesta (i.e. commissionata). Dall'altro rinvia alla presenza del nome dell'ente sull'opera con modalità tali da far emergere che la pubblicazione avviene «sotto» questo nome, negando la rilevanza della presenza sull'opera del solo nome dell'ente committente. Riconosce dunque anche nella fattispecie in esame la validità del principio generale dettato dall'art. 6 l.a. che imputa la qualità di autore unicamente alla persona fisica che l'ha creata pur in mancanza di una sua menzione espressa sull'opera. Contraddice le isolate pronunce giurisprudenziali (63), frutto di una dottrina (64) risalente al tempo della Relazione al progetto di legge sul diritto d'autore, che identificava le amministrazioni come
soggetti originari del diritto d'autore in quanto creatori basandosi su un'interpretazione letterale dell'art. 8 l.a. secondo cui è autore chi sia indicato come tale nelle forme d'uso. In questa prospettiva la presenza del nome dell'ente sull'opera veniva considerata corrispondente a quella del nome del creatore e quindi interpretata come richiesta dalla legge in quanto attestazione ed assunzione della paternità dell'opera. 5. La realizzazione delle opere di Street Art in luogo pubblico: rinuncia o licenza dei diritti d'autore? Una prima conclusione. — L'inquadramento delle opere di Street Art sotto la tutela del diritto d'autore pone la necessità di risolvere il problema (che è anche un aspetto peculiare) del regime di utilizzazione cui sono assoggettate queste opere. Mi pare che le interpretazioni in campo siano due. E che si tratti tra l'altro di interpretazioni alternative ma pacificamente coesistenti. A) La prima, che interpreta la realizzazione dell'opera in un luogo pubblico come atto di “abbandono dell'opera” da parte dell'autore: si tratta di una rinuncia abdicativa dei diritti sulla sua opera, discendenti dalle sue qualità di autore, ad eccezione dei diritti morali, e quindi limitatamente a quelli di utilizzazione economica dell'opera. La rinuncia non si interpreta in questo caso nell'accezione di semplice traslazione di diritti, i quali sono quindi ceduti a titolo gratuito; ma come rinuncia incondizionata ed assoluta, in quanto l'autore pone a disposizione della collettività i suoi diritti di utilizzazione economica perché la sua opera possa essere liberamente utilizzata. Piola Caselli si è costantemente (65) pronunciato in senso dubitativo sulla possibilità che la rinuncia costituisca un modo assoluto e definitivo di estinzione dei diritti d'autore. E anche Giannini (66), che pur si era espresso in senso favorevole alla soluzione della questione, distingueva tra rinuncia espressa e tacita dubitando dell'ammissibilità di quest'ultima: «Mancando la pratica possibilità di renderla nota, non so come possa divenir praticamente operante. D'altra parte la rinunzia fatta tacitamente, cioè non agendo contro colui che utilizza l'opera, anche se ripetuta più di una volta, non può interpretarsi come una generale rinuncia tacita, perché non vale che nei riguardi dei beneficiati, ma come semplice rinunzia singola». La rinuncia abdicativa dei diritti d'autore è una scelta tipica di quegli artisti che ripudiano il diritto d'autore come scelta ideologica (cioè di quegli artisti che sono “attivisti politici” quali Blu, o Banksy che qualifica la propria arte come Guerrilla Art
ed ha coniato la frase simbolo «Copyright is for loosers»). Questi artisti tutelano le loro opere non con azioni giudiziali ma per fatti concludenti e con l'ausilio dell'azione della comunità di persone a cui hanno donato le proprie opere (i.e. i residenti del quartiere in cui si trova l'opera realizzata dall'artista). Ciò dimostra come la rinuncia abdicativa non configuri una forma di estinzione dei diritti d'autore. B) La seconda, che lo interpreta come «convenzione atipica gratuita» (67): una licenza non esclusiva senza limiti temporali e territoriali e a titolo gratuito di una serie di facoltà patrimoniali dell'autore, secondo il modello di «licenza» adottato per il software «Open Source» (68). La licenza si concretizza nell'instaurazione di un regime autorizzatorio (e quindi non abdicativo) delle prerogative autorali (69). Implica solo l'attribuzione di una facoltà d'uso per determinate finalità, quale la divulgazione dell'opera, ma non la cessione dei diritti. Si pone poi il problema di definire quali diritti patrimoniali siano licenziati e per quali fini, ma di questo mi occuperò nel paragrafo a ciò dedicato in cui tenterò di adeguare il modello di licenza Open Source alle opere d'arte. Il modello (o schema negoziale) di licenza Open Source cui potrebbe essere ricondotta la Street Art ha alcuni aspetti di particolare rilevanza che devono essere evidenziati: a) la gratuità di tale convenzione; e b) la tecnica del copyleft. La gratuità rileva perché mette in evidenza l'interesse dell'autore nel condividere l'opera: l'assenza della previsione di un corrispettivo aveva portato la dottrina (70) a sollevare dei dubbi sulla configurazione come licenza, che tipicamente è un atto di scambio a titolo oneroso, e quindi necessitava dell'individuazione di un interesse economico dell'autore meritevole di tutela a fondamento di tale atto affinché non fosse inficiato da nullità per mancanza di causa. L'interesse patrimoniale è stato poi identificato in quello «che si realizza in modo indiretto attraverso la prospettiva di concludere altri negozi collegati caratterizzati questa volta da uno scambio di prestazioni a carattere oneroso» (71). La convenzione atipica gratuita è pertanto concepita come «strumentale e teleologicamente finalizzata al perfezionamento di altri contratti in grado di garantire un corrispettivo; è dunque un negozio preordinato al conseguimento di un affare». Nel caso specifico di un'opera di Street Art, l'interesse economico dell'autore si rinviene nel meccanismo di pubblicità dell'opera che gli permette di essere notato da soggetti (privati, pubblici, ma anche da collezionisti o galleristi o istituzioni museali) che gli possono offrire occasioni di lavoro in termini di commissioni di altre opere (72) o mostre in cui poterle esporre,
rientrando così delle spese sostenute per la realizzazione gratuita delle opere spontanee. La tecnica del copyleft è il sistema ideato nel modello di licenza Open Source per proteggere il titolare delle opere dal rischio che terzi fruitori convertano le opere rilasciate sotto una licenza non restrittiva in opere proprietarie. Il rischio è impedito attraverso l'imposizione a coloro che accedono all'opera di renderla disponibile a loro volta: si crea così un sistema di licenze basato sull'utilizzo di una serie di prerogative del diritto d'autore. Il copyleft, inteso come imposizione di certe regole di utilizzo dell'opera, costituisce quindi sempre esercizio di un'esclusiva d'autore e quindi del copyright (73). Una prima conclusione mi pare sia possibile formulare in merito al primo dei problemi configurati nell'introduzione a questo scritto: l'inquadramento dell'atto dell'artista come ipotesti alternativa di rinuncia all'esercizio dei diritti d'autore o licenza del proprio diritto d'autore non incide sull'esistenza del diritto d'autore dal momento che entrambe le ipotesi la presuppongono. Questo aspetto si riflette sulla tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore che è valida anche nel caso in cui l'autore decida di non commercializzare l'opera e di concederla a chiunque in uso in forma gratuita (74). 6. Rapporto tra la creazione in luogo pubblico dell'opera e la sua prima pubblicazione. — Le opere di Street Art dal punto di vista soggettivo sono opere anonime (75). La rilevanza di questo dato soggettivo si manifesta sul dies a quo dell'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera: la cui durata secondo il dettato dell'art. 27 l.a. è di settant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata (76). Diventa allora determinante interpretare il concetto di «prima pubblicazione» dell'opera, che l'art. 12 co. 3 l.a. definisce come «la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione» (77). La prima pubblicazione dell'opera di Street Art coincide con la sua realizzazione che è contestualmente una forma di esercizio del «diritto all'esposizione al pubblico»: diritto, che nel silenzio della legge sul diritto d'autore, è riconosciuto dalla dottrina (78) come forma di sfruttamento tipica delle opere dell'arte figurativa ad esemplare unico. Tale dottrina legittima dal punto di vista sistematico un'interpretazione estensiva dell'art. 15 l.a. (79), che rende oggetto di diritti di esclusiva le attività (di rappresentazione, esecuzione, recitazione) con cui
talune opere (opere drammatiche, drammatico-musicali, coreografiche o pantomimiche, ecc.) vengono comunicate ad un pubblico presente, alle esposizioni di esemplari originali di opere figurative. L'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 15 alle opere delle arti figurative permette di colmare la disparità di trattamento delle facoltà riservate all'autore di questa tipologia di opere rispetto a quelle esercitabili su altre opere. È bene ricordare che la ricostruzione della dottrina citata partiva dall'esame di un caso diverso da quello che qui ci occupa: era il caso in cui l'autore avesse ceduto l'esemplare originale ad un terzo che poi si arrogasse il diritto di autorizzarne a terzi l'esposizione al posto dell'artista. In quel caso il riconoscimento del diritto di esposizione in capo all'autore era lo strumento eletto a risolvere il conflitto tra autore/cedente e proprietario/cessionario dell'opera in merito allo sfruttamento economico dell'opera: attribuiva all'autore il diritto di autorizzare o negare l'esposizione quale forma tipica di sfruttamento dell'opera figurativa ad esemplare unico, garantendogli la possibilità di decidere dell'aumento del numero dei fruitori che essa comporta. Questa interpretazione si basava sulla teoria elaborata da Sarti che individua il fondamento comune delle esclusive nel potere del titolare di decidere le dimensioni di disponibilità dei beni protetti (80). Il caso della Street Art è diverso: l'autore non vende l'esemplare unico dell'opera al proprietario del supporto (il quale ne risulterà comunque proprietario in base alle regole della specificazione (81)), ma realizzando l'opera sul bene di sua proprietà lo autorizza implicitamente ad esporre l'opera ivi ritratta: gli attribuisce una licenza avente ad oggetto il diritto di esposizione dell'opera stessa. Nonostante la differenza fattuale, la ratio sottesa alle due fattispecie è comune: garantire all'autore la possibilità di determinare le dimensioni di disponibilità dell'opera da parte del pubblico, che trova la sua massima estensione nell'esposizione in un luogo accessibile a chiunque. Occorre però aggiungere che un'interpretazione del diritto di esposizione “in chiave Open Source”, e quindi avente ad oggetto un'opera d'arte la cui esposizione pubblica ne consente una fruibilità diacronica da parte di un numero elevato di soggetti, suggerisce a mio parere una interpretazione estensiva di questo diritto come espressione del più ampio del diritto di comunicazione dell'opera ai sensi dell'art. 16 l.a. (82). La dottrina (83), d'altro canto, ha già dimostrato come questo diritto possa investire tutte le opere e le modalità più svariate della loro comunicazione, inclusa l'esposizione di esemplari originali (ad esempio le esposizioni presso gallerie, musei, alberghi, banche, ecc.).
7. Il problema del conflitto con il proprietario: una seconda conclusione a favore della priorità del diritto d'autore rispetto al diritto di proprietà. — L'inquadramento delle opere di Street Art come opere ad esemplare unico si caratterizza ulteriormente per la coesistenza di due elementi. Primo, l'importanza dell'unicità dell'esemplare originale che è data dall'essere fissata manualmente dall'artista sul supporto e che gli attribuisce «un valore artistico, documentaristico e quindi economico incomparabilmente superiore a quello delle eventuali copie» (84). Secondo, il fatto che la disponibilità dell'esemplare unico è tipicamente del proprietario del supporto: ciò potrebbe indurlo a rivendicare il diritto di mantenere l'unicità dell'esemplare, impedendo l'accesso all'opera in lesione del diritto esclusivo dell'autore di decidere le dimensioni di disponibilità dell'opera. Questi elementi configurano il rischio dell'insorgenza di un conflitto tra autore e proprietario. Il problema si è recentemente posto nel nostro ordinamento per diversi casi di “abuso” dei diritti di proprietà sull'opera: che si può configurare come “diretto” se posto in essere dai proprietari che rivendicano il diritto di godere in via esclusiva dell'opera a danno della collettività; o “indiretto” se autorizzano altri soggetti, tipicamente i musei (quindi imprese culturali), a porre in essere forme di sfruttamento economico dell'opera, quali lo stacco o il restauro, in base ad asserite motivazioni di “conservazione” di queste opere effimere. Ciò detta la necessità di definire se l'esercizio del diritto d'autore, che si esplica su una cosa su cui insiste il diritto di proprietà altrui, possa costituire un limite a tale diritto di proprietà. I criteri cui affidare la soluzione del conflitto non possono essere rinvenuti sul piano delle fonti del diritto e ricondotti ad una mera operazione di gerarchia delle stesse perché si tratta in entrambi i casi di diritti costituzionalmente garantiti (85). Il conflitto tra valori costituzionali primari, dotati dello stesso livello di protezione formale e rispetto ai quali non è rinvenibile alcuna regola di carattere generale, va dunque risolto in base alla tecnica del bilanciamento di interessi (86), che deve essere calibrata al caso di specie (87). L'unica pronuncia della Corte costituzionale in materia di proprietà intellettuale che si è occupata direttamente del fondamento costituzionale del diritto d'autore e della questione del contrasto tra diritto d'autore e diritto di proprietà è la sentenza n. 108 del 1995 (88), con cui ha respinto una questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Genova del 3 gennaio 1994 (89), in merito alla pretesa del titolare dei diritti patrimoniali d'autore di impedire ingiustificatamente il noleggio di esemplari legittimamente acquistati, pur in
presenza di praticabili soluzioni dirette ad assicurare all'autore di trarre un equo compenso da tale attività (90). La Corte ha per la prima volta dichiarato il principio di «priorità» degli interessi degli autori «a fronte degli interessi sia del pubblico degli utenti delle opere di cultura che degli operatori economici del settore» (91): ha quindi ritenuto che il «bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti» operato dalla legge nel riconoscere in capo all'autore la proprietà dell'opera ed il suo diritto allo sfruttamento economico della stessa è «in sintonia con i principi costituzionali» di cui agli artt. 33, 42, 35, 3 e 9 (92). Il significato di questa dichiarazione di principio si comprende alla luce di un ulteriore passo della sentenza in cui la Corte chiarisce che la «tutela degli autori e tutela della cultura sono [...] ragionevolmente conciliabili [...] con la libertà dell'iniziativa economica di altri soggetti (produttori, rivenditori, noleggiatori) in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e rischi» (punto 10 terzo capoverso) (93). L'affermazione lascia ipotizzare l'esistenza di una contrapposizione fra i diritti esclusivi ed i valori tutelati dall'art. 41 Cost. (libertà di impresa tutelata dalla legge antitrust). I diritti esclusivi potrebbero essere costituzionalmente legittimi se ed in quanto fondati su ulteriori norme costituzionali che giustifichino compressioni alla libera iniziativa economica altrui: possibilità rinvenuta nell'art. 42 Cost. (94) (la norma afferma che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina, tra l'altro, «i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti»). Diventa allora decisiva la considerazione se il limite costituzionale della «funzione sociale», che legittima interventi limitativi della proprietà (art. 42 Cost.), nonché quello di «utilità sociale» che delimita la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost., a sua volta presupposto necessario per assicurare un impiego commerciale al bene immateriali) debbano essere interpretati come valori contrapposti a quello della libera concorrenza o al contrario armonizzati con esso (95). A favore dell'armonizzazione si è espressa la stessa dottrina costituzionalista (96) che nell'esaminare il rapporto tra Costituzione e concorrenza, ha evidenziato come «il valore della concorrenza (...) è assurto ormai a dignità costituzionale», anche grazie al processo di integrazione comunitaria che ha determinato una modifica tacita del sistema costituzionale delle libertà economiche: attesta infatti, anche dal punto di vista storico, il passaggio da un'iniziale irrilevanza della concorrenza nel testo originario della Costituzione, ad una rilevanza interpretata in senso antimercantile per poi estendersi ad una interpretazione orientata al mercato (concorrenza come modello economico di mercato), fino addirittura ad ampliare la sua rilevanza al di fuori del mercato come principio di struttura del nostro
ordinamento; ritiene quindi che il valore della concorrenza «possa essere considerato, in alcuni ambiti, un criterio di ordinazione del conflitto fra diversi interessi rilevanti», che permette perciò «una rilettura dei limiti generali della proprietà intellettuale che tenga conto anche del valore della concorrenza»; concludendo che «l'insieme dei principi costituzionali rilevanti [...] autorizza una valorizzazione dello scrutinio antitrust della legislazione sulla proprietà intellettuale» (97). D'altro canto la dottrina industrialista (98) che ha esaminato il rapporto tra diritti di proprietà intellettuale e concorrenza da tempo propugnava un'interpretazione dei primi come coerente ai principi di concorrenzialità, rinvenendo nelle posizioni monopolistiche (99) (tra le quali si deve includere quella che il diritto d'autore riconosce al titolare del diritto e che impedisce iniziative economiche concorrenti) un sacrificio che il legislatore stesso pone alla concorrenza (intesa come possibilità di iniziative economiche alternative aventi ad oggetto il medesimo risultato) in cambio del vantaggio (100) di cui la collettività potrà godere, ritenuto a priori socialmente utile. La conciliabilità tra diritto d'autore e libertà di iniziativa economica privata evocata dalla sentenza della Corte costituzionale è quindi possibile grazie ad una lettura in chiave concorrenziale della clausola generale dell'«utilità sociale» (101) che giustifica la compressione della libertà di iniziativa economica privata «quando ciò costituisca il costo dell'innovazione culturale [...] o comunque di una scelta di politica economica che oggi privilegia la dinamicità rispetto alla cristallizzazione delle posizioni acquisite» (102). Il principio affermato dalla Corte di priorità degli interessi degli autori è stato applicato al conflitto tra diritti d'autore e diritti di proprietà su un'opera ad esemplare unico da Rosaria Romano (103), che l'ha valorizzato per riconoscere in capo all'autore un diritto di accesso all'opera contro il diniego del proprietario dell'esemplare che gli impedisca di sfruttarla economicamente. Questa opinione estende le argomentazioni della Corte costituzionale «a qualsiasi forma di sfruttamento dell'opera che avvenga utilizzando esemplari appartenenti a soggetti diversi dall'autore» (104), includendovi quindi quelle relative alle opere ad esemplare unico caratterizzate dall'assenza di un'intermediazione (volta alla fabbricazione industriale di cose). Estende quindi la priorità degli interessi degli autori rispetto all'interesse contrapposto degli «operatori economici del settore» (105), nella cui definizione fa ricadere la figura del proprietario dell'esemplare unico interessato a sfruttarne il valore patrimoniale.
8. Estensione dei diritti morali. — La valutazione dei diritti morali dell'autore di un'opera sottoposta a regime di libera condivisione porta con sé due questioni: la prima concerne la compatibilità di tale regime con il riconoscimento dei diritti morali in capo all'artista; la seconda, invece, l'impatto di tale regime sull'estensione dei diritti morali. A) In merito alla prima questione non mi pare che si possano addurre argomenti contrari all'esistenza dei diritti morali dell'opera condivisa: si tratta di diritti della personalità (106) che nascono con la creazione dell'opera, e che sono indipendenti dai diritti patrimoniali (art. 20 comma 1 l.a.) non solo in sede di esercizio ma, a monte, anche dalla loro interpretazione come casi di rinuncia o licenza (107) del diritto d'autore. B) In merito alla seconda questione, vari argomenti avvalorano un'interpretazione in senso estensivo dell'ambito di applicazione dei diritti morali. a) Il diritto di paternità di opera di Street Art estende le facoltà tradizionali (108) in cui si articola (la facoltà di identificarsi autore di un'opera; la facoltà di rivelarsi autore di un'opera; la facoltà di rivendicare la paternità dell'opera) all'ulteriore facoltà di disconoscere la paternità dell'opera che abbia subito un procedimento di stacco (cioè di trasferimento dal supporto originale ad uno nuovo) e di decontestualizzazione. Il diritto morale al disconoscimento della paternità dell'opera staccata affonda le sue radici nell'art. 20 l.a.: rinviene la sua fattispecie costitutiva nell'atto di creatività intellettuale e ha per oggetto l'esemplare originale dell'opera trasformato in copia. Non rappresenta quindi semplicemente l'esplicazione del diritto al nome o allo pseudonimo (artt. 7 e 9 c.c., che si limitano a proteggere il nome e lo pseudonimo di una persona contro loro usi non autorizzati), al regime del quale dovrebbe essere assoggettato (109). b.1) Il diritto all'integrità dell'opera estende la sua operatività al diritto dell'autore di opporsi allo stacco dell'opera. La personalità dell'autore espressa nell'opera di Street Art può essere offesa mediante l'alterazione del supporto (110). Il fatto che si tratti di un atto che incide sull'opera modificandola materialmente è argomento di per sé sufficiente ad attivare la tutela dell'art. 20 l.a. che riguarda non solo gli interessi morali dell'autore ma anche i suoi interessi di natura patrimoniale. In
Puoi anche leggere