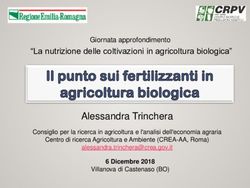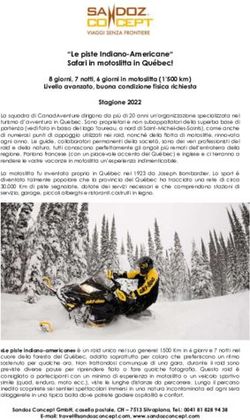La Piralide del Bosso - Cydalima perspectalis,Walker, 1959 ordine Lepidoptera, famiglia Crambidae - Regione Toscana
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Regione Toscana
La Piralide del Bosso
Cydalima
perspectalis,Walker,
1959 ordine Lepidoptera,
famiglia Crambidae
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Servizio Fitosantario Regionale2
La Piralide del Bosso è un insetto che risulta particolar-
mente dannoso al bosso (Buxus sempervirens L.), specie
ornamentale tipica del giardino all’italiana, utilizzata per
la realizzazione di siepi, bordure e sculture vegetali in
parchi e giardini sia pubblici che privati, alcuni di im-
portanza anche storica e architettonica.
Diffusione
L’insetto è originario dell’Asia ed è giunto per la prima
volta in Europa in modo accidentale, tramite piante di
Bosso infette, dapprima in Germania (2007) e in seguito
in Svizzera e Francia (2008), Austria e Olanda (2009).
Il primo rinvenimento in Italia risale al luglio 2011 in
Lombardia e successivamente in diverse altre regioni del-
la penisola.
La mancanza di fattori di controllo naturali ha permesso
un forte incremento della popolazione di questo piraloi-
deo, la cui diffusione, oltre al volo attivo degli adulti, è
agevolata dal commercio di piante provenienti da vivai
infestati.
Attualmente l’areale di diffusione del parassita è anco-
ra in espansione. L’EPPO (European and Mediterranean
Plant Protecion Organization) nel 2007, per la sua poten-
ziale pericolosità, l’ha inserito nella lista di allerta (Eppo
alert list). Nel 2011 è stata cancellata, in quanto, decorsi
più di tre anni dalla sua iscrizione, nessuna particolare
azione di carattere internazionale era stata sollecitata da
parte dei Paesi membri.
Morfologia
Di seguito s’indicano le principali caratteristiche morfo-
logiche della piralide nelle sue varie fasi di sviluppo.
Adulti
L’adulto è una farfalla con ali bianche quasi trasparen-
ti con i bordi orlati da una banda marrone; l’apertura
alare raggiunge circa i 4 cm. (foto 1). Nella fascia scura
delle ali anteriori risalta una caratteristica macchia bian-
ca; una seconda macchia bianca più piccola può essere
talvolta presente in alcuni esemplari; l’addome è bianco,3 con l’estremità marrone. Esiste anche una forma mela- nica, caratterizzata da ali completamente marroni, ma è estremamente rara. 1. foto Gaby Dorka, det. Thomas Rupp from www.schmetterling-raupe.de Uova Le uova, appiattite e di forma tondeggiante, con diame- tro di 0,8-1,0 mm, vengono deposte dalle femmine in gruppi di 5-20, sovrapposte l’una all’altra, sulla pagina inferiore delle foglie (foto 2). Inizialmente sono di colo- re giallo pallido poi, con la maturazione, evidenziano per trasparenza una piccola macchia scura corrispondente al colore del capo della larva ormai formata (foto 3). 2. foto Walter Schön, det. Colette Wagner from www.schmetterling-raupe.de
4
3. foto Colette Walter from www.schmetterling-raupe.de
Larve
Una volta schiuse le uova, le larve si diffondono sulla pian-
ta, e accrescendosi arrivano, a completo sviluppo, a circa
3-4 cm di lunghezza; lo sviluppo larvale avviene con una
successione di età variabili (5-6 stadi) caratterizzate da un
progressivo incremento delle dimensioni e da una colora-
zione sempre più intensa. Le larve mature sono di colore
verde-giallastro con capo nero lucente, caratterizzate da
striature nere e bianche disposte lungo tutto il corpo. Ne-
gli ultimi stadi il capo presenta un caratteristico disegno
bianco a forma di ipsilon (foto 4 e 5).
4. foto Colette Walter from www.schmetterling-raupe.de5 5. foto Walter Schön from www.schmetterling-raupe.de Crisalidi Le crisalidi misurano circa 2 cm e sono inizialmente di colore verde chiaro con strisce nere lungo la parte dorsale per divenire con la maturazione di colore marrone scuro. Si trovano ben nascoste all’interno della vegetazione, av- volte da un bozzolo sericeo biancastro (foto 6 e 7). 6. foto Heiner Ziegler
6
7. foto Leo Kuzmits
Biologia
In Europa l’insetto compie 3/4 generazioni l’anno. Tra-
scorre l’inverno come larva di terza età, all’interno di una
sorta di bozzolo costruito nella chioma unendo più foglie
con una tela di fili sericei. Alla fine dell’inverno, quando
le temperature rialzano (marzo) le larve ricominciano ad
alimentarsi a spese della pianta e completano la loro ma-
turazione trasformandosi in crisalide, all’interno di un
nido di tela e foglie attaccate nascosto nella vegetazione
(foto 8 e 9).
8. foto W. Schön from www.schmetterling-raupe.de7 9. foto Maspero - Tantardini, Centro MiRT - Fondazione Minoprio (IT) da pho- tos.eppo.int Dopo circa due settimane di questo stadio di crisalide, sfar- falla la prima generazione di adulti in giugno. La farfalla ha una vita di una decina di giorni, durante la quale si ac- coppia e depone le uova. Dopo uno stadio embrionale di circa 8 giorni dalle uova fuoriescono le larve di prima età, lunghe 1,5 mm circa e di colore giallo con capo nero, che si nutrono in forma gregaria della pagina inferiore delle foglie, risparmiando solo l’epidermide superiore (luglio). A partire dalla terza età, le larve, accresciute, si nutrono dell’intera foglia, rispettandone solo le nervature (aspetto “scheletrizzato”delle piante attaccate) e tessono fili sericei con cui avvolgono le foglie fino a formare una sorta di nido al cui interno si riparano; entro tale rifugio avviene la trasfor- mazione in crisalide. Lo stadio larvale si completa in circa un mese; segue una seconda generazione di adulti in agosto - settembre. Dalla bibliografia scientifica per compiere un ciclo completo (da uovo ad adulto) occorrono circa 40 giorni. In alcuni casi è stata segnalata una terza generazione lar- vale, con comparsa di adulti a inizio ottobre. Nell’ultima generazione larvale, in autunno con i primi freddi, la larva di terza età si chiude in un bozzolo tessu- to tra le foglie svernando (diapausa invernale obbligata). Nel corso dell’anno le generazioni possono parzialmente sovrapporsi, quindi la presenza di larve, pur di diversa età, è quasi continua.
8
Identificazione
Le piante di bosso attaccate subiscono defogliazione più
o meno spinta a seconda dell’intensità dell’infestazione.
Evidenziano, inoltre, un caratteristico intreccio di fili se-
ricei tra foglie e rametti (segno distintivo della presenza
dell’insetto). Le siepi colpite manifestano macchie di de-
perimento, con diffusi ingiallimenti su tutta o parte del-
la vegetazione. Tali sintomi possono a prima vista essere
scambiati per attacchi di patogeni fungini ma, a un più
attento esame, la diagnosi è più facile per la presenza delle
tracce larvali (tela bianca simile a delle ragnatele e rosura,
cioè gli escrementi delle larve) sull’intera pianta (foto 10).
10. foto JKI, Germany da photos.eppo.int
Spesso l’attacco della piralide si accompagna ad una ma-
lattia fungina causata dal fungo Cylindrocladium buxi-
cola Henricot, che contribuisce a peggiorare lo stato di
salute della pianta, incrementando il processo di dissec-
camento dell’apparato fogliare.
Danni
Il danno è causato dalle larve che, essendo molto voraci,
possono defogliare completamente le piante di Bosso in
poco tempo.
Le larve appena nate si nutrono della pagina inferiore delle
foglie, lasciando intatta la pagina superiore; le larve mature9 invece si nutrono dell’intera lamina fogliare, lasciando intatta solo la nervatura centrale, oltre ad attaccare anche la corteccia ancora verde dei nuovi rami. Nell’arco di pochi giorni posso- no provocare il rapido disseccamento di interi rami e le siepi virano dal caratteristico colore verde intenso, tipico di questo arbusto sempreverde, a una tonalità bruno ocracea o grigia- stra, con presenza abbondante tra il fogliame secco dei diversi stadi della farfalla, deiezioni larvali e teli sericei (foto 11). 11. foto Maspero - Tantardini, Centro MiRT - Fondazione Minoprio (IT) da photos.eppo.int Oltre al bosso europeo (Buxus sempervirens), di cui è par- ticolarmente appetita la varietà rotundifolia, la piralide attacca anche il bosso giapponese (B. microphylla var. Faulkner); meno frequentemente può svilupparsi a cari- co di Pachysandra terminalis, pianta tappezzante appar- tenente alla stessa famiglia. In Asia è segnalato anche su Ilex purpurea, Euonymus ja- ponicus e Euonymus alata. Tecniche E Strumenti Di Lotta E’ importante un attento e costante controllo delle pian- te di bosso nel periodo di attività dell’insetto, dalla pri- mavera all’autunno, per rilevare la presenza delle larve. In caso di deboli infestazioni si può provvedere a racco- gliere e distruggere le larve manualmente subito dopo la schiusa delle uova.
10
In caso di forti defogliazioni di siepi di bosso si ricorre
a specifici trattamenti, da effettuare alla ripresa dell’infe-
stazione dopo la diapausa invernale o su giovani larve. In
questo caso in alternativa ai mezzi chimici tradizionali
possono essere impiegati mezzi biologici.
Qualsiasi trattamento sia utilizzato per contenere l’e-
stendersi dei disseccamenti, è importante:
- agire tempestivamente, alla comparsa dei primi sinto-
mi;
- bagnare bene la chioma della vegetazione, anche al suo
interno.
Mezzi biologici
L’impiego di prodotti a base di Bacillus thuringiensis var.
kurstaki o var. aizawai dà risultati apprezzabili se si inter-
viene sulle larve giovani ai primi stadi di sviluppo, che
sono più sensibili. Il Bacillus thuringiensis è un batterio en-
tomopatogeno, efficace se ingerito dalle larve (soprattutto
quelle appena nate) e provoca la loro morte per setticemia
e paralisi in breve tempo. Questi formulati possono essere
impiegati in ambito urbano, in quanto non sono tossici
per le persone e molto selettivi, non pregiudicando la vita
degli insetti utili e i pronubi selvatici.
Il trattamento va eseguito circa 2 o 3 volte l’anno, in cor-
rispondenza della fase immediatamente successiva alla
schiusa delle uova; è importante bagnare interamente la
chioma anche al suo interno, impiegando volumi medio
alti, ed è consigliabile ripetere il singolo trattamento una
seconda volta a distanza di circa una settimana (7-10
gg), al fine di migliorare l’efficacia dell’intervento.
Nel caso di attacchi primaverili, sostenuti da larve sver-
nanti, il trattamento a base di queste sostanze potrebbe
risultare non efficace.
Mezzi chimici
Attualmente non risultano registrate sostanze attive per
l’impiego specifico contro questa avversità. Trattandosi
di un lepidottero si può far ricorso a insetticidi utilizzati
contro specie affini, autorizzati all’uso su piante orna-
mentali o in vivaio.11 E’ bene ricordare che i trattamenti chimici sono esclusi- vamente curativi e non preventivi, e devono essere quin- di eseguiti solo in presenza di infestazione. Inoltre, vista la lentezza di crescita del Bosso, può essere utile integrare la difesa chimica con opportune concima- zioni al terreno per favorire la nuova emissione di foglie e sostenere la ripresa della pianta. Tra le principali sostanze attive ad azione abbattente si ricordano: - le piretrine, a base di piretro naturale, sostanze ammes- se in agricoltura biologica; - buoni risultati si sono avuti con l’uso del Tebufenozi- de, appartenente alla categoria dei MAC, composti in- duttori di muta prematura: attivo per ingestione negli stadi larvali, simula l’ecdisone, (ormone della muta), che induce nella larva un processo di muta prematu- ra determinando una cessazione dell’alimentazione e quindi la morte dell’insetto. - i regolatori della crescita (Teflubenzuron, Difluben- zuron), registrati per l’utilizzo su piante ornamenta- li, agiscono come inibitori della sintesi della chitina. Hanno una persistenza inferiore al precedente e risul- tano efficaci su larve molto giovani, quindi il tratta- mento deve essere collocato prima della schiusa delle uova, non sempre ben individuabili come le larve. Alcune esperienze registrano risultati soddisfacenti con trattamenti eseguiti una volta al mese dai primi di giugno sino a fine settembre (nelle ore meno calde della giornata). - i piretroidi (deltametrina, cipermetrina, lambacialotri- na) e gli esteri fosforici (clorpirifos): sono prodotti ad azione neurotossica e ad ampio spettro d’azione, agi- scono per ingestione o inalazione e secondariamente per contatto; l’uso di questi prodotti può essere giustifi- cato in caso di forti infestazioni iniziali sfuggite al con- trollo, in presenza di larve ormai sviluppate, in modo da abbattere la popolazione dell’insetto. Tali prodotti sono comunque da evitare su larve ormai svernanti, protette nei loro bozzoli (settembre ottobre).
12 Servizio Fitosanitario - Difesa delle colture e delle foreste - Vigilanza e controllo
Segnalazioni
Servizio Fitosanitario Regionale
Via Pietrapiana, 30 - 50121 Firenze
Tel 055 4384076 - Fax 055 4383990
seviziofitosanitario@regione.toscana.it
www.regione.toscana.it
Nota tecnica realizzata da:
Paolo Farina, Servizio Fitosanitario Regione Toscana
Domenico Rizzo, Servizio Fitosanitario Regione Toscana
A cura della Regione Toscana - Servizio Fitosanitario Regionale
2015
Realizzazione: Direzione generale della Giunta Regionale
Agenzia per le attività di informazione degli Organi di Governo della
RegionePuoi anche leggere