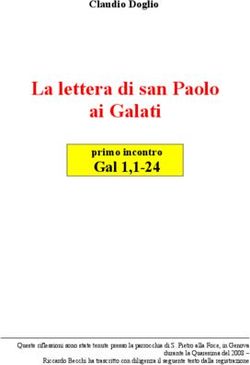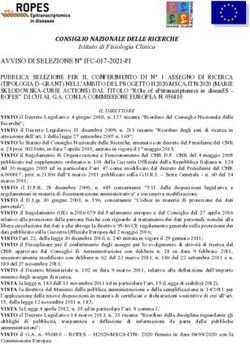ITALIAN MODERNITIES VOL.36 - PETER LANG
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
I TA L I A N M O D E R N I T I E S VOL. 36 Edited by Pierpaolo Antonello and Robert Gordon, University of Cambridge PETER LANG Oxford • Bern • Berlin • Bruxelles • New York • Wien
Innesti: Primo Levi e i
libri altrui
Gianluca Cinelli and
Robert S. C. Gordon (eds)
PETER LANG
Oxford • Bern • Berlin • Bruxelles • New York • WienBibliographic information published by Die Deutsche Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche National bibliografie; detailed bibliographic data is available on the Internet at http://dnb.d nb.de. A catalogue record for this book is available from the British Library. Library of Congress Cataloging in Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress. Cover image: G. Arcimboldo, Il Bibliotecario (1566). Skokloster Castle, Håbo (Sweden). Frontispiece image: Anonymous. Photo of Primo Levi at his desk (1960). CDEC, Milan. Cover design by Peter Lang Ltd. ISSN 1662 9108 ISBN 978-1-78997-450-8 (print) • ISBN 978-1-78997-451-5 (ePDF) ISBN 978-1-78997-452-2 (ePub) • ISBN 978-1-78997-453-9 (mobi) © Peter Lang AG 2020 Published by Peter Lang Ltd, International Academic Publishers, 52 St Giles, Oxford, OX1 3LU, United Kingdom oxford@peterlang.com, www.peterlang.com Gianluca Cinelli and Robert S. C. Gordon have asserted their rights under the Copyright, Designs and Patents Act, 1988, to be identified as the Authors of this Work. All rights reserved. All parts of this publication are protected by copyright. Any utilisation outside the strict limits of the copyright law, without the permission of the publisher, is forbidden and liable to prosecution. This applies in particular to reproductions, translations, microfilming, and storage and processing in electronic retrieval systems. This publication has been peer reviewed. Printed in Germany
Indice del volume Domenico Scarpa Prefazione xi Gianluca Cinelli e Robert S. C. Gordon Introduzione 1 Parte I Gli strumenti umani Antonio Di Meo Primo Levi e William Henry Bragg 19 Mario Porro Primo Levi e Galileo Galilei 37 Patrizia Piredda Primo Levi e Werner Heisenberg 55 Alberto Cavaglion Primo Levi e Giuseppe Gioachino Belli 73 Enzo Ferrara Primo Levi e Stanislaw Lem 87 Stefano Bartezzaghi Primo Levi e Lewis Carroll 107
viii Indice del volume Parte II La condizione umana Vittorio Montemaggi Primo Levi e Dante 127 Valentina Geri Primo Levi e William Shakespeare 143 Simone Ghelli Primo Levi e Pierre Bayle 161 Martina Piperno Primo Levi e Giacomo Leopardi 179 Damiano Benvegnù Primo Levi e Konrad Lorenz 197 PIERPAOLO Antonello Primo Levi e Charles Darwin 215 Parte III Comprendere e narrare il Lager Charles L. Leavitt IV Primo Levi e Elio Vittorini 237 Uri S. Cohen Primo Levi e Vercors 255 Sibilla Destefani Primo Levi e Charles Baudelaire 273
Indice del volume ix Stefano Bellin Primo Levi e Franz Kafka 287 Davide Crosara Primo Levi e Samuel Beckett 305 Parte IV La ricerca di sé Martina Mengoni Primo Levi e Thomas Mann 327 Gianluca Cinelli Primo Levi e Herman Melville 345 Mattia Cravero Primo Levi e Ovidio 361 Marco Belpoliti Primo Levi e Italo Calvino 381 Biografie degli autori 403 Indice dei nomi 407
Charles L. Leavitt IV
Primo Levi e Elio Vittorini1
Nel suo celebre appello per «una nuova cultura», pubblicato nel
1945, Elio Vittorini sosteneva che il fascismo aveva smentito i presunti
principi umanitari della civiltà occidentale, ossia la pretesa di conside-
rare sacra la vita umana. A prova di questa conclusione provocatoria,
Vittorini sottolineava, nello stesso saggio, l’enormità di quella che, negli
anni seguenti, sarebbe stata chiamata la Shoah. Nella seconda guerra
mondiale, scriveva, «i campi su cui si è sparso più sangue si chiamano
Mauthausen, Maidaneck [sic], Buchenwald, Dakau [sic].»2 Vivamente
scosso dall’immensità della distruzione umana in questi campi di con-
centramento e di morte, Vittorini insisteva che non sarebbe stato più
sufficiente, a livello culturale, sostenere la dignità degli esseri umani; la
cultura doveva ora assicurare la loro sopravvivenza. «Potremo mai avere
una cultura che sappia proteggere l’uomo dalle sofferenze invece di li-
mitarsi a consolarlo? Una cultura che le impedisca, che le scongiuri, che
aiuti a eliminare lo sfruttamento e la schiavitù, e a vincere il bisogno»,
si chiedeva Vittorini, ponendosi al centro di una polemica vitale non
solo sulla possibilità di una nuova cultura interventista e umanitaria, ma
anche sul valore della vita umana dopo il fascismo e il nazismo.3
Tre dichiarazioni del 1946 possono suggerire la portata e l’ampiezza,
nel contesto italiano, di questa polemica, spesso ambigua, ma sempre
1 L’autore vuole ringraziare Guido Bartolini, Damiano Benvegnù e Valentina Geri
per i loro consigli linguistici e la loro inestimabile assistenza pratica nella revisione
di questo capitolo.
2 Elio Vittorini, Una nuova cultura, «Il Politecnico», 1 (29 settembre 1945), ora in
id., Letteratura arte società, vol. 2: Articoli e interventi 1938–1965, Torino, Einaudi,
2008, pp. 234–7 (p. 234).
3 Ivi, p. 235.238 Charles L. Leavitt IV
appassionata, intorno alla figura e alla definizione dell’uomo. Durante
la guerra, affermò l’editore e giornalista Edilio Rusconi, «abbiamo visto
morire gli uomini, e forse, in quei momenti, abbiamo davvero capito che
cosa è un uomo»; dopo la guerra, sostenne il poeta Alfonso Gatto, «oc-
corre liberare gli uomini da tutte le mortificazioni e da tutte le offese»; a
causa della guerra, asserì il filosofo Umberto Segre, «il termine di “uomo”
rinasce come l’evocazione pregnante della stessa libertà.»4 Ribadire o ri-
definire il valore umano, come evidenziano tali dichiarazioni, fu inteso
come il vero e proprio obiettivo di molti intellettuali italiani del periodo
postbellico, durante il quale furono frequenti le esortazioni a «restituire
all’uomo la sua misura», a «porre sinceramente gli uomini di fronte alla
loro miseria», e perfino a «rifare l’uomo.»5 Insieme ai programmi visio-
nari – e alquanto vaghi – indicati con queste frasi, numerosi libri dell’epoca
proporranno l’avvento di un nuovo umanesimo, con titoli emblematici
come Dignità dell’uomo (Massimo Bontempelli, 1946), L’umanità al bivio
(Umberto Nobile, 1947), e Crisi dell’uomo (Remo Cantoni, 1948). Questo
presunto nuovo umanesimo si presentò come un fenomeno internazio-
nale piuttosto che strettamente italiano. In Francia, ad esempio, videro
la luce pubblicazioni quali Le Sort de l’homme ( Jacques Maritain, 1945) e
L’Existentialisme est un humanisme ( Jean-Paul Sartre, 1946), mentre The
Condition of Man (Lewis Mumford, 1944), The Science of Man in the World
of Crisis (Ralph Linton, 1945), Education for Modern Man (Sidney Hook,
1946) e innumerevoli titoli simili contribuirono a definire ciò che è stato
chiamato «l’età della Crisi dell’Uomo» nella cultura americana.6 Oggi, in
una fase culturale ben lontana dal clima del secondo dopoguerra, i suddetti
4 Edilio Rusconi, Abbiamo capito che cos’è un uomo, «L’Opinione», 13 giugno 1946,
p. 3; Alfonso Gatto, L’uomo è stato offeso, «L’Unità», 22 maggio 1947, p. 3; Umberto
Segre, Un mito dell’uomo e la realtà della forma, «La Rassegna d’Italia», 1, 9 (set-
tembre 1946): 123–30 (p. 123).
5 Mario De Micheli, Realismo e poesia, «Il ‘45», 1, 1 (febbraio 1946): 35–44 (p. 35);
Anon., Per una poesia nuova, «La Strada», 1, 1 (aprile–maggio 1946): 3–18 (p. 9);
Salvatore Quasimodo, Poesia contemporanea [1946], in Il poeta e il politico e altri
saggi, Milano, Mondadori, 1967, pp. 13–24 (p. 24).
6 Mark Greif, The Age of the Crisis of Man. Thought and Fiction in America, 1933–
1973, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2015. Tutte le traduzioni dall’in-
glese sono mie se non diversamente indicato.Primo Levi e Elio Vittorini 239
titoli possono apparire piuttosto «illeggibili […] noiosi […] inutili», così
astratte sono le loro analisi, così utopistiche le loro proposte.7 Tuttavia, il
loro significato storico non può essere negato.
Nella compagine italiana, tale “crisi dell’Uomo” fu discussa e persino
definita in gran parte nei termini forniti da Elio Vittorini, sia tramite l’ac-
corata domanda al centro del suo appello per «una nuova cultura» citata
all’inizio, sia attraverso il suo primo romanzo postbellico, pubblicato nel
1945 e intitolato, emblematicamente, Uomini e no.8 Eppure è un altro testo,
dal titolo ancora più significativo, che pone la domanda sull’uomo in modo
ancora più radicale, un testo che la critica internazionale ha riconosciuto, in
anni recenti, essere l’opera di riferimento dell’intero periodo: Se questo è un
uomo di Primo Levi, pubblicato nel 1947, due anni dopo la liberazione di
Auschwitz, dove l’autore era stato internato, come ce ne dà testimonianza
nel libro.9 Rileggere il capolavoro di Levi nel contesto dei dibattiti che si
tennero nell’Italia del dopoguerra, e rileggerlo soprattutto in confronto
con l’opera di Elio Vittorini, come farò in questo capitolo, ci aiuta a co-
gliere ancora di più l’originalità della posizione leviana e ad analizzare le
connotazioni e le conseguenze del suo rifiuto ad accettare i luoghi comuni
del cosiddetto nuovo umanesimo.10
7 Ivi, p. 11. Per una critica approfondita circa il discorso italiano in particolare, si veda
Alberto Asor Rosa, Scrittori e popolo. Il populismo nella letteratura italiana contem-
poranea, Roma, La nuova sinistra, 1965, p. 164–5.
8 Bisogna precisare che, nonostante l’appello rivolto «non ai marxisti soltanto, ma
anche agli idealisti, anche ai cattolici, anche ai mistici», il programma vittoriniano
per «una nuova cultura» – e dunque anche la sua difesa dell’«uomo» – «si situa
invece – come spiega Luperini – all’interno di un compatto blocco ideologico di
sinistra.» Romano Luperini, Gli intellettuali di sinistra e l’ideologia della ricostru-
zione nel dopoguerra, Roma, Edizioni di Ideologie, 1971, p. 56.
9 Che Levi appartenga, almeno in parte, a questo contesto culturale è stato ricono-
sciuto da parte della critica esistente. Si vedano in particolare Robert Gordon, The
Holocaust in Italian Culture, 1944–2010, Stanford, Stanford University Press, 2012,
p. 113–15; Domenico Scarpa, La specie umana negli anni del silenzio, «L’indice dei
libri del mese», 20, 7 (1997): 31–2 (p. 32).
10 Che Levi non accetti le «sofisticherie da filosofi» di un’epoca di rinato umanesimo
e un discorso appassionato sull’«uomo», è stato precisato recentemente in Nunzio
La Fauci, “Se questo è un uomo” e “I sommersi e i salvati”: significati e significanti,
in Da Primo Levi alla generazione dei “salvati”. Incursioni critiche nella letteratura240 Charles L. Leavitt IV
Le connessioni e i conflitti tra la posizione di Primo Levi e quella di Elio
Vittorini, per quanto riguarda il discorso postbellico sulla “crisi dell’Uomo”,
sono stati oggetto di un recente dibattito. È emerso che, mentre Levi stava
cercando un editore per il manoscritto che sarebbe diventato Se questo è
un uomo, Vittorini aveva promosso la pubblicazione italiana del libro sulla
Shoah di Robert Antelme, L’Espèce humaine, che era uscito in Francia nel
1947. Questo nuovo elemento ha diviso la critica: poiché il tema e il titolo
dell’opera di Antelme erano simili a quelli di Se questo è un uomo, alcuni
critici, negli ultimi anni, hanno rimproverato Vittorini di non aver rico-
nosciuto la superiorità dell’opera di Levi, mentre altri hanno ribattuto che
riconoscere l’importanza di Levi non debba implicare necessariamente la
denigrazione né di Antelme né di Vittorini.11 Piuttosto che riaprire questa
polemica, in questo capitolo intendo invece rinquadrarla, partendo dal
fatto che Antelme e Levi non furono gli unici scrittori, nell’immediato
dopoguerra, ad adottare titoli simili. La mia analisi mira quindi a essere
non solo comparativa ma anche contestuale, esaminando insieme l’opera di
Vittorini e di Levi e, allo stesso tempo, raffrontando i loro testi con quelli
di altri loro contemporanei che collettivamente parteciparono in un di-
battito culturale sulle implicazioni della Shoah in relazione alla dignità – e
perfino la natura – umana.
Prima di arrivare nel Lager, ha scritto Mino Micheli nella prefazione
a Ecce Homo … Mauthausen (1946) di Gino Gregori – un libro il cui titolo
cristologico dichiara una fede imperitura nella salvezza umana nonostante
l’attuale crisi dell’uomo –, i prigionieri «erano uomini»; appena imprigio-
nati, «divennero dei numeri, ogni personalità scomparve.»12 Allo stesso
modo, in Sotto gli occhi della morte da Bolzano a Mauthausen (1946), Aldo
Pantozzi ha scritto che, dal momento in cui entrarono nel Lager, per loro
italiana della Shoah dal dopoguerra ai giorni nostri, a cura di Sibilla Destefani,
Firenze, Giuntina, 2017, pp. 33–48 (p. 35). Il mio capitolo mira ad approfondire
ulteriormente quest’intuizione.
11 Questa polemica, così come la storia editoriale che la ispirò, sono acutamente rias-
sunte in Domenico Scarpa, Storie di libri necessari: Antelme, Duras, Vittorini, in id.,
Storie avventurose di libri necessari, Roma, Alberto Gaffi, 2010, pp. 165–202.
12 Mino Micheli, Presentazione, in Ecce Homo … Mauthausen. Testimonianze del pit-
tore Gino Gregori, Milano, Edizione Stucchi, 1946, pp. 11–14 (p. 11–12).Primo Levi e Elio Vittorini 241
«stava iniziando […] la vita dell’animale-uomo»; aggiungendo poi che
quando i loro nomi furono sostituiti con numeri, «l’uomo bestia era ormai
classificato.»13 Nel suo Triangolo rosso (1946), Paolo Liggeri ricorda come,
appena arrivato nel campo, vedendo gli altri prigionieri ammassati nel cor-
tile, esclamò con un singhiozzo: «sono uomini, uomini […]. No, veramente
erano uomini. Adesso non lo sono più, sono morti; anche se respirano
ancora, uomini non sono più.»14 La funzione disumanizzante del Lager
veniva sottolineata non solo nei libri, come quelli appena citati, ma anche
nei giornali e nelle riviste dell’epoca. «Non sono uomini, ma allucinati
automi scaturiti da un incubo pazzesco, fantasmi della notte, larve in cui
si è spenta perfino l’intelligenza», riporta la didascalia sotto una foto dei
prigionieri del Lager pubblicata sulla rivista Crimen nel 1945.15 Dopo la
Shoah, Dante Lattes chiese drammaticamente nella rivista ebraica Israel,
«dobbiamo ancora avere fiducia negli uomini?»16 E Sergio Forni, nei suoi
Ricordi di Mauthausen, pubblicati sull’Indicatore partigiano nel 1948, ha
testimoniato come «la [loro] stessa umanità veniva debilitata e avvilita, in
un quotidiano, metodico e progressivo inasprimento della prigionia.»17
Questa proliferazione di testimonianze e analisi almeno superficialmente
simili all’opera di Levi può aiutare a spiegare, piuttosto che la preferenza
che Vittorini diede ad Antelme, il motivo per cui l’originalità di Se questo
è un uomo non venne immediatamente riconosciuta nell’Italia postbellica.
Più precisamente, la diffusione di queste riflessioni può aiutare a capire
perché l’opera di Levi fu rifiutata da Einaudi, una decisione che da decenni
13 Aldo Pantozzi, Sotto gli occhi della morte da Bolzano a Mauthausen, Trento, Museo
storico in Trento, 2002, p. 56 e 70 (prima ed. Bolzano, Opera pro orfani persegui-
tati politici e derelitti, 1946).
14 Paolo Liggeri, Triangolo rosso. Dalle carceri di S. Vittore ai campi di concentramento
e di eliminazione di Fossoli, Bolzano, Mauthausen, Gusen, Dachau. Marzo 1944 –
maggio 1945, Milano, La Casa, 1946, p. 387.
15 Pifferi-Anzaldi, L’esposizione dei delitti nazisti al “Grand Palais” di Parigi,
«Crimen», 21 settembre 1945, pp. 4–5 (p. 4).
16 Dante Lattes, Dobbiamo ancora avere fiducia negli uomini?, «Israel», 12 aprile 1945,
p. 3, citato in Manuela Consonni, L’eclisse dell’antifascismo. Resistenza, questione
ebraica e cultura politica in Italia dal 1943 al 1989, Roma-Bari, Laterza, 2015, p. 25.
17 Sergio Forni, Ricordi di Mauthausen, «L’indicatore partigiano», 1, 4 (luglio–
agosto, 1948): 10.242 Charles L. Leavitt IV
numerosi critici e studiosi, nonché vari collaboratori della stessa casa edi-
trice, hanno deplorato.18 È probabile che avessero considerato quella di Levi
come l’ennesima prova di un discorso già da qualche tempo largamente
affermato. D’altronde, siccome alcuni degli stessi einaudiani avevano af-
fermato quel discorso, riflettendo sul destino umano dopo il fascismo nelle
proprie opere postbelliche, è pure possibile che Levi venisse sottovalutato
non perché sembrava (erroneamente) privo di originalità ma invece perché,
per motivi che esamino in questo capitolo, appariva piuttosto anticonfor-
mista nei loro confronti. Natalia Ginzburg, per esempio, accusata di aver
respinto l’opera di Levi, aveva pubblicato Il figlio dell’uomo nel 1946. «Non
guariremo più di questa guerra», aveva scritto la Ginzburg in quel saggio,
«ma noi siamo legati a questa nostra angoscia e in fondo lieti del nostro
destino di uomini.»19 Un altro einaudiano, Cesare Pavese, che la Ginzburg
stessa incolpò per la decisione di non aver pubblicato l’opera di Levi, aveva
sostenuto, nel suo Ritorno all’uomo, stampato nel 1945, che per gli scrittori
postbellici «il compito è scoprire, celebrare l’uomo di là dalla solitudine,
di là da tutte le solitudini dell’orgoglio e del senso. […] Una cosa si salva
sull’orrore, ed è l’apertura dell’uomo verso l’uomo.»20 Oltre a Pavese e la
Ginzburg, fra gli intellettuali einaudiani che avevano partecipato al discorso
sulla “crisi dell’Uomo” prima che la casa editrice offrisse il proprio giudi-
zio sull’opera di Levi, merita particolare attenzione Felice Balbo, grazie ai
suoi libri L’Uomo senza miti (1945) e Il laboratorio dell’uomo (1946). «Tra
i brandelli e i ruderi di una catastrofe presente», aveva teorizzato Balbo nel
secondo di questi due importanti volumi, «l’uomo cerca affannosamente
la sua perduta immagine.»21 È difficile immaginare che tali teorizzazioni,
sostenute non solo da Balbo ma da molti suoi colleghi einaudiani e dai loro
18 Si veda in particolare Marco Belpoliti, Primo Levi di fronte e di profilo, Milano,
Guanda, 2015, p. 111–19. Sul ruolo di Vittorini, cfr. Luisa Mangoni, Pensare i
libri. La casa editrice Einaudi dagli anni trenta agli anni sessanta, Torino, Bollati
Boringhieri, 1999, p. 455 n77 e 689 n286.
19 Natalia Ginzburg, Il figlio dell’uomo, «L’Unità» (1946), ora in Opere, Milano,
Mondadori, 1986, pp. 835–8.
20 Cesare Pavese, Ritorno all’uomo, «L’Unità», 20 maggio 1945, ora in La letteratura
americana e altri saggi, Torino, Einaudi, 1991, pp. 197–9 (p. 198).
21 Felice Balbo, Il laboratorio dell’uomo, Torino, Einaudi, 1946, p. 11.Primo Levi e Elio Vittorini 243
contemporanei affiliati a numerose altre case editrici, riviste e istituzioni
culturali, non abbiano determinato, almeno in parte, la lettura – e più
ancora la mancata comprensione – dell’opera di Levi.
Alla fine, quindi, non fu Einaudi, ma la piccola casa editrice De Silva,
diretta da Franco Antonicelli, che accettò di pubblicare l’opera di Levi
in una tiratura di 2.500 copie nel 1947. Fu lo stesso Antonicelli, inoltre,
a scegliere come titolo Se questo è un uomo, traendolo da un verso della
poesia con cui inizia il libro, e preferendolo sia a Sul fondo, titolo del ma-
noscritto citato sulla rivista L’Amico del popolo che ne aveva pubblicato
per la prima volta degli estratti, che a I sommersi e i salvati, titolo pre-
ferito da Levi stesso.22 Come Antonicelli avrebbe poi spiegato, citando
e interpretando quella poesia per chiarire la sua decisione, «il titolo Se
questo è un uomo implica una domanda […] e una risposta»: «La risposta
è l’orrore».23 Nell’analisi di Antonicelli, la Shoah fu «un delitto contro
l’essenza umana» e Levi, nel documentare questo delitto, forniva «la cro-
naca del degradamento da uomo a qualcosa di meno fiero di un animale,
cioè un sottouomo.»24 Sembra ragionevole pensare, quindi, che il titolo
sia stato scelto intenzionalmente dal curatore per collocare Levi all’interno
della polemica italiana sulla “crisi dell’Uomo”, una polemica, bisogna
aggiungere, alla quale Antonicelli stesso aveva partecipato attivamente,
anche se irregolarmente.25 Sembra ancora più giustificato pensare che la
partecipazione di Antonicelli a quella polemica, il suo contributo a uno
dei dibattiti più ferventi dell’Italia del dopoguerra – «il momento più
alto di [Elio] Vittorini», come più tardi lo avrebbe ricordato – sia stato
22 Questa storia è stata attestata sia da Levi (Primo Levi: capire non è perdonare, Opere,
III: 611), sia da Antonicelli. Corrado Stajano, Ritratto critico, in Franco Antonicelli,
La pratica della libertà. Documenti, discorsi, scritti politici 1929–1974, Torino,
Einaudi, 1976, pp. vii–lxxxii (p. xxxviii).
23 Franco Antonicelli, L’ultimo della catena, «La Nuova Stampa», 31 maggio
1958, p. 3.
24 Id., Calendario di letture, Torino, ERI, 1966, p. 399; id., Piccolo libro di lettura,
Torino, ERI, 1957, p. 84.
25 Si vedano, ad esempio, id., Il diritto di risorgere, «L’Opinione», 29 aprile 1945; id.,
Perché lascio “L’Opinione”, «L’Opinione», 5 aprile 1946 (entrambi ora in id., La
pratica della libertà, cit., pp. 26–9 e 37–9 (p. 27 e 37).244 Charles L. Leavitt IV
influenzato dalla sua lettura di Uomini e no.26 Questo romanzo, avrebbe
spiegato successivamente Antonicelli, pose una serie di domande impegna-
tive e inevitabili a cui tutta la cultura italiana era chiamata a rispondere.
Le domande di Vittorini sono in un campo più vasto, in un ordine più alto, metafisico
e, direi, religioso: non dov’è la ragione, dove il torto, dove il giusto, dove l’ingiusto, ma
perché avvengono certe offese e certe violenze, perché si fanno e perché si subiscono,
che senso hanno, e perché nell’uomo vive e il persecutore e la vittima. Interrogativi
che non possono avere risposta, che rimangono astratti, che, invece di raggiungere
una più profonda consapevolezza, rappresentano un’inquietudine, uno smarrirsi
della coscienza. E tuttavia significano assai bene lo sgomento (religioso, insistiamo)
dell’animo dinanzi al mistero del destino e della partecipazione dell’uomo.27
Sembra plausibile concludere che questa lettura appassionata e impegnata
di Uomini e no riveli quei sentimenti che portarono Antonicelli non solo
a pubblicare Primo Levi, ma a intitolare la sua opera Se questo è un uomo.28
Se l’opera di Vittorini abbia esercitato un’influenza su Levi stesso, come
sembra aver fatto con il suo editore, è una domanda diversa ma forse in
qualche modo correlata. La critica sostiene ad esempio che esista una certa
corrispondenza tra gli «astratti furori» che caratterizzano il protagonista
all’inizio di Conversazione in Sicilia, il romanzo vittoriniano pubblicato
nel 1941, e l’«astratto senso di ribellione» che, secondo Levi, motivava la
propria partecipazione alla Resistenza, come ha spiegato nell’edizione ei-
naudiana di Se questo è un uomo, pubblicato nel 1958.29 Interesse di questo
26 Id., Primo memoria di Vittorini, narratore e uomo di cultura, «Radiocorriere», 43,
11 (13–19 marzo 1966): 14–15.
27 Id., Uomini e no (1945–1965), «Radiocorriere», 42, 47 (21–27 novembre 1965): 22.
28 Sono d’accordo con Alberto Cavaglion quando sostiene: «che Antonicelli sce-
gliendo quel titolo volesse stabilire un nesso con il libro di Vittorini Uomini e no,
non mi sembra un’idea troppo azzardata, ma siamo nel campo dell’opinabile, e se
questo è ciò che Cases non mi perdona, sono felice di dirgli che le sue osservazioni
sebbene non mi convincano del tutto, m’inducono a ripensarci su.» La questione
dello “scrivere dopo Auschwitz” e il decennale della morte di Primo Levi, in Primo
Levi testimone e scrittore di storia, a cura di Paolo Momigliano Levi e Rosanna
Gorris, Firenze, Giuntina, 1999, pp. 97–110 (p. 108).
29 Giuseppe Mazzotta, Letteratura e verità, la lezione di Primo Levi, «Vita e Pensiero»,
91, 3 (2008): 116–22 (p. 116).Primo Levi e Elio Vittorini 245
capitolo è, però, principalmente la prima edizione dell’opera, quella pub-
blicata da De Silva nel 1947, poiché si colloca cronologicamente all’apice
del dibattito sulla “crisi dell’Uomo” e dovrebbe quindi riflettere più da
vicino i termini di quel dibattito, sia nella sua preparazione che nella sua
ricezione critica. Entrando più profondamente nel rapporto fra Levi e
Vittorini, è importante sottolineare come Levi stesso abbia affermato che,
durante la stesura dei capitoli che sarebbero diventati Se questo è un uomo,
non gli fossero ancora presenti la maggior parte delle opere di Vittorini,
ma avesse già letto quella più recente, Uomini e no, un romanzo in cui lo
scrittore siracusano sembra allontanarsi dalla posizione che aveva preso in
Conversazione in Sicilia e avvicinarsi, in qualche modo, agli stessi temi, se
non esattamente alle stesse conclusioni, che Levi avrebbe esplorato in Se
questo è un uomo.30 Vittorini, in Conversazione in Sicilia, aveva considerato
la possibilità che alcuni atteggiamenti e comportamenti potessero essere
così crudeli da trasgredire i confini dell’umano. «Ma forse non ogni uomo
è uomo; e non tutto il genere umano è genere umano», aveva scritto in un
momento centrale di quel romanzo:
Un uomo ride e un altro uomo piange. Tutti e due sono uomini; anche quello che ride
è stato malato, è malato; eppure egli ride perché l’altro piange. Egli può massacrare,
perseguitare, e uno che, nella non speranza, lo vede che ride sui giornali e manifesti
di giornali, non va con lui che ride ma semmai piange, nella quiete, con l’altro che
piange. Non ogni uomo è uomo, allora. Uno perseguita e uno è perseguitato; e genere
umano non è tutto il genere umano, ma quello soltanto del perseguitato. Uccidete un
uomo; egli sarà più uomo. E così è più uomo un malato, un affamato; è più genere
umano il genere umano dei morti di fame.31
30 Si veda Primo Levi, Più realtà che letteratura (Opere, II: 1384). Tra gli studiosi che
propongono un legame tra Uomini e no e Se questo è un uomo, si vedano in partico-
lare Alberto Cavaglion, Primo Levi era un centauro?, in Al di qua del bene e del male.
La visione del mondo di Primo Levi. Atti del convegno internazionale Torino 15–16
dicembre 1999, a cura di Enrico Mattioda, Milano, Franco Angeli, 2000, pp. 23–32
(p. 27–8); Judith Kelly, Primo Levi. Recording and Reconstruction in the Testimonial
Literature, Leicester, Troubadour, 2000, p. 11–12; Jonathan Usher, Primo Levi, the
Canon, and Italian Literature, in The Cambridge Companion to Primo Levi, a cura
di Robert Gordon, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 171–88
(p. 182).
31 Elio Vittorini, Conversazione in Sicilia, in id., Le opere narrative, Milano,
Mondadori, 1974, vol. 1, pp. 569–710 (p. 645–6). Gian Paolo Biasin ha proposto246 Charles L. Leavitt IV
Essere vittima, in quest’analisi, equivale a essere più «uomo», mentre
essere aggressore, tormentare le vittime, vuol dire perdere la propria uma-
nità, diventare non-uomini.
Nonostante il suo titolo potenzialmente ingannevole – un titolo,
infatti, che ha ingannato molti critici, tra cui alcuni di indirizzo leviano –
Uomini e no rappresenta il rifiuto di questa posizione da parte di Vittorini.32
L’autore non avrebbe potuto essere più chiaro nei suoi tentativi di prendere
le distanze dall’analisi precedente: «non esistono, insomma, “uomini” e
“non-uomini”», ha scritto in un saggio del 1947.33 Non dobbiamo, cioè,
dividere nettamente tra il bene “umano” e il male “disumano”, secondo
Vittorini, perché gli esseri umani hanno in loro la propensione sia al bene
che al male. Dobbiamo dunque affrontare direttamente il problema del
male umano, piuttosto che fingere che gli uomini siano innatamente buoni,
e che il male sia in qualche modo estraneo alla natura umana. «Uomini e
no è il titolo di un problema che il Vittorini si pone», ha correttamente
spiegato Giacomo Noventa in un importante saggio del 1946, «non di
una affermazione e di una negazione, non di un problema risolto».34 Il
problema a cui fa riferimento Noventa, e sul quale si concentra Vittorini,
riguarda il valore dell’identità umana all’indomani della seconda guerra
questo brano dal romanzo di Vittorini come una possibile fonte per il titolo del
libro di Levi: Till My Ghastly Tale is Told: Levi’s Moral Discourse From Se questo è
un uomo to I sommersi e i salvati, in Reason and Light. Essays on Primo Levi, a cura
di Susan Tarrow, Ithaca, NY, Western Societies Program Occasional Paper No. 25,
1990, pp. 127–41 (p. 130–1).
32 Sia coloro che accettano una relazione tra i progetti di Levi e Vittorini sia coloro
che la negano hanno più volte sostenuto che lo scrittore siracusano propose una
divisione manichea tra partigiani (“uomini”) e fascisti (“non-uomini”). Un esempio
a sostegno della relazione fra i progetti dei due autori si trova in Luigi Martellini,
La persecuzione necessaria, in Primo Levi. La dignità dell’uomo, a cura di Rosa
Brambilla e Clara Levi Coen, Assisi, Cittadella, 1995, pp. 92–115 (p. 112–13), mentre
un esempio che nega tale relazione si trova in Alessandro Galante Garrone, Il grido
di Primo Levi, «Nuova antologia», 2163 (1987): 212–27 (p. 219–20).
33 Elio Vittorini, [Uomo e sottosuolo], «Il Politecnico», 35 (1947), ora in id., Letteratura
arte società, cit., vol. 2, pp. 424–7 (p. 426).
34 Giacomo Noventa, Un titolo ed un libro, «Gazzetta del Nord», 29 luglio 1946, ora
in id., “Il grande amore” e altri scritti, 1939–1948, Venezia, Marsilio, 1988, pp. 261–73
(p. 263).Primo Levi e Elio Vittorini 247
mondiale, un evento che aveva causato una serie di tristemente noti crimini
contro l’umanità. Questo problema viene così affrontato in Uomini e no:
L’uomo, si dice. E noi pensiamo a chi cade, a chi è perduto, a chi piange e ha fame, a
chi ha freddo, a chi è malato, e a chi è perseguitato, a chi viene ucciso. Pensiamo all’of-
fesa che gli è fatta, e la dignità di lui. Anche a tutto quello che in lui è offeso, e ch’era,
in lui, per renderlo felice. Questo è l’uomo. Ma l’offesa che cos’è? È fatta all’uomo e
al mondo. Da chi è fatta? E il sangue che è sparso? La persecuzione? L’oppressione?
[…] Noi abbiamo Hitler oggi. E che cos’è? Non è uomo? Abbiamo i tedeschi suoi.
Abbiamo i fascisti. E che cos’è tutto questo? Possiamo dire che non è questo anche,
nell’uomo? Che non appartenga all’uomo?35
Con questa dichiarazione provocatoria, come ha notato certa parte della
critica, la distinzione tra la vittima umana e l’aggressore disumano che
Vittorini aveva sviluppato in Conversazione viene del tutto abbandonata,
anzi respinta polemicamente:36
Diciamo oggi: è il fascismo. Anzi: il nazifascismo. Ma che cosa significa che sia il
fascismo? Vorrei vederlo fuori dell’uomo, il fascismo. Che cosa sarebbe? Che cosa
farebbe? Potrebbe fare quello che fa se non fosse nell’uomo di poterlo fare? Vorrei
vedere Hitler e i tedeschi suoi se quello che fanno non fosse nell’uomo di poterlo
fare. Vorrei vederli a cercar di farlo. Togliere loro l’umana possibilità di farlo e poi
dire loro: Avanti, fate. Che cosa farebbero?37
35 Elio Vittorini, Uomini e no, Milano, Bompiani, 1945, p. 211–12. Come nel caso di Se
questo è un uomo, cito dalla prima edizione del romanzo di Vittorini, piuttosto che
dalle successive versioni, sostanzialmente rivedute, perché questa era l’edizione che
Levi avrebbe potuto leggere durante “l’età della Crisi dell’Uomo”, che rappresenta
il contesto della mia analisi. Sulle modifiche che il romanzo di Vittorini ha subito
nelle stesure successive, si veda Virna Brigatti, Diacronia di un romanzo. Uomini e
no di Elio Vittorini (1944–1966), Milano, Ledizioni, 2016.
36 Cfr. Vittorio Spinazzola, Itaca, addio, Milano, Il Saggiatore, 2001, p. 61; Giovanni
Falaschi, La Resistenza armata nella narrativa italiana, Torino, Einaudi, 1976,
p. 91–2; Brian Moloney, Vittorini, Pavese, and the Ethics of Armed Resistance, in The
Shared Horizon. Melbourne Essays in Italian Language and Literature in Memory
of Colin McCormick, a cura di Tom O’Neill, Dublin, Irish Academic Press, 1990,
pp. 185–202 (p. 188–9).
37 Vittorini, Uomini e no, cit., p. 221–2.248 Charles L. Leavitt IV
Queste righe, tanto schiette quanto pungenti, chiariscono la sostanza
della nuova posizione vittoriniana. Riconoscere l’umanità di quelli che
soffrono, ma non quella di coloro che fanno soffrire, secondo lo scrit-
tore, rappresenta un’autoassoluzione ingiustificata, l’abbandono della
nostra responsabilità morale. Ci consente, erroneamente, di mantenere
la nostra fede nell’innata virtù degli uomini, quando dovremmo invece
abbandonare quella fede e giudicare gli uomini, considerandoli – anzi,
considerandoci – responsabili per ogni propensione al male. Dobbiamo
essere in grado di riconoscere la vera natura umana se vogliamo combat-
tere efficacemente il male umano, e dobbiamo essere in grado di ricono-
scere, per prima cosa, che quelle dei nazisti furono offese umane, non di-
sumane: offese fatte dall’uomo contro l’uomo.
«Nessuno deve uscire di qui, che potrebbe portare al mondo, insieme
col segno impresso nella carne, la mala novella di quanto, ad Auschwitz, è
bastato animo all’uomo di fare dell’uomo» (Se questo è un uomo, Opere,
I: 36). Così scrive Primo Levi alla fine delle sue riflessioni sulla vita nell’in-
fermeria di Auschwitz, nel capitolo “Ka-Be”, insistendo, qui come al-
trove, sulla mostruosità dell’esperienza che deve descrivere – «condizione
umana più misera non c’è, e non è pensabile» – ma anche sull’umanità
di coloro che sono responsabili per «questa offesa, la demolizione di un
uomo» (19). Con tale affermazione, che echeggia significativamente il
vocabolario vittoriniano, pieno, come abbiamo visto, di «offese» contro
l’uomo e addirittura contro il mondo, Levi sembra essere abbastanza
vicino alla posizione di Vittorini. Eppure Levi va oltre questa stessa po-
sizione, e oltre quella della maggior parte degli altri suoi contemporanei,
sostenendo che, nel portare avanti questa offesa, i nazisti sono riusciti,
tragicamente, a disumanizzare, completamente e spesso irrevocabilmente,
le loro vittime. Se è vero, cioè, che i torturatori erano sempre uomini, è
altrettanto vero, secondo Levi, che i torturati avevano cessato di essere
uomini, così terribili erano le loro sofferenze. «Distruggere l’uomo è dif-
ficile, quasi quanto crearlo: non è stato agevole, non è stato breve, ma ci
siete riusciti, tedeschi», afferma Levi mentre racconta l’orribile esecuzione
di un uomo, «l’ultimo», che aveva osato ribellarsi (113). Lo scrittore così
costringe i suoi lettori a meditare sul fatto che, a causa della loro incapa-
cità di ribellarsi, di rispondere o persino di pensare, quelli condannatiPrimo Levi e Elio Vittorini 249
ad assistere all’esecuzione, Levi incluso, non erano più uomini. Tutto il
libro di Levi porta a questa conclusione:
Si immagini ora un uomo a cui, insieme con le persone amate, vengano tolti la sua casa,
le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede: sarà un
uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e discernimento,
poiché accade facilmente, a chi ha perso tutto, di perdere se stesso; tale quindi, che si
potrà a cuor leggero decidere della sua vita o morte al di fuori di ogni senso di affinità
umana; nel caso più fortunato, in base ad un puro giudizio di utilità. Si comprenderà
allora il duplice significato del termine “Campo di annientamento”, e sarà chiaro che
cosa intendiamo esprimere con questa frase: giacere sul fondo. (19)
Nel momento in cui si definiva la cosiddetta “crisi dell’Uomo”, quando
molti cercavano di riaffermare la dignità umana come fonte di spe-
ranza, di rinascita, e persino di redenzione dopo il fascismo, Levi, come
Vittorini, ricordava ai lettori che gli esseri umani erano responsabili di
tutti i crimini contro l’umanità che il fascismo aveva potuto commettere.38
Andando oltre il pensiero di Vittorini, però, Levi ricordava anche che, in
molti casi, questi crimini contro l’umanità cominciavano con la distru-
zione dell’umanità stessa, al punto che le stesse vittime avevano cessato di
essere riconoscibilmente umane. Si pensi a Null Achtzen, il prigioniero
che «non è più un uomo», che «eseguisce tutti gli ordini che riceve» e
che, «quando lo manderanno alla morte, ci andrà con questa stessa totale
indifferenza» (25), oppure alla massa dei prigionieri che «non pensano
e non vogliono, camminano», una condizione disumana che, secondo
Levi, rappresenta la «vittoria» delle S. S. (32). Lo stesso titolo del libro
evidenzia quest’orrendo traguardo, l’abbassamento totale dei prigionieri,
anche se il titolo che Levi aveva preferito lo segnala in maniera forse
ancora più diretta: «Sul fondo.»
Se la critica non ha sempre colto la sfida morale di Uomini e no a causa
di una lettura spesso sbrigativa del suo titolo, anche i primi critici che si
occuparono di Levi non furono sempre in grado di riconoscere il vero
38 Non sembra irrilevante notare come «l’idea dei crimini contro l’umanità [sia] nata,
formalmente parlando, alla fine della seconda guerra mondiale.» Norman Geras,
Crimes Against Humanity. Birth of a Concept, Manchester, Manchester University
Press, 2011, p. vi.250 Charles L. Leavitt IV
significato della sfida morale posta dal titolo Se questo è un uomo. Quasi
tutte le prime recensioni di quel libro descrissero l’opera di Levi come ricon-
ferma e non refutazione delle più facili banalità postbelliche riguardanti il
potere, la purezza e le prospettive della dignità umana.39 In una recensione
del 1948, ad esempio, Maria Ortiz si soffermò sul senso di speranza che Levi
trasse, durante il suo internamento, dall’amicizia con Lorenzo, un operaio
civile italiano generoso e “umano”: «fermiamoci a questa figura riconfor-
tante – ha scritto la Ortiz – invochiamo un ritorno alla pura, incorrotta,
cordiale umanità, e nello stesso tempo invochiamo che per nessuno mai,
per nessuna società o parte di società si verifichino mai condizioni di tanta
durezza di vita che solo l’eroismo e la santità possano trionfarne.»40 Eurialo
De Michelis, nella sua recensione del 1947, si è concentrato, con analogo
intento, sul capitolo finale del libro, trovando nella testimonianza di Levi
circa la liberazione del Lager «un alacre rifiorire della personalità, un de-
siderio di vita, dove i pochi gesti generosi contano assai di più dei molti
inumani, che ancora le circostanze imponevano, nell’immane catastrofe.»41
Gabriele Pepe, autore della Crisi dell’uomo, un trattato del 1945, termina
la sua recensione del 1948 con l’affermazione che, in Se questo è un uomo,
per fortuna dell’umanità i reietti, i disumanizzati, gli abbrutiti immediatamente
ritornano uomini non appena, distrutto il mostruoso mondo creato dal nazismo, è
possibile un primo, semplice gesto di fraternità. Basta il pensiero della prossima libertà
perché questi detriti umani ritrovino la capacità di una carità quasi eroica: tanto è
vero che solo la libertà rende buoni!42
Questa è sicuramente una conclusione confortante, ma rispecchia molto
di più la fede di Pepe nel valore civilizzatore della humanitas, nel suo senso
39 Sulla critica iniziale all’opera di Levi, cfr. Ernesto Ferrero, La fortuna critica, in
Primo Levi. Un’antologia della critica, a cura di id., Torino, Einaudi, 1997, pp. 303–
85, oltre al capitolo “Vicenda della critica”, in Alberto Cavaglion, Primo Levi e Se
questo è un uomo, Torino, Loescher, 1993, pp. 57–63.
40 Maria Ortiz, Recensione a Se questo è un uomo, di Primo Levi, «Lo spettatore ita-
liano», 1, 7 (luglio 1948): 110–11.
41 Eurialo De Michelis, Recensione a Se questo è un uomo, di Primo Levi, «La voce
repubblicana», 30 dicembre 1947, p. 3.
42 Gabriele Pepe, Uomini distrutti, «Scuola democratica», 2, 20 (20 febbraio 1948): 3.Primo Levi e Elio Vittorini 251
latino, che un’accurata lettura del libro di Levi.43 In sostanza, il discorso
della “crisi dell’Uomo” sembra, in questo caso come in molti altri, aver
incoraggiato abitudini mentali che impedivano l’apprezzamento dell’ori-
ginalità e della difficoltà di Se questo è un uomo.
Con questo, non si intende sostenere che i critici avessero torto nell’in-
dividuare nel libro di Levi alcune tracce di solidarietà umana nei Lager
nazisti e il risveglio di un senso di umanità nei sopravvissuti al campo.
Tanto è vero che, nell’ultimo capitolo del suo libro, Levi racconta come,
nel momento in cui lui e i suoi compagni di prigionia si ritrovarono
liberi dall’ordine brutale del campo, essi fossero «lentamente ridiven-
tati uomini» (Opere, I: 122). Eppure, la riaffermazione dell’umanità nel
racconto di Levi è, appunto, lenta, e cioè più faticosamente conquistata,
più incerta, più contingente di quanto sembri essere negli scritti di molti
suoi contemporanei. «Oggi rinasce l’uomo», fu annunciato in occasione
di una commemorazione del 1945 per i martiri della liberazione d’Italia,
quelli che avevano combattuto contro le forze che volevano «stermi-
nare gli ebrei».44 E ancora, in una testimonianza del 1946 pubblicata sul
Quotidiano, si dichiara che «oltre la tragedia dell’uomo, oltre la transuma-
nazione della sofferenza, oltre gli slanci meravigliosi del sentimento, v’era
un’altra Mauthausen, quella del superamento della pena fisica, del trionfo
dello spirito.»45 Se questo è un uomo non adduce un simile senso di trionfo,
non promette alcun simile senso di rinascita. Evita anzi completamente le
astrazioni intellettualistiche, i compromessi rassicuranti, e l’influsso bene-
fico immeritato che troppo spesso hanno caratterizzato il discorso sulla
“crisi dell’Uomo”. Non è un caso forse che, tra i partecipanti più attivi di
quel discorso, solo Aldo Bizzarri, anche lui sopravvissuto a un campo di
sterminio, seppe riconoscere, almeno in parte, il significato intimo dell’o-
pera di Levi. Bizzarri criticava spesso le invocazioni troppo ottimistiche,
illusorie, o faziose di un cosiddetto «Uomo d’oggi» e, nelle sue opere, tra
cui il libro testimonianza Mauthausen città ermetica, il romanzo Proibito
43 Id., La crisi dell’uomo, Roma, Capriotti Editore, 1945, p. 71–2.
44 Angelo Antonio Fumarola, Prefazione [Roma, primavera del 1945], in id., Essi non
sono morti. Le medaglie d’oro della guerra di liberazione, Roma, Poligrafico, 1945,
pp. 11–33 (p. 22 e 31).
45 Alfredo Stendardo, Vigilia nell’ombra, «Il Quotidiano», 30 ottobre 1946, p. 3.252 Charles L. Leavitt IV
vivere, e il saggio Il problema è la persona, analizzò, in modo alquanto
rigoroso, il funzionamento dei campi, «quel mondo disumano», nel
tentativo di spiegare come essi avessero provocato «l’avvilimento, la sper-
sonalizzazione, la degradazione, l’imbestiamento dell’uomo.»46 Nella sua
recensione a Se questo è un uomo, Bizzarri riconobbe «l’immagine orrida
dell’ambiente dove quelle vite d’uomini furono torturate e si spensero,
e dove, soprattutto, la “persona” venne deliberatamente schiacciata.»47
Questa analisi riflette certamente scelte lessicali proprie di Bizzarri, più
che di Levi, ma tuttavia identifica anche, con una certa precisione e con
molta penetrazione, la sfida morale dell’opera di Levi.48 Ancora più inci-
siva risulta essere la recensione di Italo Calvino, che mostrò ancora meno
condiscendenza per ciò che liquidò, in un saggio del 1946, come la retorica
del «Uomo con l’U maiuscola.»49 In Se questo è un uomo, come Calvino ha
giustamente notato, Levi mette in dubbio ogni fede nella dignità umana
trascendente e inviolabile, e invece «studia con una pacatezza accorata
cosa resta di umano in chi è sottoposto a una prova che di umano non ha
nulla.»50 Più radicalmente ancora, fa sì che i suoi lettori affrontino, di-
rettamente e senza riserve, l’inadeguatezza di tutto il discorso dell’uomo,
46 Per la sua critica alla polemica sulla «Crisi dell’Uomo», si veda, per esempio, Aldo
Bizzarri, Uomo d’oggi e uomo di sempre, «Domenica», 10 febbraio 1946, ora in Il
problema è la persona 1945–1952, Milano, Il Saggiatore, 1966, pp. 102–5. Sugli effetti
disumanizzanti dei campi nazisti, si veda id., Mauthausen, città ermetica, Roma,
OET, 1946, p. 14 e 41.
47 Id., Recensione a Se questo è un uomo, di Primo Levi, «L’Italia che scrive», 31, 4
(aprile 1948): 77–8 (p. 77).
48 Il Lager «schiaccia […] quella che era la persona», dice uno dei prigionieri raffi-
gurati nel romanzo Proibito vivere, e simili esempi dell’uso delle stesse parole, ado-
perate anche nella recensione a Se questo è un uomo, sono facilmente identificabili
attraverso tutta l’opera di Bizzarri. Id., Proibito vivere, Milano, Mondadori, 1947,
p. 181.
49 Italo Calvino, Le capre ci guardano, Soggezione di un cane, Il marxismo spiegato ai
gatti, Da Esopo a Disney, «L’Unità», 17 novembre 1946, ora in id., Saggi 1945–1985,
Milano, Mondadori, 2001, vol. 2, pp. 2131–6 (p. 2133).
50 Id., Un libro sui campi della morte, «L’Unità», 6 maggio 1948, ora in Giornalismo
italiano, a cura di Franco Contorbia, Milano, Mondadori, 2007, vol. 3, pp. 450–2
(p. 451).Primo Levi e Elio Vittorini 253
di tutto il nuovo umanesimo, dopo Auschwitz.51 Questo è in fondo il
significato della poesia dalla quale è stato tratto il titolo del libro di Levi,
che intima ai lettori: «considerate se questo è un uomo» (Opere, I: 7).
Con quest’ingiunzione, Levi offrì a coloro che proponevano la solida-
rietà umana come risposta alla crisi della civiltà scaturita dall’esperienza
dei Lager nazisti, il doloroso ricordo di come l’ambiguità esista non solo
relativamente alla dignità umana, ma anche e soprattutto a qualunque
idea della natura umana. L’uomo non era quindi la risposta al problema
storico e sociale; era di per sé il problema.
Seppur non sempre nello stesso modo, o nella stessa misura, l’idea di
uomo fu il problema al quale anche Elio Vittorini dedicò le sue riflessioni
nell’immediato dopoguerra. Per spiegare le conseguenze di un massacro
nazista di civili italiani, Vittorini scrisse in Uomini e no:
Chi aveva colpito non poteva colpire di più nel segno. In una bambina e in un vec-
chio, in due ragazzi di quindici anni, in una donna, in un’altra donna: questo era il
modo migliore di colpir l’uomo. Colpirlo dove l’uomo era più debole, dove aveva
l’infanzia, dove aveva la vecchiaia, dove aveva la sua costola staccata e il cuore sco-
perto: dov’era più uomo.52
Bisogna riconoscere come, in molti sensi, questa visione sia piuttosto lon-
tana dalla posizione di Levi. Nel suo libro, Vittorini attribuiva non solo
un’identità umana, ma anche un’umanità superiore alle vittime delle atro-
cità nazista. Eppure riconosceva, come anche Levi, la fragilità dell’uomo,
la facilità con cui coloro che vogliono oltrepassare i confini della civiltà
possono distruggere la vita umana. Ecco perché, per tornare al punto da
cui siamo partiti, Vittorini si chiedeva, «potremo mai avere una cultura
che sappia proteggere l’uomo dalle sofferenze invece di limitarsi a conso-
larlo?» Dopo la guerra, lo scrittore auspicò l’avvento di una nuova cultura
proprio perché era convinto che questa fosse l’unica risposta commisu-
rata alla minaccia che il fascismo e il nazismo avevano posto, e ponevano,
51 Sul cosiddetto post-umanesimo di Levi, si vedano Jonathan Druker, Primo Levi
and Humanism after Auschwitz. Posthumanist Reflections, New York, Palgrave
Macmillan, 2009; Damiano Benvegnù, Animals and Animality in Primo Levi’s
Work, London, Palgrave Macmillan, 2018.
52 Vittorini, Uomini e no, cit., p. 124–5.254 Charles L. Leavitt IV all’esistenza umana una minaccia – specificava nel saggio, andando oltre il romanzo – che comprendeva non solo la guerra, l’occupazione e le stragi di civili ma anche gli stessi campi di concentramento e di morte; una minaccia, quindi, per tutti gli esseri umani. «Vi era bene qualcosa che, attraverso i secoli, ci aveva insegnato a considerare sacra l’esistenza dei bambini», argomenta in Una nuova cultura. «E se ora milioni di bam- bini sono stati uccisi, se tanto […] la sconfitta è anzitutto di questa “cosa” che c’insegnava la inviolabilità loro. […] Questa “cosa”, voglio subito dirlo, non è altro che la cultura.»53 Ampollose difese della moralità umana, sin- cere richieste di solidarietà umana – la stessa sostanza del discorso sulla “crisi dell’Uomo” – non avevano potuto impedire né la seconda guerra mondiale né i crimini contro l’umanità che la stessa guerra aveva gene- rato e facilitato, sosteneva Vittorini, con riferimento ai Lager nazisti. Bisognava agire diversamente, e deliberatamente, per difendere l’uomo dalle minacce contro cui i più sacri valori della civiltà occidentale si erano mostrati non solo completamente inefficaci, ma in qualche modo anche complici. Non è questa, forse, la lezione che Primo Levi vuole che appren- diamo dall’esistenza del Lager? «Esso è il prodotto di una concezione del mondo portata alle sue conseguenze con rigorosa coerenza: finché la concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano. La storia dei campi di distruzione dovrebbe venire intesa da tutti come un sinistro segnale di pericolo» (Opere, I: 5). 53 Id., Una nuova cultura, cit., p. 234.
Puoi anche leggere