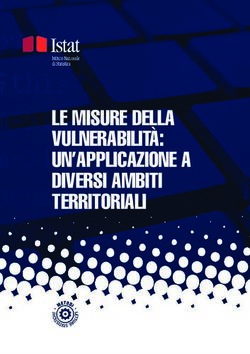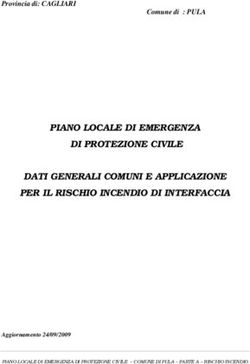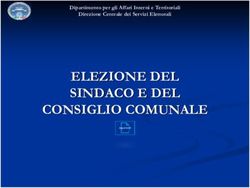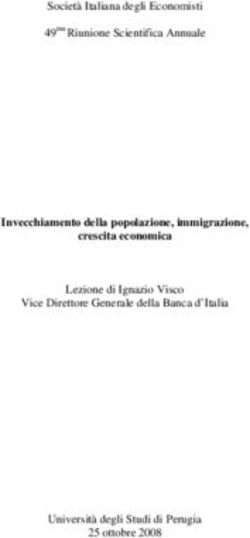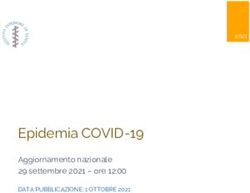I peccati della carne e la difesa dell'ambiente - Neodemos
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
I peccati della carne e la difesa dell’ambiente Le azioni per frenare il riscaldamento globale coinvolgono le organizzazioni intenazionali, gli stati, le istituzioni e le persone. Steve Morgan riflette sulla possibiità di un cambiamento dei paradigmi alimentari, mediante una riduzione dei consumi di carni comprimendo così le emissioni di gas serra che sono prodotti in abbondanza dagli allevamenti. Una battaglia in salita, perché le popolazioni in uscita dalla fame e dalla povertà danno una forte impulso ai consumi carnei. Si stanno moltiplicando gli allarmi in tema di riscaldamento globale. Vari indicatori fanno oramai temere che l’obbiettivo di limitare l’aumento della temperatura del pianeta entro 1,5 gradi centigradi non possa essere raggiunto. Nei giorni scorsi, secondo un rapporto dell’Organizzazione Metereologica Mondiale (Wmo) reso pubblico a fine ottobre, l’emissione di gas serra è ulteriormente aumentata nel 2020, nonostante il rallentamento delle attività industriali e di trasporto. Gli impegni di molti stati in termini di controllo delle emissioni vengono disattesi; alla COP 26 (Conferenza sul Cambio Climatico) di Glascow sono rimasti vuoti i seggi di pezzi da novanta come Xi Jinping e Putin, e le prudenti conclusioni stonano con l’urgenza dei problemi. Si moltiplicano inoltre gli eventi metereologici straordinari, e l’opinione pubblica inizia finalmente a percepire l’urgenza di mettere mano a politiche efficaci di controllo delle emissioni. Molto ci si attende dalla tecnologia, dalla cosiddetta transizione energetica verso fonti rinnovabili, dalla possibilità di
“catturare” i gas prima che contribuiscano a rafforzare l’effetto serra, dai mutamenti di comportamenti degli otto miliardi di terrestri, avviati ad essere dieci alla metà del secolo. Il Rapporto finale del VI ciclo di analisi dell’IPCC (International Panel on Climate Change), previsto per il prossimo anno, darà ulteriori certezze circa il procedere del cambiamento climatico, e ridurrà ulteriormente la credibilità dei pretesti avanzati per rallentare le azioni urgenti da intraprendere. Alimentazione e gas serra, il paradigma ambientalista Tra i numerosi e complessi argomenti che confluiscono nella “questione ambientale” c’è, naturalmente, l’aspetto comportamentale delle popolazioni, con riferimento ai modi di vita, ai consumi, alla generazione di rifiuti inquinanti, al rispetto dell’ambiente. Mentre si può presumere relativamente agevole l’introduzione e l’accettazione di nuove tecnologie – una volta che queste siano state inventate e sperimentate – non altrettanto può dirsi per il cambiamento dei comportamenti collettivi, spesso profondamente radicati nella società. Si consideri il cambio dei consumi alimentari che hanno un diretto impatto sul territorio e sull’ambiente, e che generano una quota importante delle emissioni di gas serra responsabili del riscaldamento globale. Il ragionamento è questo: la produzione di carne, particolarmente quella dei ruminanti (bovini in testa) è responsabile della metà delle emissioni di gas metano (una insidiosa componente del totale dei GHG) e di altri gas nell’atmosfera. Una vigorosa transizione alimentare verso diete povere di carni – soprattutto quelle rosse – determinerebbe un abbattimento di questi gas, oltre a notevoli benefici per l’ambiente e per la salute. Alcuni dati permettono di articolare il ragionamento sopra delineato. Anzitutto va ricordato che dei 130 milioni di kmq di terre emerse non coperte da ghiacci, il 12% è occupato da terre coltivate e il 37% da pascoli: insomma circa la metà della superficie del pianeta è impegnata da attività il cui fine ultimo è quello di nutrire l’umanità. Se si scompone l’emissione di GHG secondo la fonte, si stima che il 25% deriva dalla produzione di elettricità e di altre fonti di calore; il 21% dall’industria, il 14% dai trasporti, il 24% dall’agricoltura, il 16% ha altre varie origini. Sono valori basati su complicatissime stime e su dati spesso incerti, ma che consentono di ipotizzare che le emissioni dovute alla necessità di nutrire l’umanità si aggirino attorno a un quarto delle emissioni globali. Una quota importante di questo quarto (più della metà) proviene dai prodotti animali, in primis dalla zootecnia
(prevalentemente bovini, ovini e ruminanti in genere) mentre il residuo è dovuto alle colture vegetali. Inoltre la zootecnia è responsabile di circa la metà delle emissioni di metano, dovuta alla fermentazione enterica di miliardi di ruminanti, ed è la principale fonte di protossido di azoto, due gas ad effetto serra molto potenti, in aggiunta a quello predominante dell’anidride carbonica. I consumi di carne nel Mondo Negli ultimi sessant’anni, la produzione di carne si è quintuplicata (Figura 1), da 70 milioni a 350 milioni di tonnellate, mentre la popolazione del mondo si è accresciuta di due volte e mezza, con un conseguente raddoppio del consumo pro- capite. La maggioranza delle popolazioni contadine dell’Italia e del Mediterraneo, come ben si sa, fino ai primi decenni del secolo scorso, mangiavano carne solo nei giorni festivi, come avviene oggi nelle popolazioni più povere dell’Asia e dell’Africa. C’è stata però, nel corso del tempo, una forte trasformazione nella composizione della produzione; nel 1961 al primo posto erano i bovini (41% della produzione); le carni di maiale venivano al secondo posto (35%) e il pollame al terzo (13%); il residuo (11%) era composto soprattutto da ovini. Nel 2018 è il maiale al primo posto, con percentuale invariata; si è dimezzata la quota dei bovini (21%) e triplicata quella del pollame (37%). Questi valori complessivi celano la varietà dei modelli di produzione nei diversi paesi, come messo in rilievo dalla Figura 2.
Cambiare i modelli alimentari è possibile, ma lento e difficile Il raddoppio dei consumi carnei avvenuto negli ultimi sessant’anni è in stretta relazione con la crescita del reddito pro-capite, come è posto chiaramente in evidenza nella Figura 3. Il paradigma ecologico auspica che la relazione possa, se non rovesciarsi, almeno appiattirsi e che, in futuro, i consumi carnei diminuiscano sulle mense degli abitanti del pianeta. Questa inversione avrebbe effetti benefici sia per l’ambiente – minori emissioni e minore uso del suolo – sia per la salute, poiché è provato che diete meno ricche di carni (soprattutto quelle rosse) siano più sane, e contrastino molte delle patologie tipiche delle popolazioni o dei gruppi di popolazione più abbienti. Sono numerosi, e sempre più influenti, gruppi di opinione di diversa origine, che propugnano questa inversione. Ma le difficoltà che questa possa avvenire entro un orizzonte finito, sono moltissime. Contrastano, in primo luogo, preferenze e costumi alimentari profondamente radicati nelle popolazioni che possono cambiare solo con gradualità e lentezza, e sui quali poco possono le politiche dei governi e delle amministrazioni. Inoltre, nella maggioranza delle popolazioni a basso reddito i consumi di carne sono modestissimi, ed un aumento della componente carnea sulle mense produce vantaggi per la salute. E infatti, come testimoniato dalla Figura 3, le preferenze di consumo a favore della carne si impennano quando le popolazioni si sollevano oltre la soglia della povertà estrema. E la loro spinta sarà assai potente, se si tiene conto che esiste un miliardo di abitanti del pianeta sottoalimentati, che lo sviluppo
dovrà sollevare dal miserabile stato di nel quale si trovano. Infine nei paesi grandi produttori di carne, le lobby sono politicamente molto potenti, e in grado di contrastare fortemente le spinte ad una trasformazione “ambientalista” dei modelli nutritivi dell’umanità. Il destino demografico dell’occidente tra quantità e qualità L’Occidente sta entrando in una fase di declino demografico che continuerà per
tutto il resto del secolo. Ma la questione centrale non è l’essere in valore assoluto tanti o pochi. A fare la differenza nel mondo in cui vivremo nei prossimi decenni, come evidenzia Alessandro Rosina in questo contributo, è soprattutto come verranno gestiti due rapporti relativi: quello tra le diverse aree del pianeta e quello tra le diverse generazioni. L’ascesa demografica dell’Occidente La combinazione di tre grandi rivoluzioni nate in Europa (scientifica, industriale e demografica) consentono oggi all’umanità di poter vivere più a lungo, di aver accesso a maggiori risorse materiali, di usare tecnologie sempre più efficienti per comunicare e viaggiare, di aver più ampie scelte sul proprio destino sociale. Si tratta di conquiste che i Paesi occidentali hanno potuto sperimentare per primi e che hanno consentito di ottenere un vantaggio competitivo rispetto al resto del mondo. Tecnologia più avanzata e maggiori risorse economiche hanno favorito, in una prima fase, la crescita della popolazione grazie alla riduzione della mortalità (prima infantile e poi nelle fasi successive di vita). A sua volta la crescita demografica ha aumentato la forza lavoro ma ha anche stimolato ulteriore miglioramento tecnologico come risposta alla tensione tra popolazione e risorse. Ha aumentato la necessità di relazioni e commercio con il resto del mondo. Ha inoltre alimentato l’emigrazione verso altri continenti. Il riscontro maggiore di questo processo più che sul peso demografico dell’Europa o dei Paesi occidentali sul totale degli abitanti del Pianeta lo si può ottenere dal numero di coloro che usano l’inglese come strumento per comunicare. La demografia è quindi parte integrante dei meccanismi che hanno portato alla crescita dell’Occidente nello scenario mondiale, ma il peso stesso della popolazione è tra i maggiori fattori che ne hanno consolidato il ruolo. Come sottolinea Massimo Livi Bacci in “Storia minima della popolazione del mondo”, due Paesi con stessa ricchezza pro-capite tendono ad avere una popolazione che all’interno dei confini vive mediamente in condizioni di analogo benessere materiale. Ma se il primo Paese ha cinque volte la popolazione del secondo, può contare molto di più nelle relazioni con gli altri Paesi. Se gli Stati Uniti d’America improvvisamente si trovassero con una popolazione dell’ammontare di quella della Svizzera, avrebbero molta meno possibilità di usare le proprie risorse economiche per rapporti di aiuto verso altri Paesi, iniziative internazionali, investimento su nuove tecnologie, oltre che forza militare. È, infatti, la combinazione tra livelli di
ricchezza, dimensione della popolazione, attrazione di talenti esterni, che consente poi di aver anche un ruolo più rilevante verso l’esterno. Il declino demografico dell’Occidente L’Occidente si trova ora in una nuova fase della rivoluzione demografica: quella in cui, dopo la riduzione della mortalità, la fecondità non solo è diminuita ma si è portata su valori inferiori a quelli del rimpiazzo generazionale (che corrisponde, come ben noto, a circa due figli per donna). Il continente europeo, nel suo insieme, è crollato sotto tale soglia a partire dalla seconda metà degli anni Settanta. L’attuale dato dell’Unione europea è poco superiore a 1,5. Gli Stati Uniti sono riusciti più a lungo a mantenersi vicini al valore di rimpiazzo, ma nell’ultimo decennio hanno subito una sensibile riduzione. Come conseguenza di queste dinamiche i Paesi occidentali hanno perso la loro capacità di crescita demografica endogena per il resto di questo secolo. La persistenza di tale condizione ha come conseguenza la riduzione del loro peso sulla popolazione mondiale. Se nel secolo scorso la differenza era tra diversi ritmi di crescita nelle varie aree del mondo, nel resto di questo secolo sarà invece sempre più evidente il contrasto tra aree in (più o meno forte) crescita e aree in declino. In questa prospettiva, l’Europa è il continente che più si sta rimpicciolendo. Se all’inizio del secolo scorso il peso sulla popolazione mondiale era superiore al 25%, oggi è inferiore al 10%. Proprio in questi anni, anche tenendo conto del contributo dell’immigrazione, tale continente sta entrando in una lunga fase discendente della curva demografica. Raggiunti i 747 milioni di abitanti, secondo le previsioni delle Nazioni Unite (con base 2019), è previsto tornare sotto 700 milioni poco dopo il 2050 e via via poi continuare a declinare. Quelle che vengono indicate come “More developed regions” (Europa, Nord America, Australia/Nuova Zelanda e Giappone) hanno di fatto esaurito la fase di crescita e sono destinate a stabilizzarsi sotto 1,3 miliardi di abitanti per poi diminuire. Nel frattempo, entro il 2050, nel resto del Pianeta si aggiungeranno altri 2 miliardi di abitanti. Il destino demografico dell’Occidente Gli Stati Uniti dovrebbero iniziare la propria parabola discendente dopo la metà del secolo. Ma queste proiezioni risultano ottimistiche, in particolare per il fatto che la fecondità degli USA si è ridotta in modo considerevole negli ultimi anni e la
pandemia ha ulteriormente agito negativamente. Le ipotesi delle Nazioni Unite (scenario centrale) sono basate su un numero di figli per donna statunitense assestato attorno a 1,8. Ma nel 2019 risultava già sceso a 1,7 e le stime per il 2020 sono ancora più basse (1,6). Dati che hanno alimentato nel dibattito pubblico americano un’intensa discussione su cause e conseguenze del declino demografico. Nella classifica dei Paesi più popolati, dominata da India e Cina, gli USA nei prossimi decenni dovranno cedere il terzo posto del podio alla Nigeria. Entro il 2050 la Russia slitterà dal nono al 15esimo, la Germania, il Paese UE più popoloso, dal 17esimo scivolerà al 25esimo. Ma se il rapporto relativo tra i vari Stati è in grande mutamento, c’è un altro rapporto in profonda trasformazione in questo secolo: quello tra giovani e anziani. Tale cambiamento sta interessando in modo particolare i Paesi occidentali, all’interno dei quali la popolazione più matura è in continuo aumento mentre le nuove generazioni già da tempo sono in progressivo indebolimento quantitativo. Nei Paesi più sviluppati, sempre secondo le Nazioni Unite, entro il 2050 gli over-65 arriveranno a superare gli under-25, mentre su scala globale i più giovani continueranno a essere oltre il doppio rispetto ai più anziani. Più nello specifico, gli Stati occidentali non andranno solo incontro a una riduzione della popolazione ma al loro interno si ridurrà ancor più, in senso assoluto e relativo, la componente più dinamica, quella giovane-adulta che maggiormente alimenta i processi di sviluppo economico e innovazione. La transizione dalla quantità alla qualità Queste dinamiche vanno però anche viste all’interno di una transizione più ampia che porterà tutta la popolazione del Pianeta a esaurire la sua spinta alla crescita. Verso la fine del secolo il tasso di fecondità mondiale è previsto scendere attorno ai due figli per donna. I diversi tempi in cui tale processo si realizza nelle varie aree del globo fanno però la differenza. I Paesi occidentali, come abbiamo visto, hanno anticipato la fase di declino, mentre l’Africa è ancora all’apice della sua crescita. Questo significa due cose. La prima è che si passerà progressivamente dalla quantità della crescita, che ha dominato il Novecento (non solo dal punto di vista demografico), alla crescita della qualità. Ovvero diventa trainante nei processi di sviluppo più la qualità del capitale umano e la sua valorizzazione, in tutte le fasi della vita, che il peso in sé della fascia attiva. La seconda è che, però, ancora per lunga parte di questo secolo la quantità farà la differenza. Lo farà, anzi, ancor più
che in passato perché i ritmi di crescita tra aree del mondo e tra generazioni non sono mai stati così divergenti. Questo, allora, significa anche che quando gli accentuati squilibri di questa fase saranno superati e la crescita della popolazione risulterà di fatto stabilizzata in tutto il Pianeta, la configurazione geopolitica sarà nel frattempo cambiata e i Paesi leader non saranno necessariamente quelli attuali. Il limite dell’Occidente è che, nel pieno di questa fase di transizione mondiale, il suo peso è quello che maggiormente si riduce. Il vantaggio è l’essere obbligato già da subito ad agire sulla leva qualitativa (formazione continua, uso delle nuove tecnologie abilitanti, capacità di mettere in relazione culture diverse, soft power, sviluppo sostenibile) che è quella che nel lungo periodo farà la differenza. (*) Versione rivista di un articolo pubblicato da ISPI Troppi, o troppo pochi? Con l’articolo di Joel E. Cohen e Joseph Chamie neodemos apre un dibattito sul tema dello sviluppo della popolazione del mondo e degli effetti sulle condizioni ambientali del pianeta, sull’economia e società dei vari paesi. “È tempo di riconoscere che una crescita demografica più lenta arreca benefici
all’America, alla Cina e alla Terra”, così scrivono Joel Cohen e Joseph Chamie in chiusura dell’articolo che oggi presentiamo ai lettori di Neodemos. I due autori commentano i risultati dei recenti censimenti di Cina e Stati Uniti, che mostrano un forte rallentamento della crescita demografica dei due paesi, così come sta avvenendo in altre parti del mondo, con l’eccezione dell’Africa sub-sahariana. Questa minore crescita, e l’eventuale declino che si prospetta in larga parte del globo, “segnala importanti e durevoli successi. È portatrice di implicazioni incoraggianti per il cambio climatico e l’ambiente. Le coppie hanno meno figli in un mondo sempre più urbanizzato, mentre uomini e donne perseguono istruzione, lavoro e carriere, e vivono più a lungo di sempre”. Un tempo si sarebbe definito “maltusiano” il messaggio di Cohen e Chamie. Oggi le etichette non vanno più di moda, e convivono due visioni un tempo esclusive: la prima è che occorra moderare la crescita demografica del pianeta, che è direttamente associata con le emissioni di gas serra, con il riscaldamento globale, con l’occupazione disordinata dello spazio, e con molti altri aspetti del deterioramento ambientale. Alla fine del secolo, con diverse centinaia di milioni di terrestri in meno rispetto alle previsioni, gli stress ambientali sarebbero presumibilmente minori di quanto non si tema. L’altra visione sottolinea gli aspetti negativi di un sostenuto declino demografico, come si va prefigurando in vaste parti dell’Europa e dell’Asia orientale, legati all’invecchiamento e al suo costo, alla perdita di produttività e di innovazione, agli squilibri tra generazioni, e altro ancora. Potremmo dire che la prima è una visione macro, e top-down, che riguarda le sorti del pianeta, che va salvato con una robusta frenata della crescita demografica, o con una inversione della stessa. La seconda è una visione micro, bottom up, che riguarda le sorti di una nazione, di una regione, di una provincia che colpita dal declino demografico inverte la curva dello sviluppo. Temiamo i tre gradi in più della temperatura e, quindi, la desertificazione del territorio e l’innalzamento del livello del mare, ma temiamo anche la desertificazione umana e il rattrappimento della economia e della società. Troppi o troppo pochi? È un dilemma che c’insegue da millenni e che ci tocca da vicino. L’Italia perde popolazione da sette anni e c’interroghiamo quanto a lungo durerà questo declino, e cosa porterà con sé, e come opporsi alle conseguenze negative. Ma l’Italia teme anche l’intensificarsi degli eventi metereologici eccezionali, la subsidenza della laguna di Venezia, l’inaridimento di parti cospicue del territorio, fenomeni cui la crescita della popolazione mondiale dà una robusta
spinta. La crisi del pianeta si riflette sulle singole nazioni, ma la crisi di queste, in quanto dovuta al declino demografico, si riflette sulla capacità di opporsi alle malattie del pianeta. Slower population growth signals successes and benefits Joel E. Cohen1 & Joseph Chamie2 Results from 2020 population censuses for the United States and China made headlines about population collapse, baby busts and demographic decline. Lopsided lamentations have given little attention to the social, economic and environmental benefits of slower growth. Joel E. Cohen and Joseph Chamie argue instead that the slowdown in population growth signals successes and benefits for America, China, and the Earth. The past Results from the 2020 population censuses in the United States and China recently made headlines. But rather than recognizing the social, economic, environmental and climatic benefits of slower rates of population growth for the U.S., China and the planet, much of the print and broadcast media in the U.S. stressed the downsides of slower growth and chose to write about population collapse, baby bust and demographic decline. The U.S. population increase of 7.4 percent from 2010 to 2020 was the second lowest rate of growth since the country’s first census in 1790, and half the typical growth rates since 1790. Only during the Great Depression of the 1930s did U.S. population grow more slowly, by 7.3 percent. Even slower rates of growth are expected in the coming decades (Figure 1).
China’s population grew 5.3 percent in the decade ending in 2020, the lowest decadal growth rate since the catastrophic famine of the late 1950s. India projects for 2011-2021 its lowest decadal rate of population growth, 12.5 percent, since its independence. The present Lopsided lamentations have focused on the downsides of slower population growth. For example, some commentators who favor more rapid U.S. population growth contend that Americans would like to have more children than they are presently having. However, while this is the case for some American couples, others want fewer children. In 2011 (the latest available year), of the 6.1 million pregnancies in the United States, 1.6 million (27 percent) were mistimed and 1.1 million (18 percent) were unwanted at any time. Of all U.S. pregnancies in 2011, 45 percent were not intended (Guttmacher Institute 2019). Some public handwringers maintain that a large population size aids the United States’ competition for economic and geopolitical dominance with China. But the mercantilist view that there is strength in numbers alone is obsolete by centuries. A large or rapidly growing population is hardly necessary or sufficient for prosperity. Finland, ranked the happiest country in the world, has a total fertility rate of 1.4, compared to 1.6 in the U.S., 0.8 in South Korea, 1.1 in Singapore, 1.3 in Italy, 1.4 in Japan, 1.5 in Norway and 1.7 in Denmark. Women in China currently have 1.3
children on average, markedly fewer than in the United States (Figure 2). The future Some advocates of more rapid population growth argue that it would permit more people who want to migrate to the U.S. to do so. About 158 million adults in other countries would like to move and settle permanently in the U.S., according to the Gallup poll in 2018 (Esipova, Pugliese and Ray 2018). Would the U.S. willingly accept many or most of these would-be migrants? More rapid population growth, especially through increased immigration of working-age adults, would temporarily ease the pressures on pay-as-you-go public programs for the elderly, particularly Social Security and Medicare in the U.S., by broadening the country’s tax base. But there’s a catch: in the future, those additional workers would retire, requiring additional workers to broaden the tax base again for the retiring workers. This demographic expansion would need to continue indefinitely. Public discussion in the U.S. has largely ignored the notable social, economic and environmental upsides of slower American population growth. Slower population growth increases economic opportunities for women and minority groups, and
exerts upward pressures on wages, especially for unskilled labor. For a given rate of capital investment, slower population growth also raises capital per person, raising productivity. The Gross Domestic Product (GDP) grows more slowly, but GDP per person grows faster. All else equal, slower population growth lessens America’s contributions to climate change, biodiversity loss, deforestation, and pollution from commercial, industrial, agricultural, and domestic activities, such as heating and cooling buildings and fueling transport. Slower population growth makes it easier for governments, schools, and civic and religious organizations to respond more fully to increasing demands. Worries about impending demographic doom for the U.S. seem decidedly misplaced. The United Nations (2019) projects that the populations of 55 countries or areas will decrease by 1 percent or more between 2020 and 2050. China’s population is projected to fall by almost 3 percent, Italy’s by 10 percent and Japan’s by 16 percent (Figure 3). By contrast, the population of the United States, currently at 333 million, is projected to grow by nearly 14 percent, largely through immigration, to 379 million by 2050.
The world’s population growth rate peaked in the 1960s and is falling in most regions except sub-Saharan Africa, which is the last major region to go through the demographic transition from high rates of mortality and fertility to relatively low rates. Whereas the U.S. population increased nearly four-fold during the 20 th century, it is expected to increase by roughly 50 percent in the 21st century. Conclusions The United States and many other countries, including China, face real population challenges, but not principally slower population growth or even gradual population decline. These include addressing the needs of a rapidly aging population, managing cities and economies in recognition of climate change and environmental degradation, regulating and responding to migration, enabling people to have the children they want through reproductive health care and child- care support, and maintaining competitive technological change with better investments in education and worker training.
As COVID-19 has clearly demonstrated worldwide, real population challenges include protecting people against future pandemics and raising the value placed on today’s children, who are tomorrow’s problem solvers. In 2021, 22 percent of all children under age 5 years were stunted from chronic undernutrition (UNICEF, WHO, World Bank Group 2021), despite record cereal production globally (FAO 2021). The global slowdown in population growth rates is not a transitory demographic problem: it signals important durable successes. It has encouraging implications for climate change and the environment. Couples are having fewer children in an increasingly urbanized world while men and women pursue education, employment and careers and live longer than ever before. It is time to recognize that slower population growth benefits America, China, and the Earth. Note 1 Joel E. Cohen – is Abby Rockefeller Mauzé Professor of Populations at The Rockefeller University and Columbia University in New York, USA 2 Joseph Chamie – Independent consulting demographer and former director of the United Nations Population Division References Agarwal, Kabir (2020) “India’s Population Will Be 1.52 Billion by 2036, With 70% of Increase in Urban Areas”. 13 August The Wire. Esipova, Neli, Anita Pugliese and Julie Ray (2018) “More Than 750 Million Worldwide Would Migrate if They Could”. 10 December Gallup Poll. FAO (2021) World Food Situation. Finer, Lawrence B. and Zolna, Mia R. (2016) “Declines in unintended pregnancy in the United States, 2008–2011”. New England Journal of Medicine 374:843-852. DOI: 10.1056/NEJMsa1506575. Guttmacher Institute (2019) “Unintended Pregnancy in the United States”.
January. Shetty, Sudhanva (2021) “China’s 2020 Census Shows Population Barely Growing, Staring at Decline”. 11 May TRANSFIN. U.S. Census Bureau (2021) “First 2020 Census Data Release”. 26 April. U.S. Census Bureau (2020) “A Changing Nation: Population Projections”. U.S. Census Bureau (1975) “Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970”. Government Printing Office. UN (2019) “World Population Prospects: 2019.” United Nations, Population Division. New York, NY. UNICEF, WHO, World Bank Group (2021) Levels and trends in child malnutrition. Key findings. Fattori umani e fragilità ambientale delle regioni costiere La popolazione mondiale rallenta la crescita, ma aumenta la pressione sulle aree
costiere più vulnerabili. Ne parla Massimo Livi Bacci, con particolare riferimento ai processi di urbanizzazione e agli effetti del riscaldamento globale sulle fasce costiere a bassa altitudine. Fino alla metà del secolo scorso, l’idea che la crescita demografica potesse minacciare seriamente gli equilibri ambientali non si era ancora chiaramente delineata. Nel frattempo la popolazione del mondo si è triplicata, la capacità produttiva e di consumo è cresciuta di quindici volte, e il riscaldamento globale, dovuto a fattori antropogenici, è diventato una indubbia realtà. Finalmente anche la politica internazionale, i cui attori di norma suonano spartiti diversi e discordanti, sta prendendo atto della necessità di interventi coordinati per frenare gli effetti negativi di attività umane incontrollate. Trattandosi di un argomento “sensibile”, la questione demografica viene evitata nel dibattito ufficiale, anche se la verosimile aggiunta di tre miliardi di persone alla popolazione del globo prima della fine del secolo, provocherà ulteriori tensioni nel rapporto delicato tra umani e ambiente. Efficienti politiche sociali nelle regioni a maggiore crescita demografica potrebbero rallentare ulteriormente la crescita in atto, attenuando le tensioni di cui sopra. Occorre ricordare che circa i due terzi delle terre emerse risultano oggi antropizzate, mentre lo erano in minima parte due secoli fa. Antropizzate direttamente, con insediamenti abitativi, commerciali e industriali, con infrastrutture e coltivazioni. Oppure indirettamente, con pascoli e foreste gestite. Insomma, lo spazio del pianeta è limitato, e va utilizzato dagli umani con cautela crescente. Squilibri demografici e regioni costiere Non basta, però, che la popolazione del mondo rallenti e poi arresti la sua crescita verso la fine del secolo, come suggeriscono recenti proiezioni.1 Occorre anche che la sua distribuzione sul pianeta non accentui alcuni squilibri pericolosi. La crescita demografica e le migrazioni stanno aggravando la pressione umana nelle aree fragili come lo sono, ad esempio, le regioni delle foreste pluviali, Amazzonia in testa; o le aree umide necessarie alla biodiversità; o le delicate fasce fluviali e costiere. È in queste ultime che la pressione demografica sta accentuando la sua spinta; circa due miliardi e mezzo di persone – il 40 percento della popolazione mondiale – vivono a meno di 100 chilometri dalla costa, e oltre 600 milioni risiedono in aree costiere che hanno un’altitudine inferiore a 10 metri sul livello del mare e sono quindi vulnerabili a causa di inondazioni e maremoti. E più vulnerabili
diventeranno in conseguenza del riscaldamento, che determina un innalzamento del livello del mare, e una maggiore frequenza di fenomeni atmosferici violenti. Tra i grandi plessi urbani (semplificando: città) con 5 milioni di abitanti o più, tre su quattro si trovano sulle rive del mare, o in delta di fiumi che sboccano in mare, e poiché le città sono “bombe” di energia, e fonti inesauribili di inquinamento aereo, terrestre e marino, la loro crescita rappresenta una seria minaccia all’integrità dell’ambiente. Nella Figura 1 è riportata la distribuzione planetaria delle città nel 1990 e quella che con tutta probabilità si consoliderà nel 2030. In questo quarantennio, le megacittà con più di 10 milioni di abitanti passano da 10 a 43, quelle con popolazione tra i 5 e i 10 milioni crescono da 21 a 46, mentre le città “piccole”, tra 1 e 5 milioni, aumentano da 243 a 597. Questa esplosione delle grandi città si sta producendo soprattutto nelle fasce costiere. La vulnerabilità delle basse regioni costiere Un quadro più preciso del popolamento delle coste più fragili ed esposte a avversi eventi climatici è desumibile dalla Tabella 1 che riporta, per i vari continenti, la
distribuzione della popolazione nelle aree costiere basse, con altitudine inferiore a 10 metri sul livello del mare (acronimo LECZ, per Low Elevation Coastal Zones). Queste rappresentano appena il 2% delle terre emerse, ma ospitano il 10% della popolazione mondiale, e il 13% della popolazione urbanizzata del globo. In Asia, le LECZ occupano il 3% della superficie emersa del continente, ma ospitano il 13% della popolazione totale, e il 18% della popolazione urbana. E’ proprio nelle LECZ dell’Asia, dall’India alla Cina, che c’è la massima concentrazione demografica (tre su quattro abitanti delle LECZ del mondo vivono in Asia) e la massima vulnerabilità a eventi naturali. E’ in queste regioni (Indonesia, Tailandia, Myanmar, Bangladesh, India, Sri Lanka) che si è abbattuto lo tsunami del 2004, generatore di 230.000 vittime accertate e di decine di migliaia di dispersi). La popolazione delle fasce costiere a rischio è destinata ad aumentare ancora nei prossimi decenni, come si evince dalla Tabella 2, che esibisce un aumento da 625 a 893 milioni (+42,8%) tra il 2000 e il 2030, a 1128 milioni (+26,3%). Si tratta di aumenti grosso modo pari a quelli della popolazione mondiale, cosicché la quota di popolazione LECZ aumenterebbe solo lievemente, dal 10,5% nel 2000 all’11,1% del 2060. Inoltre la rapidità con cui sono cresciuti gli insediamenti urbani è andata a detrimento dello sviluppo di infrastutture adeguate per il trattamento dei rifiuti, delle acque reflue o l’abbattimento di gas inquinanti. L’attività umana è inoltre responsabile della distruzione di parte dei presidi naturali, quali le barriere coralline e le foreste di mangrovie.
La minaccia del riscaldamento globale Le regioni costiere, fin dal nascere del fenomeno urbano, hanno esercitato una grande forza attrattiva sugli insediamenti, per fattori naturali e sociali, in primo luogo per la facilità delle comunicazioni. Ma sono anche le zone più vulnerabili a causa dei cambiamenti climatici in corso. L’ International Panel on Climate Change (IPCC) valuta in 30-60 centimetri la crescita media del livello del mare nel corso del corrente secolo, in conseguenza dello scioglimento dei ghiacci polari2. L’aumento delle temperature del pianeta, inoltre, sta moltiplicando la frequenza di eventi estremi, come le tempeste e i cicloni tropicali con crescenti rischi per gli abitanti, danneggiamento di abitazioni e infrastrutture, rilevanti danni alla produzione. Nella Figura 2 sono esemplificati alcuni “modelli” di vulnerabilità nelle fasce costiere in funzione dell’evolversi di fattori naturali e della capacità adattativa delle città e delle popolazioni. Il modello contrassegnato in giallo – coste della Cina, del Vietnam, golfo del Bengala; Caraibi e Golfo del Messico – è quello che identifica sicuramente le aree costiere più a rischio del globo, oggi, e ancor più domani. Non ci distraggano questi nomi esotici, e non dimentichiamo l’Italia, che ha lunghe e basse coste, delicate e vulnerabili, come ci ricordano – tra altre catastrofi – l’acqua alta di Venezia e i nubifragi di Genova.
1
Secondo le proiezioni delle Nazioni Unite (aggiornate nel 2019, ipotesi media), il
tasso d’incremento della popolazione mondiale, oggi pari al 1%, raggiungerebbe lo
zero a fine secolo.
2
IPCC, Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, 2019
La sovrappopolazione è realmente un
problema per il pianeta?I paesi in via di sviluppo sono stati a lungo accusati di aver distrutto l’ambiente con le loro famiglie numerose. La sovrappopolazione è stata identificata come il nemico. Ma quanto è precisa esattamente questa affermazione? professor Giuseppe Costa – Università di Torino- Mortalità, salute e ambiente Neodemos 2019
Giuseppe Costa, medico, insegna all’Università di Torino. Esperto di epidemiologia occupazionale e ambientale, disuguaglianze nella salute, programmazione sanitaria, è coordinatore scientifico di programmi di ricerca per il contrasto alle diseguaglianze nella salute e nell’assistenza sanitaria a livello piemontese, nazionale ed europeo. Intervento Filippo Giorgi – L’impatto del riscaldamento globale sul territorio
Giornata di studi POPOLAZIONE, SVILUPPO, AMBIENTE Firenze, 24 novembre 2019 FILIPPO GIORGI è Filippo Giorgi e’ il direttore della sezione di Scienze della Terra del Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) di Trieste. Giorgi e’ un esperto internazionale nel campo della modellistica del clima, e dello studio dei cambiamenti climatici e dei loro impatti sulla societa’. Ha pubblicato piu’ di 300 articoli scientifici ed e’ inserito nella lista degli scienziati piu’ citati nell’area delle Geoscienze. Dal 2002 and 2008 Giorgi e’ stato membro del comitato esecutivo (Bureau) dell’ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), che nel 2007 ha vinto il Premio Nobel per la Pace. Piero Conforti e Clara Aida Khalil – Sud- Nord: le migrazioni ambientali in Africa
Fattori di primaria importanza nel determinare la mobilità del continente africano sono la disponibilità di risorse naturali, il cambiamento climatico in atto e l’intensicarsi di eventi climatici estremi. In sistemi produttivi ancora molto spesso arcaici come quelli vigenti nell’area sub-sahariana, la produzione agricola dipende fortemente dall’andamento climatico. Basti pensare che meno del 5 percento della superficie agricola della regione può contare su sistemi di irrigazione – sebbene la scarsità di risorse idriche non sia necessariamente il fattore più limitante – che solo una minima quota della produzione è basata sull’utilizzo di fertilizzanti e mezzi tecnici moderni, e che la fragilità di istituzioni e mercati limitano la capacità di adattamento alle uttuazioni ed ai cambiamenti climatici. Studi sull’impatto del cambiamento climatico sulla produzione agricola indicano che i rendimenti unitari di alcuni dei principali prodotti di base nella regione – come mais ed altri cereali – potrebbero subire un calo no al 20 percento entro il 2050. Questo fenomeno potrebbe manifestarsi in modo più ingente in alcune aree della regione rispetto ad altre. Per esempio, le zone più sensibili a variazioni delle temperature medie – come ad esempio le regioni meridionali del Senegal, Mali e Burkina Faso – potrebbero veder ridursi le rese
di produzione in misura maggiore rispetto alle regioni centro-settentrionali di questi stessi paesi. Ovviamente, i cambiamenti climatici in atto hanno un impatto sui ussi interni della popolazione. Tuttavia, il legame fra migrazioni e fenomeni climatici è lontano dall’essere basato su una relazione di lineare. Infatti, la decisione di migrare – seppur fortemente inuenzata dal vericarsi di eventi climatici estremi o dal crearsi di situazioni sfavorevoli alla produzione agricola – è mediata dalla struttura sociale, economica e politica e da fattori cognitivi come l’attaccamento al luogo d’origine. Simili interazioni possono risultare in scenari migratori altamente eterogenei e possono stimolare risposte diverse – no al punto dell’immobilità quando il vericarsi di eventi climatici estremi compromette l’accesso a beni e risorse necessari a mettere in atto il processo di migrazione. Ad ogni modo, il fenomeno dei ussi migra- tori è sempre più spesso considerato una risposta adattiva agli eetti del cambiamento climatico che ha il potere di contribuire alla resilienza delle comunità di origine. Occorre cercare modalità coordinate e coerenti per governare il fenomeno migratorio. L’idea non è di contrastare questo fenomeno, o di considerarlo come qualcosa di negativo; ma piuttosto di accompa- gnarlo e di utilizzarne le potenzialità, impegnandosi perché esso avvenga nel rispetto dei diritti umani. Al tempo stesso, è importante che i governi, le istituzioni regionali e la comunità internazionale in generale, si adoperino per promuovere le opportunità occupazionali nelle zone rurali, in particolare per i più giovani. Questo per far sì che la migrazione sia il risultato di un processo di scelta, piuttosto che la risposta ad una mera necessità di sopravvivenza.
Piercesare Secchi – Geografia umana del paese e rischi naturali Giornata di studi POPOLAZIONE, SVILUPPO, AMBIENTE Firenze, 24 novembre 2019 Piercesare Secchi è Professore di Statistica presso il Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano. Dal 2009 al 2016 è stato direttore del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano, e dal 2011 al 2016 membro del Senato Accademico dello stesso Ateneo e delegato del Rettore per i cluster e i consorzi. E’ docente di Statistica Applicata presso la Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione. E’ membro del MOX, il laboratorio di modellistica e calcolo scientifico del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano. E’ coordinatore del CADS (Center for Analysis, Decisions, and Society), centro di ricerca congiunto del Politecnico di Milano e di Human Technopole a Milano. E’ membro del consiglio di amministrazione del MIP, la Business School del Politecnico di Milano. E’ socio fondatore di Moxoff, uno spin-off del Politecnico di Milano che dal 2010 mette in sinergia il mondo della ricerca modellistica matematica, statistica e numerica, con quello industriale. E’ socio fondatore di Mathesia, una piattaforma di crowdsourcing creata nel 2014 per generare innovazione grazie all’applicazione della matematica a problemi di carattere industriale. E’ stato membro del gruppo di esperti della struttura di missione per l’attuazione del progetto “Casa Italia” della Presidenza del
Consiglio dei Ministri italiana. I suoi più recenti interessi di ricerca sono rivolti ai modelli e ai metodi statistici per la object oriented spatial statistics, ovvero all’analisi esplorativa e inferenziale di dati complessi e ad alta dimensione – come funzioni o tensori – in presenza di dipendenza spaziale. Tavola rotonda – Bruno Carli Accademia Lincei, CNR. Filippo Brandolini – Presidente di Herambiente Giornata di studi POPOLAZIONE, SVILUPPO, AMBIENTE Firenze, 24 novembre 2019 Clima, spazio, popolazione
L’ultimo rapporto del Panel internazionale sui cambiamenti climatici, IPCC, esamina i rapporti tra clima, spazio e suoli. Massimo Livi Bacci mette in rilievo, tra l’altro, la relazione tra la composizione delle diete e alcuni aspetti del degrado ambientale, e mettendo in guardia contro alcune distorte interpretazioni del rapporto. Al nascere dell’agricoltura, circa 10.000 anni orsono, si calcola che la popolazione del pianeta fosse di qualche milione di abitanti. Supponiamo che si trattasse di 6 milioni di umani (come suggeriscono alcuni autorevoli studiosi) e che questi vivessero in piccole comunità – chiamiamole demoi (plurale di demos) – ciascuna delle quali – sempre per semplificare – fosse costituita da 1000 persone. Qualora le terre emerse fossero state equidistribuite tra i demoi, ciascuno di essi avrebbe avuto in dote una quota di terra pari alla superficie della Sardegna (23mila km²). Due secoli fa, agli inizi della rivoluzione industriale, con la popolazione giunta a 1 miliardo, la dotazione di ogni demos sarebbe scesa a 150 km², quanti ne conta l’isola di Milos nel Mar Egeo, e verso la fine di questo secolo la dotazione territoriale sarà scesa a poco più di 10km² per demos, pari alla superficie dell’isola di Capri. In questa contabilità sono comprese le aree inabitabili, artiche, desertiche o montagnose. Antropizzazione della terra La terra è fissa, la popolazione cresce, e ogni abitante in più porta con sé un’accresciuta capacità di consumo di energia, di materie prime rinnovabili e non rinnovabili e una nuova richiesta di spazio. Secondo l’ultimo rapporto
dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc), reso pubblico lo scorso Agosto¹, su 130 milioni di km² non coperti dai ghiacci, la ripartizione della terra era la seguente (si tratta di stime molto approssimate): infrastrutture 1%; terre coltivate irrigate, 2%; coltivate non irrigate, 10%; pascoli intensivi 2%; altri pascoli 35%; piantagioni forestali 2%; altre foreste sfruttate per legname ed altri usi, 20%; terre con minimo o nessun intervento umano (inclusi i deserti) 28%. Insomma oltre il 70% delle terre è in qualche grado antropizzata, una proporzione che tende a crescere in funzione dell’aumento della popolazione, che secondo le ultime valutazioni potrebbe aggiungere altri tre miliardi ai quasi otto attuali entro la fine del secolo. L’estensione e l’intensificazione dell’antropizzazione pone a rischio aree vitali per gli equilibri ambientali, quali le grandi foreste pluviali; aree fragili, come quelle costiere, rivierasche, o umide. La terra è un “pozzo” naturale che assorbe i gas serra – fattore del riscaldamento – mediante vari processi, quali la fotosintesi, ma è anche produttrice di questi gas, quando la vegetazione brucia o si decompone. Secondo il rapporto citato², “Circa il 23% delle emissioni di gas serra di origine umana proviene da agricoltura, silvicoltura e altri usi del suolo (AFOLU).” Le emissioni sono prevalentemente dovute alla deforestazione, parzialmente compensate da imboschimenti e rimboschimenti e da altri usi del suolo. “L’agricoltura è responsabile di circa la metà delle emissioni di metano indotte dall’uomo ed è la principale fonte di protossido di azoto, due gas ad effetto serra molto potenti. Allo stesso tempo, la biosfera terrestre assorbe quasi il 30% delle emissioni antropogeniche di CO2 grazie ai processi naturali. Tuttavia, questa funzione è vulnerabile agli impatti dei cambiamenti climatici (ad es. a causa dell’aumento della siccità e degli incendi) e ad altre pressioni ambientali e umane.” I processi di antropizzazione possono alterare gli equilibri tra i vari ecosistemi, con effetti che possono essere negativi (per esempio, la deforestazione per espandere le terre coltivabili, per nuovi pascoli) o positivi (rimboschimenti). Meno carne e più vegetali fa bene all’uomo… e alla terra Il rapporto, che è tecnicamente assai complesso, analizza molti aspetti delle relazioni tra terra, clima e società in conseguenza del riscaldamento: la temperatura del globo, rispetto alla media del 1850-1900, è aumentata di quasi grado (Figura 1), che diventerà un grado e mezzo verso la metà del secolo. Il testo illustra i meccanismi del degrado dei suoli (Figura 2); indica le politiche da seguire
per frenare o arrestare il degrado (la protezione delle foreste, i rimboschimenti in prima linea); suggerisce alcune modificazioni nelle diete alimentari delle popolazioni, in particolare un minore consumo di carni rosse (l’allevamento è responsabile di forti emissioni di gas serra) e maggiore consumo di vegetali e frutta. Un cambio con ricadute positive sulla salute: infatti “Il potenziale di riduzione di gas serra dal cambio di alimentazione è elevato: una transizione diffusa a diete più sane potrebbe liberare un’area compresa tra i 4 e i 25 milioni di km² al 2050… e avrebbe un potenziale di riduzione di emissione confrontabile alle emissioni generate dalla deforestazione mondiale”. Insomma i mutamenti delle abitudini alimentari possono rendere meno insostenibile l’aumento dei consumi prodotto dalla crescita demografica. Ma, a livello globale, la tendenza della struttura delle diete va in direzione opposta, poiché all’aumento del reddito, nei paesi poveri, corrisponde un maggior consumo di carni, rendendo assai problematica la “transizione a diete più sane” invocata dal rapporto in questione.
Messaggi distorti e saggi ammonimenti Nell’opinione pubblica i contenuti dell’ultimo rapporto sono stati veicolati in modo assai distorto: i dispacci di agenzie, i siti dei giornali, i blog hanno fatto a gara ad annunciare che il riscaldamento globale porterà un aumento delle malattie, della fame, delle migrazioni, e dei conflitti nel mondo. Il lancio di un’agenzia nazionale di primaria importanza – ampiamente diffuso dai media – ha scritto “Onu: il cambiamento climatico aumenterà fame e migrazioni”. Peccato che il rapporto sfiori appena l’argomento delle migrazioni, avanzando solo ipotesi che però lo stesso Ipcc ritiene debolmente suffragate dai fatti. Per esempio: “C’è una corposa evidenza che indica che le decisioni migratorie sono motivate da un insieme
complesso di motivazioni, tra le quali la desertificazione e il cambio climatico giocano ruoli minori”³. Oppure. “Il legame tra degrado dei suoli e emigrazione si colloca nel più ampio contesto delle interazioni multilivello tra fattori ambientali e non ambientali.”[4] Che è un modo criptico per dire che essendo tanti i fattori che determinano le migrazioni, ogni ipotesi circa il loro andamento futuro è debole (quando non campata in aria). Stesso discorso per i conflitti: “C’è scarsa evidenza (“low confidence”) che il cambio climatico e la desertificazione conducano a conflitti violenti. C’è una moderata evidenza, e un basso consenso, circa l’ipotesi che il mutamento climatico e la desertificazione contribuiscano al potenziale conflittivo che già esiste”[5]. In parole semplici: il riscaldamento globale crea desertificazione e condizioni di maggiore stress per le popolazioni che vivono in queste aree (Africa, Asia) e che crescono rapidamente, e questo maggiore stress può alimentare i conflitti che sono però generati da innumerevoli fattori. Le considerazioni precedenti non significano certo che il riscaldamento globale non abbia conseguenze demografiche rilevanti. Sono circa 3 miliardi gli abitanti che vivono in zone aride (il 38% della popolazione mondiale), in Asia e in Africa in prevalenza, e si calcola che nel 2050 raggiungeranno i 4 miliardi. Si stima che circa un sesto della popolazione delle zone aride viva in zone nelle quali è in atto un processo di desertificazione (Figura 3). Inoltre tutte “le popolazioni delle zone aride sono molto vulnerabili alla desertificazione e al cambio climatico perché la loro sussistenza dipende predominantemente dall’agricoltura. …Il settore forse più colpito è quello della pastorizia e dell’agro-pastorizia. Non ci sono dati precisi sulla loro consistenza numerica, ma la maggior parte delle stime si pone tra i 100 e i 200 milioni, e tra questi tra 30 e 63 milioni praticano una pastorizia nomadica. Si tratta di serbatoi demografici rilevanti che gli stress climatici possono rendere maggiormente propensi alle migrazioni, in un quadro dimensionale – come già ricordato – imprecisato.
Le indagini dell’Iccp hanno toccato anche le conseguenze del cambio climatico sulla salute[6]; anche questo è un campo complicato perché solo in pochi casi si può trovare una precisa rispondenza tra clima e salute (come sarebbe per un fulmine che uccide una persona, o un’onda anomala che determina un annegamento). In sintesi si segnalano cinque punti: aumento dei rischi per la salute dovuti a più intense ondate di calore ed incendi; maggiori rischi di denutrizione per una diminuita produzione agricola in alcune regioni povere; minore capacità di lavoro e perdita di produttività in popolazioni vulnerabili; un aumento di rischi per malattie causate da microbi diffusi per via aerea o idrica, o da altri vettori. Inoltre le conseguenze negative sulla salute dovute al riscaldamento delle aree più calde, supereranno le conseguenze positive che il riscaldamento potrà avere nelle regioni più fredde.
Moderare la crescita demografica Una notazione finale: lo Ipcc, operando sotto l’egida delle Nazioni Unite, non include – tra i vari suggerimenti circa le vie da seguire per frenare il riscaldamento e mitigare le sue conseguenze – una raccomandazione, peraltro ovvia. Con serie e efficaci politiche sociali non coercitive, sarebbe possibile, nei prossimi decenni, accelerare l’attuale lenta transizione verso una natalità moderata di popolazioni ancora con altissimo tasso d’incremento, come l’Africa sub-sahariana. Secondo le ultime proiezioni delle Nazioni Unite, se nel 2050 i popoli subsahariani scendessero a 2,6 figli per donna (dagli attuali 4,7, anziché ai 3,1 previsti), conterebbero “solo” 850 milioni di abitanti in più rispetto a oggi invece dei 1.124 in più previsti. Ma la natalità è un tema politicamente sensibile che tutti ben conoscono, ma che in sede ONU non può essere invocato. Note ¹ IPCC, Climate Change and Land ²Più correttamente, secondo sua sintesi, disponibile nel sito italiano dell’IPCC, ³ Climate, cit, chapter 3, p. 39 [4] Ibidem, chapter 3, p. 57 [5] Ibidem, chapter 3, p. 39 [6] Ipcc, Global warming of 1.5 °C Causes and Effects of Climate Change | National Geographic
Four compelling reasons to fear population growth* Following on from last week’s article, Massimo Livi Bacci details four specific threats to human survival (or, at least, quality of survival) that are directly linked to population growth.
Four population-driven threats to space If from abstract principles and paradigms of my previous article (Malthus, forever?), we turn to the real, contemporary world, we may say that the rapidly expanding world population also has other consequences – beyond the reduction of “pristine” space – that may adversely affect the quality of the environment (space, in our paradigm) and bring about critical situations. Four of these consequences are strictly linked to sensitive environmental questions that will become critical as we proceed towards the end of the century, when world population growth, according to a rather optimistic consensus, is forecast to be close to zero. In the coming eight decades, the world is set to host an additional 3.4 billion people, a number equal to the increase accumulated in the preceding half a century.[1] These four consequences are: (i) human intrusion into the great forests, and particularly the rainforests, whose integrity is a guarantee of the bio-natural equilibrium; (ii) the intensification of human settlement in the most precarious habitats, in particular along coasts and on the shores of rivers and lakes; (iii) the explosion of urbanization processes and (iv) last but not least, global warming. Each one of these four processes may be described as a population-driven threat to the environment, affecting the quality of space available to humankind. Population-driven threats to the environment: 1) deforestation Deforestation processes have accompanied demographic growth ever since the initial spread of agriculture. The great forests play a crucial role in maintaining environmental balances by moderating greenhouse gas emissions, and thus global warming; by maintaining the integrity of water reserves; and by protecting biodiversity. Unfortunately, trees give more (immediate) profit when they are cut down than when they are alive and growing, and pasture and arable land have
Puoi anche leggere