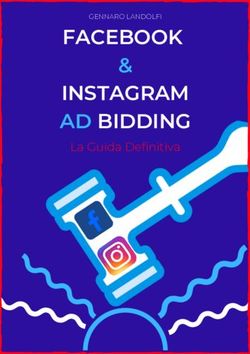Giuseppe Morbidelli: della Costituzione come costituzionalismo - di Tommaso E. Frosini
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
PAPER – 1 APRILE 2020
Giuseppe Morbidelli: della
Costituzione come costituzionalismo
di Tommaso E. Frosini
Professore ordinario di Diritto pubblico comparato
Università degli Studi di Napoli Suor Orsola BenincasaGiuseppe Morbidelli: della Costituzione come
costituzionalismo *
di Tommaso E. Frosini
Professore ordinario di Diritto pubblico comparato
Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa
Sommario: 1. Le Lezioni di diritto pubblico comparato come Allgemeine Staatslehre 2. Lo “stile fiorentino” di Beppe
Morbidelli. 3. Morbidelli e il metodo spontaneo della comparazione.
1. Le Lezioni di diritto pubblico comparato come Allgemeine Staatslehre
Mio graditissimo compito, in questa giornata di studio dedicata a un caro Amico e Maestro (e che
pertanto, nelle pagine che seguono, mi permetterò di chiamarlo Beppe), è quello di parlare di un libro
dalla copertina rilegata in un elegante blu cobalto, con lettere vergate colore oro, dal titolo semplice ma
con un sottotitolo che svela l’intensità concettuale del contenuto. Si tratta delle Lezioni di diritto pubblico
comparato. Costituzioni e costituzionalismo, che Beppe Morbidelli pubblica nel 2000, per i tipi della Monduzzi,
rendendo così editorialmente autonomo il primo capitolo di un manuale di Diritto costituzionale italiano e
comparato, scritto insieme a tre colleghi. Un libro, quello di Beppe, che conosco bene per averlo più volte
letto e studiato e, soprattutto, per averlo adottato nei corsi di diritto pubblico comparato, che ho tenuto
all’Università di Sassari negli anni dal 2000 al 2007.
Nella vasta e ricca produzione scientifica di Beppe questo è l’unico titolo “puro”, per così dire, ascrivibile
al diritto pubblico comparato, materia insegnata dal Nostro per molti anni nella Facoltà di Scienze
politiche dell’Università di Firenze. Sarebbe però riduttivo qualificare questo libro come una sorta di
dispense a uso degli studenti, così come sarebbe espansivo presentare il libro come un manuale di diritto
pubblico comparato, anche perché privato di diverse tematiche che attengono alla materia. Vorrei definire
il libro alla maniera tedesca, come i grandi testi del finale Ottocento: Allgemeine Staatslehre, e quindi dottrina
generale dello stato ovvero, meglio, della Costituzione. Perché, si trovano centrati e concentrati tutti i
concetti, e le teorie derivate, delle costituzioni e del costituzionalismo. Con una parte introduttiva sul
diritto e l’interpretazione, che si lascia altrettanto apprezzare per la sua chiarezza lessicale e puntualità
concettuale. E da dove si manifesta la prima teorizzazione di Beppe, garbata ma netta come è nel suo
stile, laddove indica il diritto quale non una creazione dello stato ma piuttosto del pluralismo sociale e
politico pieno ed effettivo: «il diritto è un prodotto necessario della vita sociale, che nasce spontaneamente
* Paper non sottoposto a referaggio.
2 federalismi.it - paper 1 aprile 2020nella convivenza umana, senza la quale non esisterebbe». Per poi ricordare la tesi della cd. “ipotesi robinsoniana”, «dove c’è un solo uomo, Robinson nell’isola deserta, non c’è diritto perché il diritto ha insito in sé il concetto di relazione». E’ quindi nel diritto la capacità di organizzare il sociale, di mettere ordine nella società, di darsi e farsi un ordinamento. Anche se un ordinamento giuridico perfettamente omogeneo, unitario, ordinato, non appartiene al mondo reale dell’esperienza giuridica, perché in ogni ordinamento giuridico evoluto la compresenza degli ordini di relazione fra gli elementi costitutivi genera problemi di contrasto o composizione. “Ordine e disordine nel diritto”, come è stato scritto. Le Lezioni raccontano e spiegano il costituzionalismo in tutte le sue declinazioni organizzative, che impattano entro il perimetro della democrazia liberale. Questo è un altro aspetto che mi preme evidenziare: il costituzionalismo non è un concetto neutro giammai adattabile a tutte le esperienze purché abbiano una costituzione, che poi eventualmente si rivela essere “di facciata”. Il costituzionalismo è una tecnica di libertà degli individui verso ogni forma di potere. La costituzione, secondo il costituzionalismo, è insieme un sistema e una storia. Come scrive Beppe, «si considerano superiori quelle leggi che appaiono opera della Storia (quasi scaturita dal corpo sociale stesso) piuttosto che del Potere». La storia è un tornante determinante per capire l’evoluzione del costituzionalismo al di là e oltre la forza del potere costituente. Certo, Beppe affronta e analizza il problema del potere costituente ma non dà quel rilievo che talvolta si intende attribuire a questo “terribile potere”, che è quello di decidere, il potere cioè di instaurare una Costituzione, di creare una Costituzione come se fosse un momento nel quale, come una sorta di bacchetta magica, si decide di dar vita a una Costituzione che regoli l’organizzazione sociale di un popolo. Mentre invece la Costituzione è costituzionalismo, ovvero è un processo di evoluzione storica che poi si invera in una codificazione, in un testo costituzionale. Oppure, come insegna la storia costituzionale inglese, può svilupparsi financo senza codifica scritta ma legittimata da un idem sentire. E le più significative tappe della storia costituzionale, italiane e comparate, sono evidenziate nelle pagine delle Lezioni, con acribia e puntualità, concedendo anche il vezzo di una citazione, che so essere cara a Beppe, dell’esperienza costituzionale della Repubblica di Lucca del 1799. La storia è uno dei formanti della comparazione, specialmente per il pubblicista. Sul punto, può utilmente citarsi James Bryce: «il costituzionalista deve essere sempre storico [comparatista], non meno che giurista, se vuole comprendere l’oggetto dei suoi studi e discuterlo profittevolmente». Credo che questa sia la cifra che abbia sempre contraddistinto lo “stile fiorentino” degli studiosi che si sono occupati di costituzioni e costituzionalismo. Anche perché il motivo di fondo delle loro ricerche, e quindi anche e soprattutto di Beppe, è prevalentemente incentrato sulla individuazione dei modi e dei limiti di esercizio dei pubblici poteri. 3 federalismi.it - paper 1 aprile 2020
2. Lo “stile fiorentino” di Beppe Morbidelli Mi sono chiesto perché Beppe, uomo mai privo di impegni professionali e istituzionali, ha deciso di dedicare tempo, energie e impegno a scrivere un libro come le Lezioni. Risposta facile ma, a mio avviso, fallace, sarebbe quella riferita alle sole esigenze didattiche, e quindi dettata dalla necessità di volere fornire agli studenti del corso di Diritto costituzionale italiano e comparato un testo sul quale studiare. Io credo, piuttosto, che le Lezioni si collochino nello “stile fiorentino”, poc’anzi ricordato. Ovvero, nella tradizione dei costituzionalisti fiorentini, che hanno voluto e saputo diffondere una cultura della costituzione e del costituzionalismo. A partire dal Maestro dei maestri, Piero Calamandrei, e la sua dottrina della viva vox constitutionis, per poi proseguire con Paolo Barile della Costituzione come norma giuridica (1951), Mario Galizia sulla Scienza giuridica e diritto costituzionale (1954), Alberto Predieri su Pianificazione e Costituzione (1963) e poi tutti gli allievi di questi Maestri (da Enzo Cheli in poi); così come va senz’altro ricordato Paolo Grossi e la sua scuola (penso soprattutto agli studi di Maurizio Fioravanti). Questa è la dimostrazione di come a Firenze ci si sia impegnati, in maniera forse più che altrove, a diffondere il concetto di Costituzione, il valore della Costituzione, la cultura costituzionale del costituzionalismo. Beppe ha voluto così contribuire, da par suo, a mantenere, ferma e forte, la tradizione costituzionalistica dello “stile fiorentino”, anche come omaggio al suo Maestro Alberto Predieri. Sullo “stile fiorentino” in tema di costituzioni e costituzionalismo, come valorizzazione e diffusione dello stesso, occorrerà indagare, magari attraverso uno studio che esamini le radici del problema, e quindi a partire dalla dottrina costituzionale di Piero Calmandrei. Per capire quanto, come e perché i maggiori allievi della scuola hanno derivato le loro teorie costituzionalistiche in maniera conforme, oppure diversificata, rispetto all’insegnamento del Maestro. Esercizio speculativo che lasciamo a futura memoria, per così dire. Intanto, chiaro e netto appare il legame fra il metodo di Alberto Predieri e quello di Beppe Morbidelli. Proprio in punto di costituzioni e costituzionalismo. Qui mi avvalgo di una citazione tratta da un recentissimo saggio di Beppe dedicato a Il contributo fondamentale di Alberto Predieri alla evoluzione e alla decifrazione della nozione giuridica di paesaggio (2019). Scrive Beppe: «per Predieri non vi era la necessità di ricorrere all’invero spesso opinabile e produttivo di incertezze criterio della interpretazione evolutiva. Riteneva […] di procedere ad una interpretazione sistematica, che non vuol dire solo sistematica dell’ordinamento giuridico, ma sistematica nel senso che va ad abbracciare tutte le scienze che hanno a che vedere con i settori toccati dal diritto positivo e che potremmo definire sistematica-integrativa». Quello della interpretazione costituzionale sistematica-integrativa ritengo sia lo stesso metodo utilizzato da Beppe, che ha appreso dal suo Maestro e come emerge chiaramente dalla lettura delle sue Lezioni. Specialmente nelle pagine iniziali del (secondo) capitolo sulle costituzioni e costituzionalismo, dove prima precisa e chiarisce che quella di costituzione è una nozione esclusivamente giuridica, per poi esporre la 4 federalismi.it - paper 1 aprile 2020
sua interpretazione sistematica-integrativa quando afferma che «la nozione di costituzione può essere identificata solo attraverso una serie di passaggi e dunque di precisazioni svolte in sequenza, e comunque può essere compresa solo dopo avere posto una serie di ulteriori nozioni o delineato una serie di istituti che la caratterizzano». 3. Morbidelli e il metodo spontaneo della comparazione Come si dispiega la comparazione nelle Lezioni, che sono per l’appunto di diritto pubblico comparato? Qual è il metodo comparativo utilizzato da Beppe? Sul punto, voglio innanzitutto dire una cosa: Beppe non è certo uomo da etichette, quindi non è un costituzionalista, tanto meno un comparatista oppure un amministrativista, egli è un giurista, un giurista tout court. I giuristi, quelli veri, non hanno bisogno di essere inquadrati in uno specifico settore disciplinare IUS: per usare una metafora, essi sono come un pianoforte perché qualunque tasto (in tema di diritto) pigi suona. Anche perché il diritto è un fenomeno unitario, che non può essere mai visto in maniera specialistica o parcellizzata ma piuttosto va interpretato e applicato tenendo in conto tutte le varie iterazioni che vi sono tra le varie discipline. Quindi, la visione comparatistica, il metodo comparativo di Beppe Morbidelli che emerge nelle Lezioni non è quella di maniera un po’ tendenziale di studiare un micro o macro istituto di un ordinamento straniero, ovvero di fare l’atlante costituzionale comparatistico diviso per Paesi. In Morbidelli c’è un unico ragionare, ci sono gli istituti, ci sono le norme, c’è la prassi e come questa si invera attraverso l’effettività negli ordinamenti stranieri. C’è quindi la capacità di saper usare la comparazione come ausilio per ben interpretare le leggi. Questa è una prerogativa riservata davvero ai veri maestri che fanno diritto comparato in maniera spontanea, cioè senza una vera e propria teorizzazione del ruolo della comparazione giuridica, perché gli viene naturale dover andare a studiare cosa e come altrove si regolamenta ma non poggiandosi sull’istituto straniero, non evidenziando come altrove è stato regolato quel determinato fenomeno giuridico, ma utilizzandolo per capire e far capire come funziona il diritto, come si interpreta una Costituzione, come si svolge e si attua un ordinamento giuridico. Vorrei allora dire che le Lezioni non è un libro di diritto comparato ma è un libro per il diritto comparato: la differenza è sottile ma ha una sua rilevanza. Non è un libro che esamina la comparazione e fa uso della comparazione, ma piuttosto un libro che aiuta a saper ragionare secondo gli stilemi comparatistici, che aiuta a ragionare affinché si possa raggiungere un certo intendimento complessivo delle problematiche giuridiche tenendo conto, come oggi non si può fare altrimenti, di ciò che altrove si è provato a regolamentare. Le Lezioni, poi, illustrano e rappresentano la classificazione delle Costituzioni. Questa è una parte molto bella, dove si prova a individuare in maniera molto chiara i passaggi più identificativi, che ci aiutano a 5 federalismi.it - paper 1 aprile 2020
capire come le Costituzioni storicamente si sono venute a rappresentare e quindi è possibile classificarle sulla base del loro formarsi, della loro rigidità o flessibilità, della scrittura o della convenzionalità, sulla lunghezza o sulla brevità. Su ognuno di questi criteri Beppe ci offre riflessioni e puntualizzazioni molto acute. Certo, c’è anche la costituzione materiale: perché è vero che per Beppe la costituzione è sempre norma giuridica, come sopra ho ricordato, e quindi la va letta e interpretata come un atto giuridico senza concedere molto all’effettività. La costituzione materiale, però, non è – né potrebbe esserlo – sottratta alla complessiva rappresentazione delle problematiche del costituzionalismo. Beppe la definisce in maniera molto pertinente e chiara. La costituzione materiale è «la costituzione formale che abbandona la funzione normativista della separazione fra diritto e politica». Si tratta di una definizione molto efficace, che semplifica un concetto che semplice non è. Infatti, è un esercizio complesso provare a spiegare (agli studenti, in primis) che cosa è e cosa si intende per costituzione materiale: anche perché è stato un concetto che ha subito, negli anni, una sorta di inquinamento lessicale dovuto all’uso dilatato che ne hanno fatto anche i giornali, che ne ha fatto la politica, che ne ha fatto un po’ il linguaggio quotidiano, che utilizza la costituzione in senso materiale quasi come se fosse un’altra e diversa costituzione rispetto a quella formale. Sappiamo, ovviamente, l’origine dottrinale del concetto e la sua collocazione storica, che sebbene abbia superato lo Zeitgeist si è poi avviluppato nelle tortuosità della strumentalizzazione politica. Beppe, con la sua definizione di costituzione materiale restituisce al concetto chiarezza e dignità scientifica. C’è poi un’altra questione, trattata da Beppe, che vale la pena di evidenziare, ed è quella relativa alle dinamiche costituzionali. Anche qui la stessa idea del dinamismo costituzionale lascerebbe intendere un uso della Costituzione affidato più al principio di effettività, alla prassi, ma anche qui Beppe tiene il discorso entro il binario giuridico. Dinamiche e non divagazioni o, peggio, deragliamenti costituzionali. Sostiene Morbidelli: «La costituzione reca con sé un implicito carattere di stabilità», ma ricorda altresì, citando Federico Cammeo, che «nessuna costruzione umana può essere eterna e tutte per vivere debbono adattarsi alle variabili concezioni politiche e sociali». Da qui il problema della presunta naturale rigidità delle costituzioni scritte, in luogo di una naturale elasticità e adattabilità delle costituzioni al cambiamento sociale, politico, sociale e tecnologico. Concludo. Le Lezioni è un libro che manifesta per così dire un esprit de géometrié ma si trasforma e si realizza in un esprit de finesse, cioè nella sua capacità di saper mettere in maniera chiara tutti i passaggi giuridico- costituzionali per poi esprimere una finezza nella esposizione e nella rappresentazione. E allora mi piace concludere queste mie brevi riflessioni con una citazione che uso spesso perché mi è sempre parsa molto significativa. E’ una citazione di Tullio Ascarelli ed estratta dal suo Gli studi di diritto comparato del 1952. Sostiene Ascarelli: «nell’attuale crisi dei valori il mondo chiede ai giuristi piuttosto 6 federalismi.it - paper 1 aprile 2020
nuove idee che sottili interpretazioni». E’ la questione del legal problems solving e si riferisce alla missione del giurista, che è quella di risolvere problemi non di crearne attraverso le sottili interpretazioni, di offrire nuove idee ai giovani, nuove idee per lo sviluppo e l’evoluzione della giurisprudenza, nuove idee che possano contribuire alla crescita della società attraverso un nuovo modo di intendere le situazioni giuridiche, i diritti, la trasformazione dei diritti, il cambiamento dei diritti sulla base del cambiamento sociale, delle innovazioni anche di natura tecnologica. Ebbene io credo che questa frase, questa affermazione di Tullio Ascarelli si calibra perfettamente nell’itinerario di Giuseppe Morbidelli, che ha saputo dispensare sempre nuove idee, soprattutto in favore dei giovani; che ha saputo sempre provare a risolvere i problemi piuttosto che elaborare, seppur sottili, interpretazioni, per consentire, a me per primo e di questo gliene sarò sempre riconoscente, di sapere andare avanti, nello studio come nella vita, con maggiore fiducia e determinazione. 7 federalismi.it - paper 1 aprile 2020
Puoi anche leggere