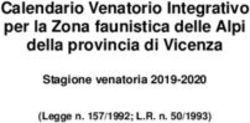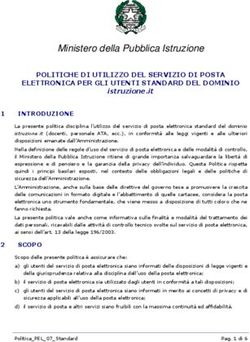Economia delle decisioni - Argomenti della lezione 5/8/18
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
5/8/18
Economia delle decisioni
Introduzione
Argomenti della lezione
• Struttura del corso
• Valutazione finale
• Cosa si studia in Economia delle Decisioni
• Cenni metodologici
2
15/8/18
Struttura del corso
Sessioni e calendario
18 sessioni da 90 minuti
Settimana Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
1 (07/05) 16-18 16-18 16-18 14-16
2 (14/05) 16-18 16-18
3 (21/05) 16-18 16-18 16-18 14-16
4 (28/5) 16-18 16-18 16-18 14-16
5 (04/06) 16-18 16-18 16-18 14-16
Tutte le sessioni in Aula 11
Alcune sessioni pratiche in cui applicheremo i concetti teorici sviluppati durante il
corso
3
Struttura del corso
Argomenti principali
1. Introduzione alla teoria della scelta
2. Scelta in condizioni di ignoranza
3. Scelta in condizioni di rischio: probabilità
4. Scelta in condizioni di rischio: utilità
5. Teoria dei giochi
Approccio
Gli argomenti saranno affrontati partendo dalla teoria base (principalmente la
teoria dell’utilità attesa)
Ci confronteremo con sviluppi recenti, concentrandoci sugli aspetti
comportamentali delle decisioni
4
25/8/18
Struttura del corso
Letture
Per la maggior parte degli argomenti, le diapositive verranno pubblicate online
dopo le lezioni
Le diapositive contengono sufficienti dettagli per coprire adeguatamente gli
argomenti principali del corso
Per approfondimenti, si consigliano i testi:
• Teoria standard: Michael D. Resnik (1987). Choices: An Introduction to Decision
Theory. University of Minnesota Press
• Sviluppi comportamentali: Nick Wilkinson and Matthias Klaes (2012). An
Introduction to Behavioral Economics. Palgrave Macmillan
5
Valutazione finale
La valutazione avviene tramite esame scritto
Struttura dell’esame
• 4 domande, da 8 punti ciascuna
• 2 domande in stile pratico (esercizi analoghi a quelli svolti nelle sessioni pratiche)
• 2 domande a risposta aperta sugli argomenti teorici (da una lista di 4)
Prossime date
22 giugno ore 15:00
27 luglio ore 15:00
6
35/8/18
Cosa si studia in Economia delle Decisioni
La maggior parte dell’economia si occupa di decisioni
Spesso queste riguardano l’allocazione ottimale di risorse scarse
Esempi
• Comportamento del consumatore: come scegliere il paniere ottimale dati i
prezzi dei beni disponibili e il reddito a disposizione
• Scelta in condizioni di rischio o incertezza: scegliere l’opzione con l’utilità attesa
più elevata
• Produzione: massimizzare il profitto data la domanda e i prezzi dei fattori di
produzione
• Interazione strategica (teoria dei giochi): scegliere la migliore strategia dato che
gli altri agenti fanno lo stesso
7
Cosa si studia in Economia delle Decisioni
L’approccio standard caratterizza il comportamento in termini di razionalità
I modelli che ne risultano intendono essere contemporaneamente:
• Descrittivi: forniscono un’adeguata spiegazione di come gli agenti economici si
comportano in realtà
• Normativi (o prescrittivi): forniscono raccomandazioni su come gli agenti
economici dovrebbero comportarsi per essere razionali
L’aspetto normativo è particolarmente importante per le sue implicazioni pratiche
– gli economisti sono fieri delle raccomandazioni che derivano dalle loro analisi
L’aspetto descrittivo spesso mette in dubbio i precetti derivanti dalla teoria
standard, ed è stato il fulcro del recente interesse per l’approccio
comportamentale
8
45/8/18
Cosa si studia in Economia delle Decisioni
Cosa si intenda esattamente per razionalità dipende dalle circostanze
Di solito si parte da una serie di assiomi – proprietà delle preferenze degli agenti
economici che si assumono vere senza bisogno di dimostrazione
Come vedremo, le più basilari sono:
• Completezza
• Transitività
Spesso si aggiungono:
• Monotonicità (nella scelta del consumatore, nota come ‘non sazietà’)
• Convessità (opzioni intermedie preferite ad opzioni estreme)
Esempio
Assunzioni di questo tipo ci consentono di descrivere le decisioni di un
consumatore usando curve di indifferenza
9
Cosa si studia in Economia delle Decisioni
A seconda delle situazioni occorrono ulteriori assiomi
Scelta in condizioni di rischio e incertezza
Per derivare la teoria dell’utilità attesa occorrono assunzioni quali:
• L’assioma dell’indipendenza (implica linearità rispetto alla probabilità)
• Le probabilità sono trattate nel rispetto delle leggi del calcolo delle probabilità
Scelta intertemporale
• Occorre stabilire come gli agenti trattano conseguenze che si verificano in tempi
diversi
Interazione strategica
• La razionalità individuale non è sufficiente
• Occorre assumere che tutti gli agenti siano razionali e che tutti sappiano che
tutti sono razionali (‘common knowledge of rationality’)
• Occorre decidere come vengono trattate le conseguenze per gli altri agenti
(autointeresse)
10
55/8/18
Cosa si studia in Economia delle Decisioni
Un modo conciso di catturare queste assunzioni è attraverso il modello economico
standard
-
max
&
) .* ) 1 2* 3( 56 * |2* )
$% ∈(% *+, /& ∈0&
A parole, il modello rappresenta il fatto che un agente razionale:
• è motivato dalla massimizzazione dell’utilità attesa
• Non ha diretto interesse per l’utilità degli altri agenti
• Utilizza le probabilità secondo le leggi del calcolo delle probabilità
• Sconta le conseguenze future in maniera esponenziale
11
Cosa si studia in Economia delle Decisioni
Esempio
Cosa bere prima della lezione di Economia delle Decisioni?
oppure
Interessante (p = 0.8) Noiosa (p = 0.2)
Caffè 10 2
Birra 6 4
EU(Caffè) = 10x0.8 + 2x0.2 = 8.4
EU(Birra) = 6x0.8 + 4x0.2 = 5.6
Perciò, per ottenere massimo giovamento dalla lezione conviene bere caffè!
12
65/8/18
Cosa si studia in Economia delle Decisioni
Applicabilità
Il modello economico standard è estremamente generale
Può essere applicato alle decisioni più disparate
Non solo quelle che possono sembrare ovviamente economiche, ma anche
decisioni come:
• La ricerca di un partner
• La scelta di guardare un documentario in TV anzichè fare qualcos’altro
• Fare una donazione
• …
Questo illustra che il dominio di applicabilità del modello – l’insieme dei fenomeni
per i quali puo’ essere utilizzato – è estremamente ampio
Ma il suo dominio di validità – l’insieme dei fenomeni per i quali le previsioni sono
accurate – è ugualmente ampio?
Incontreremo vari casi in cui la validità a descrittiva del modello è messa in dubbio
dall’evidenza empirica
13
Cosa si studia in Economia delle Decisioni
Esempi
1. Gli scommettitori fanno puntate molto più rischiose alla fine della giornata
rispetto a quelle che fanno all’inizio
2. Gli stessi individui mostrano avversione al rischio assicurandosi, e allo stesso
tempo propensione al rischio giocando d’azzardo o scommettendo
3. Il differenziale di rendimento tra azioni e titoli di stato è di gran lunga
superiore a quello che ci si può attendere sulla base di ragionevoli livelli di
avversione al rischio (equity premium puzzle)
4. Molti individui si recano spesso al bancomat ritirando meno del massimo che
possono ritirare in una volta sola
5. Molti individui preferiscono posticipare un’esperienza positiva piuttosto che
farla immediatamente
6. Un aumento di salario del 10% rende le persone felici, ma non se il loro collega
riceve un aumento del 15%
14
75/8/18
Cosa si studia in Economia delle Decisioni
Per spiegare violazioni sistematiche della teoria standard come quelle menzionate
negli esempi precedenti, dobbiamo andare oltre l’approccio standard
L’approccio comportamentale è uno dei modi di farlo
Utilizzando idee da altre discipline come psicologia cognitiva, psicologia evolutiva,
biologia evolutiva, neuroscienze cognitive, ..., si cerca di arrivare ad una
descrizione piu’ accurata del comportamento umano
Questo richiede varie iterazioni tra teoria ed evidenza (l’evidenza richiede
cambiamenti teorici, le nuove teorie vengono testate, le teorie revisionate, testate,
...)
15
Cenni metodologici
L’economia spiega il comportamento economico usando teorie e modelli
Una teoria è un apparato di proposizioni astratte volte a spiegare un fenomeno o
una serie di fenomeni
La maggior parte delle teorie sono basate su assunzioni, che vengono usate per
derivare predizioni circa i fenomeni di interesse
In economia le teorie vengono presentate utilizzando dei modelli
Un modello è una rappresentazione semplificata di entità reali, e ha l’obiettivo di
isolare gli effetti delle variabili di interesse, trascurando altri fattori
(Nota: tutti i modelli sono necessariamente ‘falsi’: ‘Essentially, all models are
wrong, but some are useful’ – George Box)
I modelli spesso consentono di derivare predizioni testabili riguardo le variabili di
interesse
16
85/8/18
Cenni metodologici
Che significa testare una teoria?
Secondo l’approccio standard, ciò che conta è che una teoria abbia predizioni
accurate, a prescindere dalla plausibilità delle assunzioni
Questo posizione metodologica è spesso attribuita al premio Nobel Milton
Friedman e chiamata ‘as if modelling’ (modellizzazione ipotetica)
Ciò che conta è il comportamento osservato, non il processo cognitivo che genera
la decisione
(Estremizzando, si può essere soddisfatti di fare la predizione giusta per le ragioni
sbagliate)
Nell’approccio comportamentale, si ritiene che le singole assunzioni possano
essere sottoposte a esame
Molti modelli comportamentali procedono rimpiazzando le assunzioni standard
con assunzioni derivate dall’evidenza sulla psicologia umana
Spesso questo risulta in modelli procedurali (‘process models’), in cui il come si
arriva alla decisione è importante quanto il risultato della stessa
17
Cenni metodologici
Criteri per la valutazione di una teoria
1. Congruenza con la realtà (realismo) – una buona teoria deve essere testabile
compatibile con l’evidenza empirica
2. Generalità – a parità di altre condizioni (ceteris paribus) una teoria è
preferibile se è applicabile ad un’ampia selezione di fenomeni
3. Trattabilità – ceteris paribus, una teoria è preferibile se è facile da applicare a
nuove situazioni (il che spesso dipende dalla sua formulazione matematica e
dal numero di parametri)
4. Parsimonia – ceteris paribus, una teoria è preferibile se richiede il minimo
numero di assunzioni necessarie per spiegare i fenomeni di interesse (il ‘rasoio
di Occam’: ‘a parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire’ – nella
versione attribuita ad Einstein: ‘Everything should be made as simple as
possible, but not simpler’)
18
95/8/18
Cenni metodologici
L’approccio comportamentale aggiunge:
5. Precisione – ceteris paribus, una teoria che fa predizioni numeriche più
accurate o seleziona un numero inferiore di possibili soluzioni è preferibile
6. Plausibilità psicologica – ceteris paribus, una teoria basata su assunzioni
compatibili con ciò che è noto sulla psicologia umana è preferibile
Ci sono chiaramente trade-offs tra questi criteri
Modelli con più parametri (meno parsimoniosi) spiegano meglio l’evidenza (hanno
maggiore realismo)
Modelli più generali sono contraddetti dall’evidenza più facilmente
Ma attenzione che aggiungere parametri per spiegare ogni dettaglio dell’evidenza
disponibile può limitare l’abiltà di spiegare nuova evidenza (over-fitting)
19
Cenni metodologici
Fonti di evidenza empirica
Studi sul campo
Gli agenti economici vengono osservati nel loro ambiente naturale, prendendo
decisioni che hanno conseguenze reali
Alta validità ecologica, ma molteplici fattori all’opera simultaneamente
(‘confounds’), e conseguente limitazioni nelle inferenze causali
Esperimenti di laboratorio
Il comportamento è studiato in condizioni controllate (di solito in laboratorio)
Alta validità interna (solide inferenze causali), ma difficoltà con la validità esterna
(anche legate all’artificialità)
Esperimenti sul campo
Una via di mezzo tra gli studi sul campo e gli esperimenti di laboratorio, con virtù e
limitazioni intermedie
Particolarmente in voga al momento
20
105/8/18
Cenni metodologici
In economia, gli studi sul campo sono stati preferiti tradizionalmente, perchè:
• L’interesse sul cosa l’agente fa supera l’interesse sul perchè lo faccia
• L’informazione ha le caratteristiche di preferenza rivelata – comportamento
effettivo con reali conseguenze economiche (‘put your money where your mouth
is’)
• Le difficoltà nel condurre esperimenti efficaci (artificialità, questioni etiche, …)
• L’interesse nel comportamento aggregato, in particolare nei mercati
(l’irrazionalità individuale non è un grosso problema se i soggetti irrazionali
vengono eliminati dal mercato)
Negli ultimi decenni il metodo sperimentale ha preso piede in economia, usando
convenzioni frequenti quali:
• Gli incentivi reali (principalmente finanziari)
• Il bando dell’inganno (‘deception’) dei soggetti sperimentali
• La descrizione astratta dell’ambiente sperimentale
• La replicazione stazionaria per facilitare la convergenza del comportamento
• La libera condivisione di dati e materiali per facilitare la replicazione
21
Cenni metodologici
Recentemente si è diffuso l’uso di evidenza neuroscientifica nel testare ipotesi
economiche, ma il suo utilizzo è ancora piuttosto controverso
22
115/8/18
Letture
• Wilkinson and Klaes (2012), capitolo 1
23
12Puoi anche leggere