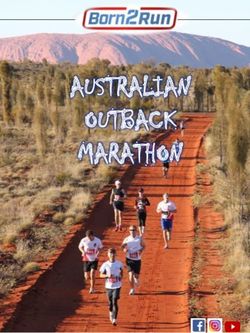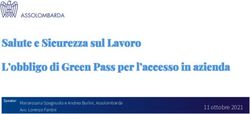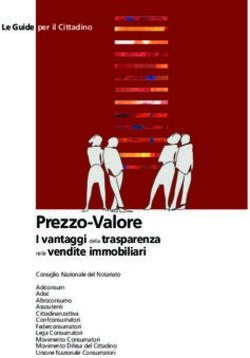E' la fine, per me l'inizio della vita - Eutanasia e suicidio assistito: una prospettiva protestante - Cristiani Sarzana
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
E’ la fine, per me l’inizio della
vita
Eutanasia e suicidio assistito: una
prospettiva protestanteCosa si intende per vita
I greci utilizzavano tre parole per indicare la vita:
1. zoé (vitalità fisica degli esseri organici, il
termine può essere riferito ad animali, esseri
umani o piante),
2. bios (riferito alla vita umana; ne indica il
costume di vita, il carattere);
3. psyché (anima vivente, si riferisce all’essere
umano che pensa, decide e agisce).L’ambito della riflessione Sino a circa 20 anni fa si pensava che i soggetti coinvolti nelle tematiche dell’eutanasia e del suicidio assistito fossero prevalentemente pazienti oncologici o, più in generale, quelli terminali Oggi scopriamo una platea più ampia e riferita a molte altre situazioni e patologie: patologie neurologiche degenerative, traumi permanenti del sistema nervoso, malattie psichiche, stati vegetativi persistenti, ecc.)
Posizione delle chiese Riguardo ad eutanasia e suicidio assistito tento nel 1998, epoca in cui fu redatto il primo documento BMV come ancora oggi in ambito cristiano è prevalso un giudizio negativo nei confronti dell’eutanasia e del suicidio assistito.
Definizioni: eutanasia
Si parla di eutanasia quando si verificano queste
condizioni:
1. uccisione intenzionale di un individuo,
2. attività praticata da parte di un medico
3. somministrazione di farmaci letali
4. richiesta volontaria e competente espressa
dall’individuo che vuole accedere alla «dolce
morte»Definizione: suicidio assistito
Si parla di suicidio assistito quando si verificano
queste condizioni:
1. Volontà di suicidarsi in modo rapido e
indolore
2. Attività assistita da un medico
3. Prescrizione di farmaci e consigli sulle
modalità di assunzionecomparazione
Condizione Eutanasia Suicidio assistito
VOLONTA’ INDIVIDUO Sì Sì
Atto volontario a cui Atto volontario a cui
MEDICO consegue la consegue la
somministrazione del prescrizione di farmaci e
farmaco letale l’indicazione modalità di
assunzione
SOMMINISTRAZIONE Effettuata da medico Effettuata da interessato
Diversa dalle due scelte sono l’astensione terapeutica e la
sospensione delle cure.
In tutte queste situazioni c’è un’esplicita volontà del malato a
seguito della quale il medico decide di astenersi o interrompere
un trattamento sanitario anche se dalla scelta potrebbe derivare
la morte del paziente.Il rapporto medico-paziente • Ippocrate, nel V sec. A.C. aveva elaborato un giuramento, oggi riscritto in forma moderna e adottato dagli Ordini Professionali, che anticipava molti aspetti moderni della medicina, della psicosomatica, della pericolosità di farmaci, ecc. • Fino agli anni ’60 vigeva in Italia un modello paternalistico dove il medico è l’unico responsabile della salute e del benessere del proprio paziente, che poteva approvare o meno le sue scelte. • Dopo il 1968 ha cominciato a manifestarsi un modello autonomista che trova le proprie radici nell’illuminismo e per il quale il medico deve prendere atto dell’autodeterminazione del «suo» paziente. • Il modello attuale è quello della «beneficità» che è inteso in due modi: uno negativo, finalizzato al non nuocere e uno positivo fare solo il bene del paziente (L’inizio e la fine della vita – le sfide della bioetica – a cura di Dora Bognandi e Martin Ibarra - Ed. Claudiana 2005 pagg. 63-64 – sulla base dell’intervento di Bruno Rimoldi)
Cure palliative Vi sono delle tecniche mediche e farmacologiche che si sono sempre più sviluppate per migliorare le condizioni in cui il paziente affronta patologie dolorose o pesanti sotto l’aspetto psicologico. La definizione che ne dà l’Organizzazione Mondiale della Sanità è:“Le cure palliative sono un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle famiglie che si confrontano con i problemi associati a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo dalla sofferenza per mezzo dell’identificazione precoce, dell’approfondita valutazione e del trattamento del dolore e di altri problemi, fisici, psico-sociali e spirituali”
Effetti dello sviluppo cure palliative Hanno cambiato il modo di porre la questione del fine vita nella società occidentale: 1) per alcuni hanno ridotto le attenzioni sociali sul tema dell’eutanasia 2) Per altri non hanno inciso sulla questione eutanasica perché questa è una scelta etica libera ed indipendente dalla tecnologia
Scenari di cura della palliativa • Approccio alternativo: si attiva quando la malattia non risponde più alle cure specifiche e occorre controllare il dolore, i sintomi collaterali ed i problemi psicologici, sociali e spirituali del malato. • Approccio simultaneo: si attiva quando la patologia inguaribile e in fase avanzata non è ancora terminale e si sviluppa contemporaneamente alle cure specialistiche contro la malattia
La sedazione palliativa Questa procedura prevede la somministrazione intenzionale di farmaci alla dose necessaria per ridurre fino ad annullare la coscienza del paziente, allo scopo di alleviare il dolore e il sintomo refrattario fisico e/o psichico intollerabile per il paziente in condizione di imminenza della morte. Requisiti contemporanei per accedervi sono: 1. Consenso informato del paziente 2. Malattia inguaribile allo stadio avanzato 3. Morte imminente attesa entro brevissimo tempo 4. Presenza di sintomi refrattari e sofferenza intollerabile
Aspetti etici della sedazione • È una procedura riconosciuta come «etica» dal Comitato Nazionale di Bioetica perché è «trattamento sanitario» e non «eutanasia» • La letteratura medica mostra che la durata media della sopravvivenza dei pazienti trattati non differisce a casi analoghi non sedati • È un diritto fondamentale per adulti e minori morenti • Valorizza la volontà attuale del malato così come quella anticipata (biotestamento) • Rende lecita la sospensione di trattamenti di sostegno vitale come idratazione e nutrizione
Aspetti giuridici L’accesso ai programmi di eutanasia e di suicidio assistito sono molto diversi tra i paesi europei: • La Svizzera richiede solo la capacità di intendere e di volere • Olanda, Belgio e Lussemburgo fanno riferimento ad un concetto di «sofferenza insopportabile» certificata da un medico e senza prospettiva di miglioramento • In Francia il paziente con prognosi di vita a breve termine può chiedere la sedazione profonda e continua sino al decesso e di rifiutare nutrizione e idratazione
I piani di riflessione
• Teologico
• Etico
• Giuridico
ma non è così facilmente distinguibile un piano rispetto
all’altro in quanto:
• Azioni problematiche dal punto di vista della fede possono
essere legittime dal punti di vista morale e viceversa
• Esistono scelte moralmente problematiche che non
riterremmo di dovere proibire per legge
• Esistono scelte moralmente legittime che il diritto può
decidere di vietarePosizioni delle chiese protestanti
storiche in Europa
• Considerano ammissibile la scelta volontaria di
interrompere o di rifiutare i trattamenti da parte
di un paziente in grado di intendere e di volere
• Sono favorevoli all’estensione e al potenziamento
di un sistema adeguato di cure palliative e
ammettono la possibilità della sedazione
palliativa
• Condannano eutanasia e suicidio assistito e si
oppongono alla loro legalizzazioneI motivi delle chiese • Dignità inviolabile dell’essere umano, che deriva dalla relazione che ciascun credente ha con Dio • Il valore della vita non è legato all’autonomia o alla funzionalità vitale • Necessità di prendersi cura dei sofferenti • Rifiuto dei concetti di autodeterminazione individuale e di beneficenza così come intesi nei contesti dell’eutanasia e del suicidio assistito
Le posizioni dei non credenti • Il miglioramento delle cure palliative e l’introduzione ed il perfezionamento della sedazione palliativa sono in grado di controllare la sofferenza del morente e dunque di minimizzare la richiesta sociale di eutanasia • Nella fasi terminali si accusano dei fenomeni che possono essere refrattari e non controllabili dalle terapie palliative. La sedazione palliativa può essere efficace ed è comunque un’azione reversibile anche se non sempre gestibile per il tempo in cui si protrae • La sedazione palliativa non accelera la morte del paziente, ma può essere in grado di prolungarla per un tempo residuo • Non si esclude che la persona sotto sedazione palliativa sia totalmente priva di rappresentazioni mentali allucinatorie
Punti di riflessione • È diffusa l’idea che l’unica vita degna di essere vissuta è quella autonoma e indipendente e che non dipende dalla cura e dall’assistenza di altri? • La richiesta di anticipare la propria morte deve essere sempre considerata in contraddizione con un’esistenza moralmente responsabile vissuta nella fede?
Come definire la qualità della vita Il prof. Andrea Porcarelli del Centro di bioetica «A. degli esposti» di Bologna parla di «indicatori» che aiutano a definire la qualità della vita, e li rileva in popolazione (natalità, indice di vecchiaia, densità sul territorio, saldo migratorio interno, ecc.); sanità (vita media, assistenza medica, livello di alimentazione, ecc.); istruzione (grado di alfabetizzazione, di scolarità, di spesa per istruzione, ecc.); lavoro (livello di occupazione e di disoccupazione); giustizia (amministrazione della giustizia, livello di criminalità, ecc.) tenore di vita (ricchezza, consumi, risparmio); ambiente (stato di degrado, politiche di tutela, ecc.). Qual è il grado accettabile di qualità della vita? Quando la vita di una persona può definirsi piena, degna di un essere umano superiore a un vegetale o a un animale? (L’inizio e la fine della vita – le sfide della bioetica – a cura di Dora Bognandi e Martin Ibarra - Ed. Claudiana 2005 pagg. 6-7)
Situazioni di fondo • La sofferenza insopportabile di un individuo per il quale la prospettiva di guarigione è assente e il decorso della malattia possiede caratteristiche precise e documentabili • Il contesto entro il quale si riflette è la richiesta di anticipare la propria fine nello sfondo in cui ogni possibilità terapeutica, di assistenza, di sostegno psicologico e di supporto spirituale sono a disposizione del paziente
Visioni diverse di eutanasia e suicidio
assistito
L’eutanasia ed il suicidio assistito possono essere
valutati diversamente rispetto ai soggetti che vi
sono coinvolti quali:
• Persona malata
• Persona che accompagna
• Persona che si prende curaIl tema della vita come dono • La richiesta di anticipare la morte non può essere valutata unilateralmente come rifiuto del dono di Dio e di legame con Lui • Non è detto che quello che ci viene donato sia indisponibile da parte di chi riceve il dono • Il dono implica un’idea di uso grato e responsabile del dono ricevuto • La scelta del morire anticipato può essere intesa tanto come rifiuto di Dio e del dono quanto come presa d’atto della libertà che Dio ha dato al credente nel riconoscersi nei propri limiti di esistenza umana e di tolleranza alla sofferenza, nella quale è coinvolto anche il prossimo
La vita naturale nella Bibbia e nella
tradizione cristiana primitiva
In alcune affermazioni di Gesù la vita biologica è un valore
relativo perché alla vita e alla morte viene dato un significato
che supera quello che possiamo conoscere (ad esempio
Giovanni 11, 25-26)
Nella preghiera ebraica l’oppresso e lo sfinito confida che al
venire meno della vita ci sarà ancora relazione con Dio (vedi
Salmo 73, 26)
Nella Bibbia i suicidi non sembrano essere ritenuti colpevoli
(vedi Giudici 9,54; Giudici 16,26-31; 1^ Samuele 31,4-6; 2^
Samuele 17,23; 1^ Re 16,18; Matteo 27,5)
Secondo la teologia cristiana dei primi secoli la vita umana
poteva essere messa a rischio, oppure a conclusione, in nome
di un bene superiore, per cui la vita naturale non veniva
considerata un bene assoluto.La vita naturale nella teologia
protestante del ‘900
La teologia protestante del ‘900 ha come principi
fondamentale dell’etica la responsabilità verso Dio e verso il
prossimo e mette in secondo piano il rispetto per la vita, che
comunque è considerata un bene, ma non il fine ultimo del
cristiano.
L’etica della responsabilità pone come suo aspetto centrale la
fedeltà di Dio, per tale motivo il cristiano è chiamato a
testimoniare la propria fede nella concretezza della situazione
storica contingente.
Questo approccio etico, personale e legato al contesto, è in
disaccordo con le impostazioni cattolico-romane: Dio non
esige un tributo di sofferenza e di «meriti» per salvare il
credente.La Bibbia, una parola dinamica La Bibbia contiene una parola dinamica e quindi difficile da fissare in normative rigide, che inquieta quanti ricercano una verità oggettiva (…) molte divergenze (…) nascono dallo sguardo con cui percorriamo il panorama della Scrittura: uno sguardo fisso, oppure, uno sguardo in cammino, capace di entrare in dialogo con le tante voci bibliche che si confrontano. (…) Può la Bibbia essere «una lampada ai miei piedi e una luce che illumina il mio cammino» al riguardo? Non cerco normative precise, ma possibili orientamenti. Forse non troverò risposte, ma imparerò a porre domande. (L’inizio e la fine della vita – le sfide della bioetica – a cura di Dora Bognandi e Martin Ibarra - Ed. Claudiana 2005 pagg. 14-15 intervento Lidia Maggi)
L’autodeterminazione L’autodeterminazione dal punto di vista teologico deve essere distinta dall’autodeterminazione dal punto di vista etico. Nel primo caso si tratta di una «frontiera» in cui Dio appare come garante di libertà; nel secondo la «frontiera» appare come argine verso uno sconfinamento della libertà stessa. In questo non ci aiuta molto il detto di Pietro: «occorre obbedire a Dio piuttosto che agli uomini» (Atti 5,29) in quanto non dice nè cosa voglia dire obbedire a Dio, né in che cosa consista il criterio (…) per quanto riguarda il protestantesimo l’atto dell’obbedienza presuppone sempre la distinzione fondamentale tra evangelo e legge. (La coscienza protestante – a cura di Elena Bein Ricco e Debora Spini - Ed. Claudiana 2016 pagg. 142-143 intervento Sergio Rostagno)
Punto di vista spirituale, psicologico e
pastorale
Nella ambito spirituale, psicologico e pastorale
la tematica del fine vita si articola su due piani:
1. Distinzione tra eutanasia e suicidio assistito
2. Sospensione oppure non attivazione dei
trattamenti
perché ciascuno dei due piani implica il rispetto
di una maggiore o minore ritualità che
l’accompagnamento pastorale realizza nelle fasi
del morire umanoSospensione o non attivazione dei
trattamenti
Occorre riflettere con cautela sulle ragioni e gli
eventuali limiti della differenza la sospensione e
la non attivazione dei trattamenti e la richiesta
di eutanasia o di suicidio assistito.
Sul piano morale la differenza è tra:
a) Azione/uccidere/ causare evento
b) Omissione/lasciare morire/lasciare che
l’evento accadaRiflessione sull’uccidere e sul lasciare
morire
Uccidere non sempre è stato considerato come
riprovevole (eccezioni al comandamento «non
uccidere»): legittima difesa, pena di morte, guerra
giusta, aborto, ecc.)
Lasciare morire è talvolta è considerato riprovevole:
omissione di soccorso, ecc.
Quindi nessuna delle due decisioni può essere
intesa in senso assolutoPoter morire Il pensiero di poter un giorno essere derubati del proprio diritto di morire (accanimento terapeutico) è una delle conseguenze nefaste della scienza medica moderna. (…) E’ da poco tempo che in Italia si è posta attenzione alla cosiddette cure palliative, cioè all’impegno di curare la persona inguaribile senza considerare questa cura una sconfitta del medico e della medicina e, soprattutto, con un dichiarato impegno di occuparsi della persona malata in modo globale. Pur con grandi ritardi, si è cominciato a dare spazio a una medicina alternativa che sa di non poter guarire ma che ha i mezzi di poter curare la persona, purtroppo con poche risorse finanziarie e ancora poca preparazione professionale. (L’inizio e la fine della vita – le sfide della bioetica – a cura di Dora Bognandi e Martin Ibarra - Ed. Claudiana 2005 pagg. 46-47 intervento Ermanno Genre) Si tratta di mettere di mettere in pratica (Mt 7, 12): «Tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro»
Caso ambiguo sull’uccidere e il lasciare
morire
L’eventuale rifiuto, da parte del medico, di mettere fine
alla vita di un paziente terminale che, nel pieno possesso
delle proprie facoltà mentali, chieda di essere aiutato a
porre fine alle proprie sofferenze senza essere costretto a
passare le ultime ore, o gli ultimi giorni, in uno stato di
incoscienza i cui contorni non sappiamo (ancora) definire
con precisione, resta comprensibile da un punto di vista
psicologico e legittimo sotto un profilo esistenziale.
Ma la tesi secondo cui la responsabilità della sua morte
sarebbe sempre esclusivamente ascrivibile alla malattia
da cui il paziente è afflitto e nel secondo caso dall’azione
del medico che arbitrariamente pone termine alla vita di
una persona innocente è difficilmente sostenibileSul caso Welby - 2006 Pietro Welby, affetto da una malattia degenerativa irreversibile che non consente la respirazione autonoma è oggi vivo solamente perché attaccato ad un respiratore, dunque irrimediabilmente dipendente da uo strumento tecnologico e per nulla «naturale». Si tratta quindi di un individuo completamente capace di intendere e di volere, dunque in grado di fornire in qualsiasi momento il proprio conenso informato. (…) la richiesta di godere del trattamento del trattamento di farmaci sedativi al fine di attenuare e se possibilmente eliminare l’intollerabile sofferenza del soffocamento si situa nella prospettiva della palliazione dei sintomi abitualmente praticata nei confronti dei malati terminali, a esempio con tumori del polmone, senza che alcuno obietti una tale decisione medica, anzi da considerare come buona prassi medica. (da Riforma del 15.12.2006 «la libertà di morire» Gianni Fornari)
domande • Nel caso di malattie terminali con residuo di vita molto ridotto anticipare la morte di qualche ora o giorno la sedazione palliativa è eticamente significativo? • Se un adeguato sistema di cure palliative non sembra in grado di eliminare totalmente la richiesta di eutanasia, quali risposte offrire a questa domanda? • Legalizzare l’eutanasia può provocare forme di accelerazione della morte anche in persone inconsapevoli o non consenzienti? • La società potrebbe incamminarsi nel pericoloso «pendio scivoloso» di sopprimere legalmente anziani, disabili e disadattati? • Il finanziamento all’eutanasia ed al suicidio assistito potrebbe essere concorrenziale con quello sanitario e per le fasce deboli • L’eutanasia potrebbe sancire il principio secondo cui l’unica vita degna di essere vissuta è quella autonoma? • Con quali criteri lo Stato e le confessioni religiose possono agire sulla legislazione? E sino a quale livello?
Puoi anche leggere