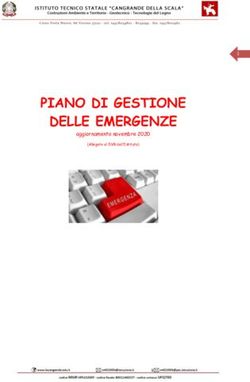Dibattito istantaneo sulla sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2022: l'opinione di Giorgio Bolego - Rivista Labor
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Dibattito istantaneo sulla sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2022: l’opinione di Giorgio Bolego di G. Bolego - 31 Maggio 2022 L’insussistenza del “fatto giuridicamente rilevante in senso stretto” quale chiave di accesso alla tutela reale attenuata 1. Con la sentenza n. 125/2022 la Corte costituzionale interviene nuovamente sul settimo comma del novellato art. 18 St. lav. dichiarandone l’incostituzionalità nella parte in cui ri- chiede(va), ai fini della condanna del datore di lavoro alla c.d. reintegrazione attenuata, la «manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo og- gettivo» (corsivo mio). Tale decisione segue quella pronunciata poco più di un anno fa (C. Cost. 1 aprile 2021, n. 59) a mezzo della quale il «può altresì applicare» è stato sostituito con «applica altresì», obliterando la facoltatività giudiziale della condanna a tale sanzione. All’esito di tali interventi del giudice delle leggi risulta praticamente demolita la soluzione compromissoria raggiunta a Palazzo Chigi nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2012[1]: compro- messo che, nella sostanza, testimoniava la ritirata del legislatore dagli intenti originari per i quali la reintegrazione avrebbe dovuto essere riservata al solo licenziamento discriminatorio o per motivi illeciti[2], per seguire un più tradizionale apparato sanzionatorio nel quale la reintegrazione (attenuata) spetta anche per i licenziamenti (disciplinari ed) economici caratte- rizzati da una particolare gravità – rectius, da un grado di ingiustificatezza particolarmente grave -, operandosi così una trasposizione dell’accertamento giudiziale dal piano delle ragioni giustificatrici del licenziamento a quello della individuazione delle sanzioni[3]. Più esplicitamente, se la sentenza n. 59/2021 ha fatto venir meno la discrezionalità del giudice, imponendo l’applicazione della reintegrazione attenuata nei casi di ingiustificatezza qualifi- cata[4], la n. 125/2022 interviene sul criterio di accesso a tale sanzione espungendo dal testo normativo l’aggettivo a mezzo del quale il legislatore, in relazione ai soli licenziamenti per g.m.o., ne voleva circoscrivere l’applicazione ai soli casi di ingiustificatezza particolarmente qualificata, tanto da dover risultare “manifesta”. Rispetto a tale aggettivazione dell’insussistenza del fatto, come ben noto, la dottrina, già all’in- domani della riforma, aveva esplicitato scetticismo evidenziandone il carattere «ridondante ed enfatico»[5]. Si è infatti affermato che un fatto o sussiste o non sussiste[6], e che l’ipotesi della manifesta insussistenza del fatto è di difficile realizzazione[7]. Per una diversa opinione, se- guita da una parte della giurisprudenza[8], invece, «manifesta» significa «evidente», sicché «nell’ipotesi di ingiustificatezza del licenziamento per motivo oggettivo la tutela reale è un’ex- trema ratio[9]. Alla luce di tali rilievi la Corte costituzione, richiamando più volte la precedente sentenza n. 59/2021, ha avuto gioco facile nell’espungere dal testo legislativo l’aggettivo oggetto di c/o STUDIO LEGALE MAZZOTTA - Borgo Stretto, 52 - PISA - Tel. (050) 540152 - 540512 - Fax 541167
censura. Invero, gli argomenti sui quali si fonda la decisione che si annota sono molteplici ed
attengono per un verso alla violazione del principio di razionalità ed eguaglianza posto che, al
comma 4 dello stesso art. 18, l’ingiustificatezza qualificata non è soggetta al requisito della
manifesta insussistenza, ma dell’insussistenza semplice. Per altro verso tale requisito viene
ritenuto indeterminato (punto 9), privo di attinenza con il disvalore del licenziamento intimato
(punto 10.1) e, quindi, eccentrico nell’apparto dei rimedi, che è usualmente incentrato sulla
gravità dei vizi dell’atto di licenziamento e non su una contingenza accidentale legata alla
linearità e alla celerità dell’accertamento (punto 10.2), che si riflette sul processo e ne complica
taluni passaggi, con un aggravio irragionevole e sproporzionato (punto 10.3).
Secondo la Corte l’irragionevolezza intrinseca della disciplina censurata deriva anche dal con-
trasto con due criteri cardine della riforma: la celerità del giudizio e la prevedibilità della de-
cisione, cioè tra i fini enunciati e i mezzi concreti prescelti. Infatti, «oltre all’accertamento,
non di rado complesso, della sussistenza o della insussistenza di un fatto, essa impegna le parti,
e con esse il giudice, nell’ulteriore verifica della più o meno marcata graduazione dell’even-
tuale insussistenza» (punto 10.3); elemento di giudizio «non legato a criteri predeterminati e
che si presta a incertezze applicative e può condurre a soluzioni difformi con conseguenti
ingiustificate disparità di trattamento (punto 9.1).
Sulla base di tali argomenti la Corte costituzionale perviene alla declaratoria di incostituzio-
nalità anche dell’aggettivo «manifesta», restituendo un testo legislativo ben diverso da quello
promulgato nel 2012. Infatti, secondo la norma di risulta, l’ingiustificatezza qualificata del
licenziamento per g.m.o. deriva «dall’insussistenza del fatto posto a fondamento del licenzia-
mento» e tale accertamento comporta, automaticamente, la condanna alla reintegrazione atte-
nuata.
2. All’esito di tale decisione vien meno, dunque, la contestata e difficilmente applicabile gra-
duazione dell’insussistenza del fatto. Tuttavia, i dubbi interpretativi non possono certo dirsi
completamente risolti; anzi, la distinzione fra le due ipotesi contemplate dal secondo periodo
del settimo comma dell’art. 18 St. lav. viene ad assumere un’importanza ancora maggiore
posto che, d’ora in avanti, in caso di «insussistenza del fatto» si ha reintegra attenuata, mentre
nelle altre ipotesi in cui «non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo» si fa luogo
alla tutela indennitaria (piena).
Sotto questo profilo, merita segnalare che la sentenza in commento, ancora una volta ripren-
dendo argomentazioni già sviluppate nella precedente sentenza n. 59/2021, esprime proprie
valutazioni sul g.m.o. di licenziamento: valutazioni che, se a rigore non risultano necessarie
per argomentare l’incostituzionalità dell’aggettivazione, potranno guidare l’interprete nel ri-
solvere i dubbi interpretativi in merito alla nozione di fatto impiegata dal legislatore, anche in
ragione dell’autorevolezza dell’organo che le ha formulate.
I giudici costituzionali, infatti, si premurano di precisare che «nel peculiare sistema delineato
dalla legge n. 92 del 2012, la reintegrazione, sia per i licenziamenti disciplinari sia per quelli
economici, si incardina sulla nozione di insussistenza del fatto, che chiama in causa l’aspetto
qualificante dei presupposti di legittimità del licenziamento» (punto 8).
2In tal modo, vengono superate le teorie che vedono nel g.m.o. la causa[10] o il mo-
tivo[11] dell’atto di licenziamento, mentre viene avallata la tesi secondo cui il g.m.o. costitui-
sce un elemento esterno al negozio di licenziamento: un presupposto, appunto, che giustifica
l’esercizio del potere di recesso[12] e che la giurisprudenza ha progressivamente ricostruito
richiedendo la sussistenza di una pluralità di elementi (di fatto): la modifica organizzativa, la
soppressione del posto di lavoro, il nesso causale, il rispetto dell’obbligo di repechage e, in
presenza di più lavoratori fungibili, il rispetto dei criteri di scelta[13].
Da qui il dubbio interpretativo circa la nozione di «fatto» posto a fondamento del licenzia-
mento per g.m.o. che un primo orientamento fa coincidere con il fatto giuridico[14], cioè con
lo stesso g.m.o. nelle sue molteplici componenti; mentre un altro orientamento lo riconduce
al fatto materiale, cioè alle circostanze tecnico-organizzative comunicate al lavoratore sulle
quali si fonda il licenziamento, causalmente collegate alla la soppressione del posto[15].
La Corte costituzionale, nel dare rilevanza all’«aspetto qualificante dei presupposti di legitti-
mità del licenziamento» segue una via intermedia coniando la nuova fattispecie del «fatto giu-
ridicamente rilevante in senso stretto», nel cui ambito rientrano le ragioni organizzative, il
nesso causale, l’adempimento dell’obbligo di repechage (punto 8)[16].
A sostegno di tale ricostruzione la Corte precisa che nell’ambito del licenziamento economico
il richiamo all’insussistenza del fatto vale a circoscrivere la reintegrazione attenuata ai vizi più
gravi, che investono il nucleo stesso e le connotazioni salienti della scelta imprenditoriale,
confluita nell’atto di recesso[17]. Tale nucleo non è costituito dalla sola modifica organizza-
tiva, cioè dal fatto materialmente inteso, ma neppure da tutti gli elementi costitutivi del g.m.o..
D’altro canto, argomentando in quest’ultimo senso si finirebbe col far coincidere il giudizio
sull’insussistenza del fatto con quello sulla giustificatezza[18]; il che si porrebbe in palese
contrasto con lo stesso tenore letterale della disposizione laddove è evidente che «il fatto posto
a fondamento del licenziamento per g.m.o.» è uno degli elementi costitutivi della fattispecie
g.m.o, la quale se ricorre integralmente rende legittimo l’atto di recesso ed esclude qualsiasi
sanzione.
A questa conclusione non è possibile opporre che il g.m.o. non nasce da un fatto, ma da «ra-
gioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare svolgimento di
essa»[19] poiché, come rileva la Corte, «il fatto che è all’origine del licenziamento per giusti-
ficato motivo oggettivo include tali ragioni e in via prioritaria il nesso causale tra le scelte
organizzative del datore di lavoro e il recesso dal contratto, che si configura come extrema
ratio, per l’impossibilità di collocare altrove il lavoratore» (punto 8).
Secondo tale ragionamento, che pare rispettoso sia del tenore letterale della disposizione sia
della ratio della norma, nell’ambito del licenziamento economico la presenza di tutti gli ele-
menti del g.m.o. rende il licenziamento legittimo ed esclude l’applicazione di qualsiasi san-
zione. Per contro, il richiamo all’insussistenza del fatto vale a circoscrivere la reintegrazione
ai vizi più gravi, che, secondo la Corte, attengono al fatto giuridicamente rilevante in senso
stretto, che si compone dei tre elementi indicati. Esula da tale nozione il mancato rispetto dei
criteri di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da licenziare, la cui carenza non
attiene al nucleo essenziale e determina l’applicazione della tutela indennitaria (piena)[20].
3La Corte accoglie, dunque, la tesi secondo cui «il fatto» cui fa riferimento il co. 7 del novellato
art. 18 non coincide con il fatto giuridico, cioè con il g.m.o. nella sua interezza, ma neppure
con il fatto meramente materiale. Per l’ingiustificatezza qualificata non è sufficiente la man-
canza di uno qualsiasi degli elementi costitutivi del g.m.o. L’insussistenza del fatto posto a
base del licenziamento per g.mo. deve attenere agli elementi costitutivi del fatto giuridica-
mente rilevante in senso stretto che include le ragioni inerenti all’attività produttiva all’orga-
nizzazione del lavoro e al regolare svolgimento di essa e si pone in una posizione intermedia
tra il fatto giuridico e il fatto materiale. Tale fatto, dunque, si compone del quid novi conse-
guente la modifica organizzativa, del nesso di causalità con la soppressione del posto,
dell’adempimento dell’obbligo di repechage.
Ne rimane escluso, come anticipato, il rispetto dei criteri di scelta in caso di lavoratori fungi-
bili: elemento che, secondo la Corte, pur condizionando la legittimità del licenziamento, esula
dal fatto giuridicamente rilevante in senso stretto non rientrando nel nucleo delle «connota-
zioni salienti della scelta imprenditoriale» (punto 8).
Tale interpretazione riprende l’orientamento più recente della giurisprudenza di legitti-
mità[21] e di merito[22] e, considerata la ratio della riforma Fornero, pare condivisibile. In-
vero, l’innovazione apportata dalla legge n. 92 del 2012 non riguarda le ragioni giustificatrici
o le caratteristiche del controllo giudiziale di legittimità, la cui latitudine e discrezionalità ri-
mane impregiudicata, compresa la non pretestuosità della scelta organizzativa. La portata in-
novativa della riforma attiene, piuttosto, ai rimedi sui quali il lavoratore potrà fare affidamento
nel caso in cui il giudice accerti la carenza delle ragioni giustificatrici, id est il grado di ille-
gittimità-ingiustificatezza del licenziamento.
Muovendo da tale considerazione la Corte fornisce una ricostruzione lineare e sostanzialmente
coerente con la posizione più recente della giurisprudenza di legittimità e di merito: se sussi-
stono tutti gli elementi del g.m.o. il licenziamento è pienamente legittimo e immune da qual-
siasi sanzione; se l’illegittimità attiene al mancato rispetto dei criteri di scelta si è nell’area
dell’ingiustificatezza semplice e troverà applicazione la tutela obbligatoria piena; se l’illegit-
timità attiene alla carenza di uno dei tre elementi costitutivi del fatto giuridicamente rilevante
in senso stretto siamo nell’area della ingiustificatezza qualificata e troverà applicazione la tu-
tela reale attenuata.
Giorgio Bolego
[1] Sulla vicenda che ha portato al “famoso compromesso” v. Ichino, La riforma dei licenzia-
menti e i diritti fondamentali dei lavoratori, in Nogler-Corazza (a cura di), Risistemare il di-
ritto del lavoro. Liber amicorum Marcello Pedrazzoli, Franco Angeli 2012, 810; nonché Maz-
zotta, I molti nodi irrisolti nel nuovo art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in WP Csdle «Mas-
simo D’Antona».it, n. 159, 20, per il quale «la versione approvata costituisce il frutto di una
evidente mediazione fra le contrapposte esigenze (che secondo la vulgata giornalistica sarebbe
da attribuire allo stesso capo del governo».
[2] Cfr. Ichino, op. cit., 797.
[3] Sul punto sia consentito rinviare a Bolego-Nogler, Opinioni sul giustificato motivo ogget-
tivo di licenziamento, in DLRI, 2014, 403.
4[4] Particolarmente critico sul punto Pisani, La riforma dei regimi sanzionatori del licenzia-
mento per mano della consulta, in DRI, 2021, 522 ss.
[5] Così, Maresca, Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo: le modifiche
all’art. 18 statuto dei lavoratori, RIDL, 2012, I , 443, secondo il quale, comunque, quell’ag-
gettivo era chiaramente rivolto a “blindare” un concetto forte: «la modalità di accertamento
della sanzione applicabile al licenziamento per g.m.o. illegittimo deve scontare che la reinte-
grazione nel posto di lavoro opererà ormai come estrema ratio».
[6] F. Carinci, Complimenti dottor Frankenstein: il disegno di legge governativo in materia
di riforma del mercato del lavoro, LG, 2012, 548; A. Maresca, op. cit., 443, secondo il quale
non si può prospettare l’ipotesi della «scelta organizzativa parziale»
[7] Alleva, Punti critici della riforma del mercato del lavoro in tema di flessibilità in entrata
e in uscita, in www.dirittisocialiecittadinanza.org, 6 ss.
[8] Cfr., da ultima, Cass. 21 marzo 2022, n. 9158, DeJure.
[9] Vallebona, La riforma del lavoro 2012, Giappichelli, 2012, 58. Nello stesso senso
Ichino, op. cit., 809, secondo il quale l’espressione «manifesta insussistenza» serve a delimi-
tare i casi eccezionali in cui appare evidente l’insussistenza del motivo economico-organizza-
tivo, «distinguendola da quelli incomparabilmente più numerosi in cui ci si può attendere una
qualche perdita in conseguenza della prosecuzione del rapporto di lavoro «ma il giudice soli-
tamente non ha gli strumenti necessari per sovrapporre alla valutazione dell’imprenditore una
propria valutazione più attendibile».
[10] Carinci M.T., Il giustificato motivo oggettivo nel rapporto di lavoro subordinato, Padova,
Cedam, 2006, 113.
[11] Gragnoli, La riduzione del personale fra licenziamenti individuali e collettivi, Padova,
Cedam, 2006, 14.
[12] Zoli, Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo tra reintegra e tutela indennitaria,
in RIDL, 2013, II, 660.
[13] Anche su questo punto sia consentito rinviare a Bolego-Nogler, op. cit., 399; peraltro, gli
elementi elencati nel testo sono tutti richiamati al punto 8 del Considerato in diritto della sen-
tenza che si annota.
[14] Perulli, Fatto e valutazione giuridica del fatto nella nuova disciplina dell’art. 18 St.
lav.. Ratio e aporie dei concetti normativi, in ADL, 2012, 801; Speziale, Il licenziamento per
giusta causa e giustificato motivo, in Chieco (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro. Com-
mentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci Bari, 2013, 345; Carinci M.T., Licenzia-
mento per g.m.o e obbligo di repechage, in RGL, 2018, II, 459.
[15] Cfr. Persiani, Il fatto rilevante per la reintegrazione del lavoratore illegittimamente li-
cenziato, in ADL, 2013, 6; Santoro Passarelli G., Il licenziamento per giustificato motivo og-
gettivo e l’ambito della tutela risarcitoria, ivi, 2013, 237; Carinci F., Ripensando il “nuovo”
art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ivi, 2013, 505.
5[16] Analoga impostazione è stata sostenuta da Perulli, op. cit., 800; Carinci M.T., op. cit.,
462; Zoli, Il giustificato motivo per ragioni organizzative nella recente giurisprudenza,
in DLM, 2020, 255.
[17] In tal senso v. Cass. 4 marzo 2021, n. 6083.
[18] Zoli, op. cit., 660
[19] Pessi, I licenziamenti per motivi economici, in ADL, 773; Carinci F., Ripensando il
“nuovo” art. 18, op. cit., 37.
[20] In tal senso si è espressa anche Cass. 19 maggio 2021, n. 13643, DeJure.
[21] Cfr. Cass. 23 febbraio 2021, n. 4894, in Guida al diritto, 2021, 10; Cass. 11 novembre
2019, n. 29102, DeJure; Cass. 8 gennaio 2019, n. 181, DeJure;
[22] App. Milano, 23 luglio 2020, n. 473; App. L’Aquila, 2 luglio 2020, n. 321; App. Milano
16 giugno 2020, n. 453; App. L’Aquila, 22 maggio 2020, n. 166; Trib. Milano 19 febbraio
2020, n. 414; Trib. Bari, 29 ottobre 2019, tutte in DeJure.
6Puoi anche leggere