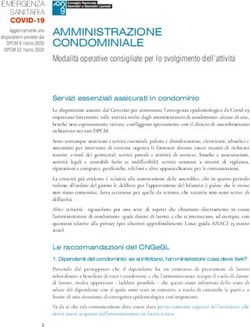Criteri generali per la scelta dei libri
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Criteri generali per la scelta dei libri
Anche di fronte al libro, come in tante altre circostanze della nostra vita,
siamo costretti - o almeno indotti - a fare una opportuna scelta. Anzitutto perchè,
accanto al libro valido e utile, ve ne sono molti che sarebbe stato meglio non pub-
blicare (e questo si verifica specialmente nel nostro tempo di produzione industria-
lizzata), e poi perchè non tutti i libri sono adatti a qualsiasi lettore.
La scelta del libro impegna la nostra responsabilità: di fronte a noi stessi, per
le nostre letture, o di fronte agli altri che ci chiedono consiglio.
In tale scelta, poi, si distinguono le varie categorie di persone:
- quelle « ragionevoli » che sanno fare una « buona scelta » ;
- quelle immature: che non sanno scegliere e procedono a caso;
- quelle tarate: che di proposito scelgono « male ».
Per fortuna questa terza categoria è un'esigua minoranza; la seconda, invece,
fa la parte del leone.
Lasciando da parte i libri che si « devono » leggere per necessità professiona-
le, la scelta si impone:
- per i libri che liberamente noi vogliamo leggere (per svago, per curiosità, per
approfondimento di cultura, per elevazione spirituale, ecc.);
- per i libri da suggerire ad altre persone;
- per i libri da immettere in biblioteca, se l'acquisto dipende da noi, o da se-
gnalare a chi di dovere per il rifornimento di biblioteche scolastiche, o di centri di
lettura, od altro;
- per i libri, infine, da presentare nelle Mostre o Fiere del Libro, o iniziative
affini che si propongono di farne diffusione.
Esiste un criterio generale che possa servire di base a questa scelta? Sì, esiste
(ed è stato già accennato in alcune lezioni), ma si tratta d'una formulazione piutto-
sto astratta, che rischia di trovare le più disparate interpretazioni quando si scende
sul piano della concretezza.
Il criterio di cui parliamo suona così: « La migliore scelta delle letture è quella
fatta in funzione dello sviluppo della personalità).
Nulla da obiettare: e chi oserebbe affermare il contrario? Tuttavia,
100in pratica, non viene detto che cosa giovi realmente allo sviluppo della per-
sonalità, quindi ciascuno può intenderlo a modo suo.
Prova ne sia l'affermazione che uno dei massimi editori italiani ripete
sovente in Congressi od altre occasioni: « Qualsiasi libro, purchè culturalmente
valido, è spiritualmente utile, e non solo per le persone colte ma anche per il pubblico in
genere ».
Ma che cosa significa in realtà l'espressione « culturalmente valido? ».
Forse vuol dire scritto bene? con eleganza di stile e proprietà di lin-
guaggio? vuol dire che è scritto con aderenza alla vita reale? Ma di quali «
idee » è permeato? Quali riflessi può avere nella vita morale del lettore?
Non si può prescindere da questo, se si vuole che il libro sia « spiri-
tualmente utile ».
Oppure l'espressione « culturalmente valido » si riferisce ad una ope-
ra di scienza, scritta da un competente?
Anche in questo caso, non si può dire che il libro sia spiritualmente
utile a tutti, senza alcuna discriminazione. Perchè il lettore « incompetente », che
affronta lo stesso la lettura di quel libro, rischia di non capire o di capire a
rovescio.
Poco male, fin che si tratta di argomenti tecnici che non possono fa-
cilmente incidere sul suo modo di vivere. Ma se invece di questo si trattasse
di ideologie errate (che il lettore ignorante e incauto è portato a ritenere «
vere » per il rispetto istintivo a ciò che è stampato), allora oltre a non esser-
ci alcuna utilità spirituale, il danno sarebbe non lieve.
Il problema, quindi, non è soltanto del libro (che in sè dovrebbe es-
sere quanto di meglio l'intelligenza e la tecnica possono produrre), ma è
anzitutto problema del lettore.
Se egli è « immaturo », non basta un libro qualsiasi (anche se nel suo ge-
nere è un capolavoro) per aiutarlo a sviluppare la sua personalità, ma ci vuole
un libro adatto.
Non sempre la immaturità è caratteristica dei giovanissimi; ci posso-
no essere persone anziane assai più sprovvedute, più indifese, più vulnera-
bili. Non è quindi solo questione di età. La immaturità dipende innanzitutto
dalla mancanza di principii sicuri su cui basarsi per il discernimento del bene dal male e
per l'obiettiva valutazione delle cose.
Il nostro semplice buon senso, il nostro gusto, la preparazione scola-
stica, ecc. (tutte cose apprezzabilissime), se non sono corroborati di Verità,
sono una base troppo fragile per potervisi appoggiare nel dare un giudizio
valido, tale da reggere all'urto della contraddizione.
Noi ci rallegriamo - e ben giustamente - per la più estesa istruzione
scolastica, per la più vasta diffusione dei mezzi di cultura, tuttavia resta
sempre attuale la necessità di educare alla lettura, giovani e non più giovani.
La maggior parte dei lettori avrebbe bisogno - almeno per un certo
tempo - di una buona guida: non solo che suggerisca se leggere o no quel
dato libro, ma specialmente che dica perchè può leggerlo o perchè non do-
vrebbe leggerlo, e precisi pure « come » leggerlo e come intenderlo. Chi ha
esperienza di biblioteca o di contatti con lettori (negli am-
101bienti giovanili, specialmente), sa quale resistenza si incontra per far accet-
tare il consiglio di « non leggere » certi libri...
(Questa resistenza è spesso la naturale reazione al metodo contro-
producente usato nel dare il consiglio: altra conferma della necessità di per-
fezionare la propria « educazione » anche per il bibliotecario!).
E' ovvio che la « proibizione » - specie se non motivata in modo
convincente - non è mai simpatica! E poi si dà il caso di chi... chiede consi-
glio « dopo » aver letto il libro che sarebbe stato meglio non leggere; ed al-
lora non resta che « discutere insieme » l'opera in questione per aiutare il letto-
re a rendersi conto del reale valore del libro e neutralizzare - fin dove è
possibile - gli eventuali elementi negativi.
Un autore moderno ha definito il libro « simile ad una forza liberata che
tende a penetrare nello spirito del lettore lasciando una traccia del suo passaggio».
Se questo è vero, la prudenza consiglia di non restare indifferenti a
quella traccia: occorrerà un ripensamento di ciò che si è letto e un sereno con-
fronto con i nostri principi religiosi e morali. In caso di dubbio, occorrerà
chiedere delucidazioni a persone esperte.
Se vogliamo che la lettura contribuisca veramente alla formazione
della nostra personalità, è necessario arrivare a saper formulare un giudizio equili-
brato di ciò che leggiamo.
Alcuni suggerimenti dettati dall'esperienza ci possono essere utili.
Si tratta anzitutto di leggere con animo sveglio. Non basta la comune
attenzione per captare il significato delle parole (e talvolta non c'è nemme-
no quella!). Occorre evitare l'atteggiamento di passività e di totale accetta-
zione supina. Solo di fronte a verità che superano (ma non contrastano) la
nostra ragione, quali ad esempio i misteri della fede cattolica presentatici
dalla Chiesa, siamo tenuti a credere in Dio sulla sua parola; ma in questo
caso siamo sicuri di non sbagliare, perchè Dio è Verità assoluta, non può
ingannarsi nè ingannare.
Trattandosi di letture d’altro genere (anche di argomenti scientifici),
teniamo presente che l'atteggiamento più saggio è quello di rispettare l'opi-
nione dello scrittore, ma di non ritenerla « un assoluto ».
Circa le letture superficiali, o fatte in istato di semi-incoscienza, pa-
recchi pensano che non debbano lasciare traccia: non è così. La traccia c'è
ugualmente, ma trovandosi in prevalenza nel subcosciente, è minore la pos-
sibilità di rendersene conto.
Si tratta poi di leggere con animo cauto e sereno. Evitare ogni eccesso di
euforia quando ci si imbatte in un libro interessante. Evitare l'atteggiamento
preconcetto di diffidente ostilità o di esagerata preoccupazione di cercare il
pelo nell'uovo (a meno che ci siano fondati motivi).
Il lettore sereno, desidera scoprire che cosa il libro insegna di bene,
piuttosto che l'eventuale insegnamento sbagliato.
E' chiaro che, quando ci accorgessimo che il libro che stiamo leggen-
do ci toglie la serenità, o ci insinua dubbi sulla fede, o risveglia in noi quel
fondo torbido che ciascuno porta con sè, dobbiamo esser pronti ad inter-
rompere la lettura: evidentemente quel libro non fa per noi,
102anche se ad altri produce un effetto diverso, anche se - in sè - non ha nulla di male.
Ancor più delicato è il caso di libri da suggerire ad altre persone, siano amici,
o alunni, o conoscenti, o frequentatori di biblioteca o di centro di lettura. Eviden-
temente, in questi ultimi casi, quando il consiglio ci è espressamente richiesto, al-
trimenti faremo soltanto delle « garbate proposte ».
Come ci si può regolare? L'ideale sarebbe di conoscere bene il libro e conoscere
bene il lettore, ossia di essere in grado di misurare le sue forze, la sua capacità di di-
scernimento, la sua preparazione ecc.: il che non succede spesso. Le difficoltà pra-
tiche non sono poche, è vero, ma non mancano aiuti per poterle affrontare - alme-
no in parte - con una certa tranquillità.
Per conoscere il libro, una prima indicazione ci viene data dalle riviste biblio-
grafiche. In Italia ve ne sono parecchie, ciascuna con particolari caratteristiche. Re-
censioni critiche di libri vengono pure pubblicate su quotidiani o altre riviste di
carattere culturale; è utile tener presenti anche queste.
Ecco un elenco delle principali riviste bibliografiche italiane:
LIBRI E RIVISTE D'ITALIA (mensile, edizioni Presidenza del Consiglio
dei Ministri; è la più completa ed aggiornata come numero di recensioni e come
indicazioni biografiche di autori, artisti, editori, segnalazioni di attività editoriali, di
problemi del libro ecc. Ha lo scopo di far conoscere « tutta » la produzione edito-
riale italiana, in Italia ed all'estero. Per questo è pubblicata anche in francese, ingle-
se, tedesco, spagnolo. Data la particolare finalità, non insiste molto sulle valutazioni
di ordine religioso e morale delle opere presentate).
LETTURE (mensile, edizione Padri Gesuiti di Milano. Molto aggiornata
specialmente per le opere di narrativa e le novità cinematografiche e teatrali. Ripor-
ta precisi orientamenti di giudizio dal punto di vista cristiano).
IL LIBRO CATTOLICO (bimestrale, edizione Unione Editori Cattolici
Italiani, di Roma).
IL RAGGUAGLIO LIBRARIO (mensile, edizione Istituto di Propaganda
libraria, di Milano).
LIBRI DI IERI E DI OGGI (bimestrale, edizione UDACI di Brescia).
LEGGERE (mensile, edizione DC di Roma).
LA PAROLA E IL LIBRO (mensile, edizione Ente Nazionale per le Bi-
blioteche Popolari e Scolastiche, di Roma).
Esistono anche altre pubblicazioni che si occupano esclusivamente di libri,
ma sono di minor interesse per noi, o per il loro carattere prevalentemente tecnico
o per l'orientamento ideologico che non possiamo condividere.
Le recensioni dei periodici bibliografici hanno lo scopo di segnalare il libro
appena edito e di dare una prima indicazione per poterlo valutare. Non si può chie-
dere alla recensione (specialmente se brevissima, come nel caso di « Libri di ieri e di
oggi ») più di quanto si propone di dare, ossia soltanto un primo orientamento su
quella determinata opera.
103Il resto, ossia il giudicare circa l'opportunità o meno di suggerire il libro a « quella »
persona, spetta a chi è stato richiesto il consiglio.
La « sigla » che alcune riviste bibliografiche usano per agevolare tale primo
orientamento, non ha - evidentemente - alcun valore assoluto, ma va usata « cum
granu salis ».
E' chiaro che solo per le biblioteche pubbliche di grande mole o per quelle
specializzate a cui attingono in prevalenza studiosi, è sufficiente che il bibliotecario
sappia « catalogare » bene il volume in base al frontespizio e sappia trovarlo quando
viene richiesto. Per le biblioteche popolari e circolanti in genere, questo non basta;
e non basta neppure basarsi su quanto dice una frettolosa recensione.
Per suggerire « con criterio » i libri occorre tener presente vari elementi ine-
renti al lettore: età, preparazione culturale, formazione spirituale, sensibilità più o
meno spiccata, momento psicologico che tale persona attraversa, situazione am-
bientale, ecc. E' un compito arduo e impegnativo, che l'esperienza a poco a poco
renderà più agevole.
Le riviste bibliografiche sono molto utili al bibliotecario anche per conosce-
re le « novità » da immettere in biblioteca. E' ovvio che, oltre a consultare quelle più
estese come panorama di edizioni, sarà bene tener conto delle valutazioni date dalle
riviste che si preoccupano di esaminare il contenuto dei libri alla luce dei principii
cristiani.
Può sorgere il problema della tempestività: vi sono lettori che vogliono « su-
bito » la novità libraria, appena ne vedono un cenno sui quotidiani e non vogliono
pazientare in attesa che la bibliotecaria s'informi se l'opera è « adatta » al carattere
della biblioteca. Che fare? Quando si tratta di biblioteca circolante di modesta por-
tata, si cerca convincere il lettore impaziente ad attendere (tanto più che queste richieste
sono per la maggior parte, relative a romanzi, non certo a libri di studio). Se non
può aspettare che la bibliotecaria segua la prassi normale... vada in libreria e si
comperi il libro. Non conviene correre il rischio di immettere in biblioteca un'opera
che può portare ai lettori danno morale, a meno che l'autore non sia sufficiente-
mente noto e sicuro per le precedenti sue opere.
Non c'è da stupire che esistano talvolta divergenze tra le valutazioni della
stessa opera date da diverse riviste bibliografiche, specialmente per quanto riguarda
opere di narrativa. Non solo ogni rivista ha un particolare obiettivo a cui tende, ma
lo stesso recensore è una persona con gusti e mentalità proprie, che non possono
non lasciare traccia nella recensione che prepara. Il buon senso, l'esame diretto del
libro e il consiglio di persone esperte possono risolvere gli eventuali problemi. Dei
resto, valutare obiettivamente un libro, non è cosa facile.
Se si tratta di opere di scienza, di tecnica, di storia, ecc. il valore del libro è in
rapporto alla competenza dell'autore in quella materia ed alla sua capacità di esposi-
zione. Invece per le opere di narrativa occorre una unità di misura più complessa. Il
romanzo, specialmente, non è solo il risultato dello studio di un determinato setto-
re della scienza, ma è la proiezione della mentalità e del costume di un certo perio-
do storico in una vicenda che è frutto di fantasia.
Il testo scientifico varia quando avvengono nuove scoperte che per
104fezionano le conoscenze precedenti in quel determinato campo. Il romanzo cam-
bia col mutare del costume, con la trasformazione delle strutture sociali, e persino
con l'evolversi della situazione politica di un Paese e dei rapporti dei popoli fra di
loro.
Non ci si può quindi permettere di trinciare giudizi avventati e superficiali su
questa o quell'opera, magari svalutando un libro perchè non è di nostro gusto. (Tra
l'altro, può capitare che non ci sia piaciuto perchè... non l'abbiamo capito! E non
sono pochi i romanzi di oggi che esigono di esser letti due o tre volte per poterne
afferrare bene il « messaggio »).
Il « giudizio » non deve limitarsi ad una vaga prima impressione avuta scor-
rendo rapidamente il libro: occorre rendersi conto dei motivi che sostengono tale
giudizio e delle validità di tali motivi. Possiamo - e in molti casi « dobbiamo » - dis-
sentire dal pensiero dell'autore, tuttavia è sempre doveroso il rispetto verso la sua
persona. E se notiamo che ha bisogno di essere illuminato perchè non possiede
ancora la verità, pregheremo il Signore per lui.
Non sarebbe però giusto sentirsi in condizioni di inferiorità solo perchè
non possiamo approvare opere di autori ché vanno per la maggiore, e magari
hanno ricevuto cospicui premi letterari. Se la linea di pensiero di questi autori
diverge da quella cristiana (e il caso è assai frequente) abbiamo ragione di dissentire.
Ci dobbiamo preoccupare, come bibliotecarie, non solo del valore dell'opera in
sè, ma anche delle « tracce » negative che essa può lasciare in chi legge.
Non ci sarebbe bisogno, tanto è ovvio, dimostrare l'incidenza della lettura.
Vale però la pena di citare la testimonianza di un autore non certo sospetto di
scrupoli religiosi, André Gide ; dopo aver citato la frase di Lessing « Nessuno pas-
seggia impunemente sotto le palme » Gide aggiunge quale commento:
« Come interpretare ciò, se non che si ha un bell'uscire dalla loro ombra,
non ci si ritrova più gli stessi di prima? ».
« Ho letto un certo libro, e dopo averlo letto l'ho chiuso e l'ho messo
nello scaffale; ma in quel libro c'era una certa parola che non posso dimentica-
re: è discesa in me così profondamente che non la distinguo più da me stesso.
Ormai non sono più come se non l'avessi mai conosciuta. Che io dimentichi il
libro, o dimentichi anche di averlo letto, non importa! Io non posso ridiventare
quello che ero prima di leggere quella parola ».
Dopo la citazione di Gide, è bene ricordare qualche brano del discorso di
SS. Pio XII tenuto agli editori nel giugno 1956:
« Nelle moderne civiltà il libro costituisce uno dei veicoli principali dell'idea
».
E dopo aver ricordato quanto sia necessario rispettare la delicatezza e la
portata dell'intelligenza dei lettori, specie se ragazzi, Pio XII raccomandava per gli
studenti una scelta e una guida. Proseguiva poi:
« Gli stessi adulti, non credano che sia loro tutto permesso. Anche per quelli che
non hanno la fede - la quale rende doveroso ammettere l'intervento materno della
Chiesa in materia - la stessa legge naturale
105proibisce di rivivere, senza una ragione grave, le scene di vizio di cui certe opere
abbondano...
« Non può essere valida scusa il dire che il lettore è libero. Il più sovente, la parte
non è uguale, soprattutto se il gioco dell'autore non è pienamente leale.
« Certa letteratura è paragonabile agli stupefacenti, contro il traffico dei quali
giustamente la legge prevede pene severissime. L'eccitazione pericolosa che tale
letteratura procura, obnubila e talvolta paralizza completamente le facoltà superiori,
in modo che ne risulta un permanente disordine, un bisogno artificiale di carattere
passionale, che va talvolta fino all'alienazione ».
Non c'è bisogno di osservare che libri del tipo di quelli di cui parla Pio XII
non contribuiscano certo al sano sviluppo della personalità del lettore e - normal-
mente - non trovano ospitalità nelle biblioteche circolanti per il popolo, dirette da
persone di buon senso.
Ed allora? Dobbiamo forse andare all'eccesso opposto, ossia, per timore che
in qualche libro ci sia una parola capace di lasciare una cattiva impressione in chi
legge, abolire drasticamente tutti i libri che contengono qualcosa di discutibile?
Anche questo sarebbe sbagliato. Solo con i ragazzini che non hanno ancora
capacità critica potremo usare questo metodo; con gli altri sarà invece il caso di
tener presente la scelta e la guida, a cui pure si riferiva Pio XII.
Daremo ostracismo assoluto alle opere « nocive », questo sì; ma, specie in
certe biblioteche d'una certa consistenza, è opportuno tenere un reparto riservato per
libri che, pur contenendo qualche elemento pericoloso, hanno però notevoli pregi
che ne giustificano la lettura da parte di persone preparate, le quali la possono af-
frontare senza danno. E la guida può anche consistere, caso per caso, nell'avvertire
i suddetti lettori che accedono al reparto riservato, dei punti controversi od errati
contenuti nel libro, magari segnalando loro la recensione che li metta in evidenza. Il
proverbio « uomo avvisato... » in questo caso calza a pennello. Se poi qualcuno,
nonostante l'avvertimento, riporta il libro manifestando il suo disappunto, occorre-
rà ricordargli che non appena si è accorto che il libro non era « sulla sua misura »
avrebbe dovuto interrompere la lettura.
Per conoscere i libri, il bibliotecario « dovrebbe » leggerli, ma come è possi-
bile? A meno che si tratti di biblioteche piccolissime, occorrono numerosi collaboratori
che conoscano bene l'ambiente, siano di principii solidissimi e sicuri, oltre che bene
armonizzati tra loro.
In una biblioteca circolante molto ben tenuta, ho trovato una serie di nor-
me, ad uso delle persone incaricate della lettura dei libri prima della catalogazione e
messa in distribuzione al pubblico. E' interessante conoscerle, se non altro come
dimostrazione del senso di responsabilità degli addetti a quella biblioteca:
Ecco le norme:
1) Non dare il giudizio di un romanzo basandoti solo sulla prima impressio-
ne o su un aspetto particolare; ripensaci e vedi l'opera nel suo insieme.
1062) Non fermarti alle eventuali situazioni irregolari presenti nella nar-
razione: guarda piuttosto e anzitutto al « modo » con cui sono presentate.
C'è una denuncia del male, oppure c'è un'approvazione di esso, anche sol-
tanto velata? Nel secondo caso, il libro è senz'altro da deplorare.
3) Quando il libro si propone di denunciare il male, la presenza e la
descrizione di esso è contenuta nei limiti del necessario, oppure è tanto
clamorosa e sovrabbondante da costituire una « pubblicità » a ciò che si
pretende deplorare?
4) La narrazione è condotta in modo da far concludere al lettore co-
mune che - dopo tutto - la virtù è noiosa e il peccato assai più simpatico?
5) Il romanzo risente di quella diffusa superficialità che si contenta di
salvare le apparenze e non approfondisce alcun problema? Non prende nul-
la sul serio? Tratta in modo scanzonato anche le cose sacre?
6) C'è mancanza di logica nel presentare le situazioni, in contrasto
con le premesse? C'è una visione irreale della vita?
7) Le situazioni scabrose o irregolari si risolvono solo dall'esterno,
per cui « sembra » che tutto sia rientrato nell'ordine solo perchè si legalizza
uno stato di cose, senza sanare il disordine interiore? Si ritiene deplorevole
il male solo per le sue scomode conseguenze esterne?
8) Sono rispettati i valori fondamentali, naturali e soprannaturali, del-
la persona umana, della famiglia, della comunità?
9) C'è una visione serena ed obiettiva della realtà umana e delle istitu-
zioni, oppure ci sono affermazioni tendenziose, unilaterali, arbitrarie?
10) Il libro induce ad un'apertura verso gli altri, oppure ad un ripie-
gamento egoistico su se stessi? E' portatore di un messaggio di speranza, di
elevazione, di bontà, oppure si mantiene in un'atmosfera disperata, o de-
primente, o scettica?
Evidentemente sono norme che ciascuno può perfezionare, adattare,
completare; è innegabile però che, per quelli ancora alle prime armi, presen-
tano una certa utilità.
Nel praticissimo manuale « Libri e Biblioteche » (ed. Paravia) che fa
testo per Corsi di preparazione degli addetti alle biblioteche popolari, l'au-
trice Luisa Nofri sottolinea che tali biblioteche hanno per scopo « l'educa-
zione e l'istruzione vera del popolo », quindi aggiunge che occorre avere come
guida nella valutazione dei libri da includervi « i criteri religiosi, morali »... «
che hanno la loro base sui cardini del vivere sociale, e questi criteri devono essere
applicati severamente ».
Giustissima osservazione. E' chiaro che, per possedere i suddetti cri-
teri occorre avere un solido fondamento di verità religiosa assimilata e vis-
suta: è questa l'unità di misura più valida per valutare obiettivamente i ro-
manzi da includere nelle biblioteche circolanti.
Naturalmente, in una biblioteca circolante che si rispetti, trovano o-
spitalità libri di vario genere, e non soltanto romanzetti più o meno rosa o
gialli. Quindi sarà necessario includervi anche alcuni classici, libri di cultura
sociale e politica, libri di storia, di viaggi, di volgariz-
107zazione scientifica, di religione, ecc., oltre a opere di consultazione che non
saranno date in prestito fuori ma riservate alla lettura in sede.
Per la scelta dei libri da acquistare, oltre alle riviste bibliografiche che
segnalano le novità, può essere di aiuto anche il Catalogo generale dell'edi-
toria cattolica italiana (edito dall'UECI) che viene aggiornato annualmente,
nonchè i cataloghi di altre Case editrici le quali, pur senza portare l'etichetta
cattolica, spiccatamente rivelano di voler mantenere la loro produzione su
un piano di serietà e di moralità.
Sarà però necessaria anche in questo caso un'oculata scelta, perchè
talvolta - accanto alle collane di libri apertamente cattolici - ce ne possono
essere altre meritevoli di molte riserve, e pur nella stessa collana, non sem-
pre tutti i libri sono raccomandabili.
Le fascette pubblicitarie, le recensioni su riviste varie e su quotidiani,
le presentazioni nelle rubriche radiofoniche e televisive, sono quasi sempre
« influenzate » dall'editore, il quale naturalmente desidera far propaganda ai
propri libri. Occorre quindi usarne con buon senso.
Conclusione: se nella scelta delle letture dobbiamo tener presente di
dare la preferenza a quelle che contribuiscono allo sviluppo della persona
umana, dobbiamo pure sapere che servono a questo scopo non solo i libri
che trattano di religione e di morale, ma anche quelli che esercitano e svi-
luppano le nostre facoltà intellettuali in modo sano e ordinato.
Il consiglio dato da P. Sertillanges ai giovani che si rivolgevano a lui
per guida: « non leggete libri buoni, leggete libri ottimi » può sembrare, a prima vi-
sta, un paradosso. Ma egli proseguiva ancora spiegando:
« Il contatto dei genii ci procura come beneficio immediato un
innalzamento. Prima ancora che ci insegnino qualche cosa, la loro
superiorità è già un dono.
« E' poi, ci danno tono, ci avvezzano all'aria delle vette. Noi ci
muoviamo nella bassa, essi di colpo ci librano nella loro atmosfera. In
questo mondo di alto pensiero, il volto della verità sembra svelarsi, la
bellezza brilla: il fatto che noi seguiamo e comprendiamo questi veggenti, ci
fa pensare che noi, dopo tutto, siamo della stessa razza.
MARIA SOLA
108Puoi anche leggere