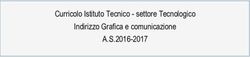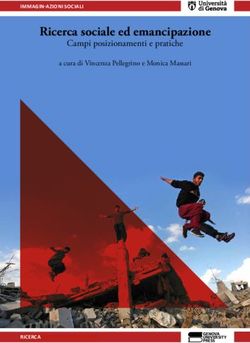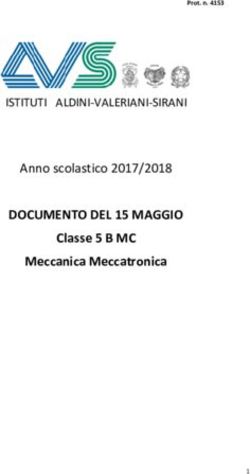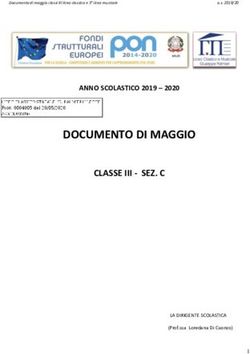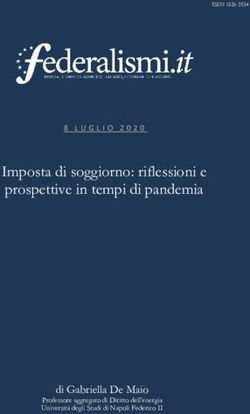American digital campaigns: da Obama a Trump - A.A. 2019-2020 Laureando Mattia Miccioni
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
American digital campaigns:
da Obama a Trump
Laureando Relatore
Mattia Miccioni Christian Ruggiero
A.A. 2019-2020American digital campaigns: da Obama a Trump Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Corso di laurea in Comunicazione, Tecnologie e Culture Digitali Mattia Miccioni Matricola 1797001 Relatore Christian Ruggiero A.A. 2019-2020
Indice
INTRODUZIONE 5
1. LA COMUNICAZIONE POLITICA
1.1. DEFINIZIONI DELLA COMUNICAZIONE POLITICA 7
1.1.1. ATTORI DELLA COMUNICAZIONE POLITICA 9
1.1.2. LE TRE FASI DELLA COMUNICAZIONE POLITICA MODERNA 10
1.1.3. VERSO UNA NUOVA FASE? 15
1.2. LA NETWORKED POLITICS 17
2. LE CAMPAGNE ELETTORALI
2.1. LO SCENARIO DELLE CAMPAGNE ELETTORALI 20
2.2. EVOLUZIONE STORICA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI 20
2.2.1. LE CAMPAGNE ELETTORALI PREMODERNE 21
2.2.2. LE CAMPAGNE ELETTORALI MODERNE 21
2.2.3. LE CAMPAGNE ELETTORALI POST-MODERNE 22
2.3. STRUMENTI E OBIETTIVI DI CAMPAGNA 23
2.3.1. IL MARKETING POLITICO-ELETTORALE 23
2.3.2. IL RUOLO DELLA TELEVISIONE 27
2.3.3. LE STRATEGIE DI IMMAGINE 28
3. LE CAMPAGNE ELETTORALI DIGITALI
3.1. LA DIGITAL CAMPAIGN 30
3.1.1. IL RECUPERO DEL FATTORE UMANO 33
3.1.2. IL GOTV 35
3.1.3. LE GRASSROOTS CAMPAIGN 37
3.1.4. L’INTERAZIONE COME ELEMENTO FONDAMENTALE 40
23.2. LA CAMPAGNA IN ATTO 41
3.2.1. YES WE CAN 42
3.2.2. #MAKEAMERICAGREATAGAIN 47
CONCLUSIONI 51
BIBLIOGRAFIA 53
SITOGRAFIA 55
3“Ciò che facciamo inizia da ciò che pensiamo di poter fare”
Rebecca Solnit
“Possiamo essere tutto quello che abbiamo il coraggio di immaginare”
Alexandria Ocasio-Cortez
A mia mamma e alla sua resilienza
A mia sorella e alla sua tenacia
4INTRODUZIONE
Obiettivo di questo lavoro è analizzare il ruolo della comunicazione politica nelle
società moderne, ponendo particolare attenzione all’evoluzione delle campagne
elettorali all’interno della Società delle reti.
È possibile osservare come la maggior parte degli eventi che accadono nella società
siano regolarmente accompagnati da un filo conduttore silenziosamente rumoroso
che li lega: la politica.
La Treccani definisce la politica come «il campo di azione dei soggetti che lottano per
il potere e che lo esercitano in modo tale da stabilire un’organizzazione della vita
pubblica che risponde generalmente agli interessi più forti».
Nel corso del tempo, questo concetto non si è di certo sottratto a mutamenti ed
evoluzioni, sino a poter essere considerato, al giorno d’oggi, come il terreno sul quale
i vari soggetti politici si scontrano a gran voce per ottenere il potere, in modo tale da
stabilire un’organizzazione della vita pubblica. Tali scontri, che avvengono ormai
all’interno di territori sempre più nuovi, fanno parte del vastissimo campo, oggetto
di questa analisi, che è la comunicazione politica.
Come sostiene Mazzoleni, «la comunicazione politica è un fenomeno antico ma anche
modernissimo, al centro dell’eterno gioco del potere, essendo l’ecosistema entro il
quale in democrazia si svolge la competizione tra i diversi attori».
Nell’era dei digital media, della politica 2.0 e della politica pop (Mazzoleni, Sfardini
2009) diventa interessante indirizzare lo sguardo verso il concetto di comunicazione
politica e le modalità attraverso le quali è presente nella società.
Risulta non meno importante, al fine di questa analisi, osservare le varie fasi che si
sono susseguite nel corso del tempo, per poi giungere ad esaminare uno dei momenti
chiave e decisivi della comunicazione politica: le campagne elettorali.
Lo scontro tra le varie forze in campo nell’arena politica è un fenomeno che occupa
sempre posti di gran rilievo nell’agenda dei mezzi di comunicazione. Nel corso del
tempo, questo fenomeno si è evoluto parallelamente alla diffusione dei mass media,
fino ad arrivare a poter parlare di campagna elettorale permanente (Blumenthal,
51980), digitale e online. Compito di questo lavoro sarà, per l'appunto, concentrare
l’attenzione sull’evoluzione delle competizioni elettorali, osservando i vari processi
di modernizzazione delle campagne in molti paesi occidentali. Inoltre, con i social
network e con il recupero della campagna “sul campo”, questo argomento si
arricchisce ancora più di interesse anche grazie alla vastità dei territori nei quali può
essere analizzato.
Il percorso si concluderà prendendo in esame la campagna elettorale “Obama for
America” per le elezioni Presidenziali statunitensi del 2008, considerata la prima vera
e propria grassroots campaign, e la più recente campagna “Make America Great Again”,
in modo tale da osservare le caratteristiche che hanno contribuito alla vittoria del candidato
repubblicano Donald Trump.
Ciò ci permetterà di osservare direttamente il modo in cui i nuovi mezzi di comunicazione e
le tecnologie digitali possono diventare degli strumenti fondamentali nelle campagne
elettorali dei nostri giorni, non solo per la mobilitazione e la partecipazione, ma anche per
raggiungere un vasto numero di elettori in pochi istanti.
6CAPITOLO UNO: LA COMUNICAZIONE POLITICA
1.1. DEFINIZIONI DELLA COMUNICAZIONE POLITICA
Nel corso del tempo numerosi studiosi, appartenenti a diversi campi della
comunicazione e della sociologia, hanno cercato di dare una definizione più che
esaustiva del concetto di comunicazione politica. Al fine di questa analisi risulta
necessario riportarne alcune, in modo tale da comprendere in linea più chiara il modo
in cui questo concetto si è andato evolvendo nel corso della storia, tanto da poter
assumere un carattere multidisciplinare.
I più importanti contributi che verranno presi in esame in questa sede sono, in ordine
temporale, quelli di Dominque Wolton, di Dan Nimmo e David Swanson, di Jacques
Gerstlé e di Brian McNair.
Wolton, in un saggio del 1989, definisce la comunicazione politica come «lo spazio
dove si scambiano i discorsi contraddittori dei tre attori che hanno la legittimità di
esprimersi pubblicamente sulla politica e che sono gli uomini politici, i giornalisti e
l’opinione pubblica attraverso i sondaggi1».
Per quanto ad una prima lettura potrebbe sembrare una definizione riduttiva, dato
che ci sono numerosi modi oltre ai sondaggi attraverso i quali l’opinione pubblica
può esprimere la sua opinione, in realtà mette in luce un aspetto di vitale importanza,
fondamentale nell’approccio a questo argomento: quando si parla di comunicazione
politica, infatti, si parla di almeno tre attori: il sistema politico, il sistema dei media e
i cittadini elettori.
Successivamente, Nimmo e Swanson, danno una definizione generale di ciò che per
loro risulta essere la comunicazione politica: «Nella sua dimensione politica la
comunicazione è una forza per entrambi il consenso e il conflitto; le campagne
elettorali nelle democrazie liberali sono per entrambi il cambiamento e la stabilità; la
comunicazione politica è al tempo stesso fonte di potere e di emarginazione, prodotta
e consumata dai cittadini, attori più o meno autonomi, informati, determinati e
1 Wolton, D., 1989, La communication politique: construction d’un modèle, in «Hermès», 4, pp. 27-41
7creativi, ma anche modellati da potenti strutture2».
I due politologi affermano, inoltre, che risulta difficile tanto quanto senza senso
costruire una teoria unica viste le diverse tecniche e i diversi approcci utilizzati per
studiare il tema.
Gerstlé afferma invece che «la comunicazione impregna l’intera attività politica a tal
punto che quasi tutti i componenti politici implicano un ricorso a una qualche forma
di comunicazione3». Per definire al meglio questo concetto, egli afferma la necessità
di osservare le sue tre principali dimensioni: pragmatica, simbolica e strutturale.
Nella dimensione pragmatica la comunicazione politica è utilizzata per diverse
finalità tra le quali persuadere, convincere, sedurre, informare, comandare,
negoziare, dominare; nella dimensione simbolica, la comunicazione politica si
esplicita attraverso i riti e le manifestazioni tipiche del contesto politico, utili per
ottenere consenso e per articolare il conflitto. Nella dimensione strutturale, infine, la
comunicazione politica risulta essere quella che transita sui canali istituzionali, di
organizzazioni, sui canali mediali e su quelli interpersonali.
McNair, infine, va a costruire la sua definizione di comunicazione politica intorno a
tre elementi fondamentali del flusso comunicativo: l’emittente, quindi «tutte le forme
di comunicazione usate da esponenti politici e altri attori politici per il conseguimento
di determinati obiettivi»; il ricevente, cioè «la comunicazione rivolta a quegli attori da
soggetti non politici quali gli elettori e i giornalisti»; il messaggio, ovvero «la
comunicazione su di essi e sulle loro attività, contenuta nelle notizie, editoriali e altre
forme di dibattito giornalistico4». Quindi, per il sociologo, risulta comunicazione
politica tutto ciò che può essere considerato discorso politico, non solo nelle forme
verbali e scritte ma anche in quelle non verbali.
Possiamo affermare quindi che la grandezza del fenomeno ha impedito la costruzione
di un modello unico, in grado di non favorire né gli approcci maggiormente politici,
tendenti a privilegiare ciò che riguarda gli aspetti in linea con le dimensioni
2 Nimmo, D.D. e Swanson, D.L., 1990, The field of political communication: Beyond the voter persuasion paradigm, in Swanson
e Nimmo, pp. 7-47
3 Gerstlé, J., 1992, La communication politique, , pp. 14-22, PUF, Parigi
4 McNair, B., 2011, An Introduction to Political Communication, ,p. 4, Routledge, Londra
8istituzionali della sfera politica, né gli approcci del versante comunicativo, protesi a
mettere in luce gli aspetti delle strategie e delle tecniche comunicative messe in atto
dagli attori della comunicazione politica.
A tal punto, per dare un giusto peso ai fattori del processo della comunicazione
politica, possiamo definire la comunicazione politica come «lo scambio e il confronto
dei contenuti di interesse pubblico-politico prodotti dal sistema politico, dal sistema
dei media e dal cittadino-elettore, al fine di esercitare conquistare o condizionare il
potere».
1.1.1. Attori della comunicazione politica
Nel momento in cui si entra in contatto con questo concetto, risulta necessario
distinguere le caratteristiche differenti della comunicazione degli attori che prendono
parte a tale processo. Gli attori della comunicazione politica possono essere
raggruppati entro tre grandi sistemi: il sistema politico, il sistema dei media e il
cittadino-elettore.
Quando ci si riferisce al sistema politico, si intende l’insieme delle istituzioni che
costituiscono l’intera vita politica di un paese. In particolare, si sta parlando del
Parlamento, del Governo e della magistratura e anche del Capo dello Stato. La
comunicazione attivata da questi soggetti è di tipo principalmente istituzionale.
Rientrano sotto l’etichetta di sistema politico anche coloro facenti parte di quell’area
non istituzionale, come i vari rappresentanti dei partiti o dei movimenti che prendono
parte alla vita politica di un paese.
Passando al sistema dei media, si ha a che fare con coloro i quali si occupano delle
«attività di produzione e di distribuzione del sapere5». Ci si riferisce principalmente
ai grandi mezzi di comunicazione di massa, come la televisione, la stampa, la radio,
il cinema, i libri ma anche i new media, come Internet e i social media.
Il modo in cui i vari attori politici ricorrono ai media dipende dalla cultura di un
determinato paese e, nella maggior parte dei casi, essi sono oggetto di misure
legislative atte a regolamentarne la loro attività all’interno della società.
5 McQuail, D., 2007, Mass Communication Theory, Sage, Londra
9Il compito di questi mezzi è quello di fornire da interlocutori nel dibattito pubblico e
politico; nel caso dei media digitali e soprattutto dei social media, essi vengono
utilizzati sempre di più anche da parte degli stessi attori politici, sia per fini
istituzionali che per fini propagandistici.
In ultimo, ma non per importanza, possiamo trovare il sistema del cittadino-elettore.
Protagonista dell’azione politica, nei paesi democratici il cittadino-elettore, o meglio
l’elettorato, risulta essere centrale nel processo politico sostanzialmente per due
motivi: innanzitutto poiché, attraverso i processi elettorali, è in grado di decidere a
chi assegnare il proprio voto e quindi capace di diventare l’ago della bilancia negli
scontri politici; in secondo luogo, nell’era dei social media e del marketing politico, il
cittadino-elettore diventa sempre più il bersaglio principale del sistema politico che
cerca di raggiungerlo in modo costante, sia attraverso i classici strumenti di
campagna offline ma, in maniera sempre più diffusa e pervasiva, anche attraverso gli
strumenti offerti dal contesto delle campagne online.
1.1.2. Le tre fasi della comunicazione politica moderna
Una volta individuati coloro che prendono parte al processo di comunicazione
politica, risulta ora necessario andare ad osservare come, nel corso del tempo, alcuni
studiosi hanno proposto quella che può essere considerata una periodizzazione
storica dello sviluppo della comunicazione politica, utile, ai fini di questo lavoro, per
inquadrare maggiormente l’oggetto di studio.
A tal proposito, verrà preso in considerazione un famoso articolo del 1999 di Jay
Blumler e Dennis Kavanagh6.
In questo articolo è possibile identificare i cambiamenti chiave presenti nella società
e nei media, i quali hanno avuto un ruolo importante nel plasmare la comunicazione
politica in molte democrazie dal dopoguerra in poi.
Gli studiosi osservano come questi mutamenti potrebbero dare alla luce a una nuova
forma di comunicazione politica qualitativamente diversa dal passato. Non solo le vie
6 Blumler, J.G., e Kavanagh, D., 1999, The third age of political communication: Influences and features, in «Political
Communication», 16, 3, pp. 209-230
10della comunicazione politica si moltiplicano in un processo che sta diventando
sempre più diversificato, frammentato e complesso, ma anche, a un livello più
profondo, vengono riorganizzati i rapporti di potere tra i principali fornitori di
messaggi e i loro ricevitori.
Sebbene affronti molte tendenze e fenomeni ancora da elaborare, questo contributo
cerca di fornire un quadro per pensare alle principali forze in gioco, al fine di
percepire meglio cosa potrebbe esserci all’orizzonte.
La comunicazione politica in molte democrazie sembra aver attraversato tre fasi
distinte, ognuna caratterizzata da vari elementi, sebbene abbiano prevalso anche altre
influenze.
La prima fase. I primi due decenni dopo la Seconda guerra mondiale sono stati
definiti "l'età d'oro dei partiti" in quanto essi svolgevano una salda funzione di
trasmissione tra il sistema politico e i cittadini. In questo periodo, il consenso è stato
accompagnato da un alto livello di fiducia nelle istituzioni politiche e molta della
comunicazione politica del tempo era subordinata a istituzioni e credenze politiche
relativamente forti e stabili.
In un sistema di comunicazione così dominato dal partito, è possibile individuare tre
caratteristiche ricorrenti. Innanzitutto, molti messaggi politici erano sostanziali e i
leader, non dovendosi preoccupare della loro immagine o delle tecniche di
comunicazione, tendevano a parlare delle questioni che li interessavano, in
particolare dei cambiamenti che desideravano attuare nel governo e i principi e le
politiche che li distinguevano dai loro avversari. In secondo luogo, molti di questi
messaggi godevano di un accesso abbastanza diretto ai mass media e, inoltre, la
risposta dei cittadini a questa tipologia di comunicazioni era caratterizzata da
selettività e dal rafforzamento delle opinioni.
Un aspetto interessante osservato da Blumler e Kavanagh relativamente a questo
sistema è il fatto che ruotava su un paradosso intrigante: sebbene ospitasse un
dibattito vivace su orientamenti e politiche alternative, pochi cittadini sembravano
capaci di comprendere gli argomenti in questione, tendendo piuttosto a votare su
11lealtà basate sull’appartenenza a gruppi.
Naturalmente, era anche presente un corpo di elettori fluttuanti le cui precedenti
alleanze politiche non erano abbastanza forti da conformarsi a questo modello di
rafforzamento del comportamento elettorale. Ma poiché tendevano a essere meno
interessati alla politica, avevano anche meno probabilità di essere raggiunti dai
messaggi politici.
La seconda fase. Nel corso degli anni ’60 nacque una nuova era caratterizzata dalla
diffusione sempre più pervasiva della televisione come mezzo dominante della
comunicazione politica e dal progressivo allentamento della presa della lealtà del
partito sugli elettori. I due studiosi individuano quattro trasformazioni che
scaturirono da questa nuova fase.
Innanzitutto, viene osservata una riduzione della frequenza dei modelli selettivi di
esposizione alla propaganda dei partiti, permessa soprattutto dalla diffusione del
mezzo televisivo in grado di ampliare le opzioni di attenzione del pubblico
mostrando non solo i leader politici durante i periodi di campagna elettorale ma
anche in altri momenti della vita politica. La selettività è stata anche minata da un
declino di giornali, club e altre organizzazioni legate ai partiti, specialmente
nell'Europa continentale.
La seconda trasformazione è riconducibile alle caratteristiche del nuovo mezzo in
quanto, considerato come mezzo costituzionalmente obbligato a norme non di parte
come equità, imparzialità e neutralità, poteva essere la piattaforma centrale per la
comunicazione politica.
Questo carattere imparziale e pervasivo della televisione porta gli studiosi ad
assegnarle il merito di aver allargato il pubblico della comunicazione politica
penetrando in un settore dell’elettorato meno esposto ad un certo tipo di messaggi e
più difficile da raggiungere. Probabilmente, per la maggior parte degli spettatori, e
soprattutto per quelli meno interessati, le influenze a lungo termine sulle prospettive
politiche, come l'identificazione del partito e la socializzazione precoce, hanno
iniziato a lasciare il posto a quelle a breve termine, come gli eventi di attualità, i
12successi immediati, i fallimenti dei governi e le linee di attacco dei loro avversari.
Si pensava, infine, che un canale cruciale di tali influenze a breve termine fossero le
notizie televisive. I suoi valori e formati hanno quindi avuto un impatto sempre più
ampio sulla programmazione di eventi politici, sul linguaggio della politica e sui
modi di presentazione di leader e altri soggetti. Per far fronte alle esigenze del nuovo
mezzo, del suo pubblico sempre più vasto e di un elettorato più mobile, i governi, i
partiti e i loro leader hanno dovuto lavorare sempre più rapidamente per imparare
nuovi trucchi in modo tale da adottare una serie di tattiche in grado di modellare
l'agenda dei media. Queste nuove tecniche portano i politici ad abbracciare una
comunicazione basata più sulle realtà stabilite dal clima d'opinione che su visioni
civiche.
Come il suo predecessore, anche questo sistema di comunicazione politica
appartenente alla seconda fase ruotava attorno a un paradosso: in un momento in cui
molti cittadini erano diventati più aperti e flessibili ed erano pronti a intrattenere
approcci diversi ai problemi del giorno, quello che gli veniva offerto era piuttosto una
dieta di comunicazione più vuota, scarna e meno nutriente.
La terza fase. Questa fase, tutt’ora in atto, è caratterizzata dalla proliferazione dei
principali mezzi di comunicazione, dall’abbondanza dei media e dalla loro
pervasività, dall’ubiquità e dalla velocità. La televisione, in particolare, una volta un
concentrato di comunicazione fatta di pochi canali facilmente gestibili da parte dei
politici, è diventata e sta diventando un mezzo ampiamente elaborato, che ospita una
quantità sempre maggiore di notizie e canali sempre più difficili da controllare.
L'abbondanza della comunicazione comporta un cambiamento anche nei modi in cui
le persone vengono a contatto con la politica: infatti, accanto ai media tradizionali e
alla televisione, stanno emergendo altri media, come Internet e le attività ad esso
collegate, i quali si pongono sempre più come alternative all’informazione
mainstream di giornali, radio e televisioni.
Secondo Blumler e Kavanagh, la comunicazione politica di questa fase sarà
probabilmente rimodellata da cinque tendenze principali, non tutte in armonia tra
13loro. Analizziamole di seguito.
1. Professionalizzazione del rapporto intensivo con l’opinione pubblica.
Con il procedere della terza fase, è probabile che la dipendenza dei politici
dall'assistenza professionale aumenti ulteriormente. Già in passato, il personale
qualificato si è sempre attaccato ai partiti politici, offrendo il loro know-how
organizzativo; oggi i politici sono sempre più costretti a ricorrere a professionisti per
comunicare in maniera corretta e senza imperfezioni con l’opinione pubblica. Tipico
della terza fase è, infatti, il passaggio dall’arte del governare all’arte nel gestire
l’informazione pubblica.
2. Aumento della pressione competitiva.
Con l'avanzare dell'abbondanza dei media, la politica intesa a informare, rivelare o
persuadere deve competere ai fini di ottenere l’attenzione, in un ambiente molto più
competitivo. Le fonti di maggiore pressione competitiva sono, infatti,
formidabilmente numerose. Gran parte di questa competizione proviene
dall’emergere della tendenza all’intrattenimento: gli approcci alla "politica
dell'infotainment" sono sempre più diffusi e sono qui per rimanere e proliferare. Ciò
si riflette soprattutto nell'esplosione di sottogeneri concepiti come ibridi, come ad
esempio, talk show o varietà, programmi scandalistici e sensazionalistici.
3. Popolarizzazione e populismo.
Al giorno d’oggi la sfera pubblica appare diversamente popolata rispetto al passato.
Per quanto protesa e rigida, questa tendenza potrebbe portare ad una trasformazione
delle relazioni tra comunicatori politici e il loro pubblico.
Fino a poco tempo fa, infatti, il flusso delle comunicazioni politiche era una faccenda
che seguiva una direzione dall'alto verso il basso: le questioni del giorno erano
principalmente definite e discusse da politici, giornalisti ed esperti, mentre i membri
del pubblico ordinario potevano partecipare solamente premiando o punendo i
comunicatori più autorevoli solamente continuando ad ascoltarli o a sintonizzarsi.
Dall'inizio degli anni ‘90, tuttavia, forti correnti di populismo si sono diffuse sempre
più rapidamente arrivando addirittura a soffocare il mondo della politica e dei media,
creando nuove opportunità e insidie per il pubblico.
14Queste opportunità per il pubblico derivano anche dal declino dell’ideologia, la
quale, lasciando una sorta di gap di legittimità, permette al populismo di entrare nel
flusso della società civile ma anche all’interno dei territori della politica e dello stesso
sistema mediatico. Il sistema mediatico risulta particolarmente colpito da questo
ingresso populista, tanto da arrivare a “popolarizzare” anche la stessa politica
cercando di renderla più in linea con i gusti e le tendenze correnti.
4. Diversificazione centrifuga.
Una quarta area di potenziali conseguenze riguarda il rapporto tra comunicazione e
comunità. Nel periodo di massimo splendore della seconda fase, molta della
comunicazione politica era centripeta. Il mezzo di massa più attraente offriva una
scelta relativamente scarsa e il pubblico delle notizie era quasi universale.
Nell’ormai avanzata terza fase, tuttavia, i comunicatori politici hanno a disposizione
più canali e possibilità per adattare la comunicazione a condizioni e gusti particolari.
Questo porta ad una riduzione del pubblico di massa e facilita la diversificazione
delle varie forme di comunicazione politica, permettendo agli attori politici di
indirizzare i propri messaggi a specifici gruppi di destinatari. Gli strumenti attraverso
i quali tutto ciò risulta possibile sono le indagini di mercato, la posta elettronica e, in
tempi più recenti, gli strumenti offerti da Internet e dai social media.
Nella maggior parte delle società moderne, quindi, la comunicazione centripeta si sta
in qualche modo ritirando e la comunicazione centrifuga sta avanzando.
5. Ricezione della politica da parte del pubblico.
L’abbondanza dei media cambia il modo in cui il pubblico riceve i messaggi politici.
Emerge una cultura del tipo "scegli e scegli", nella quale è possibile trovare la
comunicazione politica anche in contenitori informativi non tradizionali. La politica,
quindi, tende a fondersi spesso in un flusso di generi diversi tanto da arrivare ad una
ridondanza ed a una ripetizione degli stessi messaggi.
1.1.3. Verso una nuova fase?
Alla luce dell’ingresso e dell’applicazione dei più recenti sviluppi tecnologici
15all’interno dell’arena politica, verrà ora preso in considerazione l’articolo7 “Political
Communication −−Old and New Media Relationships” di Michael Gurevitch, Stephen
Coleman and Jay G. Blumler pubblicato in «“The ANNALS of the American Academy
of Political and Social Science» nel 2009.
Questo articolo riflette sul modo in cui la televisione ha cambiato il panorama politico
ma soprattutto considera fino a che punto i nuovi media, come Internet, stanno
sostituendo la televisione e riconfigurando il sistema delle comunicazioni politiche.
Gli autori suggeriscono che la relazione politico-televisiva emersa negli anni ’60
prevale ancora in una certa misura nell’era digitale ma deve affrontare nuove pressioni
che vanno ad indebolire il primato del modello broadcast di comunicazione politica.
A tal proposito, essi individuano cinque nuove caratteristiche della comunicazione
politica. Ai fini di quest’analisi ne verranno prese in considerazione tre di particolare
importanza.
1. L’ubiquità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ormai non più
monopolizzate da organizzazioni professionali centralizzate industrialmente. A mano
a mano che un numero sempre maggiore di persone ha avuto accesso alle nuove
tecnologie, la capacità di ottenere informazioni sul sistema politico e di condizionarne
l’agenda è cresciuta in maniera esponenziale. Tuttavia, questo allargamento del potere
dell’opinione pubblica non è stato accompagnato dall’opportunità di deliberare
collettivamente su questioni di interesse comune a causa di una frammentazione della
ricezione pubblica.
2. Minore enfasi sulla televisione come fornitura di un servizio pubblico e maggiore
enfasi sulla capacità di aprire uno spazio pubblico. La televisione, oggi, sia pubblica
che privata, grazie anche alla sua integrazione con altre piattaforme di comunicazione,
ha la capacità di diventare un’arena aperta per la produzione e la distribuzione di
valore potenzialmente universale in cui recitano diversi attori.
3. Una ridefinizione dell’idea di cittadinanza che tenga conto dei termini di una nuova
relazione tra pubblico e privato. I ruoli civili e politici sono entrati nelle case, nelle
7 Gurevitch, M., Coleman, S., Blumler, J.G., 2009, Political Communication − Old and New Media Relationships in «The
ANNALS of the American Academy of Political and Social Science», 625, pp.164-181
16scuole e nei luoghi di lavoro. Politico non si riferisce più solamente alle istituzioni dello
Stato ma è arrivato a descrivere una serie di incontri quotidiani con il potere che danno
origine a riposte civiche e non. Se i media hanno il compito di promuovere la
cittadinanza all’inizio del ventunesimo secolo, ciò deve accadere in occasioni sempre
più ricorrenti.
Queste nuove funzionalità della comunicazione politica rappresentano, dunque, una
sfida formidabile per gli esperti della comunicazione politica, in quanto risulta sempre
più essenziale la conoscenza di questi nuovi paradigmi. Si tratta, in ogni caso, di
caratteristiche in evoluzione e che tendono ad adattarsi da paese a paese, a seconda
delle riconfigurazioni culturali e politiche presenti.
1.2. LA NETWORKED POLITICS
Dopo aver analizzato le varie fasi che si sono susseguite nel corso dell’evoluzione della
comunicazione politica, risulta ora necessario comprendere in che direzione e con
quale velocità si stanno dirigendo i metodi e le tecniche di comunicazione, per riflettere
poi sulla crisi delle modalità tradizionali di partecipazione politica.
Numerosi studi sul tema hanno analizzato le cause della decadenza della
partecipazione politica; tra questi risulta doveroso menzionare il lavoro di Dalton e
Wattenberg, Parties Without Partisans: Political Change in Advanced Industrial
Democracies, e il contributo di Kriesi et al., Democracy in the Age of Globalization and
Mediatization.
Una delle cause che ha portato al declino delle modalità di fare politica, indicata dagli
autori come una delle cause più profonde, risulta essere l’eccesso di mediatizzazione.
La pervasività assunta dai media all’interno della sfera politica ha fatto sì che essi si
trovassero in dovere di compiere molte delle azioni prima riservate ai partiti tanto da
arrivare ad essere uno strumento indispensabile di familiarizzazione politica. I partiti,
di conseguenza, non hanno mai cercato di sfuggire a questa situazione; anzi, hanno
cercato di sfruttarla il più possibile disinvestendo, ad esempio, sulla relazione diretta
con gli elettori tramite i comizi e preferendo le più comode vie messe in atto dalla
mediazione televisiva. Ciò ha portato ad un declino della partecipazione politica da
17parte dei cittadini.
Al giorno d’oggi, però, con l’avvento dei media digitali, assistiamo ad ulteriori
trasformazioni. Nel paradigma della società delle reti, la Networked Society,
assistiamo ad una trasformazione del rapporto tra media e politica. La politica, oggi,
può essere considerata networked politics.
Internet comincia a rivoluzionare il mondo della comunicazione, creando nuovi spazi
in cui gli utenti possono interagire tra di loro, senza tenere conto dei limiti di spazio e
di tempo. Questo cambiamento di prospettiva può essere riscontrato anche nel campo
della partecipazione politica. La rete, infatti, permette agli attori politici e ai cittadini-
elettori di bypassare i media tradizionali diventando così lo spazio della
disintermediazione. Disintermediare la comunicazione politica significa «sfruttare le
opportunità offerte dai media digitali per prendere la parola in prima persona,
eliminando la necessità della mediazione dei media tradizionali, come avveniva in
passato». 8
Manuel Castells definisce tutto ciò con il neologismo autocomunicazione di massa in
quanto «di massa poiché in grado di raggiungere un pubblico globale» ma allo stesso
tempo «autocomunicazione poiché la produzione dei messaggi è autogenerata, la
definizione dei potenziali destinatari è autodiretta, e il reperimento di specifici
messaggi o contenuti dal web e dalle reti di comunicazione elettronica è
autoselezionato».9 L’autocomunicazione è il modo in cui i cittadini-elettori e i politici
comunicano con l’avvento delle tecnologie mediali.
Questo processo risulta facilitato dal diffondersi di device e contenuti sempre più
personalizzati, i quali permettono all’individuo di assumere il ruolo di produttore,
distributore e consumatore di contenuti, ponendolo al centro del sistema
comunicativo. «Post-moderno gatekeeper di sé stesso»10, l’individuo segna ormai una
rottura decisiva con il passato.
Questo ripensamento del concetto di mediatizzazione, in ogni caso, non cancella i
media tradizionali dalla scena. Piuttosto, come afferma Cepernich, si assiste alla
8 Cepernich C., 2017, Le campagne elettorali al tempo della networked politics, Laterza, Roma-Bari
9 Castells M., 2017, Comunicazione e potere, UBE Paperback
10 Cepernich C., 2017, Le campagne elettorali al tempo della networked politics, Laterza, Roma-Bari
18nascita di un sistema ibrido, nel quale media mainstream e media digitali convivono
integrando vecchie e nuove modalità comunicative11. Al centro di questo sistema
troviamo l’individuo, sempre connesso.
Tutte queste trasformazioni che emergono nelle modalità di partecipazione politica
sono riscontrabili nel momento di più alta tensione nel sistema della comunicazione
politica: le campagne elettorali.
11 Cepernich C., 2017, Le campagne elettorali al tempo della networked politics, Laterza, Roma-Bari
19CAPITOLO DUE: LE CAMPAGNE ELETTORALI
2.1. LO SCENARIO DELLE CAMPAGNE ELETTORALI
Dopo aver tracciato lo scenario della comunicazione politica, presentato gli attori che
prendono parte a questo processo e osservato la periodizzazione storica, andiamo
avanti mettendo in luce il momento di più grande fermento presente in tutte le
democrazie, momento in cui gli strumenti della comunicazione politica vengono messi
in atto: le campagne elettorali.
Gli appuntamenti elettorali sono da sempre un «momento simbolico forte12», capace
di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica, di riempire l’agenda dei media ma
soprattutto di dimostrare le capacità comunicative ed espressive dei singoli attori che
prendono parte allo scontro politico. Buona parte degli strumenti della comunicazione
politica, infatti, viene messo alla prova durante i periodi di campagna elettorale nei
quali viene valutata la loro efficacia o meno.
Nel corso del tempo, è stato possibile osservare come i cambiamenti intercorsi nelle
società democratiche e nelle tecniche di comunicazione, grazie soprattutto alla
rivoluzione di Internet, si sono riscontrati anche nel modo di portare avanti le
campagne elettorali da parte dei soggetti politici. Vediamo quindi quali trasformazioni
sono state riscontrati negli anni.
2.2. EVOLUZIONE STORICA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI
L’evoluzione delle campagne elettorali ha seguito di pari passo la diffusione dei mass
media all’interno delle democrazie liberali. Al giorno d’oggi, infatti, le campagne
elettorali si giocano su territori inediti rispetto al passato che si sono formati con
l’avvento della radio, della televisione e dei nuovi media.
I cambiamenti riscontrati possono essere analizzati prendendo in considerazione il
contributo di Pippa Norris, la quale ha proposto una periodizzazione storica
dell’evoluzione delle campagne elettorali analizzando i processi di modernizzazione
12 Mazzoleni, G., 2012, La comunicazione politica, p. 131, Il Mulino, Bologna
20delle campagne in molti paesi occidentali. Questa segmentazione divide la storia delle
campagne elettorali in tre fasi principali: le campagne elettorali premoderne, le
campagne elettorali moderne e le campagne elettorali post-moderne.
2.2.1. Le campagne elettorali premoderne
Questa fase comprende un periodo piuttosto lungo che va dalla metà del 1800 fino al
1950 caratterizzata da una tipologia di campagna breve.13
Secondo la Norris, le tre caratteristiche ricorrenti sono l’organizzazione della
comunicazione con fini propagandistici basata sostanzialmente su modalità dirette di
comunicazione tra i canditati e gli elettori; una mediazione da parte degli organi di
informazione tra i partiti e i cittadini; un’adesione e un riconoscimento ancora forte da
parte dell’elettorato verso i partiti. Questa fase presenta aspetti differenti a seconda dei
vari paesi democratici. Negli Stati Uniti, ad esempio, il contatto diretto con l’elettorato
da parte del ceto politico rimane costante anche se la democrazia inizia ad assumere
un carattere di massa. In Europa, invece, nonostante le campagne elettorali presentino
delle assonanze con quelle statunitensi, l’esperienza democratica non risulta ancora
matura, subendo inoltre un brutto colpo a causa dell’esperienza con i regimi totalitari
e con le due guerre mondiali.
2.2.2. Le campagne elettorali moderne
Questa fase abbraccia un periodo che va dagli anni ’60 fino alla fine degli anni ‘80 del
secolo scorso. Tipiche di questa fase sono campagne relativamente lunghe. 14
Sono gli anni nei quali assistiamo ad un ingresso dirompente dei media nel dibattito
politico e sono gli anni del boom di uno dei mezzi di informazione più importanti
dell’epoca moderna: la televisione.
La televisione diventa il palcoscenico privilegiato delle competizioni elettorali e lo
strumento necessario per avvinare la politica ai cittadini: in un paese che stava uscendo
dai limiti di un dopoguerra faticoso, avvicinare la gente alla politica era un dovere
13 Plasser, S., e Plasser, G., 2002, Global Political Campaigning. A Worldwide Analysis of Campaigning Professionals and Their
Practices, Praeger, Westport, CT
14 Ibidem
21sociale primario.15
Gli attori politici compresero da subito il potenziale del nuovo mezzo televisivo,
avendo ora la possibilità di entrare nei salotti di milioni di italiani con estrema
semplicità rispetto al passato. Assistiamo, inoltre, alla nascita e alla diffusione di figure
professionali che diventeranno poi indispensabili nel condurre le campagne elettorali.
Stiamo parlando di figure come gli esperti del marketing politico, i consulenti politici,
i copywriters, gli spin doctors ed esperti di relazioni pubbliche.
Protagonisti di questa fase delle campagne elettorali sono senza dubbio gli spot
televisivi come anche i primi talk show politici che andranno sempre più a sostituirsi
alle piazze come strumento di competizione elettorale.
Dal punto di vista del cittadino-elettore, ormai sempre più volatile, si assiste ad una
scollatura nell’identificazione e nella fedeltà verso i vecchi partiti di massa e verso la
politica in generale; inoltre la tendenza inarrestabile alla spettacolarizzazione porterà
a delle conseguenze determinanti nel modo di percepire le istituzioni politiche.
2.2.3. Le campagne elettorali post-moderne
Andiamo ora ad analizzare la fase che va dagli anni ’90 fino ai nostri giorni.
Abbiamo a che fare con una fase in cui sono sempre più ricorrenti campagne lunghe e
che si contraddistingue per una diffusione sempre maggiore della televisione fino ad
arrivare poi, con il nuovo secolo, alla nascita e al progressivo diffondersi di Internet il
quale ha contributo al moltiplicarsi dell’offerta politica tanto da accorciare sempre di
più la distanza tra il sistema politico e i cittadini-elettori.
Le potenzialità della rete e delle nuove tecnologie sono sfruttate anche dal punto di
vista del marketing elettorale: infatti, grazie ai nuovi media è sempre più facile
segmentare gruppi di elettori e contattarli uno ad uno. Da qui l’importanza che la
Norris assegna agli esperti e agli strateghi delle campagne tanto da considerarli come
«attori comprimari con i politici».16 È quindi ricorrente l’affidamento delle campagne
a degli esperti esterni.
15 Monteleone, F., 2003, Storia della radio e della televisione, Marsilio Editori
16 Norris, P., 2000, A Virtuous Circle: Political Communications in Postindustrial Societies, Cambridge University Press
22Di conseguenza, i cittadini-target risultano ancora più distaccati dai partiti rispetto al
passato. Ciò è dovuto al carattere più fluttuante che assume l’elettorato in questo
preciso momento storico.
2.3. STRUMENTI E OBIETTIVI DI CAMPAGNA
Considerato ormai nella maggior parte dei paesi democratici come il momento
decisivo per ottenere il consenso, la campagna elettorale è il luogo in cui gli attori
politici mettono in atto tutti i loro strumenti per cercare di raggiungere un vasto
numero di cittadini-elettori in modo tale da ottenere quanti più voti possibili e quindi
vincere.
Nel corso del tempo, l’evoluzione delle campagne elettorali è andata di pari passo con
l’evoluzione e la nascita di nuovi strumenti messi poi in campo dagli strateghi delle
competizioni elettorali. Stiamo parlando di mezzi come la televisione, sin dalla sua
nascita considerata come miniera d’oro per l’avvicinamento dei cittadini della politica,
il sempre più diffuso marketing politico elettorale e le strategie di immagine.
Nei paragrafi che seguono andremo quindi ad analizzare questi tre strumenti per
comprenderne le caratteristiche e le peculiarità.
2.3.1. Il marketing politico-elettorale
«Una campagna che non segue le logiche del marketing non è una campagna
professionalizzata»17. Questa osservazione di Jesper Strömbäck mette in luce quanto sia
sempre più necessaria una professionalizzazione delle campagne elettorali. Infatti, il
marketing politico-elettorale può essere considerato come lo strumento che indica il
passaggio effettivo dalle campagne del passato alle campagne post-moderne, ormai
sempre più data-driven.
La letteratura accademica nel corso degli anni ha fornito varie definizioni di marketing
politico. In questa sede in particolare ne verranno prese in considerazione due, capaci
di definire in maniera corretta l’oggetto di indagine. La prima è quella di Michel
17 Strömbäck, J., 2007, Political makreting and professionalized campaigning. A conceptual analysis, in «Journal of Political
Marketing», 6, (2-3), pp. 46-67
23Bongrad secondo il quale «il marketing politico è un insieme di tecniche aventi come obiettivo
di favorire l’adeguamento di un candidato al suo elettorato potenziale, di farlo conoscere al
maggior numero di elettori e a ciascuno di essi in particolare, di creare la differenza con i
concorrenti e gli avversari e, con un minimo di mezzi, di ottimizzare il numero di voti che
occorre guadagnare nel corso della campagna» 18.
Questa definizione è stata sin da subito criticata dagli appartenenti ai partiti in quanto
non vedevano di buon occhio la commercializzazione della politica poiché in grado di
mettere in pericolo il processo democratico. La paura consisteva nella constatazione
che vendere un qualcosa di politico poteva essere recepito come un inganno. Bongrad
difende la sua posizione affermando che il marketing politico corretto consiste nel
«sedurre informando» un consumatore che «è anzitutto un cittadino di cui si deve
catturare l’attenzione e mobilitare l’interesse»19.
La seconda definizione ci viene fornita da Bruce I. Newman il quale afferma che «il
marketing politico è l’applicazione dei principi e delle tecniche di marketing nelle campagne
politiche»20 andando quindi a porre l’attenzione sulle campagne strategiche finalizzate
ad influenzare l’opinione pubblica e vincere le elezioni.
Una campagna che si affida al marketing elettorale risulta molto complessa in quanto
il lavoro si sviluppa in quattro fasi21 complesse che non posso essere gestite solamente
dal team di campagna ma che richiedono la professionalizzazione di particolari gruppi
di persone in grado di gestire tutti gli strumenti del ciclo di marketing.
La prima fase viene vista come la fase primordiale nella quale vengono posti gli
obiettivi che si vogliono cercare di raggiungere attraverso il piano di marketing. A
seconda della figura politica con cui si ha a che fare, verranno messi a punto diversi
obiettivi: se si tratta di un leader politico conosciuto, ad esempio alla ricerca di un
secondo mandato, bisognerà cercare di riproporre la sua figura ai cittadini-elettori in
modo tale da rimarcare la sua presenza nel ventaglio politico mentre se la figura in
questione risulta essere un candidato alle prime armi o al suo primo scontro elettorale,
18 Bongrad, M., 1995, Marketing politico, p. 13, M&B, Milano
19 Ibidem, p.14
20 Newman, B.I., 1999, Handbook of Political Marketing, Thousand Oaks, Calif., Sage
21 Maarek, P., 2001, Communication et marketing de l’homme politique, II ed., Litec, Parigi
24sarà necessario puntare a raggiungere una notorietà tale da diffondere la sua figura.
La secondo fase è caratterizzata, invece, dall’analisi del contesto competitivo22. Questa
analisi viene portata avanti attraverso varie ricerche eseguite su diversi ambiti come
ricerche del candidato e dell’avversario, l’analisi degli elettori, l’analisi dei temi che
possono risultare di maggiore interesse nell’opinione pubblica e, infine, l’analisi dei
media per indagare e comprendere il modo in cui un particolare candidato viene
descritto dalla macchina mediatica. L’analisi dei votanti risulta essere quella verso la
quale vengono dedicate più risorse in quanto una buona conoscenza della domanda
risulta essere un aspetto fondamentale per un piano di marketing funzionale. Lo
strumento maggiormente utilizzato per analizzare le tendenze di voto dei cittadini-
elettori è il sondaggio.
Proseguendo si giunge alla terza fase, considerata la fase tattica. A questo punto, dopo
aver analizzato le intenzioni di voto della platea elettorale, è il momento di elaborare
una strategia tale da riuscire a posizionare il candidato. Innanzitutto, viene scelto il
target al quale puntare a seconda del soggetto e a seconda della tipologia di campagna
con la quale si ha a che fare; successivamente si sceglie il posizionamento del
candidato. Questa fase si caratterizza soprattutto perché è qui che viene scelto il piano
di media-mix da utilizzare e i vari canali attraverso i quali l’immagine del leader o del
partito verrà comunicata ai potenziali elettori. I manager valutano attentamente su
quali media far viaggiare la campagna di comunicazione e possono scegliere tra i
media tradizionali quali la stampa o la televisione ma anche tra i nuovi media, i quali
sono diventati strumenti sempre più diffusi nel panorama del marketing politico.
La quarta fase è quella che viene considerata come la fase operativa di tutto il piano di
marketing, nella quale il candidato è pronto a scendere in campo e battersi per una
buona riuscita della campagna. In questa fase, ancor più che nelle altre, risulta
necessaria un’organizzazione centralizzata in grado di controllare e condurre tutte le
attività da portare avanti sul campo.
Dopo aver analizzato le quattro fasi che caratterizzato la definizione e la messa in atto
della campagna di marketing, risulta utile osservare quali sono gli strumenti
22 Cacciotto, M., 2011, Marketing politico. Come vincere le elezioni e governare, Il Mulino, Bologna
25maggiormente utilizzati negli scontri elettorali appartenenti alla fase post-moderna.
Accanto alle tecniche tradizionali, ovvero quelle che venivano utilizzate
maggiormente nel corso delle campagne premoderne e che ancora vengono impiegate
al giorno d’oggi, troviamo nuovi strumenti resi possibili dalla nascita delle tecniche di
profilazione nate con l’avvento di Internet e dei social media. Questi mezzi portano
dei cambiamenti nel modo di condurre ogni singola campagna in quanto permettono
di parlare direttamente con ogni singolo elettore, così da affinare il microtargeting e
quindi raggiungere un potenziale pubblico di cittadini-elettori in un modo più mirato
rispetto al passato. Non solo, ciò permette anche di capire le intenzioni di voto degli
elettori attraverso l’analisi dell’attività compiuta sul web dai vari utenti.
Di certo non si può parlare di targettizzazione su Internet senza citare i social network,
quali Facebook e Twitter. Questi nuovi strumenti, innanzitutto, danno la possibilità di
analizzare i movimenti dei singoli utenti così da indirizzare il corretto contenuto alla
giusta persona. Sono anche utilizzati sempre più come strumento imprescindibile
dell’interazione tra gli attori politici e i cittadini-elettori in una forma di dialogo sempre
più ravvicinato.
I nuovi media non solo consentono un’evoluzione delle campagne nel mondo online
ma negli ultimi anni si sono rivelati come strumenti utili per il rinascimento di forme
di organizzazione nel mondo offline. Questi mezzi, come vedremo, sono utilizzati
sempre di più per l’organizzazione dell’attività atte a sostenere un candidato senza la
necessità di incontrarsi dal vivo ma avendo comunque la possibilità di interagire in
tempo reale.
Le attività appartenenti alla sfera del marketing politico-elettorale risultano essere
molteplici, e per far sì che questa macchina funzioni correttamente è necessario, come
si è visto, il ricorso ad un’organizzazione ben centralizzata. Risulta visibile, inoltre,
quanto i leader politici appaiano come protagonisti indiscussi, in quanto senza la loro
presenza non ci sarebbe alcuna campagna. In ogni caso, risulterebbe sbagliato
concedergli tutti i meriti in quanto gli scontri elettorali vengono portati avanti per la
maggior parte da soggetti che non prendono parte ai comizi ma che rimangono
nell’ombra: stiamo parlando dei consulenti politici. Sotto questa etichetta, rientrano i
26media advisers, gli spin doctors e i campaign managers, i quali forniscono le loro
competenze con lo scopo di condurre i leader politici sulla strada giusta verso la
vittoria.
2.3.2. Il ruolo della televisione
Il rapporto tra la politica e la televisione fonda le sue radici in tempi non troppo recenti.
In Italia, il momento nel quale l‘offerta di comunicazione politica ha subìto
un’espansione come mai prima d’ora è senza dubbio la «discesa in campo» del
presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi23.
La televisione, al giorno d’oggi, nonostante i cambiamenti nati con l’era di Internet, è
ancora uno dei mezzi maggiormente utilizzati dai partiti e dagli esponenti politici in
quanto viene considerato un dispositivo molto efficace nell’influenzare il rapporto con
i cittadini-elettori. L’utilizzo del mezzo televisivo risulta tuttora una prerogativa di
ogni campagna elettorale in quanto l’apparire in televisione viene visto come uno
strumento importante per legittimare la figura del candidato agli occhi degli elettori,
così da essere riconosciuto come un’appartenente alla «mappa del paesaggio
politico»24 e dunque essere ricordato tra coloro i quali i cittadini dovranno scegliere il
giorno delle elezioni. Ma non solo, la televisione può rivelarsi come uno strumento
efficace anche per quelle forze politiche poco conosciute ma che vedono nella
televisione il palco nazionale per raccogliere la giusta quantità di notorietà tra i
cittadini e quindi avere la possibilità di ottenere quanti più consensi possibili.
Lo strumento televisivo più efficace e di conseguenza più utilizzato nel corso delle
campagne elettorali moderne e post-moderne è lo spot. Secondo la definizione di
Jamieson, lo spot elettorale è «un comunicato di breve durata, tra i 15 e i 60 secondi, che
asserisce ma non discute, mostra prove spesso in forma di esempio, personalizza e visualizza
concetti astratti e, in quanto breve affermazione drammatizzata, favorisce la semplicità a scapito
della complessità»25». Un’altra definizione, ritenuta anch’essa utile nel panorama
accademico per definire il concetto, è quella di Kaid, per il quale uno spot elettorale «è
23 Ruggiero, C., 2014, Le sorti della videocrazia: Tv e politica nell'Italia del mediaevo, Mondadori università
24 Maarek, P., 1989, Le message télévisé a-t-il besoin du discours politique, in «Moots», 20, 3
25 Jamieson, K.H., 1992, Dirty Politics. Deception, Distraction, and Democracy, p.150, Oxford University Press, New York
27un messaggio politico nel quale lo stile e il contenuto si trovano sotto il controllo del loro
produttore e che viene trasmesso attraverso l’utilizzo di un mezzo di comunicazione di
massa»26.
Lo spot nacque negli Stati Uniti con lo scopo di applicare le tecniche della pubblicità
commerciale e televisiva al campo della comunicazione politica. Venne utilizzato per
la prima volta nelle Presidenziali americane del 1952, quando Eisenhower fece
preparare quaranta filmati nei quali alcuni cittadini ponevano delle domande al
candidato repubblicano sui temi più importanti del paese.
Ciò che caratterizza lo spot televisivo come strumento di campagna è il fatto che
solitamente fonda la sua forza nelle immagini che è in grado di trasmettere piuttosto
che sui contenuti: nella maggior parte dei casi, infatti, l’informazione sui problemi
rilevanti è minima o del tutto assente.
In ogni caso, lo spot rimane ancora un’arma efficace utilizzata nelle campagne post-
moderne e in quelle digitali, nonostante la pervasività assunta da Internet.
2.3.3. Le strategie di immagine
Un altro importante strumento che risulta essenziale all’interno delle strategie delle
campagne moderne è ciò che riguarda la costruzione dell’immagine del candidato.
L’importanza dell’immagine dell’uomo politico nel contesto elettorale è un concetto
che attraversa i secoli tant’è che già ne “Il Principe” di Niccolò Machiavelli è possibile
riscontrare quella che può essere definita come una prima definizione della figura del
candidato: secondo l’autore, «niente procura tanta stima al principe quanto il fatto […]
di fornire un’eccezionale immagine di sé stesso, […] di dare un’immagine di uomo
grande e di ingegno eccellente27».
Grazie all’integrazione tra media tradizionali e media digitali, le immagini hanno
assunto un ruolo fondamentale all’interno dei dibattiti elettorali tanto che le moderne
campagne elettorali vengono definite anche come le campagne delle immagini. Il termine
immagine si declina in due accezioni differenti: l’immagine proiettata e l’immagine
26 Kaid, L. L, 2004, Political Communication Research
27 Machiavelli, N., 1975, Il Principe, Rizzoli Editore, Milano
28Puoi anche leggere