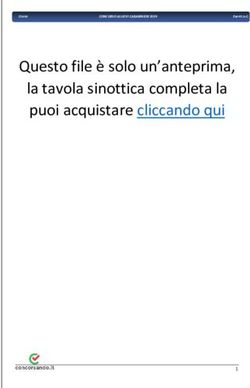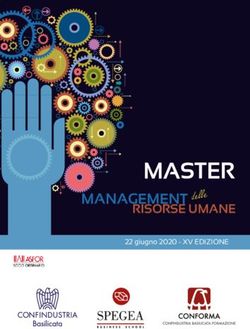ALESSANDRO PROVERA AVVOCATI, INTELLETTUALI E RAGIONI DELLA GRANDE GUERRA
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
ABCompos - 3B2 v. 7.51c/W (Jun 11 2001) - M:/15_RIVISTE/03_LEGALE/0103_19-
RICO_2018-2019/041_204.3d
Studi e commenti La Rivista del Consiglio
Anno 2018-2019
7
ALESSANDRO PROVERA
AVVOCATI, INTELLETTUALI
E RAGIONI DELLA GRANDE GUERRA
Alla memoria dei giovani Avvocati, Professori e
studenti Caduti nella Grande Guerra
SOMMARIO: 1. Un’occasione per commemorare. 2. Non solo una ricorrenza. 3. Un
giurista al fronte. 4. La ‘retrovia’. 5. La trincea come confine temporale ed esisten-
ziale. 6. Il fante gregario e Palinuro.
1. Un’occasione per commemorare
Da diversi anni l’Alta Scuola Federico Stella sulla Giustizia Penale (ASGP)
dell’Università Cattolica è coinvolta in un progetto dedicato alla riflessione sui
temi di giustizia emergenti dalle pagine della letteratura della Grande Guerra,
che si colloca nel più ampio filone di ricerca di Giustizia e letteratura (1). Il frut-
to di quest’impegno, il volume La Grande Guerra. Storie e parole di giustizia (a
cura di G. Forti e A. Provera, Vita e Pensiero, 2018), è stato, nel corso dell’ul-
timo anno, presentato in molte città italiane e luoghi simbolo del primo con-
flitto mondiale, in una sorta di ‘pellegrinaggio della memoria’, persuaso, in sen-
so michelstaedteriano, del fatto che solo conoscendo il nostro passato, mai del
tutto concluso, potremo evitare di subire nuovamente o perpetuare le sue in-
giustizie.
L’occasione per tornare a riflettere sul tema del contributo degli intellettuali
prima e durante la Grande Guerra, cui sarà dedicata un’ulteriore pubblicazione
monografica nei prossimi mesi, è stata offerta dall’importante incontro tenutosi
il 24 ottobre 2018 presso il Salone Valente della Casa del Mutilato, luogo ben
noto all’Avvocatura milanese. Vegliati dall’affresco di Antonio Giuseppe Santa-
gata, raffigurante la resistenza sul Piave e la vittoria, l’Ordine degli Avvocati e
il Tribunale di Milano, rappresentati dai rispettivi Presidenti, Remo Danovi e
Roberto Bichi, hanno commemorato il sacrificio dei numerosi Avvocati caduti
(1) Il frutto dei Cicli seminariali di Giustizia e letteratura sono i tre volumi editi da Vita e Pensiero:
G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. VISCONTI (a cura di), Giustizia e letteratura I-II-III, Milano, 2012-2014-
2016.
82ABCompos - 3B2 v. 7.51c/W (Jun 11 2001) - M:/15_RIVISTE/03_LEGALE/0103_19-
RICO_2018-2019/041_204.3d
La Rivista del Consiglio Studi e commenti
Anno 2018-2019
nella Grande Guerra. Tale evento assume un’importanza notevole per la collet-
tività, visto che i profili biografici degli Avvocati caduti sono stati raccolti a cu-
ra dell’Avv. Andrea Benzi e dell’Associazione Volontari di Guerra.
Karl Kraus, nel 1915, chiudeva il suo potente pamphlet di denuncia della
mistificazione della tragedia della guerra, In dieser großen Zeit, augurandosi che
l’«epoca [potesse] diventare grande abbastanza da giungere al livello delle sue
vittime, e mai tanto grande da vivere crescendo oltre la loro memoria» (2). L’au-
tore austriaco comprendeva, pertanto, già agli albori delle tempeste d’acciaio, il
problema della necessità della memoria del sacrificio, contrastando la retorica,
l’enfasi, alla ricerca di un significato di quel dolore e, in generale, della soffe-
renza umana. A distanza di cent’anni, commemorare (cum memorare) significa
quindi in primo luogo ricordare assieme, costruire una comunita` sulla memoria
condivisa.
È, pertanto, auspicabile che l’iniziativa dell’Avvocatura milanese possa essere
un faro guida per gli altri Ordini e i Tribunali del nostro Paese, affinché sot-
traggano all’oblio i propri caduti, i cui nomi affiorano dalle lapidi sparse in
tutta Italia, per esempio quello del volontario Avv. Guido Pellegrini sepolto
nel cimitero degli eroi di Aquileia, o dai ritratti alle pareti delle sale consigliari,
come quello dell’Avv. Riccardo Testa, alessandrino, caduto sul fronte isontino
nel 1916 (3).
È da sottolineare che, in tale prospettiva, il Consiglio dell’Ordine degli Av-
vocati e il Tribunale di Milano, sempre grazie ai loro Presidenti, hanno dimo-
strato anche in un’occasione più recente di considerare essenziale la formazione
umanistica per il giurista, non dimentica della storia e delle sue tragedie, parte-
cipando al convegno Eredita` e attualita` di una guerra senza pace, del 29 gen-
naio 2019, organizzato dall’Alta Scuola ‘‘Federico Stella’’ sulla Giustizia Penale
(ASGP), in cui si è continuata la riflessione sulle conseguenze della Grande
Guerra e sulle ‘paci’ che ne sono seguite, caratterizzate da un’evidente natura
punitiva.
(2) K. KRAUS, In questa grande epoca, Venezia, 2018, p. 87.
(3) Occorre a tal proposito ricordare che le Facoltà Universitarie e il mondo delle professioni liberali
furono tra i settori della popolazione più colpiti dal lutto, venendo in essi reclutati gli ufficiali di comple-
mento. I nomi delle vie che conducono ai Palazzi di Giustizia sovente ricordano la Grande Guerra: per
esempio via Carlo Freguglia, Avvocato milanese caduto a Flondar nei pressi dell’Ermada. La toponoma-
stica della Grande Guerra, che caratterizza in larga misura ogni città italiana, è tutt’altro che irrilevante,
ricorda, infatti, l’impatto eccezionale che tale guerra ebbe nella memoria collettiva e la sua importanza
come fattore di mutamento sociale radicale, base per la costruzione di una nazione all’epoca giovanissi-
ma. Le intitolazioni delle vie servono per comprendere e perpetuare la memoria di un sacrificio senza
uguali di un popolo chiamato a una delle prove più dure di tutta la sua storia e che, tragicamente, trovò
unità proprio in quell’esperienza.
83ABCompos - 3B2 v. 7.51c/W (Jun 11 2001) - M:/15_RIVISTE/03_LEGALE/0103_19-
RICO_2018-2019/041_204.3d
Studi e commenti La Rivista del Consiglio
Anno 2018-2019
2. Non solo una ricorrenza
In Italia, fin dal 1918, la Prima Guerra Mondiale è stata chiamata Grande
Guerra. Questa guerra può essere considerata grande certamente per il numero
di persone coinvolte, molte di più dei combattenti, per il numero di Stati, di
morti, feriti, mutilati e dispersi. Ma fu grande anche perché è stato un evento
epocale che cambiò i costumi dei popoli, la scienza e la letteratura. Scrittori,
poeti e intellettuali di tutte le Nazioni si confrontarono, infatti, con l’immane
tragedia di un’intera generazione.
I governi vincitori, all’indomani della guerra, iniziarono a tessere la celebra-
zione epica del conflitto, che quindi divenne grande per l’ideale perseguito, in
Italia si parlava, infatti, di Quarta Guerra di Indipendenza, e per l’eroismo.
Alla prospettiva ufficiale degli inni, delle celebrazioni e dei sacrari, si affianca
la guerra dei Fanti, dei ‘‘gregari’’ per utilizzare un’espressione di Giani Stupa-
rich, dei soldati semplici alla Ungaretti e dei tanti nostri parenti che combatte-
rono lungo un fronte di mille chilometri in uno degli ambienti più inospitali
di tutta la Guerra e al contempo naturalisticamente di una bellezza ecceziona-
le. Grande Guerra quindi anche per il senso del dovere, il sacrificio quasi inu-
mano, la speranza nella pace, l’anelito di libertà, la necessità di confronto con
lo straniero e di riflessione sui ‘confini’ e sulle ‘frontiere’ che questi uomini di
cento anni fa mostrarono e che la letteratura del tempo ci ricorda.
Risulta quindi ancor oggi essenziale riflettere sulla letteratura della Grande
Guerra, non tanto in occasione delle celebrazioni del centenario appena con-
cluso, ma nella convinzione che la Prima Guerra Mondiale non sia un avveni-
mento passato su cui sia ‘‘già stato detto tutto’’, avendo essa un’importanza
ancora centrale per il presente, nell’Europa d’oggi in cui si ergono nuove fron-
tiere, se ne ‘‘abbattono’’ altre e non sempre si riesce a superare antichi confini.
Inoltre, cent’anni fa la situazione di drammatica contrapposizione tra Nazio-
ni, culture ed esperienze storiche estremamente diverse tra loro non venne di
certo risolta grazie alla ‘pace’ che seguı̀ al conflitto. Eppure, proprio dall’espe-
rienza tragica della guerra, emersero o avrebbero potuto emergere con ancora
più nitidezza le fondamenta culturali e filosofiche dell’Europa contemporanea.
3. Un giurista al fronte
Uno dei più celebri giuristi al fronte è Piero Calamandrei, il quale si arruolò
volontario, spinto dall’ideale dell’interventismo democratico, e combatté tutta
la guerra alla fronte trentina, dove peraltro concluse la stesura della sua prima
importante monografia La Cassazione civile, grazie anche ad Ada, di cui Piero
84ABCompos - 3B2 v. 7.51c/W (Jun 11 2001) - M:/15_RIVISTE/03_LEGALE/0103_19-
RICO_2018-2019/041_204.3d
La Rivista del Consiglio Studi e commenti
Anno 2018-2019
amava gli occhi stellanti, la quale faceva recapitare in trincea i testi di diritto al
futuro marito.
La scelta interventista del giovane giurista poliziano fu dettata dall’anelito di
garantire al proprio popolo e a quelli europei la libertà dal giogo illiberale dei
sistemi militaristi rappresentati dagli Imperi centrali. Si nota, in questa scelta,
la tensione morale di Calamandrei, che lo accompagnò in tutta la vita, a intra-
prendere le necessarie battaglie per garantire lo stato di diritto.
Vi è una stretta relazione, come riportato in Zona di guerra (4), tra tale tratto
biografico e l’impegno come avvocato difensore in alcuni processi militari. No-
nostante il sistema penale militare italiano dovesse garantire lo scopo politico
dell’obbedienza del soldato e del mantenimento ferreo della gerarchia, come è
stato descritto, tra gli altri, da David Brunelli (5), Calamandrei riuscı̀, perlomeno
nei suoi processi, a fare in modo che venissero rispettate le garanzie dell’impu-
tato, per quanto limitate potessero essere.
Un ultimo elemento merita di essere menzionato, senza dubbio non il meno
rilevante. Nei giorni di Caporetto, Calamandrei percepı̀ limpidamente la ne-
cessità di raggiungere la verità su quel fatto storico che già all’epoca pareva di
centrale importanza, nella consapevolezza che solo la verità può fondare la ri-
cerca della giustizia in una società.
Per commemorare, mantenendo la coscienza viva del dolore (6), è necessario, co-
me primo passo di questo percorso di verità, associare un pensiero ai nomi di
chi quella guerra la scelse o si trovò a combatterla, scoprendo cosı̀ che le deci-
sioni di molti singoli, come dimostra l’esempio paradigmatico di Calamandrei,
furono dettate da ideali di giustizia che possono ispirare le vite non solo di
chi, per professione di giurista, è chiamato ancor oggi a confrontarsi con l’e-
sperienza del male e del dolore.
4. La ‘retrovia’
Come è noto, l’Italia entrò in guerra quasi un anno dopo lo scoppio del
conflitto mondiale, nel maggio 1915, il cosiddetto ‘maggio radioso’. Prescin-
dendo dai motivi politici e dalle pur interessantissime manovre di politica in-
terna e internazionale dei neutralisti e degli interventisti, occorre concentrarsi
sulla posizione che assunse la maggior parte degli intellettuali italiani che scel-
(4) P. CALAMANDREI, Zona di guerra, Roma-Bari, 2006.
(5) D. BRUNELLI, Fuggire la trincea. Il disertore, l’imboscato e lo scemo di guerra nella giurisprudenza dei
tribunali militari, in FORTI - PROVERA (a cura di), La Grande Guerra, cit., pp. 241 ss.
(6) G. STUPARICH, Ritorneranno, Milano, 2008, p. 477.
85ABCompos - 3B2 v. 7.51c/W (Jun 11 2001) - M:/15_RIVISTE/03_LEGALE/0103_19-
RICO_2018-2019/041_204.3d
Studi e commenti La Rivista del Consiglio
Anno 2018-2019
sero di far propria la causa dell’intervento bellico, partendo poi volontari per il
fronte (7).
Poi che il soldato che non parte in guerra
e` femmina che invecchia senz’amore
e c’e` un binomio, che nel mesto cuore
uno squillo ancor da`: Trento e Trieste:
poi che la vita e` un male, e son moleste dopo la prima giovinezza, l’ore:
ma chi soldato fra i soldati muore
resta giovane sempre sulla terra (8)
In questi versi di Saba, che riecheggiano Mimnermo e l’ideale greco della
morte eroica, si comprende che la guerra sia volta a uno scopo, Trento e Trie-
ste, cioè al completamento dell’unità nazionale. La posizione degli altri intel-
lettuali interventisti, che divennero poi soldati volontari è, però, molto più
complessa.
Carlo Emilio Gadda è autore del fondamentale Giornale di guerra e prigio-
nia, che racconta dell’esperienza dell’autore al fronte, percorso tra l’altro tutto,
da Edolo, retrovia dell’Adamello, cima della ‘guerra bianca’, fino alle pietraie
del Carso e a Caporetto, dove venne fatto prigioniero. Già da giovane la sua
personalità è duplice: da un lato, la spiccata sensibilità letteraria e la vocazione
patriottica, dall’altro, il razionalismo matematico-scientifico che lo portano a
indagare scrupolosamente e attentamente il mondo circostante.
Gadda si arruola volontario nel quinto reggimento alpini con il grado di sot-
totenente, mostrando un forte spirito risorgimentale: «Noi non abbisognamo
di Termopili, vogliamo Magenta e Solferino», ed è per questo che la parte del
diario del 1916 viene dall’Autore intitolata ‘‘Diario della Guerra di Indipen-
denza’’.
(7) Non si può chiaramente dimenticare il movimento futurista. I futuristi costituirono allo scoppio
della guerra il battaglione lombardo ‘‘Ciclisti e automobilisti’’, con a capo Filippo Tommaso Marinetti.
Si arruolarono nella formazione paramilitare Umberto Boccioni, l’architetto Antonio Sant’Elia e il pittore
Anselmo Bucci. Ne fecero poi parte anche Mario Sironi, Achille Funi, Carlo Erba, Ugo Piatti e Luigi
Russolo. Carlo Erba morı̀ sull’Ortigara, Sant’Elia, medaglia d’argento a valor militare sul Monte Zebio,
perse la vita a quota 85 di Monfalcone. Boccioni morı̀ in un’esercitazione. Ardegno Soffici fu ferito due
volte sulla Bainsizza. A fianco a componimenti tipici dell’idea futurista della guerra come unica igiene
del mondo e come reazione al passatismo (Guerra di Govoni, Aeroplano di Ardengo Soffici, Con Boccioni
a Dosso Cassina di Marinetti e Battaglia a 9 piani, sempre di quest’ultimo, dedicata al pittore Fortunato
Depero, arruolatosi con gli alpini come Giacomo Balla) vi sono le annotazioni di Boccioni che indivi-
duano realisticamente la tragedia della guerra e il senso della stessa.
(8) U. SABA, Congedo, in Canzoniere, Torino, 1961, p. 84.
86ABCompos - 3B2 v. 7.51c/W (Jun 11 2001) - M:/15_RIVISTE/03_LEGALE/0103_19-
RICO_2018-2019/041_204.3d
La Rivista del Consiglio Studi e commenti
Anno 2018-2019
Edolo, 27 ottobre 1915, ore 16
[...] Quanti con cavilli, con sofismi, con gran teorie giustificano la loro poca
eroica condotta! Il buon Marchini che io battezzai anarchico tolstoiano per dire
spirito libero e stravagante, dice di essere individualista, di non volersi adattare
all’idea dei più, di aver in ripugnanza le guerre, ecc. ecc. Fin qui, benone. Ma
quando gli chiesi se egli creda che una persona assalita debba difendersi, mi ri-
spose che sı`; quando gli chiesi se la Francia, se la Russia avevano il diritto di
lottare o dovevano darsi mani e piedi legate alla Germania, mi rispose che dove-
van lottare. E allora solo l’Italia che io credo minacciata nella sua stessa esisten-
za dal dilagare del Germanesimo strapotente, doveva lasciarsi fregare? (9)
Le motivazioni che spingono il giovane sottotenente alla guerra sono eviden-
ti: gli Imperi centrali, e soprattutto quello tedesco, sono considerati illiberali e
autoritari a livello politico. La loro vittoria equivarrebbe alla rinuncia agli ideali
ottocenteschi che Gadda ritiene fondare lo Stato italiano da poco unificato. È
dunque una motivazione culturale e politica quella del giovane Gadda, che ve-
de nel ‘‘germanesimo’’ il nemico dell’evoluzione culturale italiana dai tempi
antichi fino al Risorgimento. Beninteso: Gadda conosce bene la cultura di lin-
gua tedesca, filosofica e letteraria, la apprezza e la studia, anche durante la
guerra stessa. Quando parla di ‘‘germanesimo’’ fa riferimento al sistema politi-
co illiberale e con volontà di espansione che considera caratterizzare gli Imperi
centrali. È quindi una ‘guerra latina’ per la sopravvivenza di una cultura, quel-
la greco-romana.
Forte è l’influsso di D’Annunzio che ebbe un ruolo centrale nelle radiose
giornate di maggio, soprattutto nel ricollegare la necessità dell’intervento belli-
co al compimento del Risorgimento italiano, come emerge dai vari discorsi
pubblici del Vate.
Questa spada di Nino Bixio, ‘‘secondo dei Mille’’, primo fra tutti i combattenti
sempre, questa bella spada che un donatore erede di prodi offre al Campidoglio,
o Romani, e` un pegno terribile [...]
Io m’ardisco di baciare per voi, su questa lama, i nomi incisi delle vittorie. Suo-
nate la campana a stormo! Oggi il Campidoglio ` e vostro come quando il popolo
se ne fece padrone, or e` otto secoli, e v’istituı` il suo parlamento. O Romani, e`
questo il vero Parlamento. Qui da voi oggi si delibera e si bandisce la guerra.
Sonate la Campana! (10)
(9) C. E. GADDA, Giornale di guerra e prigionia, Milano, 2002, p. 49.
(10) G. D’ANNUNZIO, Per una più grande Italia, Milano, 2013, p. 11.
87ABCompos - 3B2 v. 7.51c/W (Jun 11 2001) - M:/15_RIVISTE/03_LEGALE/0103_19-
RICO_2018-2019/041_204.3d
Studi e commenti La Rivista del Consiglio
Anno 2018-2019
La tematica dello scontro tra la cultura greco-latina e il ‘‘germanesimo’’ per-
vade ovviamente anche i Canti della guerra latina di D’Annunzio.
Nazionalismo da un lato, socialismo rivoluzionario dall’altro, mai cosı̀ vicini,
pur partendo da posizioni tanto distanti. La guerra libererà il proletariato dalle
imposizioni imperiali e borghesi, entrambe retaggio e immagine di una società
della diseguaglianza. Cosı̀ pensa e sostiene pubblicamente Filippo Corridoni,
altro intellettuale volontario che eroicamente morirà, il 23 ottobre 1915, dopo
aver conquistato con un manipolo di uomini la trincea delle frasche a San
Martino del Carso. «È povera un’idea che non ha bisogno di martiri», sostiene
Corridoni, e con questa consapevolezza spinge il plotone sotto il fuoco austria-
co cantando «morte a Franz, viva Oberdan», refrain del famoso inno irredenti-
sta a Guglielmo Oberdan.
Sarebbe però riduttivo pensare all’interventismo come a un movimento su-
scitato da pochi pensatori, è più verosimile l’immagine di un vento dalle origini
antiche che scuote coscienze individuali diversissime tra loro.
Giuseppe Ungaretti si arruola come volontario, spinto anch’egli da una no-
tevole idealità di opposizione al germanesimo. Quella di Ungaretti è una figura
chiave, soprattutto perché rimane durante tutta la guerra soldato semplice. In-
fatti, il Comando centrale dell’esercito lo riterrà sempre inidoneo a comandare.
La scelta interventista di Ungaretti, lontana dall’essere influenzata dal dannun-
zianesimo, dipende dalla volontà consapevole di sacrificarsi per un’ideale che si
considera essenziale per la propria vita e per quella dei popoli.
Vi sono poi gli irredentisti, tra cui si devono ricordare Scipio Slataper e i
due fratelli Giani e Carlo Stuparich, anche loro inizialmente soldati semplici
nel primo reggimento Granatieri di Sardegna. Quelle degli irredentisti sono fi-
gure molto complesse, come testimonia l’incipit della prosa poetica del Mio
Carso di Slataper, di poco precedente alla guerra, dove l’autore triestino si defi-
nisce «italiano, sloveno, croato», un’identità multipla, insuscettibile di unitarie-
tà, come lo stesso Carso. L’anelito irredentista di Slataper è volto dunque a far
convivere identità culturali diverse, affinché nessuna venga sopraffatta dall’al-
tra. Scipio Slataper morirà sul Monte Calvario, il Podgora, il 3 dicembre
1915.
Anche i fratelli Stuparich entrano in guerra dopo aver fatto parte del circolo
della Voce di Prezzolini. La guerra, secondo i due intellettuali giuliani, serve af-
finché l’identità culturale italiana di Trieste non scompaia e sia riunita a quella
della Patria. Carlo Stuparich, il 30 maggio 1916, durante la Strafexpedition,
per non cader prigioniero degli austriaci, che l’avrebbero ‘giustiziato’ come
‘traditore’, dopo aver comandato l’ultimo assalto alle pendici del monte Cen-
gio, si spara.
88ABCompos - 3B2 v. 7.51c/W (Jun 11 2001) - M:/15_RIVISTE/03_LEGALE/0103_19-
RICO_2018-2019/041_204.3d
La Rivista del Consiglio Studi e commenti
Anno 2018-2019
Come si nota, la scelta interventista dipende quindi da un preciso motivo.
Si vuole difendere la propria appartenenza culturale che si ritiene minacciata
da altre espressioni straniere. Non c’è, però, in generale, volontà di annienta-
mento della diversità, ma solamente intenzione di difesa. La difesa della pro-
pria cultura è per gli intellettuali dell’epoca una chiamata alle armi senza possi-
bilità di sottrarsi, da qui la consapevolezza della necessità di farsi gregario e se-
guire il destino della Patria (11). Come si nota in tutti gli autori ricordati, già
dalla scelta interventista, emerge chiara la tendenza a un confronto con l’al di
la` della frontiera per riflettere sulle proprie convinzioni.
Ma siamo ancora nella ‘retrovia’, poiché questa è la posizione di coloro che
non hanno sperimentato il fronte e ‘visto’ la trincea. Occorre specificare che
nessuno di questi autori abbandonerà le convinzioni di partenza, ma le sotto-
porrà a critica, facendole maturare e rendendole più profonde.
5. La trincea come confine temporale ed esistenziale
Tutti gli scrittori arruolatisi arrivano ‘in linea’ e sperimentano la trincea.
L’intera narrativa gaddiana sarà sempre caratterizzata da un’attenzione parti-
colare verso il male e il dolore. Il Giornale di guerra e prigionia è all’origine di
tale interesse. Il male sperimentato è estremo: una guerra che non si è mai vi-
sta con tali proporzioni. Gadda vede la prima morte, ma non è tanto questa a
colpirlo. È l’irrazionalità (12) di tutto ciò che lo circonda il primo male: le trin-
cee non sono costruite bene, i comandi non arrivano, quando arrivano sono
sbagliati o suicidi, i vertici militari sono lontani, nella truppa vi sono anche
codardi ed egoisti, che non si sacrificano per gli altri etc.
È qui che emerge la duplicità dell’animo dell’autore. La curiosità e l’apertura
verso il mondo e verso la tragedia e la sofferenza degli uomini data dalla sensi-
bilità letteraria e artistica fa si che il ‘problema del male’ attiri magneticamente
Gadda.
Non si può dunque non reagire all’irrazionalità, dipanare il gomitolo e Gad-
da tenterà di farlo, in primo luogo, servendosi della ragione matematica e in-
gegneristica. Tutto il Giornale è corredato da schemi, schizzi, operazioni alge-
(11) Molto significativo è il concetto di «andare assieme» alla base della scelta interventista di R. SER-
RA, Esame di coscienza di un letterato, Cesena, 2015, pp. 27 ss.
(12) Male che diventa indicibile per alcuni poeti, come Eugenio Montale, che combatte alle pendici
del Pasubio, in Valmorbia e dedica alla guerra una sola poesia contenuta in Ossi di seppia.
Valmorbia, discorrevano il tuo fondo//fioriti nuvoli di piante agli a`soli.//Nasceva in noi, volti dal cieco ca-
so,//oblio del mondo.//Tacevano gli spari, nel grembo solitario//non dava suono che il Leno roco.//Sbocciava un
razzo su lo stelo, fioco//lacrimava nell’aria.//Le notti chiare erano tutte un’alba//e portavano volpi alla mia
grotta.//Valmorbia, un nome, - e ora nella scialba//memoria, terra dove non annotta.
89ABCompos - 3B2 v. 7.51c/W (Jun 11 2001) - M:/15_RIVISTE/03_LEGALE/0103_19-
RICO_2018-2019/041_204.3d
Studi e commenti La Rivista del Consiglio
Anno 2018-2019
briche, che servono per costruire i ripari, proteggere i suoi soldati, evitare la
carneficina, perlomeno il più possibile.
Si cerca inoltre di soddisfare il bisogno di riconoscimento della propria umani-
ta` che ogni individuo sembra richiedere nella disumanità del conflitto e delle
condizioni di vita che rendono gli uomini cose più o meno inerti in balia di
forze superiori
Fra le ondulazioni dolcissime dell’Altopiano, vestite dal folto pratile, il trillo del-
l’allodola nell’estate `
e segnato da una nota di apprensione paurosa: un bizzarro
spaventapasseri fa venir l’itterizia alle povere creature, avvezze al deserto silenzio
della vegetazione. Esse lo credono un mostro giallo e maligno, che guarda l’uni-
verso con l’occhio dell’augurio funebre: ma egli non ` e che il vecchio e bravo capi-
tano, a cui il Ministero ha tardato la promozione, a cui la guerra ha cosparso
di peli e di sudiciume la faccia, ha impolverato le scarpe, bisunto il vestito. Co-
me un palo sgangherato egli sorge dal verde, le tasche rigonfie di carte e di ogget-
ti di prima necessita`, gli abiti color frusto e pieni di ogni sorta di pataffie, la
giacca corsa da funicelle che reggono il cannocchiale e il fischietto e la borsa, la
cravatta sollevata nel collo, la faccia malata e stanca. [...] ascolto alcune sue os-
servazioni molto sensate, che egli pronuncia con qualche spruzzo di saliva dalla
bocca stanca, e mi allontano per non intenerirmi, perche´ il dar corso a senti-
menti troppo affettuosi non ` e da soldato. Egli mi guarda mentre m’allontano
con una faccia che dice: ‘‘te ne vai perche´ ti ho annoiato?’’ (13).
Il celebre brano gaddiano appare solo a una prima lettura meramente de-
scrittivo. Come fare a non sorridere amaramente del capitano che sembra uno
‘spaventapasseri’ per gli uccelli dell’Altopiano o delle molte cordicelle che pen-
dono dalla sudicia divisa che, unitamente alla magrezza, fanno dell’uomo quasi
un burattino? Al contrario, più l’occhio indagatore di Gadda si avvicina al ca-
pitano, più ne comprendiamo la personalità: la cura nei confronti dei suoi uo-
mini, il senso di appartenenza mostrato dalla medaglia, che però non viene
sfoggiata vanagloriosamente, e la disillusione nei confronti della vita. Com-
prendendo l’animo del capitano, costui non è più un essere inanimato come
uno spaventapasseri, la parola gli ha ridato la sua umanita` e ha creato comu-
nanza con l’osservatore.
Vi è poi una terza risposta di Gadda all’irrazionalità, perché cercare la ragio-
ne significa anche tendere alla verita`. È per questo che Gadda, ormai in prigio-
(13) GADDA, Giornale di guerra e prigionia, pp. 129-130.
90ABCompos - 3B2 v. 7.51c/W (Jun 11 2001) - M:/15_RIVISTE/03_LEGALE/0103_19-
RICO_2018-2019/041_204.3d
La Rivista del Consiglio Studi e commenti
Anno 2018-2019
nia, ricostruirà minuziosamente le ore della disfatta di Caporetto (14), capendo
perfettamente che non potrà esserci futuro per l’Italia senza verità su un avve-
nimento cosı̀ colossale e cosı̀ volutamente frainteso già durante la guerra stessa.
È un caso di piena consapevolezza della funzione di strumento di verità della
letteratura e di necessità di verità per la fondazione di qualsiasi Stato.
Anche lo stesso Ungaretti ebbe modo di sostenere che Il porto sepolto e
l’Allegria di naufragi avessero richiesto per essere scritte una conversione del
linguaggio all’essenzialità, come se la parola fosse l’unico strumento di com-
prensione esatta della situazione concreta. La letteratura sembra diventare
quindi l’unico strumento per approssimarsi alla verità. La trincea pone, infat-
ti, a livello esistenziale una domanda di verita` e di giustizia che non può esse-
re trascurata.
6. Il fante gregario e Palinuro
Nel Libro VI dell’Eneide, Enea scende agli inferi per avere responso sul suo
futuro da Anchise. Lı̀ incontra anche il nocchiero Palinuro (15) che, ancora lon-
tano dalle coste italiane, vinto dal sonno era caduto in mare, lasciando i com-
pagni senza timoniere. Enea gli chiede di raccontare la sua storia, lamentando-
si che, mendacemente, Apollo gli avrebbe mentito sul destino di Palinuro, il
quale sarebbe dovuto giungere con i compagni fino in Italia. Palinuro spiega a
Enea che, in effetti, ciò è accaduto: prima di essere inghiottito dai flutti, per
tre giorni e tre notti venne portato dalle onde, fin tanto che, alla quarta alba,
intravide le coste italiane, «prospexi Italiam summa sublimis ab unda» (16). Dal-
l’alto di un’onda Palinuro intravede (prospicere) l’Italia e poi viene vinto da
una forza più grande di lui, le armi di un popolo ostile.
Gadda utilizza il verso virgiliano ripetutamente nell’intero Giornale di guerra
e prigionia e come conclusione alla pagina della vittoria del 4 novembre
1918 (17), divenendo quindi questo verso la chiave di lettura dell’opera. Il fante
in trincea è Palinuro, perché è il ‘nocchiero d’Italia’, conducendo un intero
popolo. Il suo sacrificio in trincea permette a tutti, anche a coloro che sono
nella retrovia, di giungere a ottenere uno scopo. Il fante, però, come Palinuro,
intravede solo l’Italia, il suo fine, perché, non appena ne è al cospetto, una
forza irresistibile lo vince. È l’epopea del gregario e del milite ignoto.
(14) GADDA, Giornale di guerra e prigionia, pp. 264 ss., parte del diario intitolata La battaglia dell’I-
sonzo.
(15) VIRGILIO, Eneide, VI, vv. 236 ss.
(16) GADDA, Giornale di guerra e prigionia, p. 98.
(17) GADDA, Giornale di guerra e prigionia, p. 390.
91ABCompos - 3B2 v. 7.51c/W (Jun 11 2001) - M:/15_RIVISTE/03_LEGALE/0103_19-
RICO_2018-2019/041_204.3d
Studi e commenti La Rivista del Consiglio
Anno 2018-2019
Non a caso Ungaretti intitola la raccolta di versi pubblicata da una piccola
stamperia di Udine nel 1916 Allegria di naufragi. Banalmente si dice che l’allegria
è il sentimento di chi ‘‘se l’è vista brutta’’, ma è superstite alla guerra. L’allegria
è, invece, un sentimento molto più complesso, di chi, vivendo un naufragio di
dimensioni enormi, sa in primo luogo che questo non finirà con la guerra. L’alle-
gria non è inoltre ebrezza per l’‘avventura’ della guerra, ma è comprensione nel-
l’immane tragedia di un senso della vita, tematica già presente nel Porto sepolto.
Un’intera nottata
buttato vicino
a un compagno
massacrato
con la sua bocca
digrignata
volta al plenilunio
con la congestione
delle sue mani
penetrata
nel mio silenzio
ho scritto
lettere piene d’amore
Non sono mai stato
tanto
attaccato alla vita (18)
L’Allegria è, però, anche consapevolezza di concorrere alla formazione italiana,
non solo o non soprattutto dal punto di vista territoriale, ma a un’idea di Italia,
che parta da quella trincea. L’idea del fante gregario, che si sacrifica per un idea-
le, è propria di un’altra grande opera: Guerra del ’15 di Giani Stuparich.
Avverto il lettore che ho voluto mantenere a questo mio diario di guerra, ripreso
in mano dopo quindici anni, tutto intero il suo carattere: d’annotazioni fatte
sul momento, di giorno in giorno, anzi d’ora in ora, da un semplice gregario,
che riproduceva soggettivamente, sotto la prima impressione, tutto cio` che udiva
o vedeva o sentiva dal suo umile posto, senza controllo, senza possibilita` d’appu-
rare la verita` storica di certi fatti o la giustezza di certi apprezzamenti.
(18) UNGARETTI, Veglia, in Il porto sepolto, ora in Vita di uomo, Milano, 1966, p. 30.
92ABCompos - 3B2 v. 7.51c/W (Jun 11 2001) - M:/15_RIVISTE/03_LEGALE/0103_19-
RICO_2018-2019/041_204.3d
La Rivista del Consiglio Studi e commenti
Anno 2018-2019
Il gregario non è l’ultimo, anzi è il primo perché comprende la necessità di
solidarietà coi compagni e, in generale, nella vita umana e di adempimento
del dovere, che solo un grande ideale può suggerire. Un ideale, l’Italia, che è
al di là della trincea non solo fisicamente, come simboleggiano le poche luci
di Trieste sul mare intraviste dalle alture del Carso, ma è uno scopo da rag-
giungere e parzialmente da costruire.
Sono un poeta
un grido unanime
sono un grumo di sogni
Sono un frutto
d’innumerevoli contrasti d’innesti
maturato in una serra.
Ma il tuo popolo e` portato
dalla stessa terra
che mi porta
Italia
E in questa uniforme
di tuo soldato
mi riposo
come se fosse la culla
di mio padre (19)
La divisa grigioverde di Ungaretti diventa culla perché anche in questo caso
il sacrificio è volto all’Italia, non solo come ‘‘espressione geografica’’, ma idea
culturale e politica. È per questo che si muore per Trento e Trieste.
La trincea è quindi, per i poeti e gli scrittori al fronte, un confine, non solo
perché al contempo separa e unisce due popoli, ma perché segna la distinzione
tra un prima e un dopo. Chi fa esperienza della trincea vedrà, infatti, la sua vi-
ta cambiare e anche coloro che ritorneranno dovranno per sempre confrontarsi
con tale esperienza limite. Come emerge anche dal romanzo Ritorneranno (20) di
Giani Stuparich, tale confronto non può che essere volto alla ricostruzione che
non vuol dire mantenimento di quello che era prima. La trincea è, infatti, di-
visione tra un prima e un dopo culturale, imponendo la stessa di trovare co-
stantemente un senso alla propria azione e altresı̀ di aver chiara la finalità per
cui si combatte. Gli scrittori in trincea hanno la netta sensazione che anche
(19) UNGARETTI, Italia, in Il porto sepolto, ora in Vita di un uomo, Milano, 1966, p. 48.
(20) STUPARICH, Ritorneranno, cit.
93ABCompos - 3B2 v. 7.51c/W (Jun 11 2001) - M:/15_RIVISTE/03_LEGALE/0103_19-
RICO_2018-2019/041_204.3d
Studi e commenti La Rivista del Consiglio
Anno 2018-2019
dal punto di vista umano e culturale nulla potrà essere come prima. Non si
combatte per un’identità culturale immobile nei millenni e astratta, ma si
comprende che si può combattere solo se il ‘‘dopo la trincea’’ terrà conto della
stessa e si confronterà con il conflitto appena concluso.
Di che reggimento siete
Fratelli?
Parola tremante
nella notte
Foglia appena nata
Nell’aria spasimante
involontaria rivolta
dell’uomo presente alla sua
Fragilita`
Fratelli (21)
In tutta la letteratura italiana della Grande Guerra vi è una continua ricerca
di rapporto con l’altro. L’uscita dalla trincea vuol dire innanzi tutto, per gli
autori, creare legami stabili tra coloro che hanno combattuto e l’intero popolo.
Legami di verita`, che possono fondare una fratellanza. Una nuova comunanza
di intenti, umana e culturale. Legami quindi che dipendono da un confronto
serrato partendo da impostazioni diverse.
Tale confronto non deve, però, riguardare solamente gli italiani
Macchinalmente, senza un pensiero, senza una volonta` precisa, ma cosı`, solo per
istinto, afferrai il fucile del caporale [...]. Ero come in un poligono e mi potevo
prendere tutte le comodita` per puntare. Poggiai bene i gomiti a terra, e comin-
ciai a puntare.
L’ufficiale austriaco accese una sigaretta. Ora egli fumava. Quella sigaretta creo`
un rapporto improvviso fra lui e me. Appena ne vidi il fumo, anch’io sentii il
bisogno di fumare [...] Fu un attimo. Il mio atto di puntare, ch’era automatico,
divenne ragionato [...] Pensavo. Ero obbligato a pensare [...]
Avevo di fronte un uomo. Un uomo!
Un uomo! (22)
Fausto Maria Martini in Perche´ non ti uccisi sostiene
(21) UNGARETTI, Fratelli, in Il porto sepolto, ora in Vita di un uomo, cit., p. 34.
(22) E. LUSSU, Un anno sull’Altipiano (1945), Milano, 1970, pp. 160-161.
94ABCompos - 3B2 v. 7.51c/W (Jun 11 2001) - M:/15_RIVISTE/03_LEGALE/0103_19-
RICO_2018-2019/041_204.3d
La Rivista del Consiglio Studi e commenti
Anno 2018-2019
Non fu dunque per tema
S’io non t’uccisi: fu per non morire!
Per non morire in te: m’eri gemello,
o apparso sulla gemina trincea (23)
Quella necessità di umanizzazione che Gadda provava nei confronti dei suoi
commilitoni, Lussu e Martini mostrano di percepirla altresı̀ per il ‘‘nemico’’,
uomo anch’egli.
In Gadda si fa, però, un passo ulteriore. Non si dubita mai in tutto il Gior-
nale di guerra e prigionia che l’altro, il ‘‘nemico’’, sia un uomo, anzi se ne ap-
prezzano le virtù allo stesso modo di come si biasimano le piccolezze di alcuni
fanti italiani. È di estrema rilevanza che la pagina più significativa del diario
gaddiano non sia quella del 4 novembre 1918, dedicata alla vittoria, pur vi-
brante di emozione. È il 9 gennaio 1919 e Gadda è ancora in Germania vici-
no ad Hannover. Non è più prigioniero ma, a causa della lunghezza dei rim-
patri, deve attendere il suo turno per raggiungere l’Italia. Lui e i commilitoni
ufficiali sono soliti frequentare una Gasthaus per mangiare e bere qualcosa. Ed
è lı̀ che un ufficiale italiano si prende gioco di un tedesco.
La beffa contro il suo damo: lo facemmo cantare dei Lieder tedeschi (Deutsch-
land über alles, Wacht am Rhein, der gute Kamarad ecc.) e ballare sopra una
gamba sola. Era un uomo stupido. Facile vittoria. Tristezza mia; gia` come nei
primi giorni della vittoria lo spettacolo del popolo vinto mi rattrista profonda-
mente, non perche´ io sia evoluto nel senso internazionalista, ma perche´ mi metto
al loro posto; stato d’animo che chiamero` omerico, di Omero auctor (24).
Gadda non disconoscerà mai le ragioni della guerra, la volontà rimarrà «fer-
missima» anche in prigionia. Lo dice, infatti, lo stesso autore di non accedere
a una visione internazionalista, nel senso che i motivi che spinsero alla guerra
furono diversi tra i vari popoli e alcuni inaccettabili. Né tanto meno le diffe-
renze nazionali si debbono eliminare qualora portino a una ricchezza. Si capi-
sce, tuttavia, che una costruzione culturale, anche solo italiana, non possa non
confrontarsi con il ‘‘nemico’’, con le sue ‘ragioni’, con la sua umanità. Negare
(23) F. M. MARTINI, Perche´ non ti uccisi, in Tutte le poesie, Milano, 1968, p. 60. Su questo tema, il
riferimento essenziale è a G. CAPECCHI, Lo straniero nemico e fratello, in FORTI - PROVERA (a cura di), La
Grande Guerra, cit., pp. 175 ss.
(24) GADDA, Giornale di guerra e prigionia, p. 416.
95ABCompos - 3B2 v. 7.51c/W (Jun 11 2001) - M:/15_RIVISTE/03_LEGALE/0103_19-
RICO_2018-2019/041_204.3d
Studi e commenti La Rivista del Consiglio
Anno 2018-2019
il confronto con l’altro impedirebbe qualsiasi superamento della trincea e la ri-
cerca di giustizia e di verità.
Non capisco ne´ quello che mi si domanda da ogni parte, ne´ quel che rispondo.
Devo comprimere dentro di me un impulso che farebbe balzar su, correre via,
nascondermi in qualche angolo solitario, per pensare, senza questo nodo alla gola
che mi soffoca, alla nostra famiglia. Forse era più facile pensare ad essa in trin-
cea che in mezzo alla vita, dove ritornati dopo due mesi di fronte, non abbiamo
il conforto di poter riabbracciare nostra madre, lontana, irraggiungibile (25).
È forse possibile sostenere, grazie alle parole di Stuparich, che la trincea, es-
sendo il confine ultimo a cui si può spingere l’uomo, diventi anche metafori-
camente l’unico modo per pensare e comprendere, comportando una necessa-
ria e drammatica dialettica. Il pensiero si evolve quindi non grazie al conflitto,
certamente, ma grazie al confronto. Emerge pertanto dalla letteratura della
Grande Guerra l’idea che ogni popolo esprima un modello culturale e un’idea
di giustizia. Ogni modello deve, tuttavia, confrontarsi con gli altri e richieder-
ne le ragioni. Solo in questo modo si creano legami di solidarietà, considerati
essenziali per la vita di ogni individuo, legami di solidarietà non solo all’inter-
no di una singola nazione, ma in una dimensione europea.
Di fronte all’inascoltato sacrificio, che per il fante gregario era volto alla co-
struzione di «un forte avvenire sereno» (Canzone del Grappa), in cui la pace
non avrebbe potuto tollerare «né oppressi, né stranieri» (Leggenda del Piave),
riecheggiano i versi della canzone degli alpini Ortigara «solo pace, solo pietà»,
che chiedono ancor oggi per i caduti gregari e per le migliaia di ignoti Palinu-
ro di continuare a fare memoria (26) di quello che per loro effettivamente è stata
la guerra e di quello che doveva essere il ‘‘mondo dopo la trincea’’.
(25) STUPARICH, Guerra del ’15, p. 181.
(26) Pietà deve intendersi come pietas virgiliana, che significa anche comprensione dell’individuo.
96Puoi anche leggere