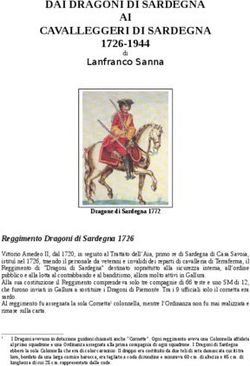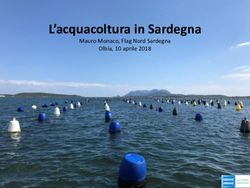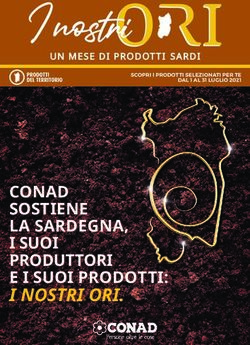90 SARDEGNA TRA INSULARITA' E SPOPOLAMENTO THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS - Centro ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
SARDEGNA
TRA INSULARITA’
E SPOPOLAMENTO
THE INTERNATIONAL
ASSOCIATION
OF LIONS CLUBS
90
“Osvaldo de Tullio”
Poste Italiane S.p.A. CENTRO STUDI “GIUSEPPE TARANTO”
Spedizione in a.p. 70%
Roma - DCB Roma ROMA - APRILE 2019We Serve
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI LIONS CLUB
DISTRETTO 108 L I.T.A.L.Y.
CENTRO STUDI “GIUSEPPE TARANTO”
Quaderno del Lionismo
90
SERVICE INTER CLUB
Annata Lionistica 2018 -2019
CAGLIARI HOST TEMPIO PAUSANIA LA MADDALENA-CAPRERA SASSARI HOST
P. FRANCO PIGA P. CARLO GIUA P. BACHISIO LEDDA P. PIERO MASIA
SARDEGNA TRA INSULARITÀ E SPOPOLAMENTO
Centro Studi “Giuseppe Taranto”
Delegato alla Presidenza PDG Pietro Pegoraro
Roma - Aprile 2019Pubblicazione edita dal Distretto 108 L
della Associazione Internazionale dei Lions Club
nell’anno sociale 2018-2019
Governatore Leda Puppa
Roma - Aprile 2019
Direttore Responsabile Armando Di Giorgio
Autorizzazione del Tribunale di Roma n° 14457 del 17-3-1972
Stampa Industria Tipografica Laziale - Palestrina
Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in a.p. 70% Roma - DCB Roma
Anno XLVIII - n° 90 Aprile 2019
Periodico QuadrimestraleQUADERNI DEL LIONISMO
“Osvaldo de Tullio”
Direttore Editoriale
Leda Puppa, Governatore
Direttore Responsabile
Armando Di Giorgio
Redattore
Luigi MatteraPREFAZIONE
Leda Puppa
Governatore
L’insularità è una condizione pregiudizievole che grava pesantemente sulla quali-
tà della vita della popolazione e sull’economia delle isole.
In Italia, questo svantaggio colpisce non solo le due isole principali - Sicilia e
Sardegna - ma anche quelle minori, sparse nel mare tra il Veneto, la Liguria, la
Toscana, la Campania, la Puglia e la Sicilia.
Premesso che la Costituzione emanata nel 1948 faceva un preciso riferimento
all’insularità, nella riforma costituzionale del 2001 tale riferimento è stato elimina-
to, con la conseguenza che le isole restano realtà svantaggiate, sia dal punto di vista
economico che sociale, per le gravi ripercussioni sul trasporto, sul commercio, sul
diritto alla salute e sull’istruzione.
Le isole italiane, quindi, non sono protette da una norma che tenga conto della loro
peculiarità e fragilità; inoltre, gli abitanti delle isole continuano a soffrire di uno
svantaggio strutturale e infrastrutturale che impedisce loro di avere pari opportuni-
tà con gli altri connazionale e con i cittadini europei.
La soluzione ideale sarebbe quella di reintrodurre il principio dell’insularità e dei
conseguenti aiuti di stato nella Costituzione, ma la strada sarebbe lunga e irta di
ostacoli.
Quattro club sardi - Cagliari Host, Tempio Pausania, La Maddalena-Caprera e
Sassari Host - hanno rotto gli indugi e si sono uniti per un’analisi approfondita del
problema e delle sue conseguenze; ne è venuto fuori un pregevole documento che
tratta in prima battuta l’insularità e le sue ricadute sul territorio, per giungere alle
cause che stanno determinando il progressivo spopolamento dell’isola.
In questa analisi viene evidenziato che i trasporti delle persone e delle merci, la
qualità delle infrastrutture, il dinamismo del mercato del lavoro e l’accesso al cre-
dito sono molto differenti in Sardegna; ma anche il costo dell’energia, della sani-
tà, dell’istruzione e dell’alta formazione presentano costi più alti per i cittadini
sardi che non meritano di essere considerati diversi dagli altri cittadini italiani.
I problemi della Sardegna non riguardano soltanto i sardi, ma devono costituire un
problema per tutta la comunità nazionale: se per i sardi non è semplice raggiunge-
re il continente, può dirsi altrettanto per i cittadini del continente, poiché i collega-
menti aerei non sono sufficientemente garantiti e incidono negativamente sulla
continuità territoriale; in questo caso, è lo Stato che deve farsi carico di erogare i
fondi e le sovvenzioni necessarie per assicurare la continuità, intervenendo sugli
aeroporti e sulle linee aeree.
Non è una banalità: quando è sera, gli abitanti dell’isola più distante geografica-
mente dal continente, dopo la partenza dell’ultimo aereo e dell’ultima nave, resta-
no isolati dal resto del mondo.
Di questo disagio è delle sue conseguenze sulla vita dell’isola è permeata l’analisi
dei quattro club sardi, ai quali va il mio personale ringraziamento per aver affron-
tato - con spirito critico e costruttivo - un lacerante problema politico, che rientra
pienamente fra gli scopi del Centro Studi.
5INTRODUZIONE
PDG Pietro Pegoraro
Tra gli scopi del lionismo, uno dei principali, è certamente quello di “partecipare
attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità”.
In questo ambito, si inquadra completamente il presente lavoro, con l’intento di
dare impulso alle Istituzioni suggerendo possibili soluzioni per lo sviluppo e la cre-
scita sociale, in un periodo di crisi, soprattutto economica, ma anche di valori, con
l’analisi di questa problematica specifica del territorio che vede correlate tra loro
insularità e spopolamento.
I Lions, quale parte viva e pienamente operante nel contesto sociale di cui fanno
parte, con la loro professionalità, in applicazione dei principi lionistici che li distin-
guono, propongono la modifica costituzionale mediante l’inserimento di misure
atte a superare le evidenti problematiche e a garantire pertanto una effettiva parità
di diritti nel contesto nazionale.
Un grazie ai Club Lions che hanno posto in essere queste riflessioni, senza alcuna
logica politico-partitica, ma con attenzione ai principi di eticità, ai valori di cono-
scenza e innovazione, finalizzati alla costituzione di un nuovo modello di svilup-
po partecipato, che possa creare nuove opportunità soprattutto per i giovani, nel-
l’attuale contesto del cambiamento globalizzato, per il superamento del naturale
svantaggio della insularità.
6PRIMA PARTE
SARDEGNA TRA INSULARITÀ E SPOPOLAMENTO
Riflessioni e contributi di quattro club Lions della Sardegna
Indice Prima Parte
Introduzione 8
Premessa 11
1. Contributo Cagliari Host 13
1.1 Le ragioni della crisi della Sardegna 13
1.2 Industrializzazione senza sviluppo 14
1.3 La “pentola bucata” 17
1.4 Cosa succede nel “Villaggio globale” 18
1.5 I rischi della de-territorializzazione 19
1.6 I rischi dei cambiamenti climatici 21
1.7 I rischi della technological “disruption” 22
2. Contributo Sassari Host 25
2.1 Limiti della riforma delle Autonomie locali 25
2.2 Per una corretta riforma delle Autonomie locali 27
2.3 Insularità e responsabilità istituzionali a livello locale 27
2.4 Prossimi passi 29
2.5 Lionismo sociale per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro 31
Quel senso forte dell’appartenenza alla Polis che orienta la nostra azione
comunitaria 37
La nuova frontiera del Lionismo. La realtà sarda. 39
3. Contributo Lion Club Tempio Host 40
3.1 Spostamenti di popolazione e fenomeni migratori 40
3.2 L’insularità: i rischi dell’isolamento 42
4. Contributo La Maddalena - Caprera 44
4.1 Le Isole minori 44
4.2 Insularità “al quadrato” 44
4.3 Nuovi scenari per La Maddalena 46
7Introduzione
I Lions Club storici della Sardegna hanno assunto un’iniziativa, su impulso del
Lions Club Cagliari Host, di avviare un’azione di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica e delle istituzioni su alcuni temi importanti, oggi di estrema attualità, per
il futuro della Sardegna. Li muove, assieme agli altri 28 Club distribuiti in tutta
l’isola, uno dei più determinanti scopi altruistici dell’Associazione Internazionale
dei Lions Club, presente in 210 paesi del mondo: “Partecipare attivamente al bene
civico, culturale, sociale e morale della comunità”. Determinante impulso, questo,
allo studio e alla elaborazione della proposta volta alla crescita e allo sviluppo della
nostra società, da divulgare e offrire alla considerazione e all’iniziativa specie di
chi ha la rappresentanza e la responsabilità di governo della nostra isola.
L’obiettivo di questa iniziativa è quello di condividere, divulgare e rendere pubbli-
che tali riflessioni, in particolare con chi ha la responsabilità di governo della
nostra Isola.
Attraversiamo oggi un generale periodo di crisi a tutti i livelli, dall’economia alle
politiche di governo sino alle stesse rappresentanze delle istituzioni. Motivo in più
per intraprendere questa iniziativa che vuole essere, non solo un momento di
approfondimento, ma soprattutto un’occasione di stimolo e supporto per una clas-
se dirigente che auspichiamo sappia rigenerarsi e mostrarsi più attenta nel creare
occasioni di confronto con la propria comunità.
Questa riflessione avviene mentre in Sardegna è in atto, benché sulla stessa non ci
sia grande attenzione, un’importante iniziativa, sostenuta da una campagna refe-
rendaria nazionale, per l’inserimento del principio dell’insularità nella nostra
Costituzione. L’obiettivo è la modifica dell’art. 119 della Costituzione, concernen-
te il riconoscimento del principio del grave e permanente svantaggio naturale che
deriva dall’insularità. Testualmente la raccolta di firme ha ad oggetto la seguente
modifica all’articolo 119 della Costituzione: dopo il quinto comma è inserito il
seguente testo: “Lo Stato riconosce il grave e permanente svantaggio naturale
derivante dall’insularità e dispone le misure necessarie a garantire una effettiva
parità ed un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili”.
Dentro questa cornice di riferimento e data l’importanza dell’iniziativa referenda-
ria per i risvolti che la stessa potrebbe avere, soprattutto sulla possibilità di ridise-
gnare un percorso di rilancio economico e sociale della nostra Isola, ci siamo inter-
rogati, come LIONS, sul ruolo che anche noi possiamo avere nell’ambito di que-
sto importante dibattito pubblico.
In altre parole, ci siamo chiesti:
a) ha un senso che i Club Lions della Sardegna intervengano in questo dibattito
pubblico, ovviamente fuori da logiche di tipo politico-partitico?
b) e se avesse senso intervenire, quale potrebbe essere concretamente il contributo
che l’organizzazione dei circoli può dare al dibattito in corso?
c) e se avesse un senso partecipare e fosse definito il tipo di contributo, quale
potrebbe essere il programma delle azioni specifiche in grado di connotare e
qualificare la partecipazione dei Lions?
Alla prima domanda ci è sembrato quasi scontato che la risposta dovesse essere un
sì convinto. Si tratta di una battaglia di libertà e civiltà, del tutto compatibile con
8le finalità istituzionali dei LIONS e con i principi che orientano la nostra azione di
servizio. Si tratta di un’importante occasione per riportare al centro del dibattito
regionale il tema del rilancio della nostra Isola che da tropo tempo soffre di una
perdurante crisi economia ed occupazionale che va ad incidere negativamente
soprattutto sulle prospettive future dei nostri giovani.
I Club LIONS della Sardegna non si sono mai sottratti a questi temi e continuiamo
a fare questo nel rispetto delle prerogative istituzionali di servizio che caratterizza-
no le nostre attività. Tra queste si annoverano le iniziative finalizzate a trovare
nuove opportunità di sviluppo economico e sociale della nostra Isola e soprattutto
occasioni di crescita culturale e professionale per i nostri giovani.
Con questa iniziativa, quindi, abbiamo voluto anche dimostrare che possiamo met-
terci in gioco e svolgere un ruolo importante nel proporre nuovi percorsi, modifi-
cando anche il nostro modo di agire nella società, per contribuire e partecipare
sempre più attivamente alle scelte sulle “politiche” della nostra Regione.
La strada intrapresa con la campagna referendaria per il riconoscimento del princi-
pio dell’insularità, riformando la Costituzione italiana, è una grande occasione
anche per i LIONS sardi dalla quale prendere spunto per costruire un nostro per-
corso da protagonisti.
E’ dentro questo contesto che è partita dal Club Cagliari Host l’iniziativa che oggi
presentiamo che ha coinvolto i Circoli LIONS storici della Sardegna (Lions Club
Sassari Host, Lions Club Tempio e Lions Club La Maddalena - Caprera) e che si è
conclusa con questo documento che portiamo all’attenzione di un pubblico più
vasto nella speranza che possa essere raccolto e discusso anche dentro le istituzio-
ni della nostra Regione.
È stata una sfida ambiziosa che, come si vedrà nel prosieguo del presente lavoro,
rimette anche in gioco lo stesso concetto di Autonomia speciale della Sardegna per-
ché prova ad “andare oltre”, sino ad ampliare tale concetto con nuovi e moderni
significati e disegnando una nuova prospettiva “autonomistica” aperta e propositiva.
Per rispondere alla seconda domanda, abbiamo dovuto fare uno sforzo preliminare di
analisi e di approfondimento dello “stato dell’arte”. Per questo abbiamo lanciato
l’idea di avviare una riflessione aperta non solo ai nostro soci, ma a tecnici ed esper-
ti dei diversi settori coinvolti (istituzionali, tecnico-giuridici, economici, sociali, cul-
turali, storico-identitari, etc.) che potessero aiutarci a capire meglio i fenomeni del-
l’insularità e dello spopolamento per poterli quindi interpretare e rilanciare in un qua-
dro di coerenza con i principi ispiratori della nostra organizzazione.
Da queste riflessioni è emersa una prima questione ed anche un rischio che come
LIONS intendiamo contribuire a scongiurare. Abbiamo avuto l’impressione, infat-
ti, che il dibattito sia troppo sbilanciato sugli aspetti tecnico-giuridici legati all’in-
serimento dell’insularità in Costituzione. Le conseguenze di questo rischio, non
sono solo legate al fatto che il dibattito possa restare “chiuso” fra addetti ai lavori,
principalmente giuristi e costituzionalisti, ma al fatto che, anche in caso di succes-
so, e quindi di riconoscimento del principio dell’insularità in Costituzione, non ci
sarebbero conseguenze e ricadute concrete per la società sarda e per i sardi e,
soprattutto non si creerebbero nuove opportunità per i nostri giovani. È un rischio
da contrastare con decisione, perché la vera partita in gioco, la vera sfida non è per
addetti ai lavori, ma è quella di costruire un nuovo modello di sviluppo economi-
9co e sociale per la nostra Isola, che sia partecipato e condiviso.
Dopo il fallimento del vecchio modello, calato dall’alto e ormai superato, della
grande industria energivora ed inquinante, assistita dallo Stato, caratterizzato dai
grossi poli della chimica di base, della mineral-metallurgia, della produzione di
energia da fonte fossile, la Sardegna deve con decisione voltare pagina se vuole
trovare nuove traiettorie di sviluppo.
Per questi motivi abbiamo voluto orientare il confronto, che si è svolto nei nostri
quattro Club storici sui temi dell’insularità, andando a cercare di capire come, nel
concreto, questa battaglia per l’insularità si possa riempire di nuovi contenuti che
abbiano a che fare direttamente con la vita reale delle persone, delle imprese, dei
giovani, degli studenti.
Accettata, quindi, l’ipotesi di giocare un ruolo attivo nel partecipare con contribu-
ti di idee alla elaborazione di un nuovo modello di sviluppo per la Sardegna le cui
implicazioni siano facilmente comprensibili e i cui effetti siano chiaramente perce-
pibili, si trattava anche di formulare una risposta convincente anche alla terza
domanda richiamata in premessa: definire un programma di azioni specifiche e
tempi certi per la sua realizzazione.
A questa domanda abbiamo risposto condividendo l’esigenza di attribuire obietti-
vi chiari ad una serie di incontri-dibattito che poi sono stati promossi al livello ter-
ritoriale dai Club storici. Abbiamo condiviso un metodo di lavoro per fare in modo
che, già a partire dagli incontri-dibattito, si potesse convergere verso un comune
obiettivo finale. In altre parole, abbiamo organizzato una serie di incontri territo-
riali e fatto in modo che ciascun contributo territoriale fosse strutturato seguendo
un comune denominatore e che lo stesso potesse concorrere alla elaborazione del
documento finale che qui presentiamo. Questa pubblicazione è, pertanto, frutto di
questo lavoro e rappresenta il nostro contributo al dibattito in corso che portiamo
all’attenzione, non solo di tutti i Club LIONS della Sardegna, ma alla discussione
di un vasto pubblico al livello regionale, e anche all’attenzione dei rappresentanti
istituzionali che hanno responsabilità di governo della nostra Regione.
Il lavoro svolto dai quattro Club si divide in due parti.
I contributi assicurati dai singoli Circoli di Cagliari Host, Sassari Host, Tempio e
La Maddalena - Caprera sono andati a comporre la prima parte (primo volume) dal
titolo “Sardegna tra insularità e spopolamento: il punto di vista dei LIONS”.
Il successivo dibattito e gli approfondimenti promossi grazie ai contributi dei Club
LIONS hanno portato all’elaborazione della seconda parte (secondo volume) dal
titolo “Sardegna tra insularità e spopolamento: il punto di vista dei LIONS - Idee
e suggestioni per una Sardegna che ce la può fare”.
Il coordinamento dell’iniziativa è stato assicurato da Cagliari Host, che per la ste-
sura dei documenti finali si è avvalso della collaborazione dell’economista
Mariano Mariani.
Hanno collaborato alla stesura dei documenti i soci dei Clubs, che ringraziamo per
la disponibilità e l’entusiasmo, e gli amici economisti: Mariano Mariani, Carlo
Marcetti, Gianfranco Sabattini.
Franco Piga Piero Masia Carlo Giua Bachisio Ledda
Presidente L. C. Cagliari Host Presidente L. C. Sassari Host Presidente L. C. Tempio Presidente L. C.
La Maddalena-Caprera
10Premessa
I quattro Clubs Lions della Sardegna: Sassari Host, Tempio, La Maddalena-
Caprera, Cagliari Host, aderendo ad una proposta del Club Cagliari Host, hanno
stabilito di celebrare la felice ricorrenza dei sessant’anni di attività, dando vita ad
un service di grande rilievo per le rispettive comunità, e per la Sardegna tutta, sui
temi tra loro collegati dell’insularità e dello spopolamento.
Il principio costituzionale di insularità, come segnalato in precedenza, dovrebbe
costituire un’ulteriore specificazione della nostra specialità autonomistica. La
ragione che indusse i padri costituenti all’approvazione dello Statuto sardo risiede-
va nella consapevolezza che, per colmare il divario tra la Sardegna e il resto
d’Italia, fosse necessario disporre di strumenti normativi che riconoscessero più
ampi margini di autonomia.
Per comprendere a fondo le implicazione dell’insularità sull’evoluzione della
società sarda e sul fenomeno dello spopolamento, si imponeva anche una riflessio-
ne più ampia, critica, ma costruttiva, sul modello di sviluppo sperimentato in
Sardegna dal dopoguerra ad oggi.
La vera sfida unificante per la Sardegna è l’affermazione di un nuovo modello di
sviluppo. Ma quale modello?
Quale Sardegna è cresciuta nel corso degli ultimi decenni? Quali sono i settori trai-
nanti? Quali sono le sue debolezze e le aree di maggiore sofferenza? Il suo model-
lo di sviluppo è adeguato o merita di essere aggiornato soprattutto per contrastare
il fenomeno dello spopolamento delle aree interne? Tradizione e modernizzazione
possono rappresentare una sintesi felice?
A distanza di settant’anni dall’approvazione dello Statuto di autonomia, le consi-
derazioni di carattere generale relative alla condizione socio-economica della
Sardegna per certi aspetti legati al miglioramento della qualità della vita, possono
anche considerarsi positive, ma è indubbio che permangono ancora forti ritardi e
crescenti divari rispetto alle altre Regioni italiane ed europee. Fermarsi a riflettere
sul modello di sviluppo che nel corso dei decenni è maturato in Sardegna è quindi
fondamentale per poter prima di tutto fare un confronto con le economie dei Paesi
più sviluppati.
La nostra è una società fortemente terziarizzata che non può che continuare a pun-
tare sui valori della conoscenza e dell’innovazione, con la difficoltà però legata ai
settori del primario e del secondario (comparto agro-pastorale e artigianale-indu-
striale) che vivono una fase di sofferenza cronica. Il dato relativo all’emigrazione
(forse più esterna che interna), specie quella giovanile, in continua crescita è il
maggiore indicatore di una crisi di sistema.
È in questo contesto che si è inserita la riflessione promossa dai Clubs LIONS sul
valore dell’inserimento in Costituzione del principio di insularità che non può esse-
re considerato, a mo’ di bacchetta magica, la soluzione alle contraddizioni di uno
sviluppo economico che, ovunque, si caratterizza per forti e improvvise accelera-
zioni.
Alla luce di queste considerazioni i vantaggi che potranno discendere dal ricono-
scimento del principio di insularità acquisteranno forza e credibilità alla luce di una
considerazione di fondo: la comunicazione è la cifra delle società e delle economie
11post-moderne. Tutto ciò che potenzia e rafforza la comunicazione (dalle politiche della mobilità, ai collegamenti e alle relazioni) rende forti e stabili i tessuti econo- mico-sociali. Per queste ragioni un dibattito incentrato solo su argomenti tecnico- giuridici ci avrebbe portato su un percorso per specialisti, lontano da un ampio ed ambizioso processo di comunicazione e sensibilizzazione nei riguardi del grande pubblico. Per questo motivo l’attività dei LIONS attraverso l’analisi del problema concreto dell’insularità e dello spopolamento, soprattutto con riferimento alla situazione dei centri minori della Sardegna, si è indirizzata a proporre la ricerca di contributi orientati alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo che sia partecipato, con- diviso e che, soprattutto, sappia creare nuove opportunità per i nostri giovani, colo- ro che dovrebbero essere il vero e principale obiettivo del riconoscimento dello svantaggio costituito dal fattore geografico. Entro questo quadro, con il dibattito che si è sviluppato all’interno dei Club, si è voluto approfondire il tema dell’insularità in termini multidisciplinari con attenzio- ne particolare alle variabili economiche e sociali ed alle criticità/opportunità per i territori più deboli e per il sistema produttivo. Ogni Club ha fornito un proprio originale contributo. Cagliari Host in particolare ha approfondito le ragioni della crisi che ancora morde la nostra Sardegna in larga parte riconducibili al modello di sviluppo già sperimen- tato. Nel contempo si è riflettuto su quali siano oggi i principali fenomeni che stan- no caratterizzando la società globale. Notevoli cambiamenti stanno caratterizzan- do la nostra società e gli stessi hanno dirette conseguenze per la nostra Regione, con particolare riferimento: ai rapporti tra Paesi ricchi e poveri; alle previsioni sulla crescita della popolazione mondiale; alle implicazioni di tale crescita demografica soprattutto sull’ambiente, sul controllo dell’alimentazione e delle principali risor- se come acqua ed energia; ai cambiamenti climatici ed alle conseguenze degli stes- si sulla salute del nostro pianeta; al ruolo sempre più rilevante delle tecnologie digitali sulla nostra vita quotidiana. Grazie al contributo di esperti questi temi sono stati sviluppati nel corso di una conferenza dove sono state poste anche le basi per un ragionamento complessivo, a tutto tondo, su un possibile nuovo modello di svi- luppo della Sardegna. Grazie al contributo offerto dai soci del Lions Club Sassari Host, sono stati appro- fonditi i legami tra principio di insularità e Statuto autonomistico per evidenziare, da un lato, i limiti e le criticità della condizione attuale e, dall’altro lato, per pro- porre, partendo dall’insularità, una più ampia riforma costituzionale dello Stato ita- liano e della Regione. Grazie al contributo dei soci del Lions Club Tempio e degli esperti coinvolti si è indagato sulle dinamiche degli spostamenti della popolazione e i principali vinco- li all’attività d’impresa per effetto dell’insularità con particolare riferimento ai maggiori costi dell’energia e dei trasporti. Grazie ai temi sviluppati rispettivamente dal Lions Club La Maddalena - Caprera, una particolare attenzione è stata invece riservata alla situazione dello spopolamen- to delle aree interne e a chi vive, nelle nostre Isole minori, una doppia condizione di insularità e per questo una situazione ancora più delicata e preoccupate per lo spopolamento. 12
Il lavoro svolto dai soci del Lions Club La Maddalena - Caprera ha affrontato in
particolare gli aspetti della doppia insularità che caratterizza la situazione delle
isole di La Maddalena e Caprera, territori di bellezza straordinaria, ma non immu-
ni dal fenomeno dello spopolamento che, anche in queste realtà, in gran silenzio,
si sta sviluppando progressivamente e che, ancora di più che in altri contesti,
rischia di diventare uno dei drammi più laceranti della società contemporanea.
L’auspicio è che su tutti questi temi, l’azione dei Lions ottenga il risultato di una
forte sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni alle quali spetta
trovare soluzioni utili.
1. Contributo Cagliari Host
Questo contributo riflette in primo luogo sulle ragioni della crisi che ancora morde
la nostra Sardegna nel convincimento che dalla comprensione dei nostri errori del
passato dobbiamo partire per non commetterne di nuovi e per fare tesoro dei pre-
ziosi insegnamenti che a quegli errori sono legati.
Segue un approfondimento sullo scenario globale per comprendere i notevoli cam-
biamenti che stanno caratterizzando la nostra società e che hanno dirette conse-
guenze per la nostra Regione, con particolare riferimento: ai rapporti tra Paesi ric-
chi e poveri; alle previsioni sulla crescita della popolazione mondiale; alle impli-
cazioni di tale crescita demografica soprattutto sull’ambiente, sul controllo dell’ali-
mentazione e delle principali risorse come acqua ed energia; ai cambiamenti cli-
matici ed alle conseguenze degli stessi sulla salute del nostro pianeta; al ruolo sem-
pre più rilevante delle tecnologie digitali sulla nostra vita quotidiana ed ai rischi di
una “dittatura” occulta da parte di chi detiene il controllo delle informazioni e di
quantità enormi di dati anche sulle nostre singole vite.
Solo a partire dai nostri errori e dalle conseguenze delle più recenti dinamiche che
caratterizzano la società globale, è possibile affrontare il tema più importante, quel-
lo della sfida, della nuova visione strategica per costruire un nuovo modello di svi-
luppo della Sardegna.
1.1 Le ragioni della crisi della Sardegna
Troppo complessa e troppo tecnica sarebbe l’analisi da fare per capire le ragioni
storiche, di tipo istituzionale, politico, economico e sociale, che hanno portato la
Sardegna dal dopoguerra ad oggi, dopo oramai 70 anni di Autonomia speciale, a
doversi ancora interrogare sul perché non si sia raggiunta un’accettabile e diffusa
condizione di benessere economico e sociale e, soprattutto, sul perché siano rima-
sti irrisolti i principali nodi, di tipo infrastrutturale e trasportistico, tipici di
un’Isola, che continuano a penalizzare fortemente la vita delle imprese, dei lavora-
tori, degli studenti e di tutti i cittadini della Sardegna.
Tuttavia, le determinati principali di questo stato di cose sono ormai ben note,
soprattutto fra gli addetti ai lavori, anche se non ancora adeguatamente divulgate
e, per questo, non ancora di dominio pubblico.
A voler sgombrare il campo da equivoci, va detto fin da subito che l’insularità non
è una condanna. Non è una condizione solo negativa che porta con sé svantaggi per
chi la vive. Un’isola è un insieme variegato di componenti positivi e negativi che,
a seconda di come vengono combinati e gestiti, possono generare situazioni di svi-
13luppo e benessere ovvero di sottosviluppo e di povertà. Già nel 1985, uno straordinario libro, che non ha avuto tutto il successo che avreb- be meritato (forse anche a causa del fatto che è stato scritto in Sardegna da studio- si sardi, della Facoltà di Economia dell’Università di Cagliari) spiega il perché la Sardegna non sia riuscita a compiere il passaggio dal sottosviluppo allo sviluppo.1 Quei concetti chiave dell’economia, usati per spiegare le ragioni della crisi della Sardegna, sono oggi del tutto attuali e risultano ancora fondamentali per capire che cosa sia realmente successo in Sardegna a partire dal dopoguerra, fino ad oggi. Purtroppo, per la complessità del linguaggio tecnico utilizzato, sono rimasti ai più, al cittadino comune, del tutto incomprensibili e, ancora peggio, sono rimasti total- mente inascoltati dalle classi dirigenti della nostra Isola che, di volta in volta, si sono succedute al governo della Regione. Innanzitutto quel libro ci consegna un fondamentale lascito metodologico, impre- scindibile anche per le finalità che questo lavoro vuole conseguire. Esiste un fon- damentale collegamento tra la scienza e la tecnica, da un lato, e la politica, dall’al- tro. Se le scelte di natura politica non sono sorrette da un’adeguata analisi scienti- fica e dai possibili obiettivi tecnici alternativi, tali scelte si traducono in interventi casuali e questo ha anche come sgradita conseguenza il fatto che non si potranno appurare correttamente le responsabilità di chi le ha fatte, né mai si potranno scar- tare le idee e le esperienze sbagliate, non essendo state chiaramente esplicitate. È quindi fondamentale, sul piano scientifico, avere sempre presente un modello sta- bile di riferimento in base al quale misurare l’efficacia degli interventi realizzati. Oltre a questo importante lascito metodologico, il libro di Bolacchi, Sabattini e Usai espone, entro una prospettiva organica, le più importanti relazioni funzionali di un modello esplicativo del passaggio dal sottosviluppo allo sviluppo e le verifi- cano sul “caso Sardegna” che rappresentava allora (ma è così ancora oggi) un tipi- co esempio di area economica sottosviluppata che tenta di realizzare il salto verso lo sviluppo. Per il rigore dell’analisi, tuttavia, quelle verifiche accreditano la vali- dità del modello come esplicativo di tutte le possibili situazioni di sottosviluppo e di attuazione dello sviluppo, ponendosi, pertanto, come modello scientifico gene- rale valido per qualsiasi contesto territoriale. 1.2 Industrializzazione senza sviluppo Con un linguaggio più semplice, e con finalità divulgative, proviamo a riprendere i concetti principali di quel modello per spiegare quali siano i fondamenti della crisi sarda. Alla fine degli anni cinquanta, e nei primi anni sessanta, la Sardegna, grazie all’art. 13 del proprio Statuto di Autonomia speciale, negoziò e ottenne dallo Stato di poter attuare il suo primo “Piano di Rinascita”. Fu una conquista importante, ma com- pletamente sbagliata nella sua impostazione. In attuazione di quel primo ed anche, successivamente negli anni settanta, del secondo “Piano di Rinascita”, la Sardegna fu interessata da un rilevante processo di industrializzazione pesante basato sui cosiddetti “poli di sviluppo” che, disloca- 1 Giulio Bolacchi, Gianfranco Sabattini, Tullio Usai (1985), “Oligopolio e crescita economica. Il pas- saggio dal sottosviluppo allo sviluppo in Sardegna”, Franco Angeli, Milano. 14
ti al Nord, al Centro ed al Sud dell’Isola, avrebbero dovuto fungere da traino dello
sviluppo, creando ricchezza e occupazione per i sardi. Furono così creati nel Nord
Sardegna, nell’area industriale di Porto Torres, i grandi impianti della chimica di
base, mentre al Sud, oltre alla petrolchimica di Sarroch ed alla chimica di base di
Assemini, nel Sulcis, furono mantenute le produzioni minerarie ed avviate le pro-
duzioni metallurgiche (alluminio, piombo e zinco) fortemente energivore ed inqui-
nanti. Di quell’inquinamento paghiamo ancora oggi le conseguenze con oltre
400.000 ettari del territorio regionale completamente interdetti e sottratti a qualun-
que progetto di riuso perché non ancora bonificati.
Perché non ha funzionato quel modello?
La tipologia delle industrie scelte, quali poli che avrebbero dovuto trainare lo svi-
luppo, fu decisiva per le future sorti negative del modello. Questa è la prima fonda-
mentale riflessione: il tipo di industria scelta con i piani di Rinascita non poteva,
“per definizione”, innescare processi di sviluppo perché non in grado di far nasce-
re, a valle del polo, un tessuto diffuso e articolato di nuove imprese che avrebbero
potuto produrre ricchezza e occupazione all’interno del territorio regionale.
Questo “non essere in grado, per definizione”, viene spiegato in modo scientifico
nel libro di Bolacchi, Sabattini e Usai. Proviamo qui invece a spiegarlo con un
semplice esempio.
Come detto, ci sono diverse tipologie di industrie, e questa differenza, fa proprio
la differenza in termini di capacità di innescare o meno processi di sviluppo endo-
geno (ovvero processi capaci di creare reddito e occupazione all’interno del terri-
torio che intende promuovere lo sviluppo).
Se in Sardegna anziché la chimica di base, o la petrochimica, o la metallurgia, fosse
stata promossa la creazione, per esempio, di una industria automobilistica, le cose
sarebbero andate molto diversamente. Chi produce automobili, infatti, sta al verti-
ce superiore della cosiddetta catena del valore, ovvero si situa nella parte termina-
le (ultimo tassello produttivo prima del mercato dei consumatori) del continuum
dei molteplici processi produttivi, interdipendenti tra loro, che concorrono alla rea-
lizzazione di un automobile. Completati quei processi, il prodotto ultimo, l’auto-
mobile, viene collocata nel mercato dei consumatori finali. Quella della produzio-
ne delle automobili è, quindi, un tipo di industria che si colloca nel punto “più vici-
no” al mercato. Questo fatto ha delle potenti implicazioni sul sistema produttivo
locale che sostiene le diverse produzioni legate al prodotto finale automobile.
L’industria automobilistica, infatti, non produce al proprio interno tutto ciò che le
serve per realizzare un auto. Una parte di questi beni li importa da altri territori ed
una grande parte li acquista da altre imprese che, nel frattempo, proprio grazie alla
presenza di quell’industria, sono nate e si sono consolidate a livello locale. In altre
parole, la presenza di un’industria di automobili, è in grado di generare, a livello
locale, un fitto tessuto di relazioni produttive (verticalizzazioni) con altre imprese
che diventano fornitrici di beni e servizi strumentali alla produzione dell’automo-
bile: dai servizi di progettazione ingegneristica, a quelli commerciali e di marke-
ting, ma soprattutto, alle principali componenti meccaniche e motoristiche, ai tes-
suti degli interni, alle plastiche dei cruscotti, ai cristalli dei parabrezza, ai cuscinet-
ti, agli ammortizzatori, ai pneumatici, per fare solo i principali esempi.
Da questa fitta rete di relazioni di interdipendenza, nascono nel tempo, anche per
15la diffusione generalizzata di una cultura d’impresa e di comportamenti imprendi- toriali e manageriali, di competenze e professionalità, ulteriori occasioni di impre- sa che nascono e si distribuiscono in modo articolato nel territorio dove opera il “polo trainante”, andando a colmare ulteriori segmenti del mercato di un numero crescente di beni e servizi richiesti da altre imprese e dai consumatori. Già da questo semplice esempio si possono capire le differenze fra tipi di industrie. Quella automobilistica, come altre industrie che si collocano al vertice superiore della catena del valore, “vicino” al mercato, ha la capacità di generare molteplici effetti diffusivi su altre industrie, anche di altri settori, svolgendo appieno proprio quel ruolo di polo in grado di “trainare” altre imprese ad esso collegate e generare sviluppo endogeno. È quello che tecnicamente viene definito un processo di gene- razione di verticalizzazioni produttive “all’indietro” (backward linkages), la gran parte delle quali si insediano nel medesimo contesto produttivo territoriale del polo industriale che le ha generate. Dal punto di vista dello sviluppo, questi effetti sono centrali e decisivi in quanto, è solo la capacità di generare questi effetti diffusivi “all’indietro”, che può connota- re un processo come virtuoso. È solo la nascita di un sistema articolato di nuove imprese legate da relazioni di interdipendenza (verticalizzazioni) con il polo trai- nante che sancisce il successo del modello, in quanto quel sistema di nuove impre- se sarà in grado di produrre redditi d’impresa a livello locale, di pagare salari e sti- pendi ai propri lavoratori, di creare nuova occupazione, e di alimentare il proces- so, in via continuativa, con l’innovazione e nuovi investimenti. Quella della Sardegna, è stata invece un’altra storia, proprio a causa del tipo di industria che fu scelto di porre al centro del modello di sviluppo. Partendo dal convincimento, diffuso fra i principali economisti dello sviluppo delle aree sottosviluppate del periodo, che solo un intervento esterno avrebbe potuto innescare meccanismi virtuosi per rompere gli “equilibri di povertà” che caratte- rizzavano il tessuto produttivo e sociale delle aree arretrate come la Sardegna, fu avviato un processo di industrializzazione forzata, coordinato da un gruppo di lavoro istituito presso il Centro di programmazione regionale, basato sull’industria di base, ignorando totalmente quanto la natura di quel tipo di industria avrebbe pesantemente influito sulle conseguenze di quella scelta. “L’industrializzazione forte”, perseguita attraverso la scelta di promuovere gli insediamenti delle attività della chimica di base, della metallurgia e della petrolchi- mica - attività labour-intensive, ovvero che necessitavano di un alto numero di lavoratori per unità di capitale investito - assorbì completamente, anche per ragio- ni “ideologiche”, l’attenzione sia delle forze sociali (sindacali e imprenditoriali) e politiche, che dell’opinione pubblica. Non che al tempo non esistesse una valida alternativa; infatti, fra la fine degli anni cinquanta e la prima metà degli anni settanta, la Sardegna aveva visto alcuni setto- ri produttivi “leggeri”, come l’agro-alimentare ed il turismo, cominciare a svolge- re un ruolo importante nella produzione di ricchezza endogena e nel garantire opportunità di tipo occupazionale. Ma questo fu ignorato. L’installazione di grandi stabilimenti industriali nei settori minerario-metallurgico, chimico e petrolchimico non ebbe gli effetti sperati proprio per la tipologia di quei grandi impianti. Si tratta infatti di comparti produttivi che, a differenza dell’esem- 16
pio del settore automobilistico, sopra citato, si trovano all’inizio della catena del
valore e “molto distanti” dal mercato, con la conseguenza che non potevano gene-
rare effetti diffusivi “all’indietro” verso altre imprese interdipendenti dalle quali
approvvigionarsi. Come successo in Sardegna per la chimica di base e per la
petrolchimica, l’unico approvvigionamento, che si realizzava, ma al di fuori del
territorio regionale, era quello della principale materia prima utilizzata, il petrolio,
necessaria per la produzione dei composti chimici (come ad esempio benzene,
fenolo e propilene) che, quasi sempre, venivano poi esportati al di fuori del terri-
torio regionale per essere utilizzati da altri impianti di produzione della chimica
secondaria e dalla chimica fine come beni intermedi per le ulteriori trasformazioni
in prodotti finiti per il mercato a base di gomme, materie plastiche, tecnofibre.
Nessun ruolo trainante per l’industria di base, dunque, ma solo effetti di tipo eso-
geno attraverso l’attivazione di “verticalizzazioni in avanti” (forward linkage) ed
al di fuori del territorio della Sardegna. I pochi effetti indotti in Sardegna sono stati
soltanto quelli legati al comparto delle manutenzioni degli impianti industriali, con
la nascita di qualche nuova imprese metalmeccanica.
Quello che si verificò fu un processo di industrializzazione senza sviluppo.
Un’ingente canalizzazione di risorse finanziarie pubbliche fu trasferita in
Sardegna, attraverso le industrie delle partecipazioni statali, sia per la copertura
delle spese di investimento necessarie alla attivazione degli impianti dell’industria
di base, sia per pagare salari e stipendi ad una nuova classe di operai, A ciò si
aggiunsero le conseguenze sociali ed economiche dello sradicamento, dalle loro
attività tradizionali, di un numero cospicuo di agricoltori e pastori.2
Per quanto nel breve periodo l’esito di tali interventi di politica economica abbia
determinato un miglioramento del reddito disponibile di molti cittadini sardi e
delle loro condizioni di vita, nel lungo periodo quel modello ha mostrato tutti i suoi
evidenti limiti, con il risultato di non essere riuscito ad innescare alcun processo di
crescita e sviluppo endogeno, né ad eliminare o affievolire il divario economico
che continua ancora oggi a separare la Sardegna dalle aree più avanzate del resto
d’Italia e del mondo.
1.3 La “pentola bucata”
L’attuazione di quel processo d’industrializzazione forzata, come detto, determinò
profonde e radicali trasformazioni culturali e sociali della società sarda, anche per
effetto dall’abbandono dei modelli economici tradizionali e consolidati, soprattut-
to in campo agricolo e pastorale. È vero che aumentò il benessere sociale per molti
sardi, ma solo per effetto del maggior reddito disponibile (trasferito dall’esterno) e
non certo per una capacità di generare reddito effettivo all’interno del territorio
regionale.
Era un modello fortemente dipendente dai trasferimenti pubblici e non sarebbe
potuto durare a lungo. Con la crisi petrolifera quel tipo di industrializzazione della
Sardegna entrò, infatti, in crisi, perdendo impulso e avviandosi ad un declino che
è continuato senza sosta fino ai giorni nostri.
2
Gianfranco Sabattini (2006), “Capitale sociale, crescita e sviluppo della Sardegna”, Franco Angeli,
Milano.
17La principale conseguenza negativa di quel modello, adottato in Sardegna, può essere così sintetizzata: un aumento del reddito disponibile per abitante e, quale conseguenza, un aumento della domanda di beni consumo; non essendo quei beni di consumo prodotti in Sardegna, si verificò un consistente incremento delle importazioni, più che proporzionale all’aumento del reddito pro-capite, a vantag- gio di altre Regioni italiane, soprattutto settentrionali, e di altri Paesi produttori. Si determinò quella che è poi diventata una costante del sistema produttivo della Sardegna, ovvero lo squilibrio della bilancia commerciale per una quota rilevante di beni intermedi e di consumo a favore di attività produttive esterne alla Sardegna. Lo squilibrio riguardò, e riguarda tuttora, anche la bilancia agro-alimentare della Sardegna con la conseguente perdita dell’autosufficienza alimentare rispetto al fabbisogno interno dei sardi. Negli anni settanta l’economista Paolo Savona (formatosi anche lui alla “scuola” degli economisti della Facoltà di Economia dell’Università di Cagliari), per spiega- re questi squilibri e le conseguenze del mancato sviluppo della Sardegna, nonostan- te il processo della industrializzazione forzata, utilizzò la metafora della “pentola bucata”.3 Col il ricorso alla metafora della “pentola bucata” l’economista sardo chia- rì che, per quanto con i trasferimenti si continuassero ad immettere nella pentola (la Sardegna) risorse (liquido) dall’esterno, senza intervenire in alcun modo per tappare i buchi della pentola, quel liquido continuava a disperdersi al di fuori della Sardegna. È vero che aumentò il reddito disponibile, ma poi i sardi, per effetto della “pento- la bucata”, lo utilizzavano per acquistare i principali beni di prima necessità (auto, lavatrici, frigoriferi, mobili, etc.) al di fuori della Sardegna, a tutto vantaggio dei territori dove le imprese produttrici di quei beni di consumo erano ubicate. In conclusione, quindi, le attività dell’industria di base ad alto rapporto capitale/lavoro, contribuirono ad elevare solo il reddito disponibile, ma non anche il reddito prodotto e progressivamente, si trasformarono, con la crisi petrolifera e al venir meno dei trasferimenti esterni, nelle famose “cattedrali nel deserto”. Il risultato finale è stato quello di avere promosso una crescita ed uno sviluppo fit- tizi, perché le forme d’investimento assunte dai trasferimenti a sostegno di quel modello, non solo risultarono estranee alla cultura e alle tradizioni della Sardegna, ma come detto non erano in grado di generare alcuna verticalizzazione produttiva all’interno del territorio regionale. La loro natura intrinseca ad orientamento eso- geno, all’inizio della catena del valore e “troppo lontano” dal mercato dei consu- matori, non avrebbe potuto, in alcun modo e per definizione, sviluppare, a valle, un nuovo tessuto di piccole e medie imprese locali, diffondere cultura imprendito- riale e capacità tecnica, tecnologica, commerciale, finanziaria e manageriale. 1.4 Cosa succede nel “Villaggio globale” La globalizzazione sta portando con se, una serie di fenomeni del tutto nuovi e di grande rilevanza per il nostro Pianeta, ma anche rischi ed opportunità da compren- dere e valutare con attenzione per la costruzione del nuovo modello di sviluppo della Sardegna. 3 Paolo Savona (1970), “Una interpretazione finanziaria delle risorse reali per lo sviluppo regionale”, La programmazione in Sardegna, No. 28/29. 18
Un primo importante fenomeno, frutto delle dinamiche della globalizzazione, è
legato all’esodo ed alla progressiva concentrazione della popolazione mondiale in
vaste aree urbane. La conseguenza più evidente di queste dinamiche è la deterrito-
rializzazione delle popolazioni dai luoghi di nascita, con effetti catastrofici che non
sono affatto dissimili da quelli che determinano i processi di spopolamento delle
aree interne anche nella nostra Isola.
A questo fenomeno contribuiscono anche i cambiamenti climatici che metteranno
sempre più a dura prova gli equilibri dei processi ambientali e degli habitat, ovve-
ro degli ecosistemi naturali quali foreste, praterie, deserti, sistemi montani e costie-
ri, fiumi e laghi, oceani e altri mari.
Ma un ulteriore fenomeno che accompagna la globalizzazione, sta cambiando gli
stili di vita dell’intero Pianeta: la rivoluzione digitale.
Se, da un lato, sono evidenti i vantaggi di questo storico processo innovativo, in
termini di maggiore benessere, opportunità e qualità della vita, dall’altro lato, vi
sono anche notevoli rischi insiti in questo fenomeno globale. Il controllo delle
informazioni e la gestione centralizzata, attraverso gli sviluppi dell’intelligenza
artificiale, di enormi quantità di dati (big data e blockchain), potrebbero consenti-
re a pochi uomini di detenere un potere travolgente su tutti gli altri. Ecco perché
della rivoluzione digitale dobbiamo comprendere tutte le strutture, le dinamiche e
le opportunità, ma anche prepararci a contrastarne rischi ed effetti indesiderati.
1.5 I rischi della deterritorializzazione
Una data importante segna la storia dell’umanità a livello globale. Nell’anno 2008,
infatti, per la prima volta nella storia, la popolazione urbana ha superato globalmen-
te quella rurale (si consideri che alla fine dell’ottocento, in Italia più dell’80% della
popolazione viveva in ambienti rurali). È questo un evento che con l’avvento della
globalizzazione sta assumendo una dimensione incontrollata e preoccupante.
La globalizzazione sta portando con se, infatti, l’esodo e la progressiva concentra-
zione della popolazione mondiale in vaste aree urbane. Un flusso crescente di
milioni di agricoltori viene sradicato dalle loro comunità rurali di origine e percor-
re una via senza ritorno verso i sobborghi (slums) delle periferie urbane delle
megalopoli; lungo la strada, la distruzione delle comunità locali, della loro produt-
tività sociale, culturale e materiale, dei loro sistemi di produzione consolidati.
Oggi la popolazione mondiale ammonta a circa 7,5 miliardi di persone. La popo-
lazione urbana è attualmente in crescita costante: ogni anno aumenta di circa 60
milioni di persone. Nelle previsioni dell’ONU, al 2050 saranno 6,4 miliardi gli
inurbati (71%) su 9 miliardi di popolazione mondiale complessiva.
Già oggi, circa un terzo della popolazione urbana mondiale (1,4 miliardi di perso-
ne) vive nei sobborghi (slums), e in Africa questa percentuale sale al 60%, dove si
concentrano povertà, emarginazione e discriminazione. Più del 10% della popola-
zione urbana mondiale (circa 500 milioni di persone) vive attualmente in megalo-
poli, città con oltre 10 milioni di abitanti che si sono moltiplicate in tutto il piane-
ta: a New York e Tokyo, che rientravano in questa lista già dagli anni Cinquanta,
si sono aggiunte altre 19 megalopoli, tutte (tranne 3) ubicate in Asia, America lati-
na e Africa. Tuttavia, la quota maggiore dell’incremento umano in ambiente urba-
no si sta verificando non nelle megalopoli, ma in città più piccole: è qui infatti che
19vive la maggioranza dei bambini e dei giovani urbanizzati. Le popolazioni dell’Europa occidentale e degli USA sono già quasi completamente urbane. La spropositata crescita dimensionale dell’urbanizzazione che, come detto, nelle previsioni dell’ONU al 2050 vede 6 miliardi e 400 milioni di inurbati su 9 miliar- di di popolazione mondiale complessiva, una volta recise le radici territoriali ori- ginarie, ci mostra un quadro desolante di un’umanità priva di identità, degradata, impoverita, affamata. Ma chi e come si occuperà di alimentare queste moltitudini urbane? La FAO pre- vede per il 2050 la necessità di incrementare la produzione alimentare del 70% a livello mondiale. Non è un caso, quindi, se fra il 2007 e il 2008, l’indice dei prez- zi del cibo della FAO sia cresciuto di oltre il 70%, mentre il prezzo del grano sia aumentato dell’80% e quello del mais del 90%. Le rivolte sociali contro l’impen- nata del prezzo degli alimenti hanno attraversato il nord-Africa, l’Asia e il medio Oriente e hanno messo a serio repentaglio la stabilità socio-politica di quei Paesi, creando destabilizzazione e preoccupazione crescente. A ciò si aggiunga la forte diseguaglianza fra ricchi e poveri: l’1% più ricco della popolazione mondiale continua a detenere il 99% della ricchezza mondiale. Più della metà della popolazione mondiale vive con un reddito di povertà che oscilla tra i 2 e i 10 dollari al giorno. Nel 2017, le 42 persone più ricche del mondo pos- sedevano la ricchezza netta equivalente di 3,7 miliardi di persone. Le persone al mondo che vivono in condizioni di povertà estrema (potendo contare al massimo su 1,9 dollari/giorno) sono pari all’11% della popolazione mondiale, si tratta di circa 785 milioni di persone che si concentrano in Africa e Asia meridionale. Questi mega-trends evidenziano in modo impietoso il crescente degrado sociale e ambientale che accompagna questi fenomeni e che non riguarda solo le periferie di destinazione del mega-esodo. Quello che gli esperti evidenziano, in particolare Alberto Magnaghi e che “il flus- so crescente di milioni di agricoltori che percorre la via senza ritorno dalle comu- nità agricole verso le periferie di megacity, avviene con processi di distruzione delle comunità locali nei territori di provenienza e di sradicamento territoriale dei sistemi di produzione dei piccoli agricoltori; la distruzione del presidio delle comunità locali nelle aree agro-forestali, apre la strada a un processo di monetiz- zazione, mercificazione e compravendita dei beni naturali, degli ecosistemi e dei servizi ecosistemici; la distruzione del capitale naturale, la desertificazione, la deforestazione (per biomasse e monoculture commerciali). Si compie cosi un per- corso verso una mutazione antropologica che vede da una parte la condizione urbana come destino dell’ambiente di vita dell’umanità sul pianeta; dall’altra spazi aperti inospitali per la vita dell’uomo, di nuova wilderness da abbandono e inselvatichimento, di desertificazione, con incursioni ‘fuori porta’ di grandi appa- rati tecno-finanziari per lo sfruttamento della natura residua. È questa la terra promessa?” Riportando questi “mega-trends” della globalizzazione al nostro contesto regiona- le e locale è evidente che vi siano forti e preoccupanti collegamenti ed analogie. Per effetto del modello sperimentato in passato e per le logiche attuali della globa- lizzazione, si vanno affermando modelli di comportamento economico e sociale, anche in Sardegna, che stanno completamente recidendo il legame delle persone 20
dai loro territori di origine. Lo spopolamento delle aree interne, ne è la più plasti-
ca rappresentazione e le cause possono essere ricercate proprio nel venire meno del
legame dell’uomo con il proprio territorio.
Sia a livello globale, che a livello locale quel che occorre è una totale inversione di
rotta. Si impongono interventi consistenti e risorse per la progressiva ricostruzione
delle relazioni fondanti fra l’uomo e la terra. Riconnettere uomo e territorio per
riallacciare i fili spezzati dalla globalizzazione può essere, a pieno titolo, l’obietti-
vo strategico più astratto da perseguire con il nuovo modello di sviluppo della
nostra Isola.
Per conseguire questo obiettivo è però necessaria una crescita di consapevolezza
delle comunità locali dei nostri tanti paesi, quelli delle aree interne in particolare,
attraverso processi partecipativi di valorizzazione dei beni comuni patrimoniali
(ambientali, insediativi, paesaggistici, socio-culturali). L’identità e gli stili di vita
di ogni territorio della Sardegna devono essere riportati al centro del nuovo model-
lo di sviluppo per la produzione di ricchezza durevole, condivisa e sostenibile. Una
vera e propria presa di coscienza da parte delle comunità locali: la coscienza della
centralità e del protagonismo dei luoghi, quale fulcro del nuovo modello di svilup-
po.
Un progetto complesso che impone chiare scelte politiche e investimenti pubblici
consistenti, come se dovessimo lanciare un nuovo new deal: un piano articolato,
che muove “dal basso”, di partecipazione e auto-investimenti da parte dei sistemi
socio-economici locali a partire dalle loro grandi e inesplorate energie latenti.
I timidi tentativi in questa direzione avviati in Sardegna a partire dai piani integra-
ti d’area (PIA), dai progetti integrati territoriali (PIT), oggi confluiti nel processo
in atto della programmazione territoriale, sono “pannicelli caldi” rispetto alle esi-
genze sopra richiamate in quanto ancora lontani dall’aver innescato processi di
consapevolezza a livello locale, viziati da troppo centralismo regionale, privi di un
modello di riferimento e, pertanto, ancora fortemente caratterizzati da logiche di
distribuzione “a pioggia” delle risorse.
1.6 I rischi dei cambiamenti climatici
Nei prossimi decenni, purtroppo, si intensificheranno gli effetti dei cambiamenti
climatici che interesseranno tutte le regioni del mondo e di cui non si può non tene-
re conto anche in Sardegna.
Una delle principali conseguenze del cambiamento climatico è un impatto sul ciclo
dell’acqua e quindi sulla disponibilità delle risorse idriche. L’aumento della tempe-
ratura ed il riscaldamento globale potrebbero provocare allo stesso tempo lo scio-
glimento delle calotte polari e dei ghiacciai, facendo crescere il livello dei mari. In
alcune regioni i fenomeni meteorologici estremi e le precipitazioni sono già oggi
sempre più diffusi, mentre altre sono colpite da siccità e ondate di calore senza pre-
cedenti.
Se le attuali tendenze dovessero perdurare, assisteremo ad una maggiore disponi-
bilità di acqua nelle zone dove le risorse idriche sono già abbondanti, ad esempio
nell’emisfero Nord, e ad una minore disponibilità di acqua nelle aree già affette
dalla scarsità di risorse idriche, ad esempio in Africa e Asia.
Le variazioni delle precipitazione porteranno a un deterioramento della qualità del
21Puoi anche leggere