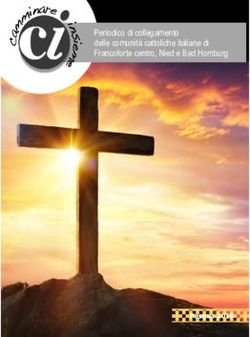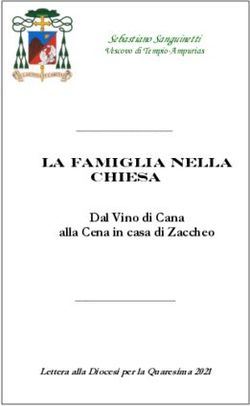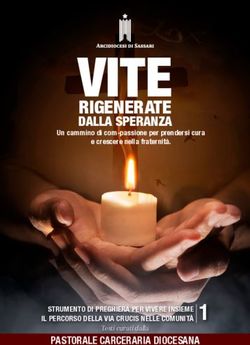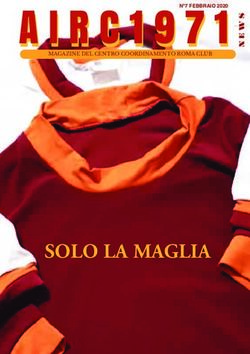Vaticano, 23 luglio 2018 - Presentazione della "Positio super virtutibus" del Servo di Dio Ignazio Stuchlý
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Vaticano, 23 luglio 2018 – Presentazione della “Positio super virtutibus” del Servo di Dio Ignazio Stuchlý (AgenziaNotizieSalesiane – Città del Vaticano) – Il 20 luglio nel corso della visita che il Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández Artime, accompagnato da don Pierluigi Cameroni, Postulatore Generale, e della Dott.ssa Lodovica Maria Zanet, collaboratrice della Postulazione, ha fatto al Cardinale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, è stato presentato il volume della Positio super Vita, Virtutibus et Fama Sanctitatis del Servo di Dio Ignazio Stuchlý, Sacerdote Professo della Società di San Francesco di Sales. La Positio ha avuto come relatore padre Zdzisław Kijas, OFM Conv., come Postulatore don Pierluigi Cameroni e come Collaboratori la dott.ssa Lodovica Maria Zanet, Don Jan Ihnát, SDB e don Petr Zelinka, SDB. Elementi strutturali della “Positio” – che presenta in modo articolato ed approfondito tutto l’apparato probatorio documentale e testificale riguardante la vita virtuosa del Servo di Dio – sono: una breve presentazione da parte del Relatore; l’Informatio super virtutibus, ossia la parte teologica nella quale viene dimostrata la vita virtuosa del Servo di Dio; i due Summarium con le prove testificali e documentali; la Biographia ex Documentis. Dopo la consegna, la Positio sarà anzitutto esaminata dai Consultori storici della Congregazione delle Cause dei Santi. Il Servo di Dio don Ignazio Stuchlý nasce a Bolesław, nell’ex Slesia prussiana, il 14 dicembre 1869, in una numerosa famiglia di contadini. Giovane uomo tenace nell’impegno e
fermo nella speranza, viene accettato tra i Salesiani nel 1894. Arriva a Torino l’8 settembre, e vive le tappe di formazione a Valsalice e Ivrea: si forma a contatto con i grandi Salesiani della prima generazione. Inizialmente destinato alle missioni, per ordine di don Rua il Servo di Dio resta in Italia, e si prepara a supportare la crescita delle opere salesiane nelle aree slave. È allora a Gorizia (1897-1910); quindi in Slovenia, tra Ljubljana e Verzej, fino al 1924; poi, dal 1925 al 1927, è a Perosa Argentina, dove forma le nuove leve per innestare la Congregazione salesiana “al Nord”. Nel 1927 ritorna in patria, a Fryšták, e anche lì ricopre incarichi di governo, compreso l’ispettorato, dal 1935. Dopo le conseguenze a più ampio raggio della Guerra Balcanica e la Prima Guerra Mondiale, affronta sia la Seconda Guerra Mondiale sia il dilagare del totalitarismo comunista: in entrambi i casi, le opere salesiane vengono requisite, i confratelli arruolati o dispersi, ed egli vede d’un tratto distrutta l’opera cui aveva consacrato la vita. Quaranta giorni prima della fatidica “Notte dei barbari”, nel marzo 1950, è colpito da apoplessia: la vivissima stima che egli sempre aveva suscitato nei superiori, e la sua grande capacità di amare e farsi amare, fioriscono allora più che mai in fama di santità. Si spegne serenamente nella sera del 17 gennaio 1953. Economo, prefetto, vice-direttore, direttore, ispettore, il Servo di Dio aveva ricoperto, per ampia parte della vita, ruoli di responsabilità. Un po’ come il beato don Rua, da lui preso ad esempio, era considerato “regola vivente”, testimone efficace dello spirito di don Bosco e capace di trasmetterlo alle generazioni successive. Uomo che ha vissuto in molte e diverse realtà geografiche, linguistiche e culturali (come le odierne Moravia, Boemia, Slovacchia, Polonia, Slovenia, Italia), anche in terre di confine, il Servo di Dio si propone oggi come uomo di pace, unità e riconciliazione tra i popoli.
Fonte: http://www.infoans.org/index.php?option=com_k2&view=ite m&id=5969:vaticano-presentazione-della-positio-super- virtutibus-del-servo-di-dio-ignazio- stuchly&Itemid=1680&lang=itSONS Anna Kolesarova e Teresa Bracco, due beate ispirate dalla santità di Domenico Savio (AgenziaNotizieSalesiane – Roma) – Anna Kolesarova è stata beatificata sabato 1° settembre in Slovacchia, nello stadio Lokomotíva di Košice, dal cardinal Giovanni Angelo Becciu, neo prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, in rappresentanza del Santo Padre. Teresa Bracco fu beatificata vent’anni fa da Giovanni Paolo II. Queste due donne hanno in comune, oltre la giovanissima età in cui sono morte, la devozione verso san Domenico Savio, che ispirò la loro vita. Anna, o Anka come la chiamavano i suoi cari, era nata nel villaggio di Vysoka nad Uhom, nella Slovacchia dell’Est, in una famiglia profondamente religiosa che la fece battezzare il giorno dopo la nascita. Poi, all’età di dieci anni ricevette l’Eucaristia e confermò successivamente la sua fede con la Cresima.
La sua vita procedeva tranquilla fin quando, con l’avanzata del fronte sovietico, l’armata russa occupò il suo villaggio. Durante un raid dell’Armata Rossa, il 22 novembre 1944, Anka e i suoi si nascosero, ma un soldato li scoprì e, nonostante i tentativi del padre di rabbonirlo, lui iniziò a fare avances alla giovane. Lei oppose resistenza, per difendere la sua castità. La reazione del soldato fu la più terribile: la uccise davanti ai suoi familiari. A causa della difficile situazione, i suoi parenti dovettero celebrare il rito funebre in segreto e solo dopo la caduta del regime si tornò a parlare di questa eroica ragazza, morta per difendere la sua purezza. I giovani iniziarono allora ad andare nel cimitero del villaggio e a pregare sulla sua tomba, dove è inciso il motto di Domenico Savio: “La morte, ma non i peccati”. Lo stesso motto ispirò tutta la vita di un’altra giovanissima Beata, Teresa Bracco. Nata a Santa Giulia, oggi frazione di Dego, in provincia di Savona, era cresciuta in una famiglia profondamente religiosa e fin da piccola mostrò una singolare inclinazione alla pietà. Nel 1931 ricevette la Comunione e due anni dopo la Cresima. La sua vita spirituale cresceva di giorno in giorno. Fu molto colpita da un’immagine di Domenico Savio recante il suo famoso motto “La morte, ma non peccati”, così la collocò in capo al letto e ne fece il programma della sua vita. La sua vita fu sconvolta nell’agosto del 1944, quando le truppe naziste occuparono il suo paese. Durante la fuga venne catturata da un soldato che provò ad abusare di lei. Lei lottò coraggiosamente per difendere la sua castità e questo le costò la vita. Il soldato la uccise con un colpo di pistola. Anna e Teresa hanno difeso la propria purezza a costo della vita, tenendo fede fino alla fine al motto di Domenico Savio “La morte, ma non i peccati”, che aveva ispirato tutta la loro esistenza.
Fonte: http://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/6303-rmg-an
na-kolesarova-e-teresa-bracco-due-beate-ispirate-dalla-
santita-di-domenico-savio
Spunti sulle Letture di
domenica 16 settembre 2018
1. «Chi dice la gente che io sia?» Gesù non cerca una
risposta grandiosa per essere applaudito, Lui sa chi è
veramente. Ma è pronto a sorprendere i suoi discepoli.
2. «E voi chi dite che io sia?» Adesso il Signore si
rivolge agli apostoli, come a noi. Ci chiede di prendere
una posizione personale, di fare una scelta tra Lui e le
molte ipotesi, coloro che allettano ma poi deludono…
3. «Il Figlio dell’uomo doveva molto soffrire, ed essere
riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli
scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni,
risuscitare». Il cuore del messaggio cristiano. Già
dall’inizio viene incompreso e rifiutato perfino dai più
vicini.
4. «Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi
perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la
salverà». Quanti modi di fuggire o di perdere la vita
per Cristo…
5. Isaia: «Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto
confuso».
6. Salmo 116: «Il Signore protegge gli umili: ero misero ed
egli mi ha salvato».7. San Giacomo: «Così anche la fede: se non ha le opere, è
morta in se stessa».
Alessandro D’Avenia. Letti da
rifare 25. A testa alta
«Perché lo avete ucciso?», chiede il magistrato. «Perché si
portava i picciriddi (i bambini) cu iddu (con lui)», risponde
il sicario che ha sparato il colpo alla nuca. Si tratta del
Cacciatore, questo il suo soprannome a Brancaccio. Aveva
sparato a padre Pino Puglisi, 3P, come lo chiamavamo noi a
scuola, il 15 settembre 1993, 25 anni fa. Stavo per cominciare
il quarto anno e lui, uno dei professori della mia scuola, il
Liceo Vittorio Emanuele II di Palermo, non sarebbe più entrato
in classe. Capo d’accusa: far giocare e studiare, con l’aiuto
volontario dei ragazzi di cui era professore di religione,
bambini che altrimenti erano preda della strada e di chi su
quella strada comandava. Troppo poco?
3P sapeva infatti mescolare i quadrati della scacchiera di
Palermo, facendo muovere chi conosceva solo la città di luce
verso quella più tenebrosa, e viceversa. I ragazzi di un
rinomato liceo classico aprivano gli occhi su strade nuove,
perché l’inferno poteva essere girato l’angolo. A cosa serviva
la cultura che ricevevamo se restavamo ciechi su ciò che
avevamo accanto? Don Pino sapeva che per far rifiorire il
quartiere in cui era nato e cresciuto, bisognava ripartire da
bambini e ragazzi, anche se, per stare fermi e in silenzio,
gli alibi non mancavano. La sua battaglia era tanto semplice
quanto pericolosa: ridare dignità ai giovanissimi attraverso
il gioco, lo studio, la catechesi, prospettando loro una vita
diversa da quella del «picciotto mafioso». La mafia alleva ilsuo esercito tenendo la gente nella miseria culturale e assicurando il sufficiente benessere materiale, condizioni che riescono a garantire un consenso indiscusso nei contesti da cui attinge. Don Pino ne inceppava dall’interno il meccanismo, ripetendo a bambini e ragazzi di andare «a testa alta», perché la dignità non è un privilegio concesso da qualcuno, ma dono connaturato al nostro essere qui, voluti dal Padre Nostro e non dal Padrino di Cosa Nostra. Per questi motivi lottò per aprire un centro che chiamò «Padre Nostro», dove i ragazzi potevano stare anziché lasciarsi ghermire dalla strada, e si batté per avere la scuola media nel quartiere. Il giorno del suo omicidio era andato per l’ennesima volta nei sordi uffici del Comune a sollecitare i permessi per la scuola, inaugurata solo 7 anni dopo la sua morte. Nonostante i molti impegni pastorali non smise mai di insegnare religione. Proprio quell’estate, forse temendo qualcosa, aveva chiesto una diminuzione d’orario, ma il preside che teneva a lui quanto i ragazzi, lo aveva convinto a non farlo. Ho conosciuto il suo volto, sempre sorridente anche se provato, da cui non traspariva la lotta impari che stava combattendo silenziosamente. La sua pace veniva dall’unione con Cristo, di cui offriva lo sguardo ad ogni persona, perché riteneva ogni vita unica e necessaria alla multiforme armonia del mondo, e infatti paragonava le singole vite alle tessere dei meravigliosi mosaici del duomo di Monreale. Per questo decisero di ucciderlo, perché scardinava il sistema mafioso da dentro, non con slogan o bei pensieri, ma lavorando accanto alle persone, calpestando le loro strade e dando loro nutrimento per il corpo e lo spirito, così che percepissero la possibilità di un’altra «strada». Per questo lo fecero fuori, erano gli anni di Riina, al quale i Graviano, capi mandamento del quartiere, erano affiliati. 3P era, a suo modo, dal basso, tanto pericoloso quanto Falcone e Borsellino, uccisi un anno prima. «Si portava i picciriddi cu iddu»: portava i bambini, non a lui, ma con lui verso una vita nuova, più piena, più bella, sicuramente meno facile, ma costruttiva, libera, vera.
Padre Puglisi era «pericoloso» perché era un vero maestro, apriva la strada, ti prestava il coraggio che non avevi, come i veri padri. E proprio come i veri padri pagò di persona. Avevo solo 16 anni. Ho provato a raccontare questa storia di tenebra e luce nel romanzo «Ciò che inferno non è», perché ha determinato il mio sguardo su me stesso e sul mondo. Ho sentito entrare dentro di me una vita molto più ampia e non volevo che quel fatto diventasse, con il tempo, l’ennesima, archeologica, commemorazione di una delle tante ferite della mia città, recuperata per l’occasione nelle soffitte della retorica. In molti sentimmo che quel sangue mite e coraggioso raggiungeva cuore e membra come una trasfusione. E così se il professore di lettere mi aveva fatto vedere «che cosa» sarei voluto diventare, un altro, 3P, mi fece vedere «come»: impegnarsi per ogni vita, anche quando c’è poco da sperare o attorno hai un sistema che ti scoraggia, ostacola, deride. Quel giorno ho capito che dovevo bandire dalla mia vita gli alibi: il pessimismo diventò per me una scusa per starsene comodi e la speranza la principale attività della testa, del cuore e delle mani. Grazie a 3P ho imparato che la vita può essere felice solo quando è impegnata per gli altri, il suo umanesimo era integrale, non solo mentale o verbale: affermare la vita altrui, costi quel che costi, perché raggiunga la vera altezza: «a testa alta, dovete andare a testa alta!». Per questo portava i bambini a guardare il cielo stellato, per trasformare il loro desiderio di vita attraverso la morte, come mostrava la mafia, in desiderio di vita attraverso la vita, come mostrava lui. A lui mi ispiro per il mio lavoro. L’uomo che sono diventato lo devo alla ferita di quel sedicenne inconsapevole, ingenuo, egoista, che aprì gli occhi su un modo di impegnarsi nella vita che non poteva essere fatto solo di sogni e parole, ma doveva farsi carne. 25 anni dopo voglio ricordare quell’uomo minuto, sembrava che il vento potesse farlo volar via, ma gigantesco nella fede in Dio e quindi nella fede nell’uomo.
L’ho constatato incontrando i ragazzi che operano oggi al Centro Padre Nostro, di fronte alla chiesa di San Gaetano. Studenti delle superiori o universitari si impegnano per i bambini come faceva don Pino, come è chiamato a fare ogni maestro, «portarsi i picciriddi cu iddu», non a lui, ma con lui: perché educare è dare a un giovane uomo coraggio verso se stesso e il mondo, ma tale forza educativa si sprigiona solo se io stesso sono impegnato, come posso, a crescere con quell’uomo. Abbiamo bisogno di maestri, il messaggio arriva forte e chiaro da una delle tante lettere sul tema, ricevuta pochi giorni fa: «Mi son sempre sentita sbagliata in classe. Ho avuto paura di occupare un posto nel mio banco e nel mondo, mi sono convinta di non essere abbastanza: abbastanza intelligente, abbastanza creativa, abbastanza bella… Non ho trovato insegnanti innamorati del proprio mestiere e capaci quindi di scovare il tesoro che ogni persona nasconde, ma insoddisfatti della propria condizione e convinti dell’inferiorità delle nuove generazioni. Ho avuto insegnanti che non leggevano una poesia “perché tanto non capireste”. Così mi sono ritrovata, da sola, a cercare parole che mi avrebbero salvato. Ho divorato libri, anche il manuale di letteratura. Cercavo chi mi avrebbe abbracciato anche da epoche lontane, chi mi avrebbe dato la mano e accompagnato nei tempi più bui. Ho trovato chi mi facesse conoscere il mondo, gli altri e me stessa. Da sola. Sto studiando per diventare maestra e ho fatto la mia prima esperienza in quarta elementare. È stata una delle cose più belle che mi siano successe. Ho scoperto con i bambini mondi così profondi che non scorderò mai». Essere maestri è aprire strade e aiutare le persone a sentirsi «abbastanza», scoprendo che in realtà lo sono già: «a testa alta, dovete andare a testa alta!». 3P da vero maestro non ha mai accampato alibi (in latino «alibi» vuol dire letteralmente essere «altrove») in un quartiere difficilissimo, né a scuola, ma ha creduto in quei giovani contro ogni speranza. Ha amato lì dov’era, con lui nessuno era «sbagliato».
La più bella definizione di maestro che io conosca si trova nell’incontro tra Dante e Brunetto Latini. Il poeta dice al defunto maestro che nella sua mente «è fitta, e or m’accora,/la cara e buona imagine paterna/di voi quando nel mondo ad ora ad ora/m’insegnavate come l’uom s’etterna». Ricorda con affetto la figura «paterna», maestro è chi dà la vita, uomo o donna che sia, e gli è grato perché «ad ora a ora», che mi piace pensare in termini di quotidiano orario scolastico, gli insegnava «come l’uom s’etterna», parole che indicano l’immortalità dell’anima, ma in senso più ampio, la ricerca radicale di ogni uomo: attingere a una vita che non si rovina, ma sempre si rinnova, all’altezza del desiderio umano. Brunetto si rammarica: «figliuolo mio… s’io non fossi sì per tempo morto… dato t’avrei a l’opera conforto». Egli avrebbe voluto continuare a prestare servizio, come si dice con lampante verità anche in burocratese scolastico, alla vita dell’allievo. Maestro è chi riconosce «l’opera» che l’altro deve fare e la serve, con la sua vita. Così è stato 3P, padre che ha dato la vita perché altri ne avessero una più degna, vera, felice. L’uomo che sono oggi lo devo a ciò che vidi a 16 anni, una lezione che non dimenticherò, ed è la lezione che ha reso la mia vita bellissima, perché solo i maestri ci liberano dalla paura della vita, ci prestano il coraggio di andare a testa alta lì dove siamo, spazzando via gli alibi, e ci fanno essere «abbastanza», anche se pensiamo di non esserlo mai. Grazie, 3P, il letto oggi lo rifai tu per me. Fonte: Corriere della Sera, 10 settembre 2018 Mariateresa Zattoni. “Ritorno
a casa. La nascita di una coscienza” Storia del cammino verso la ‘guarigione’ di una tossicodipendente morta a 26 anni per AIDS È l’autunno ’89. Sono passati otto lunghi anni dal primo buco, la morte per AIDS è alle porte e per la prima volta Salina mi guarda con aria stupefatta ed infinitamente triste, dicendomi: «Mariateresa, ho contagiato altri, mi vendevo e non dicevo niente . . Tanto non me ne fregava assolutamente niente. Ma l’ultimo, un tizio di P .. . , si è sposato un mese fa. Devo andarglielo a dire»? La domanda è per me come il grido del neonato che si sveglia alla vita del mondo e per la prima volta respira in proprio. Circa nove mesi prima di morire, finalmente e definitivamente, Salina si sveglia alla coscienza e vi sta aggrappata guardando in faccia alla morte … «In quasi cinque anni che so di essere sieropositiva, non mi era mai successo di considerare l’AIDS come una possibilità concreta ed invece quella notte ho saputo cosa significa aver paura che rimanga poco tempo. Ho scritto una lettera a Redento riguardo a questo, poi non ne ho più parlato ed anche la paura
è sfumata: ma non è stato come se l’avessi accantonata, si
è piuttosto trasformata in una piena coscienza di me». Dal
Diario che pubblichiamo in appendice, p. l
Altri spunti per la Santa
Messa di domenica 9 settembre
Sordità autentica: peccato che impedisce di rendersi docili
alla voce di Dio e dei fratelli.
Pericolo:
che si diffonda la sordità, che si battezzi il “fanno
tutti così”.
Cadere nell’abitudinarismo.
Comodità.
Annunziare se stessi più che Gesù Cristo.
Paura che trattengono dall’annuncio, di non essere
all’altezza, di far brutta figura, che gli altri non
capiscano.
Correre tanto, ma non annunciare con umiltà e verità.
Intervento di Gesù: sembra un po’ complicato, ma al centro sta
l’emettere lo Spirito! (gesto trinitario)
Come far entrare lo Spirito Santo in ogni istante della nostragiornata?
Lui è semplice.
Noi, invece, complicati a causa del peccato.
Eseguendo bene, in serenità, con gioia anche nei momenti
di sconforto il proprio dovere.
Elevando spesso, più spesso possibile il pensiero a Dio
(giaculatorie, frecce)
Trovando dei momenti, specialmente al mattino e alla
sera espliciti per il Signore: non parlano di come
vivere la nostra giornata, ma di “perché” affrontarla.
Nei momenti di sconforto, non scappare, ma rimanere con
la serenità e la fiducia di chi sa di essere figlio
amato: “Non temere”.
Mons. Luigi Negri: ci si
purifica se si vive
l’annunzio
Lo scandalo degli scandali è che la Chiesa non parla più di
Gesù Cristo.
Non si può negare che ci sia una situazione di vero scandalo,
nel senso che la manifestazione dell’immoralità è diventata
così ovvia e naturale, che il popolo vive una situazione
permanente di scandalo. Ed è come se la Chiesa fosse tutta
concentrata a parlare di questi scandali, a cercare di
chiarirli, di dettagliare. C’è un incredibile dettaglio del
male che porta però a una reale alterazione della situazione
della Chiesa. Gli scandali della pedofilia, della immoralità
del clero, dell’evidentissima presenza nel tessuto dellaChiesa di forme di pressione omosessuale sono davanti agli occhi di tutti; però lo scandalo degli scandali è che la Chiesa non parla più di Gesù Cristo. La Chiesa finisce per ridursi a formulare una serie di interventi corretti politicamente, in cui è evidente che non si propone più l’immagine di Gesù Cristo, non si pone più quella presenza inquietante e insieme confortante che la Chiesa deve vivere e comunicare agli uomini di ogni generazione. Il sospetto è che questa attenzione spropositata a situazioni certamente gravi dal punto di vista morale, finiscano per impedire alla Chiesa di tenere fermo il punto. Quale è il punto su cui la Chiesa deve tenere ferma la sua presenza? Che ci sono questi scandali terribili oppure che nonostante tutti questi limiti c’è la presenza di Cristo che salva l’uomo, che riempie la vita dell’uomo di un significato vero e profondo, che apre davanti ad ogni uomo quel sentiero buono della vita di cui parlava in modo indimenticabile papa Benedetto XVI? Se la Chiesa si esaurisce nell’analisi dei suoi mali, o di certi suoi mali, di fronte al male resta sgomenta, perché il male sembra invincibile. Non è una Chiesa che rinnova ogni giorno ad ogni uomo l’esperienza dell’annunzio, che il Signore è risorto ed è con noi, che la vita umana non è perduta, non è neanche spezzata, non è neanche inutile: la vita umana acquista il suo senso profondo, il suo significato profondo per la presenza di Cristo e dalla presenza di Cristo. Forse è anche inutile fare confronti fra le situazioni di crisi di oggi e di altri momenti della Chiesa. Non credo ci sia stato un momento della storia in cui la Chiesa non abbia sofferto anche gravemente per le incoerenze di chi doveva tenere alta la barra della fede e dell’amore a Cristo. Oggi è evidente che quanto più il tempo passa e quanto più ci si impegna in questa dialettica senza fine sulla natura degli
errori, sul peso degli errori, sulle radici degli errori morali, tanto meno si tiene ferma l’unica cosa che deve essere tenuta ferma, dentro la Chiesa e nel rapporto tra la Chiesa e il mondo: che Cristo è il redentore dell’uomo e del mondo, centro del cosmo e della storia. E che quindi nessuna condizione, nessuna situazione che si provochi all’interno della Chiesa per l’immoralità dei suoi aderenti o che invece proceda dal mondo verso il cuore della Chiesa con la forza terribile del demonio, può scuotere la serena certezza che «se Cristo è con noi chi può essere contro di noi?». Vorremmo che soprattutto le autorità della Chiesa si rendessero conto che il popolo si aspetta che si rinnovi l’annunzio di Cristo, che si rinnovi all’uomo la grande certezza che la vita è buona, perché nasce da Dio, nasce dal mistero di Cristo, ci viene donata in virtù della sua presenza e della sua grazia. Si sperimenta come vita nuova, come modo nuovo di essere, di agire, di vivere, di lottare, di soffrire, di morire. E questa vita nuova, che rende ogni giorno nuova l’esistenza, non deve essere trattenuta con qualche forma di neghittosità nello spazio della coscienza privata, dei singoli o delle comunità, ma deve essere annunciata con forza ad ogni uomo di questo mondo, perché soltanto nell’incontro con Cristo l’uomo di questo mondo può trovare il senso profondo della sua esistenza. Tutto il tempo che si dedica all’analisi degli errori interni alla Chiesa è tempo tolto alla fede, è tempo tolto all’amore personale al Signore, è tempo tolto a quella esperienza di verità, di bellezza, di bene, che rende più faticosa e insieme più lieta l’esistenza. «Il mio cuore è lieto perché Dio vive»: solo la Chiesa può dare questa letizia. Se si sottrae a questo compito di proporre agli uomini quella letizia che il cuore dell’uomo desidera, la Chiesa non compie un peccato particolare, compie il peccato di Giuda, «meglio per te che non fossi neanche nato». Non si tratta di far finta che nulla sia successo o
minimizzare la portata di certe situazioni, ma tutto va vissuto alla luce del compito che ci è stato dato, tutto va vissuto in funzione di una ripresa. Tutto va tradotto in termini di coscienza nuova, altrimenti è un tempo perduto. È un tempo perduto perché non ci è chiesta immediatamente la purificazione di noi stessi, che si operi magari come esito della nostra capacità morale. Ci è chiesto l’annunzio, ed è l’annunzio che ci purifica. Non c’è una purificazione morale previa dopo della quale comincia l’annunzio. Se si vive l’annunzio ci si purifica, come ci ha insegnato Paul Claudel in modo indimenticabile in alcuni grandi personaggi di quel documento della genialità cristiana che è “l’Annunzio a Maria”. Fonte: http://www.lanuovabq.it/it/ci-si-purifica-se-si-vive-la nnunzio Grazie https://costanzamiriano.com/2018/06/27/la-valigia-dei-libri-pe r-le-vacanze/
Foto nella homepage: Lago di Tiberiade – 2014 foto di Leonora
Giovanazzi
Spunti per la meditazione
sulle letture di domenica 9
settembre 2018
1. Dite agli smarriti di cuore: “Coraggio! Non temete; ecco
il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina.
Egli viene a salvarvi”.
2. A l l o r a s i a p r i r a n n o g l i o c c h i d e i c i e c h i e s i
schiuderanno gli orecchi dei sordi.
Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia
la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel
deserto, scorreranno torrenti nella steppa.
3. Il Signore protegge lo straniero.
Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie degli empi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.4. Fratelli miei, non mescolate a favoritismi personali la
vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore
della gloria.
5. E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la
mano.
E portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose
le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la
lingua;
guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e
disse: «Effatà» cioè: «Apriti!».
Verso un commento…
San Lorenzo da Brindisi (1559-1619)
Cappuccino, dottore della Chiesa
11a domenica dopo Pentecoste, Prima omelia, 1.9.11-12; Opera
omnia, 8, 124.134.136-138
“Ha fatto bene ogni cosa”
La Legge divina racconta le opere che Dio ha compiute nella
creazione del mondo e aggiunge: “Dio vide quanto aveva fatto;
ed ecco, era cosa molto buona” (Gen 1,31)… Il Vangelo
riferisce l’opera della Redenzione e della nuova creazione e
dice nello stesso modo: “Ha fatto bene ogni cosa” (Mc 7, 37)…
Certamente il fuoco può spandere soltanto il calore, per sua
natura, e non può produrre freddo; il sole può diffondere
soltanto la luce e non può essere causa delle tenebre. Così
Dio può fare soltanto cose buone, poiché è la bontà infinita,
la luce stessa. È il sole che spande una luce infinita, il
fuoco che produce un calore infinito: “Ha fatto bene ogni
cosa”… La Legge dice che tutto ciò che Dio ha fatto era buonoe il Vangelo dice che egli ha fatto bene ogni cosa. Però, fare cose buone non è semplicemente farle bene. Molti, in verità, sono quelli che fanno cose buone senza farle bene, come gli ipocriti che fanno, certo, cose buone, ma con spirito cattivo, con intenzione perversa e falsa. Dio fa ogni cosa buona e la fa bene. “Il Signore è giusto in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere” (Sal 145, 17)… E se Dio, sapendo che troviamo gioia in ciò che è buono, ha fatto per noi tutte le sue opere buone e le ha fatte bene, perché, di grazia, anche noi non ci spendiamo per fare soltanto opere buone e farle bene, dato che sappiamo che in questo sta la gioia di Dio? Fonte: https://vangelodelgiorno.org/IT/gospel/2018-09-09 Gesù vivo oggi Effetà – Paolo VI La storia di questa Scuola dei Sordi di Betlemme (Israele – Stato Palestinese) gestita dalle Suore Dorotee di Vicenza ha le sue origini nella visita pastorale che Sua Santità Paolo VI effettuò in Terra Santa nel 1964. Il Santo Padre, avendo constatato in questa terra la presenza di numerosi bambini sordi privi di assistenza, espresse il desiderio che fosse realizzata un’opera educativa per la loro riabilitazione. La risposta fu data dalla Congregazione delle Suore Maestre di Santa Dorotea, Figlie dei Sacri Cuori, originarie dall’Italia, già presenti in Terra Santa dal 1927. Esse avevano avviato a Betlemme una costruzione per uso proprio; sensibili all’appello del Papa gliene fecero dono perché vi potesse realizzare l’opera auspicata. Il Santo Padre gradì l’offerta e la riconsegnò alla
Congregazione allo scopo che essa stessa avviasse un Istituto speciale per i bambini audiolesi considerato che questo è un aspetto carismato della sua missione. Con il contributo della Santa Sede, la costruzione iniziale venne ampliata, adeguata alle nuove esigenze e dotata di apparecchiature specifiche. Il 30 giugno 1971 il Card. Massimiliano Furstemberg inaugurò l’Istituto che prese il nome di “Effetà Paolo VI”. Nel titolo si è voluto ricordare l’ideatore e benefattore, ed inoltre richiamare la parola pronunciata da Gesù nel guarire un sordomuto. Il 1° luglio 1971 vi si stabilì la prima comunità educativa composta di sette Religiose ed il 6 settembre dello stesso anno, 24 bambini audiolesi iniziarono il programma riabilitativo audiofonetico. Di anno in anno il loro numero andò crescendo fino a raggiungere oggi circa 140 alunni. L’Ufficio Pellegrinaggi di Vicenza promuove la raccolta di vestiario e cancelleria per l’Istituto Effeta di Betlemme. Visita il sito dell’Istituto Effeta
Udine, 7 settembre 2018. Costanza Miriano e Stephan Kampowski. Un fiore nel deserto. L’attualità di “Humanae vitae”
Puoi anche leggere