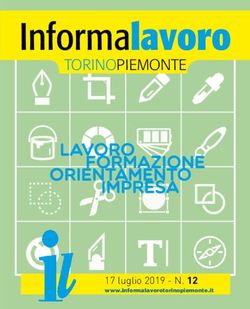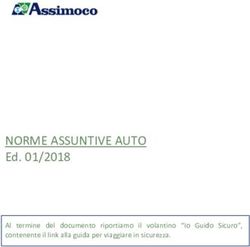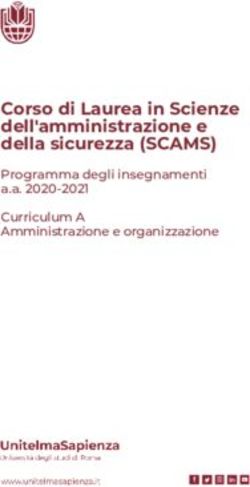RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE - Quarterly Journal of Environmental Law
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
RIVISTA QUADRIMESTRALE
DI
DIRITTO DELL’AMBIENTE
-
Quarterly Journal of Environmental Law
NUMERO 1 - 2017
MAURO PENNASILICO
Contratto ecologico e conformazione dell’autonomia negoziale
G. Giappichelli editoreRIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI -
ANNO 2017/NUMERO 1
MAURO PENNASILICO*
Contratto ecologico e conformazione dell’autonomia negoziale**
SOMMARIO: 1. Contratto ecologico e consumo critico: il consumatore
come parte attiva del rapporto. – 2. La conformazione dell’autonomia negoziale
tra sostenibilità e sussidiarietà: l’interesse ambientale come limite interno
all’attività di operatori pubblici e privati. – 3. La “costituzionalizzazione” del
principio dello sviluppo sostenibile. – 4. L’incidenza sulla categoria contrattuale
dell’interesse ambientale: gli appalti verdi. – 5. Il nuovo paradigma del
“contratto ecologico”. – 6. Segue: riflessi sulla formazione, interpretazione,
integrazione ed esecuzione del regolamento contrattuale. – 7. Il contratto
ecologico come strumento di godimento e gestione condivisa di beni comuni e
fonte di rapporti giuridici patrimoniali sostenibili. – 8. L’analisi “ecologica” del
diritto privato contrattuale: attività d’impresa e mercato agroalimentare. – 9.
Segue: «commercio equo e solidale» e «gruppi di acquisto solidale». – 10.
Segue: contrattazione immobiliare e contratto di rendimento energetico. – 11. Il
contratto ecologico in funzione protettiva della specie umana e delle generazioni
future: una categoria euristica.
1. Contratto ecologico e consumo critico: il consumatore come parte
attiva del rapporto
Considero «contratto ecologico» l’espressione sintomatica di un
autentico «mutamento di paradigma» in materia contrattuale, tale da mettere in
discussione, sotto la spinta del modello globale dello «sviluppo sostenibile»1 ,
*
Professore ordinario di Diritto privato presso l’Università degli Studi di Bari “A. Moro”.
**
Il testo riproduce, con l’aggiunta delle note, la relazione al convegno «Il diritto a tutela
dell’ambiente», organizzato dall’Unione Nazionale Camere Civili e svoltosi a Roma il 17 marzo
2017 presso la sede del Consiglio Nazionale Forense.
1
Si veda, anche per ulteriori indicazioni, M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità
costituzionale e analisi “ecologica” del contratto, in Pers. merc., 2015, n. 1, p. 37 ss., e in P.
POLLICE (a cura di), Liber Amicorum per Biagio Grasso, ESI, Napoli, 2015, p. 473 ss. (da cui si
citerà); ID., Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in
Rass. dir. civ., 2016, p. 1291 ss., e in ID. (a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica”
del diritto contrattuale, Atti del convegno, Bari, 22-23 ottobre 2015, ESI, Napoli, 2016, p. 287 ss.
(da cui si citerà); I. ALOGNA, La circolazione del modello di sviluppo sostenibile. Prospettive di
diritto comparato per un percorso multidirezionale, in G. CERRINA FERONI - T.E. FROSINI - L.
MEZZETTI - P.L. PETRILLO (a cura di), Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici
comparati per lo sviluppo sostenibile, vol. I, tomo 1, CESIFIN, Firenze, 2016, p. 145 ss. (reperibile
in www.cesifin.it). Il nuovo quadro globale della materia è oggetto dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, adottata il 25 settembre 2015 in occasione della 70a Assemblea generale delle Nazioni
4RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI -
ANNO 2017/NUMERO 1
l’adeguatezza della nozione stessa di contratto, come formulata dal codice del
1942, e da imporre una conformazione “ecologica” dell’autonomia negoziale2.
Per svolgere questo assunto, occorre subito liberarsi della possibile, ma
riduttiva, rappresentazione del contratto ecologico come contratto dei
consumatori, attenti a selezionare prodotti ecosostenibili e, dunque, bisognosi di
protezione dalla pratica scorretta, sempre più diffusa tra i produttori, di usare
dichiarazioni ambientali mistificatorie (c.d. greenwashing, cui pongono rimedio
gli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lett. b, e 23 c. cons.)3. Se siamo stati abituati
a vedere nel consumatore la parte “debole” del rapporto, assistita da molte forme
di tutela, nella «contrattazione ecologicamente orientata» 4 , in una sorta di
Unite (Risoluzione NU A/RES/70/1); quanto agli impegni dell’UE in tema di sostenibilità, si veda
la comunicazione COM(2016) 739, «Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe. L’azione
europea a favore della sostenibilità». La politica commerciale dell’UE, illustrata nella
comunicazione COM(2015) 497, «Commercio per tutti. Verso una politica commerciale e di
investimento più responsabile», appoggia lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo, puntando in
particolare sul nesso tra commercio, sviluppo, diritti umani e buona governance, nella
consapevolezza che il commercio «non è fine a se stesso, è uno strumento a vantaggio delle
persone» (p. 30). Il punto sull’attuazione in Italia della vasta gamma di obiettivi economici, sociali,
ambientali e istituzionali contenuti nell’Agenda 2030 è fatto dal Rapporto 2016 dell’Alleanza
italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(disponibile in www.asvis.it).
2
Il tema è ampiamente sviluppato in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente, cit., al
quale si rinvia anche per ulteriori indicazioni.
3
Si vedano, ad es., i provvedimenti dell’AGCM, 8 febbraio 2012, n. 23278, in Boll., n. 6 del 27
febbraio 2012, p. 159 ss., e 14 novembre 2012, n. 24046, ivi, n. 46 del 3 dicembre 2012, p. 43 ss.
(consultabili in www.agcm.it); il punto 24 della risoluzione del Parlamento europeo 4 febbraio 2014
sull’applicazione della direttiva 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali; il documento
di lavoro dei servizi della Commissione europea SWD(2016) 163, «Orientamenti per
l’attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali», p.
110 ss.; il documento del Dialogo Multilaterale sulle Asserzioni Ambientali (MDEC, Multi-
stakeholder Dialogue on Environmental Claims), «Compliance Criteria on Environmental Claims.
Multi-stakeholder advice to support the implementation/application of the Unfair Commercial
Practices Directive 2005/29/EC», 2016 (disponibile in https://ec.europa.eu). Occorre, in tal caso,
che l’impresa da causa del problema divenga artefice della sua soluzione, come testimonia la
progressiva ascesa della responsabilità sociale d’impresa e, in particolare, degli obblighi
d’informazione ambientale a favore dei consumatori, sotto forma di ecoetichettature, marchi
ecologici, impronte di carbonio. In argomento, v. S. LANDINI, Clausole di sostenibilità nei contratti
tra privati. Problemi e riflessioni, (2015), in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente, cit.,
p. 343 ss., spec. p. 361 ss.; M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p.
307, ove ulteriore bibliografia.
4
Così si esprime A. JANNARELLI, Principi ambientali e conformazione dell’autonomia negoziale:
considerazioni generali, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente, cit., p. 19 ss., spec.
p. 22.
5RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI -
ANNO 2017/NUMERO 1
consapevole ribaltamento della realtà, il consumatore è spesso la parte attiva, che
promuove e difende un mercato più equo, corretto e responsabile5.
Il mutamento radicale della realtà dei mercati si compendia in un solo
termine: «consumo critico», ossia un modo di acquisto di beni e servizi in virtù
del quale rilevano non soltanto il prezzo e la qualità dei prodotti, quanto piuttosto
la solidarietà tra produttori e consumatori e la sostenibilità ambientale della filiera
produttiva6.
2. La conformazione dell’autonomia negoziale tra sostenibilità e
sussidiarietà: l’interesse ambientale come limite interno all’attività di operatori
pubblici e privati
Il discorso va svolto interrogandosi, preliminarmente, sui presupposti
normativi della categoria del «contratto ecologico»7.
Occorre subito osservare che ogni attività umana, pubblica o privata,
purché giuridicamente rilevante ai sensi del codice dell’ambiente (d.lgs.
152/2006, d’ora in poi c.a.), «deve conformarsi al principio dello sviluppo
sostenibile» (art. 3-quater, comma 1, c.a.), in modo da individuare un rapporto
equilibrato tra risorse da risparmiare e da trasmettere, affinché nelle dinamiche
della produzione e del consumo «si inserisca altresì il principio di solidarietà per
salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro» (art. 3-
quater, comma 3, c.a.). Del resto, il medesimo codice impone un pregnante
vincolo a garantire la tutela dell’ambiente in capo anche ai soggetti privati8, così
avvalorando la conformazione “ecologica” dell’autonomia negoziale.
5
Cfr. B. AGOSTINELLI, «Gruppi di acquisto solidale»: un nuovo modo di negoziare, in Riv. dir. civ.,
2015, p. 1200 ss., spec. p. 1224, nonché, infra, § 9.
6
Si veda, sul piano sociologico, F. FORNO - P.R. GRAZIANO, Il consumo critico, il Mulino, Bologna,
2016; su quello giuridico, M. IMBRENDA, Le relazioni contrattuali nel mercato agroalimentare,
ESI, Napoli, 2016.
7
Si veda M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 287 ss.
8
L’art. 3-ter c.a. così dispone: «La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio
culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche
pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione,
dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente,
nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle
unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale» (ora art. 191, comma 2,
Tratt. FUE).
6RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI -
ANNO 2017/NUMERO 1
Tuttavia, il coinvolgimento dei privati nella realizzazione dell’interesse
ambientale trova il proprio fondamento ancor più nel principio costituzionale di
sussidiarietà “orizzontale”, che legittima, ai sensi dell’art. 118, comma 4, Cost.,
«l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale»9, con due fondamentali conseguenze: «il contratto
non è più configurabile come esclusivo strumento per regolare interessi
patrimoniali individuali ed egoistici delle parti»10; l’interesse ambientale diventa
un limite interno all’autonomia negoziale11.
Emblematico, al riguardo, è l’orientamento della Corte di Cassazione in
materia di immissioni. I giudici di legittimità hanno chiarito che la disciplina
contenuta nell’art. 844 c.c., «nel prevedere la valutazione, da parte del giudice,
del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della
proprietà, [...] deve essere interpretata, tenendo conto che il limite della tutela
della salute e dell’ambiente è da considerarsi ormai intrinseco nell’attività di
produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione
9
Significativa conferma nella nuova disciplina del condominio (legge 220/2012), curvata verso
l’attuazione di esigenze collettive di sicurezza e di sostenibilità ambientale. L’art. 1135, ultimo
comma, c.c. prevede, infatti, che l’assemblea dei condòmini può autorizzare l’amministratore «a
partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni
locali o da soggetti privati qualificati, [...] al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio
esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il
condominio è ubicato». La norma è di particolare importanza non soltanto perché introduce per la
prima volta nel codice civile un riferimento diretto alla sostenibilità ambientale e dunque indiretto
all’ambiente, termine tuttora ignoto al codice del 1942, ma anche per il riferimento espresso
all’iniziativa di «soggetti privati qualificati», a conferma della logica della sussidiarietà orizzontale.
L’indagine più ampia e documentata in materia si deve a M. NUZZO (a cura di), Il principio di
sussidiarietà nel diritto privato, vol. I-II, Giappichelli, Torino, 2014, a commento della quale si
veda P. PERLINGIERI, La sussidiarietà nel diritto privato, in Rass. dir. civ., 2016, p. 687 ss.; da
ultimo, F. MAISTO, L’autonomia contrattuale nel prisma della sussidiarietà orizzontale, ESI,
Napoli, 2016.
10
Così, P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e sviluppo, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto e
ambiente, cit., p. 321 ss., spec. p. 325.
11
In tal senso, M. PENNASILICO, Contratto e uso responsabile delle risorse naturali, in Rass. dir.
civ., 2014, p. 753 ss., spec. p. 763, e ID., Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 291.
Osserva, al riguardo, G. ROSSI, L’evoluzione del diritto dell’ambiente, in Riv. quadr. dir. amb.,
2015, n. 2, p. 2 ss., spec. p. 4, che l’interesse “primario” all’ambiente giustifica e, anzi, richiede,
nelle ultime direttive europee, «una alterazione rispetto ai parametri meramente economici nei
contratti delle pubbliche amministrazioni», sì che «il parere delle Autorità preposte alla tutela
ambientale non può essere disatteso nelle decisioni che si adottano nelle conferenze di servizi». La
sostenibilità ambientale è, dunque, «parametro di valutazione e della stessa liceità dello sviluppo.
Lo sviluppo è un valore tutelato e promosso dall’ordinamento, ma trova un limite nel valore
ambientale, che è preminente».
7RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI -
ANNO 2017/NUMERO 1
costituzionalmente orientata dei beni protetti dall’art. 844 c.c., dovendo
considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento
del diritto ad una normale qualità della vita»12.
Eloquente conferma si rinviene nel nuovo Código Civil y Comercial de
la Nación Argentina (CCyC), pubblicato l’8 ottobre 2014 ed entrato in vigore il
1° agosto 2015 13 . In conformità alla Costituzione del 1994, che regola
principalmente agli artt. 41 e 43 i derechos de incidencia colectiva, l’art. 14 CCyC
vieta l’esercizio abusivo dei diritti individuali quando possa danneggiare
l’ambiente e, in generale, i diritti di incidenza collettiva; l’art. 240 CCyC, a sua
volta, pone espressamente limiti di sostenibilità ambientale all’esercizio dei diritti
individuali sui beni; l’art. 1094 CCyC, infine, stabilisce: «Le norme che regolano
i rapporti di consumo devono essere applicate e interpretate in conformità con il
principio di protezione del consumatore e di accesso al consumo sostenibile»,
inteso, quest’ultimo, come parte essenziale dello sviluppo sostenibile14.
Non meno significativa è l’opinione di un insigne giurista15, il quale, nel
chiedersi quali elementi potrebbero rendere un contratto irrazionale, iniquo e
perciò in contrasto con l’esigenza dell’accesso generalizzato ai beni, osserva che
«un primo limite cogente può porsi in nome delle ragioni dei terzi», ossia «delle
ragioni collettive, espresse nell’integrità ambientale. Norme che, per proteggere
l’ambiente, ponessero limiti alla libertà contrattuale, non difetterebbero di un
appoggio costituzionale. Trova qui applicazione l’idea della solidarietà che i
contraenti debbono ai terzi ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, da mettersi in
relazione con il dettato dell’art. 9».
12
Cass. 8 marzo 2010, n. 5564, in Giust. civ., 2010, I, p. 815 ss., spec. p. 820.
13
A proposito del nuovo codice argentino si rinvia, anche per ulteriori riferimenti, ai contributi
raccolti in R. CARDILLI - D.F. ESBORRAZ (a cura di), Nuovo codice civile argentino e sistema
giuridico latinoamericano, Wolters Kluwer - CEDAM, Milano, 2017.
14
Chiarisce, al riguardo, R. STIGLITZ, Comentario al art. 1094, in M. HERRERA - G. CARAMELO -
S. PICASSO (dir.), Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, II ed., tomo III, Editorial
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Buenos Aires, 2016, p. 490 (disponibile
in www.saij.gob.ar): «La protección de los más altos intereses de la comunidad determina que sea
hoy insoslayable exigir que toda actividad productiva o de comercialización de bienes y servicios
respete las exigencias propias de la preservación de un medio ambiente sustentable, lo que exige
que en la comercialización de productos de consumo se prevean los mecanismos necesarios para el
reciclado o la disposición adecuada de los residuos que puedan generarse». Si guardi anche, nel
nostro ordinamento, agli artt. 6, lett. d, 30, comma 1, e 136, comma 3, c. cons.
15
R. SACCO, in R. SACCO - G. DE NOVA, Il contratto, III ed., tomo I, in Tratt. dir. civ. Sacco, UTET,
Torino, 2004, p. 35 (ora ID., in R. SACCO - G. DE NOVA, Il contratto, IV ed., UTET - Wolters
Kluwer, Torino-Milano, 2016, p. 32).
8RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI -
ANNO 2017/NUMERO 1
3. La “costituzionalizzazione” del principio dello sviluppo sostenibile
Eppure, la Costituzione italiana non fa riferimento espresso allo sviluppo
sostenibile, la cui copertura non manca, tuttavia, di essere assicurata
dall’interpretazione “evolutiva” di alcune disposizioni costituzionali 16 e, in
particolare, dal concetto di «utilità sociale», la cui feconda indeterminatezza
consente al testo dell’art. 41 di adattarsi alle nuove frontiere dello sviluppo
sostenibile17.
In realtà, nonostante tale lettura “evolutiva”, l’operatività del principio
dello sviluppo sostenibile nell’ordinamento nazionale potrebbe essere
notevolmente rafforzata da un recepimento espresso all’interno del testo
costituzionale, che ne chiarisca la portata precettiva18.
Tuttavia, la “costituzionalizzazione” esplicita dello sviluppo sostenibile
non è l’unica strada per sancire l’incidenza del principio sulle dinamiche dei
rapporti civili. In realtà, l’integrazione tra principi normativi di fonte
sovranazionale e diritto interno, che si desume dagli artt. 11 e 117, comma 1,
Cost., apre il varco alla penetrazione di quei principi non soltanto nella sfera del
potere pubblico, ma anche nel tessuto dell’autonomia privata19.
16
Sulla pluralità di norme costituzionali dalle quali è possibile desumere l’operatività del principio
dello sviluppo sostenibile (in gran parte richiamata dall’art. 3-bis, comma 1, c.a.), v. M.
PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale, cit., p. 479 s.
17
Cfr. R. BIFULCO - A. D’ALOIA, Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto
costituzionale, in ID. (a cura di), Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile
e della responsabilità intergenerazionale, Jovene, Napoli, 2008, p. IX ss., spec. p. XXVI. In questa
prospettiva, la nozione di “utilità sociale” comprende la protezione delle aree di particolare
interesse, la tutela delle tradizioni locali e l’incremento culturale ai sensi dell’art. 9 Cost. (cfr. V.
PEPE, Riforma dell’art. 41 della Costituzione per uno sviluppo sostenibile: la sostenibilità come
etica pubblica, in Italia forest. mont., n. 1, 2012, p. 44 ss., spec. p. 53). Tale lettura è stata avvalorata
dalla Corte costituzionale, la quale ha ricondotto al concetto di utilità sociale gli interessi fondati
nell’art. 9 Cost., «che impegnano la Repubblica ad assicurare, tra l’altro, la tutela del patrimonio
culturale nazionale e dell’ambiente, ad assecondare la formazione culturale dei cittadini e ad
arricchire quella esistente, a realizzare il progresso spirituale e ad acuire la sensibilità dei cittadini
come persone» (Corte cost. 30 luglio 1992, n. 388, in www.giurcost.org).
18
Così, M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale, cit., p. 487; in senso analogo,
già D. AMIRANTE, I principi generali nell’evoluzione del diritto contemporaneo: note minime
introduttive, in ID. (a cura di), La forza normativa dei principi. Il contributo del diritto ambientale
alla teoria generale, CEDAM, Padova, 2006, p. 9 ss., spec. p. 15. Auspica, di recente, tale soluzione
il Rapporto ASVIS, L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, cit., pp. 7, 26 e 74.
19
In tal senso, M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 293 ss.;
diversamente F. FRACCHIA, Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente. Principi, concetti e
9RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI -
ANNO 2017/NUMERO 1
Si riconosce, così, che i principi generali della legislazione ambientale
(artt. 3-ter e quater c.a.) sono «principi indiscutibilmente conformativi e di
regolazione dell’agire negoziale» 20 , in quanto - come si legge nell’art. 3-bis,
comma 2, c.a. - fungono da criteri guida «nell’adozione degli atti normativi, di
indirizzo e di coordinamento». In particolare, il principio dello sviluppo
sostenibile dovrebbe porsi come norma di ordine pubblico21, con la conseguenza
che la sua violazione determinerebbe la nullità del contratto (art. 1418 c.c.)22,
rilevabile d’ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.).
4. L’incidenza sulla categoria contrattuale dell’interesse ambientale: gli
appalti verdi
Occorre chiedersi, pertanto, quale sia l’incidenza sulla categoria
contrattuale dell’interesse ambientale, che implica un giudizio di valore
istituti, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 145, il quale reputa che, in ragione del criterio della
predeterminazione legislativa dei doveri di solidarietà, «lo sviluppo sostenibile si applichi ai
soggetti privati soltanto in presenza di una norma che tipizzi il vincolo in capo alla persona»; e già
ID., Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, in Riv. quadr. dir. amb., 2010, n. 0, p. 13
ss., spec. pp. 18, 35 ss. (da cui si cita) e in F. ASTONE - F. MANGANARO - A. ROMANO TASSONE - F.
SAITTA (a cura di), Cittadinanza e diritti delle generazioni future, (Atti del Convegno di Copanello,
3-4 luglio 2009), Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, p. 21 ss., il quale, tuttavia, non può negare
che «un importante ruolo in vista della garanzia della sostenibilità sia giocato dai singoli e dai
rispettivi comportamenti, soprattutto sul versante del consumo sostenibile delle risorse, in ordine al
quale meno incisivi sembrano essere i poteri tradizionali dei soggetti pubblici» (p. 39).
20
S. PAGLIANTINI, Sul c.d. contratto ecologico, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto e
ambiente, cit., p. 367 ss., spec. p. 368, il quale riconosce che amplissimo è ormai il catalogo dei
contratti - tipici e atipici, pubblici e privati - che hanno a oggetto una prestazione specifica di
rilevanza ambientale.
21
Lo sviluppo sostenibile, nelle attuali tendenze della scienza giuridica europea e internazionale,
diventa lo scopo finale del nuovo concetto di «ordine pubblico ecologico», che impone «limiti
ecologici inderogabili all’esercizio dell’autonomia privata e al diritto di proprietà» (M.
MONTEDURO, in M. MONTEDURO - S. TOMMASI, Paradigmi giuridici di realizzazione del benessere
umano in sistemi ecologici ad esistenza indisponibile e ad appartenenza necessaria, in Benessere
e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi, Atti del 9° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C.
in ricordo di G. Gabrielli, Napoli 8-9-10 maggio 2014, ESI, Napoli, 2015, p. 161 ss., spec. p. 193
e, per ulteriori indicazioni, p. 192, nota 80). Tuttavia, autorevole dottrina mette in guardia
dall’esaltare il profilo meramente ambientale, discorrendo di «ordine pubblico ecologico», giacché
dal sistema ordinamentale si desume un unico e unitario ordine pubblico costituzionale: cfr. P.
PERLINGIERI, Persona, ambiente e sviluppo, cit., p. 331.
22
Sul punto, cfr. V. PEPE, Riforma dell’art. 41, cit., p. 54, il quale, nel considerare lo sviluppo
sostenibile «la chiave di lettura dell’intera Costituzione economica», afferma che la sostenibilità,
come principio etico, «è “l’ordine pubblico economico”, è quel valore che rende nullo finanche il
contratto ex art. 1418 c.c.».
10RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI -
ANNO 2017/NUMERO 1
sull’attività economica, considerata meritevole soltanto se rispetti l’ambiente e le
esigenze anche delle generazioni future23.
È un tema, questo, che ha assunto un iniziale rilievo nella contrattazione
pubblica, dove si sviluppa l’esperienza dei così detti “appalti verdi”, termine che
indica non già un tipo contrattuale autonomo, bensì l’insieme degli strumenti
giuridici volti a promuovere la graduale integrazione degli interessi ambientali
nella materia contrattuale24 . Il soggetto pubblico, senza alterare l’assetto pro-
concorrenziale del mercato di riferimento25, ma agendo secondo ragionevolezza
e proporzionalità, inserisce tra i criteri di aggiudicazione le “clausole verdi” (o
«criteri ambientali minimi»: CAM), al fine di selezionare concorrenti in grado di
offrire prodotti e servizi eco-efficienti, favorendo una gestione ecologicamente
virtuosa degli acquisti e delle opere pubbliche. Funzione promozionale, questa,
che trasforma una clausola, altrimenti accessoria, in clausola “primaria”26, tanto
più se l’inserimento di clausole ambientali nel contratto sia non già facoltativo,
23
Sul punto, v. M. PENNASILICO, Contratto e promozione dell’uso responsabile delle risorse
naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi, in Benessere e regole dei rapporti civili, cit., p.
249 ss., e ID., Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 294 ss.
24
Nella letteratura più recente si veda, anche per ulteriori riferimenti, A. ADDANTE, I c.d. appalti
verdi nel diritto italo-europeo, in M. PENNASILICO (a cura di), Manuale di diritto civile
dell’ambiente, ESI, Napoli, 2014, p. 182 ss.; B. FENNI, Il green public procurement come strumento
di sviluppo sostenibile, (2014), in www.ambientediritto.it; G. FIDONE, Ecoefficienza e sviluppo
sostenibile nell’attività di diritto privato della pubblica amministrazione, in Tratt. dir. amb.
Dell’Anno e Picozza, vol. III, Tutele parallele. Norme processuali, CEDAM, Padova, 2015, p. 1069
ss.; ID., Il Green Public Procurement nel diritto comunitario con particolare riferimento alle nuove
direttive appalti e concessioni, in G.F. CARTEI - M. RICCHI (a cura di), Finanza di progetto e
partenariato pubblico-privato. Temi europei, istituti nazionali e operatività, Editoriale Scientifica,
Napoli, 2015, p. 223 ss.; M. PENNASILICO, Contratto e promozione, cit., p. 253 ss.; S. VILLAMENA,
Appalti pubblici e clausole ecologiche. Nuove conquiste per la «competitività non di prezzo» anche
alla luce della recente disciplina europea, in Dir. econ., 2015, p. 355 ss.; F. DI GIOVANNI, “Appalti
verdi” e responsabilità sociale dell’impresa, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente,
cit., p. 61 ss.; C. VIVANI, Appalti sostenibili, green public procurement e socially responsible public
procurement, in Urb. app., 2016, p. 993 ss.
25
La prassi degli appalti verdi potrebbe porre delicati problemi di bilanciamento tra l’esigenza di
protezione ambientale e gli obiettivi di tutela della concorrenza, con particolare riguardo ai corollari
della parità di trattamento e del divieto di discriminazione. Si veda, a conferma di un orientamento
giurisprudenziale consolidato, TAR Puglia-Lecce 17 novembre 2006, n. 5373, in Urb. app., 2007,
p. 479, con nota di L. MASI, Appalti pubblici e risparmio energetico: un esempio di appalto verde;
in dottrina, G. FIDONE, Gli appalti verdi all’alba delle nuove direttive: verso modelli più flessibili
orientati a scelte eco-efficienti, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2012, p. 819 ss., spec. p. 822 ss.; ID.,
Osservazioni critiche sull’utilizzo dei criteri ambientali nei sistemi di contrattazione pubblica, in
M. AMADEI - M. COZZIO (a cura di), Appalti di servizi e criteri ambientali. Aspetti giuridici e tecnici,
Tangram Edizioni Scientifiche, Trento, 2013, p. 113 ss.
26
Cfr. M. PENNASILICO, Contratto e promozione, cit., p. 253 ss.
11RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI -
ANNO 2017/NUMERO 1
come ancora prevedono le direttive europee in materia di appalti, bensì
obbligatorio, come stabilisce la legislazione interna più recente.
Il d.lgs. 102/2014 riconosce espressamente tale obbligatorietà (art. 6), al
fine di sviluppare l’efficienza energetica, mentre la legge 221/2015, sulla green
economy e il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali (c.d. collegato
ambientale alla legge di stabilità 2014), ha reso obbligatoria, tramite
l’introduzione degli artt. 64, comma 4-bis, e 68-bis nel vecchio codice dei
contratti pubblici (d.lgs. 163/2006), l’applicazione di «criteri ambientali minimi».
Obbligatorietà poi definitivamente confermata dal nuovo codice appalti (artt. 34
e 71 d.lgs. 50/2016)27.
Del resto, il medesimo codice afferma che il principio di economicità,
alla base dell’azione della P.A., può essere subordinato a criteri ispirati «alla
tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello
sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico» (art. 30, comma 1).
Siffatta conformazione segna una fondamentale metamorfosi della pubblica
amministrazione, che deve non soltanto esercitare i tradizionali poteri di
pianificazione, autorizzazione e controllo delle attività private a impatto
ambientale, ma anche diventare “consumatore” di prodotti e servizi eco-
compatibili28.
27
In tal modo, «gli appalti verdi si avviano a diventare, da oggetto di singoli programmi intrapresi
da alcune pubbliche amministrazioni, una pratica rispondente al normale e dovuto modus operandi
di qualsiasi pubblica amministrazione» (F. DI GIOVANNI, “Appalti verdi”, cit., p. 68; sul punto, v.
T. CELLURA, L’applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, Maggioli,
Santarcangelo di Romagna, 2016; I. GOBBATO, Il nuovo Codice degli appalti rilancia i CAM, in
Amb. svil., 2016, p. 481 ss.). Tuttavia, in conflitto con tale indicazione si colloca il d.lgs. 175/2016
(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), là dove prescrive che, nell’ipotesi di
costituzione di società a partecipazione mista pubblico-privata, i criteri di aggiudicazione «possono
includere, tra l’altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all’oggetto dell’affidamento o
relativi all’innovazione» (art. 17, comma 2; corsivo aggiunto).
28
In questi termini, M. PENNASILICO, Contratto e promozione, cit., p. 257 ss. La “relativizzazione”
del principio di economicità «implica che tale principio debba essere perseguito dalle
amministrazioni nei limiti in cui lo stesso non risulti essere un ostacolo per il perseguimento di altri
fini pubblici ritenuti apprezzabili, come appunto il fine della protezione dell’ambiente» (G. FIDONE,
Ecoefficienza e sviluppo sostenibile, cit., p. 1085). Reputa, invece, che una simile conformazione
debba fare i conti con il principio di legalità, sotto forma di riserva di legge, giacché la stessa
disposizione dell’art. 30, comma 1, c. app. prevede che il principio di economicità possa essere
subordinato a interessi sociali e ambientali «nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme
vigenti», S. VILLAMENA, Appalti pubblici, cit., p. 366, il quale segnala l’atteggiamento di timore
della disposizione, che rimanda «alle scelte discrezionali (future ed eventuali) del Legislatore».
12RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI -
ANNO 2017/NUMERO 1
5. Il nuovo paradigma del “contratto ecologico”
Occorre, dunque, chiedersi se non siano maturi i tempi per accreditare un
nuovo paradigma contrattuale, il “contratto ecologico”29 , che sembra avere in
comune con i contratti dei consumatori e con i contratti tra imprenditori
l’asimmetria informativa e la conseguente necessità di riequilibrare posizioni
negoziali dispari.
In effetti, se è vero che un rilevante ostacolo alla gestione ecologicamente
virtuosa degli acquisti pubblici è nel deficit informativo, che non consente alle
stazioni appaltanti di orientare opportunamente le proprie preferenze30, non può
sfuggire che tale deficit fa parte di una più generale e fisiologica asimmetria
informativa della pubblica amministrazione nei confronti del contraente
privato31.
Si tratterebbe, dunque, indulgendo alla discutibile tendenza a declinare le
vicende evolutive del contratto addirittura in funzione di indicazioni
numeriche - primo, secondo, terzo contratto32 -, di un “quarto contratto” o, forse,
29
È la proposta già avanzata in M. PENNASILICO, Contratto e uso responsabile, cit., p. 767 ss.; ID.,
Contratto e promozione, cit., p. 268 ss.; più in generale, per l’incidenza dell’interesse ambientale
sugli istituti e le categorie tradizionali del diritto civile, al punto da imporne una profonda revisione
concettuale, ID., Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie civilistiche, in ID.
(a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, cit., p. 34 ss.; v. anche ID., Le categorie del
diritto civile tra metodo e storia (A proposito del libro di Nicola Lipari), in Riv. dir. civ., 2016, p.
1246 ss., spec. p. 1253 ss.
30
Cfr. Commissione CE, COM(2001) 274, «Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le
possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici», p. 8.
31
In tal senso, M. PENNASILICO, Contratto e uso responsabile, cit., p. 766; ID., Contratto e
promozione, cit., p. 267. Sottolinea la persistente asimmetria e autoreferenzialità dell’attività
amministrativa c.d. partecipata, L. FRANZESE, Autoregolamentazione e sussidiarietà: oltre le aporie
del nuovo procedimento amministrativo e della visione antagonista del contratto, in Riv. dir. civ.,
2008, I, p. 272 ss.; registra, più in generale, «la perdita di centralità della figura del consumatore a
favore di una disciplina dai confini più ampi rivolta ad un soggetto di mercato impegnato in una
relazione asimmetrica, dipendente da fattori fisiologici e non dalla patologia dell’accordo», G.
VETTORI, Il contratto del terzo millennio, in Pers. merc., 2010, p. 216; ID., Oltre il consumatore, in
Obbl. contr., 2011, p. 86; v. anche S. MAZZAMUTO, Il contratto: verso una nuova sistematica?, in
www.juscivile.it, 2016, n. 5, p. 347 ss., spec. pp. 349 ss., 353.
32
Per tutti, R. PARDOLESI, Prefazione, in G. COLANGELO, L’abuso di dipendenza economica tra
disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un’analisi economica e comparata,
Giappichelli, Torino, 2004, spec. p. XII ss.; ID., Dalla Pangea al terzo contratto?, in Studi in onore
di Nicolò Lipari, tomo II, Giuffrè, Milano, 2008, p. 2143 ss.
13RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI -
ANNO 2017/NUMERO 1
“quinto contratto”33, qualora si ipotizzi, come “quarto contratto”, lo schema di un
contratto asimmetrico «al di fuori degli squilibri di rilevanza macroeconomica»34.
Comunque sia, il contratto ecologico si differenzia dai consueti
paradigmi dei contratti dei consumatori e dei contratti tra imprese, perché
l’interesse ambientale penetra e colora la causa del contratto, enfatizzando tanto
la convergenza degli interessi dei contraenti all’utilità ambientale,
indipendentemente dalla possibile ma non sempre ricorrente asimmetria
informativa35, quanto la doverosità dell’uso responsabile delle risorse naturali a
vantaggio anche delle generazioni future36. Il principio dello sviluppo sostenibile
costituisce, così, un parametro di meritevolezza dei contratti ecologici, con la
conseguenza che un appalto “verde”, pur presentando una causa lecita, potrebbe
essere non meritevole di tutela qualora non sia idoneo a realizzare il concreto
interesse ambientale37.
6. Segue: riflessi sulla formazione, interpretazione, integrazione ed
esecuzione del regolamento contrattuale
La centralità dell’interesse ambientale, sottesa all’obbligatorietà degli
appalti verdi, impone una conformazione “ecologica” dell’autonomia negoziale
33
Così, M. PENNASILICO, Contratto e uso responsabile, cit., p. 767 ss.
34
E. NAVARRETTA, Luci e ombre nell’immagine del terzo contratto, in G. GITTI - G. VILLA (a cura
di), Il terzo contratto. L’abuso di potere contrattuale nei rapporti tra imprese, il Mulino, Bologna,
2008, p. 317, la quale, peraltro, reputa preferibile «affidarsi non tanto ad una moltiplicazione di
categorie isolate, quanto ad un approccio capace di declinare al plurale l’istituto del contratto, senza
trascurare la dimensione generale del sistema e l’attitudine delle clausole generali ad aggregare e a
conferire uno spirito coerente ed unitario alla molteplicità dei singoli sottosistemi» (p. 329). In
argomento, v. anche M. PENNASILICO, Contratto del consumatore e interpretazione, in Studi in
onore di Giovanni Iudica, Egea, Milano, 2014, p. 1041 ss., spec. p. 1046 ss.
35
Cfr., infra, § 9.
36
Similmente anche in M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 299.
37
La libertà contrattuale, secondo C.M. BIANCA, Contratto europeo e principio causalista, in M.
PARADISO (a cura di), I mobili confini dell’autonomia privata, Atti del Convegno di studi in onore
del Prof. C. Lazzara, Catania 12-14 settembre 2002, Giuffrè, Milano, 2005, p. 387 ss., spec. p. 402,
non può esercitarsi al fine di perseguire interessi contrastanti con l’utilità sociale (art. 41, comma
2, Cost.), sì che immeritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico saranno gli interessi
socialmente dannosi. La dannosità sociale deve ravvisarsi ogni qual volta il contratto miri a
pregiudicare beni o valori che la società riconosce come propri: l’ambiente, l’occupazione,
l’eguaglianza sostanziale, l’informazione, l’educazione, ecc. Devono, così, reputarsi nulli per
immeritevolezza degli interessi perseguiti «i contratti che, ad es., abbiano a programma il degrado
ambientale di una determinata zona» (p. 403). Per ulteriori svolgimenti, v. M. PENNASILICO,
Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 299 ss.
14RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI -
ANNO 2017/NUMERO 1
e tende a “funzionalizzare” il rapporto tra contratto e diritto dell’ambiente: il
primo diventa funzionale alla realizzazione degli obiettivi del secondo, con
conseguenze rilevanti sulla formazione, interpretazione, integrazione ed
esecuzione del contratto ecologico.
Nella prima fase, quella di formazione del contratto, assume particolare
rilievo l’individuazione discrezionale di specifiche tecniche (art. 68 c. app.), che
consente all’ente aggiudicatore di prescrivere che i concorrenti adottino un
determinato metodo di produzione o di gestione ambientale, facendo ricorso (ex
art. 69 c. app.) anche a sistemi di ecoetichettatura (il più noto dei quali è il
marchio di qualità ecologica dell’Unione europea, Ecolabel)38.
Nella fase dell’interpretazione, le peculiarità del diritto degli appalti
pubblici, pervaso dal dato oggettivo dell’interesse pubblico 39 , consentono di
valorizzare, come criteri primari d’interpretazione ecologicamente orientata degli
appalti “verdi”, la buona fede oggettiva (art. 1366 c.c.), la conservazione degli
effetti (art. 1367 c.c.) e l’interpretazione funzionale del contratto (art. 1369 c.c.):
la prima impedisce all’impresa appaltatrice di abusare del proprio potere di
mercato a danno di concorrenti e consumatori40; la seconda, ogni qual volta siano
possibili due interpretazioni delle clausole contrattuali, una conforme ai principi
che tutelano l’ambiente, l’altra contraria, induce a preferire la soluzione che
assicuri la salvezza del contratto e dei suoi effetti ecologici41; la terza permette di
risolvere la plurivocità del testo contrattuale nel senso più conveniente alla
protezione dell’interesse ambientale o al miglioramento dell’efficienza
energetica42.
38
L’adozione di etichette o marchi ecologici, che consentono di comparare le prestazioni
ambientali di prodotti diversi dello stesso genere, vale, nelle parole della Commissione europea, a
«indurre il mercato a lavorare per l’ambiente» [Commissione CE, COM(2001) 31, sul Sesto
programma di azione per l’ambiente della Comunità europea «Ambiente 2010: il nostro futuro, la
nostra scelta», p. 15]; funzionalizzazione, questa, che mostra come gli interessi ambientali debbano
considerarsi non necessariamente antitetici o antagonisti al mercato (così, M. PENNASILICO,
Contratto e promozione, cit., p. 258; v. anche B. POZZO, Le nuove regole dello sviluppo: dal diritto
pubblico al diritto privato, in Benessere e regole dei rapporti civili, cit., p. 71 ss., spec. p. 84 ss.).
39
Cfr., anche per ulteriore bibliografia, M. PENNASILICO, L’ermeneutica contrattuale tra pubblico
e privato, in Contratti, 2014, p. 187 ss., spec. p. 193.
40
In tal senso, M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 301.
41
Così, M. PENNASILICO, Contratto e promozione, cit., p. 258 ss.; ID., Sviluppo sostenibile, legalità
costituzionale, cit., p. 492 ss.
42
Cfr. G. BELLANTUONO, I contratti dell’energia: mercato al dettaglio; fonti rinnovabili; efficienza
energetica, in V. ROPPO - A.M. BENEDETTI (a cura di), Mercati regolati, in Tratt. contr. Roppo,
vol. V, Giuffrè, Milano, 2014, p. 1363 ss., spec. p. 1397; S. TRINO, Il contratto di rendimento
15RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI -
ANNO 2017/NUMERO 1
Con riguardo all’integrazione del contratto, la Corte di Cassazione ha
riconosciuto, entro determinati limiti, il potere dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas di (etero)integrazione del contratto di somministrazione di energia
elettrica43, affinché il sistema tariffario, secondo il dettato dell’art. 1, comma 1,
della legge n. 481 del 1995, istitutiva dell’Autorità, armonizzi «gli obiettivi
economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di
carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse».
Quanto all’esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti possono
esigere, ai sensi dell’art. 100 c. app., condizioni particolari legate anche a
esigenze ambientali (quali il recupero, il riciclaggio o il riutilizzo dei materiali
adoperati dall’appaltatore), purché siano compatibili con il diritto europeo e i
principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, innovazione e siano indicate nel bando di gara, nell’invito o nel
capitolato d’oneri44.
7. Il contratto ecologico come strumento di godimento e gestione
condivisa di beni comuni e fonte di rapporti giuridici patrimoniali sostenibili
L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, fin qui abbozzata, consente
di cogliere, da un lato, che la funzione del contratto si evolve dalla tradizionale
funzione di scambio o circolazione di beni individuali a quella di godimento e
gestione condivisa di beni comuni45, sì che il contratto ecologico è uno strumento
energetico. Il tipo contrattuale nella prospettiva del diritto privato regolatorio, in Annuario di
Diritto dell’energia, 2016, Politiche pubbliche e disciplina dell’efficienza energetica, a cura di L.
Carbone - G. Napolitano - A. Zoppini, il Mulino, Bologna, 2016, p. 393 ss., spec. p. 404.
43
Cass. 27 luglio 2011, n. 16401, in Rass. dir. civ., 2012, p. 896 ss., con nota di M. ANGELONE,
Poteri regolatori dell’Aeeg e integrazione dei contratti di somministrazione di energia elettrica;
Cass. 30 agosto 2011, n. 17786, in www.iusexplorer.it; Cass., ord., 8 novembre 2012, n. 19333, in
Corriere giur., 2013, p. 603 ss., con nota di M. GRONDONA, Integrazione del contratto di utenza
tramite delibera dell’autorità per l’energia elettrica e il gas: un problema (ancora) aperto; Cass.
31 ottobre 2014, n. 23184, in www.iusexplorer.it; Cass. 31 agosto 2015, n. 17301, ivi; Cass. 2
febbraio 2016, n. 1906, ivi; in argomento, v. anche M. GRONDONA, Poteri dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas e integrazione del contratto di utenza (problemi di ermeneutica
contrattuale in margine a una recente casistica), in Annuario del contratto 2012, diretto da A.
D’Angelo - V. Roppo, Giappichelli, Torino, 2013, p. 38 ss.
44
Cfr. M. PENNASILICO, Contratto e promozione, cit., p. 259 ss.
45
Cfr. A. NERVI, Beni comuni e ruolo del contratto, in Rass. dir. civ., 2014, p. 180 ss.; ID., Beni
comuni, ambiente e funzione del contratto, ivi, 2016, p. 418 ss., e in M. PENNASILICO (a cura di),
Contratto e ambiente, cit., p. 35 ss.
16RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI -
ANNO 2017/NUMERO 1
preordinato non tanto a scambiare utilità tra soggetti portatori di interessi
antagonisti, quanto piuttosto a regolare il concorso di una pluralità di interessi
necessariamente convergenti alla protezione dell’ambiente e delle generazioni
future 46 ; dall’altro, che la nozione stessa di contratto (art. 1321 c.c.) è
insufficiente, se non integrata dai principi di solidarietà e di sostenibilità nell’uso
responsabile delle risorse naturali, sì che il contratto oggi è fonte non
semplicemente di rapporti giuridici patrimoniali, ma di rapporti giuridici
patrimoniali sostenibili47.
Il nesso tra patrimonialità e sostenibilità testimonia la coesistenza, nella
regola contrattuale, di interessi patrimoniali e interessi non patrimoniali
(esistenziali, sociali e ambientali); coesistenza che, nel contratto ecologico, non
è meramente eventuale (come si desume dall’art. 1174 c.c.), ma è necessaria e
indissolubile48.
8. L’analisi “ecologica” del diritto privato contrattuale: attività
d’impresa e mercato agroalimentare
In questa prospettiva, sempre più ampio è lo spazio che lo sviluppo
sostenibile guadagna anche nei rapporti contrattuali di diritto privato, al punto da
proporsi di sostituire alla definizione comune di «appalto pubblico verde» (Green
46
Così, M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 302.
47
In questi termini, già M. PENNASILICO, Contratto e uso responsabile, cit., p. 768, e ID., Sviluppo
sostenibile, legalità costituzionale, cit., p. 493. Diversamente, ma in una logica di segno mercantile,
che patrimonializza “a cascata” l’ambiente, sovrapponendo il mezzo (la valutazione di convenienza
economica) al fine (la tutela ambientale), S. PAGLIANTINI, Sul c.d. contratto ecologico, cit., p. 367
ss. Le argomentazioni dell’A., volte a dimostrare che il “contratto ecologico”, «se da un lato è
percorso da un valore non patrimoniale che talora ne indirizza la funzione, dall’altro, col fatto di
operarne una sussunzione incipiente, nella sostanza lo patrimonializza» (p. 379), sembrano
contraddette dal confronto con il laboratorio del diritto europeo dei contratti, nel quale «il requisito
della patrimonialità è ignorato del tutto» (U. BRECCIA, Contratto e comune quadro europeo. Note
introduttive, in Annuario del contratto 2009, diretto da A. D’Angelo - V. Roppo, Giappichelli,
Torino, 2010, p. 38, con riferimento all’art. II.-1:101 del DCFR, a norma del quale il contratto è un
accordo diretto a produrre un rapporto giuridico o qualche altro effetto). L’A. intravede, altresì, nel
“contratto ecologico”, inteso come fattispecie costitutiva di rapporti patrimoniali ecosostenibili,
«una (lodevole) provocazione argomentativa più che l’avvio di una riconcettualizzazione
categoriale» (p. 372 ss.), «un’espressione raffinata ma predicata di un valore soltanto descrittivo»
(p. 381), che si presta, al più, «ad un esercizio di dépouissiérage delle categorie tradizionali» (p.
382). Condivide, invece, l’esigenza della «riconcettualizzazione delle categorie civilistiche», N.
LIPARI, Intorno ai «principi generali del diritto», in Riv. dir. civ., 2016, p. 28 ss., spec. p. 31, nota
17 (ora in ID., Il diritto civile tra legge e giudizio, Giuffrè, Milano, 2017, p. 83 ss.).
48
Così, M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 303.
17RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI -
ANNO 2017/NUMERO 1
Public Procurement) quella onnicomprensiva di «appalto sostenibile»
(Sustainable Procurement)49.
Con riguardo all’attività d’impresa, non può sfuggire che lo statuto delle
imprese (legge 180/2011) mira, tra le varie finalità, a promuovere l’inclusione
delle tematiche ambientali «nello svolgimento delle attività delle imprese» (art.
1, comma 5, lett. d). Si riconosce, così, che l’interesse ambientale è un limite
interno all’attività d’impresa50, al punto che la teoria dell’imprenditore e la stessa
nozione di imprenditore (art. 2082 c.c.) si arricchiscono di valori e contenuti
nuovi51, nel segno della sostenibilità ambientale e della contrattazione ecologica
quale fonte di rapporti patrimoniali ecosostenibili, come testimonia la nuova
disciplina dell’impresa sociale (d.lgs. 112/2017), che annovera tra le attività
d’impresa di interesse generale quelle aventi a oggetto «interventi e servizi
finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali» (art. 2, comma 1, lett.
e, d.lgs. cit.)52.
Ancora, nei contratti di affiliazione commerciale (legge 129/2004)
l’impresa affiliante può mettere a disposizione degli affiliati il proprio know-how
in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e prevedere, nel codice di
condotta, il rispetto da parte degli affiliati stessi di standard di ecosostenibilità
(c.d. green franchising)53; mentre nei contratti di fornitura a imprese il fornitore
può vincolarsi a standard di produzione ispirati a criteri di sostenibilità54. Ed è
49
Cfr. M. PENNASILICO, Contratto e uso responsabile, cit., p. 766. Del resto, la comunicazione della
Commissione CE, COM(2008) 400, «Appalti pubblici per un ambiente migliore», riconosce al GPP
la funzione di «stimolare l’applicazione di norme verdi negli appalti privati» (p. 3). I criteri
adoperati per individuare e promuovere merci «più verdi» presuppongono, nelle parole della
Commissione, «un approccio basato sul ciclo di vita e comprendono elementi che riguardano tutta
la catena di approvvigionamento, dall’utilizzo di materie prime e metodi di produzione ai tipi di
imballaggio utilizzati e al rispetto di talune condizioni di ritiro. Tali criteri possono applicarsi anche
agli appalti privati. Gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sono incoraggiati a rafforzare il
collegamento fra settore pubblico e privato in materia di acquisti verdi» (p. 12). Per un rilevante
esempio di tale collegamento, si veda il Mayor of London’s Green Procurement Code (Codice del
sindaco di Londra sugli appalti verdi) all’indirizzo www.greenprocurementcode.co.uk/.
50
M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 305.
51
Cfr. G. MEO, Luce europea sul diritto d’impresa, in R. FONTOLAN - A. ALTINA (a cura di), Lo
Statuto delle imprese, Retecamere, Roma, 2012, p. 24 ss., spec. p. 28.
52
Cfr. M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 305, con riferimento
alla disciplina previgente (d.lg. 155/2006).
53
Cfr. S. LANDINI, Clausole di sostenibilità, cit., p. 357.
54
Si veda S. LANDINI, Contratti di assicurazione contro la responsabilità civile automobilistica e
sostenibilità, in S. LANDINI - A. VENCHIARUTTI - P. ZIVIZ (a cura di), Sfide e novità nel diritto della
18RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI -
ANNO 2017/NUMERO 1
proprio in osservanza di tali criteri che, nelle associazioni di professionisti o di
imprese, gli associati s’impegnano sovente ad agire, pena l’impossibilità di
acquisire la qualità di socio o la revoca della stessa, laddove, in altri casi, gli
statuti sanciscono sanzioni premiali legate al rispetto di condizioni di
sostenibilità55.
In questa logica, il contratto di rete56 può essere considerato il punto di
emersione di un fenomeno più ampio, ossia la gestione con strumenti contrattuali
delle interdipendenze economiche e ambientali che legano una pluralità di
imprenditori. Non si tratta semplicemente di ottimizzare i tradizionali cicli
produttivi, ma di investire nella trasformazione degli stessi per costruire nuove
filiere o aumentare la capacità di competere nei mercati anche stranieri, come
accade, ad esempio, nel settore dell’energia alternativa57, investito da innovazioni
tecnologiche “verdi”, o nel settore agroalimentare58, espressione di un’agricoltura
sostenibile e durevole, destinata a combattere il degrado dell’ambiente e i
mutamenti climatici59.
assicurazione contro la responsabilità civile automobilistica, ESI, Napoli, 2016, p. 99 ss., spec. p.
103.
55
Così, S. LANDINI, Clausole di sostenibilità, cit., p. 356 ss., con riguardo al «riconoscimento di
premi a favore dei soci che abbiano raggiunto un livello alto di conformità a standard di sostenibilità
ambientale»; sul punto, v. anche EAD., Travel and Tourism Contracts. Design of Sustainable
Tourism Systems, Antezza, Matera, 2013, p. 151 ss., spec. p. 160 ss.
56
Con tale contratto, concepito dal legislatore italiano come contratto plurilaterale con comunione
di scopo, più imprenditori «perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente,
la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla
base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura
industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più
attività rientranti nell’oggetto della propria impresa» (art. 3, comma 4-ter, d.l. 5/2009, convertito in
legge 33/2009). Sull’evoluzione della figura, cfr. C. CREA, Reti contrattuali e organizzazione
dell’attività d’impresa, ESI, Napoli, 2008; F. CAFAGGI (a cura di), Il contratto di rete.
Commentario, il Mulino, Bologna, 2009; P. ZANELLI, Reti e contratto di rete, CEDAM, Padova,
2012; F. BRIOILINI - L. CAROTA - M. GAMBINI (a cura di), Il contratto di rete. Un nuovo strumento
di sviluppo per le imprese, ESI, Napoli, 2013.
57
Sul punto, v. G. BELLANTUONO, Le reti di imprese nel settore dell’energia, in Merc. conc. reg.,
2013, p. 299 ss.; G. TUCCI - C.O. FALCONE, Applicazione del contratto di rete al settore delle
energie alternative, in A. GENOVESE (a cura di), Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici
e fiscali, Cacucci, Bari, 2013, p. 215 ss.; M. PENNASILICO, Contratto di rete ed energie rinnovabili,
in ID. (a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, cit., p. 232 ss.
58
Cfr. L. RUSSO, Il contratto di rete in agricoltura, in Riv. dir. civ., 2015, p. 181 ss.
59
Cfr. A. JANNARELLI, Cibo e diritti. Per un’agricoltura sostenibile, Giappichelli, Torino, 2015,
spec. p. 49 ss., il quale nota che «il nuovo diritto agrario si delinea come eco-oriented ossia nella
prospettiva, in definitiva, di coniugare il right to food con la green economy» (p. 183).
19Puoi anche leggere