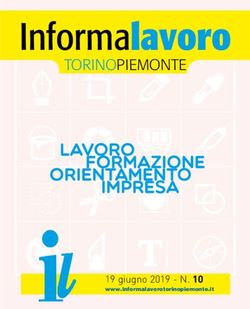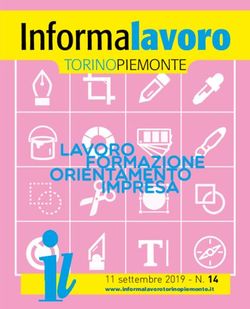PRE-PRINT Studi italiani di Linguistica Teorica e Applicata 2020, 49/3 ELWYS DE STEFANI, KU Leuven DANIELA VERONESI, Libera Università di Bolzano ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
PRE-PRINT
Studi italiani di Linguistica Teorica e Applicata 2020, 49/3
ELWYS DE STEFANI, KU Leuven
DANIELA VERONESI, Libera Università di Bolzano
DAGLI STUDI SUL PARLATO ALLA LINGUISTICA INTERAZIONALE. RICERCHE
SULL’USO ORDINARIO DELLA LINGUA ITALIANA
La lingua parlata serve agli usi comuni, si usa sol tra i presenti,
si adopera in cose che direttamente e immediatamente
interessano, non si prefigge che l’intelligenza degli ascoltanti, e
l’effetto; non è preceduta da pensamento e dall’arte; il piacere,
che può derivarne in chi l’ascolta, è talora la conseguenza, ma
non l’oggetto e ’l fine primario di chi favella.
(Cesarotti 1785 (1969), I: 3)
ABSTRACT: This article provides an overview of the research traditions that shaped current
interactional research in Italian linguistics. It discusses different ways in which talk-in-interaction has
been conceptualised, starting from the early writings in Romance philology and its subfields and then
focusing especially on Leo Spitzer’s pioneering work, which was consigned to oblivion for decades in
the Italian-speaking world. The article carves out the impact disciplines such as sociology and
anthropology had on the establishment of interaction as an object of investigation. Finally, it offers a
brief historical and epistemological account of conversation analysis and interactional linguistics, and
presents a synopsis of studies carried out in and on Italian.
KEYWORDS: Italian, spoken language, talk-in-interaction, historical overview
PAROLE CHIAVE: italiano, parlato, lingua-in-interazione, inquadramento storico
L’oggetto di studio della linguistica interazionale, emersa in area anglosassone verso la fine del
secondo millennio, è la lingua parlata-in-interazione. Due sono le dimensioni che si incrociano
in questa descrizione, la lingua parlata (parlato, parlare, oralità, ecc.), un oggetto di ricerca
che si inserisce naturalmente negli studi filologici e linguistici, e l’interazione, riconosciuta
come fenomeno di studio da sociologi e antropologi. I paragrafi che seguono forniscono un
inquadramento epistemologico che evidenzia i lavori precursori sul tema, per poi illustrare i
principi teorici e metodologici della linguistica interazionale.1
1. DAL PARLATO AL PARLARE
In ambito italiano, l’interesse per il parlato è strettamente legato alla nascita della filologia
romanza, che si è soliti far combaciare con la pubblicazione della Grammatik der
romanischen Sprachen (Diez, 1836-1843). In particolare, la necessità di studiare il parlato è
rivendicata da dialettologi come Ascoli, che proprio a Diez dedica il primo volume
dell’Archivio Glottologico Italiano (1873). È una rivendicazione che consolida i metodi
sviluppati dai dialettologi e studiosi di lingue romanze e che permette loro di posizionarsi,
1
Il presente articolo è frutto del lavoro congiunto dei due autori; Elwys De Stefani è direttamente responsabile
dei paragrafi 1 e 3, mentre Daniela Veronesi si è occupata nello specifico dei paragrafi 2 e 4. Gli autori
desiderano ringraziare Carla Bazzanella per i suoi preziosi commenti ad una prima versione di questo articolo.talora con toni polemici, nei confronti dei neogrammatici, allora in auge (v. Schuchardt, 1885). Si oppone all’atomismo attribuito ai neogrammatici anche l’approccio Wörter & Sachen (cfr. Meringer, 1904; Schuchardt, 1912), che ebbe nell’Atlante italo-svizzero (AIS) (Jaberg e Jud, 1928-1940) la sua magistrale applicazione. A ben vedere, contrariamente a quanto spesso si legge, i neogrammatici assegnavano un ruolo centrale non solo alla lingua parlata, ma anche alla reciprocità degli scambi verbali. Così, secondo Paul (1880: 28), “il vero oggetto del linguista sono […] piuttosto tutte le espressioni dell’attività linguistica, in tutti gli individui, nella loro reciprocità”2 (v. Auer, 2015). Nella stessa epoca, un impulso fondamentale giunge da un’altra disciplina emergente, la fonetica, che si deve confrontare con importanti problemi pratici e metodologici relativi alla registrazione e alla trascrizione del parlato. Non sorprende, pertanto, che l’abate Rousselot (1897-1901) dedichi oltre cento pagine dei suoi Principes de phonétique expérimentale (pp. 61-174) alla descrizione dei dispositivi di registrazione della voce umana. È poi noto come proprio verso la fine dell’800 vi fosse la necessità di definire delle precise norme di trascrizione fonetica, che si materializzarono nell’alfabeto fonetico internazionale (IPA) la cui prima versione risale al 1888.3 Ciò a scapito di altre proposte, avanzate ad esempio nelle numerose pubblicazioni che Alexander Melville Bell4 consacrò al tema (ad es. Bell, 1867; v. anche Jespersen, 1889). Gran parte di questi primi lavori dedicati alla lingua parlata abbracciano una visione “monologica” del parlato, che fornisce il materiale empirico presentato e analizzato in dizionari, atlanti linguistici, ecc.5 Per contro, il primo studio che si interessa dell’italiano parlato in conversazione è dovuto a un altro grande romanista, Leo Spitzer, che nel 1922 pubblica il volume Italienische Umgangssprache. Sebbene accolto positivamente dai critici, il volume ha sofferto di una marcata disattenzione in area italiana, ove Spitzer, come ricorda Segre (2007: 8) nella presentazione della versione italiana del volume, era perlopiù “considerato l’iniziatore della stilistica letteraria o critica stilistica […]”. Lo studio di Spitzer si inserisce in una tradizione di pensiero che riconosce nell’uso colloquiale l’habitat naturale della lingua (v. già Cesarotti, 1785), particolarmente sentito in area tedesca. Per Wegener (1885: 182), ad esempio, “la lingua si fonda sullo scambio reciproco tra gli uomini”,6 mentre Wunderlich pubblica nel 1894 il volume Unsere Umgangsprache [sic!], che Spitzer prenderà a modello.7 Il termine Umgangssprache – per cui Tonelli (2007: 45) segnala la difficoltà di traduzione in italiano – è attestabile in tedesco nel ‘700: Takada (2012: 175) lo registra infatti nel 1751 nella forma analitica tägliche(n) Sprache des Umganges (‘lingua quotidiana 2 “Das wahre object für den sprachforcher sind […] sämmtliche äusserungen der sprachtätigkeit an sämmtlichen individuen in ihrer wechselwirkung auf einander”, traduzione nostra. 3 Ad opera della Dhi Fonètik Tîcerz’ Asóciécion, fondata a Parigi nel 1886, che nel 1897 diverrà l’Associazione Internazionale di Fonetica. 4 L’interesse per la lingua parlata di Alexander Melville Bell fu continuata dal figlio, Alexander Graham Bell, che, nel 1876, brevettò per primo un nuovo dispositivo per la trasmissione della voce umana, il telefono. 5 La monologicità dei dati presentati negli atlanti linguistici si configura, in sé, come una riduzione, ragionata, di di scambi interazionali verificatisi tra intervistatori e informatori. A questo proposito, i verbali delle inchieste svolte per l’Atlante Linguistico Italiano offrono una preziosa illustrazione dei problemi che i ricercatori riscontravano sul campo e del modo in cui essi contribuivano a costituire i dati linguistici (che, in quest’ottica, sono tutt’altro che ‘dati’); v. Massobrio et al. (1995). 6 “Die Sprache beruht auf dem Verkehr der Menschen untereinander […]”, traduzione nostra. 7 Oltre al rinvio alla Umgangssprache, si noterà anche che per il primo capitolo del proprio volume (Die Eröffnungsformen des Gesprächs) Spitzer sceglie lo stesso titolo che Wunderlich aveva usato nel secondo capitolo del suo lavoro.
dell’uso’), sottolineando come sin dalle prime attestazioni il termine venisse usato con
accezioni diverse che si riflettono anche nelle definizioni proposte dai rispettivi studiosi. Nel
suo Nuovo dizzionario italiano-tedesco e tedesco-italiano Antonini (21777) traduce Umgang
come ‘conversazione, amento, pratica, uso, usanza, usamento, bazzica.’, mentre Campe
(1811) definisce il termine Umgangssprache come ‘la lingua della vita comune, di cui ci si
serve nella pratica [Umgang] sociale (lingua della conversazione)’.8 Come risulta evidente,
ricorre in queste prime definizioni il rinvio alla conversazione, alla pratica, all’uso della
lingua nella concretezza dell’incontro sociale, che diventerà poi centrale negli studi di stampo
pragmatico e, ancor più, conversazionale che si affermeranno dopo quasi due secoli.
Il volume di Spitzer godette di maggiore attenzione tra gli intellettuali russi, che nello stesso
periodo sviluppavano un forte interesse per la lingua del dialogo, anche da un punto di vista
stilistico (cfr. Jakubinskij, 1923). Sia Vološinov (1929) che Bachtin (1929) rinviano infatti
esplicitamente all’Italienische Umgangssprache nelle loro descrizioni delle pratiche
dialogiche e interazionali. In effetti, nel volume di Spitzer l’interesse dell’autore per le
pratiche conversazionali è visibile sin dall’organizzazione dei capitoli, intitolati
rispettivamente Le forme di apertura della conversazione, Parlante e ascoltatore, Parlante e
situazione, Le forme di chiusura della conversazione.9 Basandosi largamente su dialoghi tratti
da pièce teatrali e romanzi, nonché sull’osservazione diretta dell’autore, Spitzer descrive lo
scambio conversazionale nella sua situatezza concreta, evidenziando le risorse linguistiche a
disposizione dei parlanti, la rilevanza sociale delle loro azioni, e persino il ricorso a modalità
non vocali, come lo sguardo e i gesti. La dimensione pionieristica di questo studio,
sottolineata anche da Caffi (2007), emerge chiaramente dai temi affrontati. Gli esempi sono
numerosi:10
▪ il volume si apre con una squisita riflessione sulle aperture di conversazioni
telefoniche (p. 2, n. 1/66, n. 2), un argomento che Schegloff (1967) tratterà nella sua
tesi di dottorato, vera pietra miliare dell’analisi conversazionale;
▪ un argomento centrale riguarda i rapporti riflessivi tra gli enunciati di due parlanti, in
particolare nella sequenza domanda/risposta, così cara agli analisti della conversazione
(v. la sezione Ineinandergreifen von Rede und Gegenrede, pp. 175-190/239-254);
▪ Spitzer identifica una serie di fenomeni caratteristici del parlato-in-interazione in parte
con termini tuttora usati nella Gesprächsforschung moderna,11 come a)
Selbstkorrektur ‘autocorrezione’ (p. 73/137; il fenomeno che Schegloff et al., 1977
chiameranno self-correction o self-repair), b) Nachtrag ‘aggiunta’ (p. 59/123; ovvero
l’aggiunta di materiale verbale dopo la fine possibile di una costruzione sintattica; cfr.
Auer, 1991); c) l’idea secondo la quale i parlanti producono i propri enunciati passo
dopo passo, stoßweise (‘a singhiozzo’, p. 58/122; pensiamo inevitabilmente alla teoria
8
“[D]ie Sprache des gemeinsamen Lebens, deren man sich im gesellschaftlichen Umgange bedient
(Conversationssprache)” cit. in Takada (2012: 189), traduzione nostra.
9
Die Eröffnungsformen des Gesprächs, Sprecher und Hörer, Sprecher und Situation, Die Abschlußformen des
Gesprächs. Nell’edizione italiana (2007), Livia Tonelli sceglie di tradurre il tedesco Gespräch con discorso.
Preferiamo conversazione, che sembra rendere meglio la dimensione ‘parlata’ presente nella voce tedesca e che
si giustifica anche in base alle attestazioni ottocentesche di Umgangssprache a cui abbiamo accennato.
10
Nelle indicazioni che seguono, il primo rinvio si riferisce all’edizione tedesca del volume di Spitzer, il
secondo a quella italiana.
11
Nella ricerca di lingua tedesca, con Gesprächsforschung si rinvia ad approcci che studiano la conversazione in
base a dati empirici, con metodi spesso ispirati all’analisi conversazionale.della grammatica emergente di Hopper, 1987 e all’online syntax di Auer, 2009); d) il
fenomeno dei turni incompiuti, o aposiopesi (p. 134/198; designedly incomplete
utterances per Koshik, 2002).
La modernità di Spitzer e il suo spirito pionieristico sono dunque innegabili;12 eppure, in area
italiana l’Italienische Umgangssprache per lunghi decenni verrà collocato nel dimenticatoio
della ricerca linguistica, fino alla pubblicazione, nel 2007, dell’edizione italiana tradotta da
Livia Tonelli e curata da Claudia Caffi e Cesare Segre. In effetti, è solo a partire dal 1967
(con il convegno della Società di Linguistica Italiana a Palermo, cfr. AA. VV., 1970) che in
Italia si osserva un interesse ritrovato per la lingua parlata, per quanto – e ciò è evidente
soprattutto negli atti del seminario sull’italiano parlato tenutosi a Firenze nel 1976 – gli aspetti
conversazionali fossero a quel tempo meno studiati rispetto a questioni di ordine
dialettologico e sociolinguistico, nonché pragmatico (AA. VV., 1977). Va inoltre rilevato
come gli studi sociolinguistici di Labov (1966), Fishman (1970) da un lato e quelli pragmatici
di Austin (1962) e Searle (1969) dall’altro abbiano trovato in Italia un terreno più fertile
rispetto alle ricerche di stampo conversazionale che cominciarono ad affermarsi negli Stati
Uniti sin dagli anni Settanta dello scorso secolo (Sacks et al., 1974) – con l’eccezione di
Orletti (1977) di cui diremo più avanti.
In quegli anni, tuttavia, un forte impulso per lo studio del parlato che oggi definiremmo
“conversazionale” venne da Giovanni Nencioni, che era docente a Firenze dal 1952 al 1974.
Con il suo appoggio, a partire dal 1965 Harro Stammerjohann cominciò a registrare
conversazioni spontanee e interviste, analizzate in diversi contributi (Stammerjohann, 1970,
1977); ne conseguì, tra l’altro, una riflessione critica sul concetto stesso di “italiano parlato”
presentata nel saggio magistrale di Nencioni (1976). Negli anni 1980 si assisterà poi a un
incremento notevole degli studi dedicati all’italiano parlato, che si inaugura con il volume Sul
parlato di Rosanna Sornicola (1981) e che si sviluppa su assi diversi, focalizzandosi su aspetti
pragmatici (Sbisà, 1978, 1989; Stati, 1982; Bazzanella, 1984), sociolinguistici (Berruto, 1985;
Holtus e Radtke, 1985), comparati (Koch e Oesterreicher, 1990) o interessandosi di fenomeni
specifici, come segnali discorsivi (elementi di articolazione per Stammerjohann, 1977,
connettivi per Bazzanella, 1986)13 così come la sintassi (Cresti, 1987) e il modo in cui essa si
intreccia con la prosodia (Voghera, 1992). La grande novità di questi studi (seppure non di
tutti) risiede anzitutto nel loro radicamento empirico. La commercializzazione di dispositivi di
registrazione audio portatili ed economici, a partire dagli anni 1960, offrì ai ricercatori la
possibilità di registrare il parlato nelle sue varie manifestazioni, di fissare la fugacità della
parola. Essi potevano quindi riascoltare, trascrivere e sottoporre le loro analisi al giudizio di
altri (v. Sacks, 1992, I: 622). Così, molti lavori di quegli anni si distinsero per le descrizioni
accurate delle caratteristiche ‘formali’ (lessicali, sintattiche, prosodiche, ecc.) della lingua
parlata, spesso trascurando però la dimensione azionale e situata della parola. Non a caso, lo
stesso Nencioni avverte che:
12
Come scrive Segre (2007: 9): “Se le grosse novità presenti in Lingua italiana del dialogo possono essere ben
percepite solo ora, è perché Spitzer in questo volume ha precorso i tempi.”
13
La denominazione “connettivi” avanzata da Bazzanella (1986) è stata poi rivista, nello sviluppo della sua
ricerca, in phatic connectives, pragmatic markers, segnali discorsivi e discourse markers (v. ad es. Bazzanella,
2006, 2015).“[...] bisogna muovere, nello studio del parlato, dalla teoria dell’interazione verbale, cioè dall’atto linguistico in situazione concreta, condizionato da presupposizioni conoscitive linguistiche ed estralinguistiche, dal ricorso a codici diversi da quello verbale (gestualità, visività, prossemicità), dal concorso dell’interlocutore uno o plurimo, dalla tecnica e regia del colloquio, dagli scopi ed effetti perlocutivi.” (Nencioni, 1986: 178) Emerge da queste righe una critica del “parlato”14 studiato indipendentemente dalla situazione comunicativa in cui si manifesta. Infatti, come è evidente, gli interattanti useranno risorse (lessicali, sintattiche, comunicative) diverse in interviste, esperimenti map task, incontri di servizio, colloqui di lavoro, ecc; proprio per questo motivo risulta fondamentale collegare l’analisi della lingua usata con l’analisi delle attività sociali in cui gli individui si impegnano. Si passa allora, da un uno studio sul “parlato” (Berretta, 1994) alla ricerca che si concentra sul “parlare” come pratica sociale. È quanto propone Duranti (1992) nel volume Etnografia del parlare quotidiano. La scelta dell’autore di richiamarsi al “parlare” è significativa, poiché sottolinea la processualità dell’uso della lingua, “la natura cosiddetta emergente, in fieri, delle strutture linguistiche e di quelle socio-culturali” (Duranti 1992: 17), una dimensione evidenziata anche da Zorzi Calò (1990), Bazzanella (1994), e, in ambito psicologico, da Mininni (2000).15 2. LINGUA E COMUNITÀ La centralità delle pratiche linguistiche e interazionali nel costituirsi delle comunità emerge anche dagli studi di orientamento antropologico e sociologico nel corso del Novecento. Un secolo prima, si assiste alla nascita dell’indoeuropeistica (v. Bopp, 1816), che si manifesta nei lavori comparativi volti a ricostruire il proto-indoeuropeo e a classificare le lingue che ne sono derivate. Nella seconda metà dell’Ottocento si insinuò gradualmente l’idea secondo la quale le lingue indoeuropee fossero superiori e ben presto le ‘lingue superiori’ vennero equiparate a ‘culture superiori’ (v. Cardona, 1976: 47-53). Non sorprende, pertanto, che molti studi antropologici dell’epoca, peraltro spesso compiuti a tavolino, fossero volti a classificare le “razze”, a studiare i “selvaggi”, reificando in tal modo il concetto di “razza”, visto come criterio di “naturale” diseguaglianza. Questa visione comparativa, volta a classificare lingue e culture in base a criteri “genetici” si scontrò, a partire dai primi anni del Novecento, con una visione opposta, secondo la quale è attraverso le pratiche comunicative dei membri di una società che essi costituiscono rapporti sociali. La centralità della lingua e dell’interazione nella costituzione dell’ordine sociale affiora negli scritti di vari ricercatori, prevalentemente di ambito antropologico e sociologico, come si illustrerà qui di seguito. 2.1. Antropologia Franz Boas, che combattè attivamente l’evoluzionismo e l’ineguaglianza razziale, fu senz’altro uno dei critici più influenti del metodo comparativo. Nei suoi studi sulle lingue di 14 Per le varie accezioni con cui sono stati usati i termini “parlato” e “oralità”, rinviamo a Voghera (1992: 13- 49). 15 In Italia, la ricerca sul parlato s’intensificerà a partire dal 2000, grazie a iniziative come il convegno sulla “comunicazione parlata” (tenutosi per la prima volta a Napoli nel 2003, e giunto nel 2018 alla sesta edizione).
area americana, la ricerca sul campo e la descrizione accurata e situata dei materiali (orali e documentari) costituirono i capisaldi del suo metodo. Nell’introduzione al suo Handbook of American Indian Languages (1911), Boas descrive non solo la necessità di studiare la lingua come pratica culturale, ma offre anche riflessioni riguardo ai problemi pratici che si pongono al ricercatore che voglia raccogliere dati linguistici; fu pionieristica anche la sua ricerca sui nomi di luogo dei Kwakiutl (oggi detti Kwakwaka’wakw), che vivono nella parte settentrionale dell’isola di Vancouver (Boas, 1934). Le ricerche di Boas rimasero tuttavia largamente ignorate dai linguisti dell’epoca. Gli studi di Bronisław Malinowski godettero invece, anche se non immediatamente, di maggiore attenzione da parte dei linguisti. Se oggi viene comunemente considerato il “padre” di quella che poi sarà nota come osservazione partecipante (un metodo a cui si ispireranno anche alcuni sociolinguisti; cfr. Milroy, 1980), ciò è anche una conseguenza della facilità con cui Malinowski riuscì a imparare la lingua delle comunità studiate e quindi a partecipare alla vita delle comunità. Ciò gli permise di sottolineare la necessità di fare antropologia dal punto di vista delle comunità studiate, adottando quella che oggi chiameremmo una prospettiva emica (Malinowski, 1922). La riflessione approfondita sui metodi di ricerca sul campo ha fatto sì che furono proprio gli antropologi i primi a sperimentare le possibilità di registrazione filmica prima, poi video.16 Ma il contributo che più ha influenzato il pensiero di molti linguisti è stato senz’altro il suo saggio The problem of meaning in primitive languages in cui l’autore descrive la comunione fatica come “un tipo di parlato in cui legami di unione sono creati attraverso il semplice scambio di parole” (Malinowski, 1923: 315).17 È noto come Jakobson (1960) abbia ripreso da Malinowski l’idea della funzione fatica del linguaggio e come molti studiosi di small-talk si riferiscano proprio al saggio di Malinowski come prima testimonianza di un parlato volto in primo luogo a mantenere rapporti sociali (ad es. Coupland, 2000; De Stefani e Horlacher, 2018). Nello stesso saggio, Malinowski enfatizza anche il rapporto che lega l’uso del linguaggio alla situazione comunicativa, rendendo necessaria un’analisi situata, che tenga conto del contesto in cui si svolge l’interazione: “La considerazione degli usi linguistici associati a qualsiasi attività, ci porta a concludere che la lingua, nel suo focus primitivo, dovrebbe essere vista e studiata sullo sfondo delle attività umane e come un modo di comportamento umano in circostanze pratiche.”18 (Malinowski, 1923: 312) L’importanza che riveste il linguaggio nell’esperienza sociale umana è esibita nel nome di una disciplina emersa nel secolo scorso, l’antropologia linguistica, nota anche come etnolinguistica (Cardona, 1976), che si avvale di pratiche etnografiche (Duranti, 1992) per studiare i rapporti tra uso del linguaggio e l’essere-in-società (Duranti, 2007). 2.2. Sociologia 16 Il primo film etnografico è realizzato da Alfred C. Haddon nel 1898 nelle isole dello stretto di Strait. Negli anni 1930, Gregory Bateson e Margaret Mead, pinoieri dell’antropologia visuale, analizzano sequenze filmate a Bali e nella Nuova Guinea (v. Mondada, 2006: 315, n. 2). 17 “[…] a type of speech in which ties of union are created by a mere exchange of words”, traduzione nostra. 18 “[T]he consideration of linguistic uses associated with any practical pursuit, leads us to the conclusion that language in its primitive focus ought to be regarded and studied against the background of human activities and as a mode of human behaviour in practical matters”, traduzione nostra.
La centralità del contesto si manifesta anche nella ricerca sociologica dei primi decenni del ‘900, in particolare nei lavori svolti dalla cosiddetta scuola di Chicago. L’importanza che ricercatori come Robert Ezra Park, William Isaac Thomas, Ernest W. Burgess e Florian Znaniecki (tra molti altri) assegnavano alla ricerca sul campo, al rispetto dell’ecologia particolare in cui si iscrive ogni attività sociale, e alla prospettiva emica iscrive i loro lavori nella continuità della ricerca antropologica, e posiziona la sociologia come una disciplina empirica, interessandosi anche di argomenti come la criminalità, l’alcolismo, la povertà. È un approccio che influenzò il grande sociologo canadese, Erving Goffman, che fu decisivo nel consolidare l’interazione come oggetto di studio nelle scienze sociali e umane.19 Numerosi i suoi contributi destinati a lasciare tracce indelebili anche nella ricerca linguistica; il suo modello drammaturgico (Goffman, 1959), ad esempio, definisce l’individuo in società come un attore in scena che si muove nei luoghi di ribalta o nel retroscena, riconoscendo nell’interazione faccia a faccia l’oggetto privilegiato per l’analisi del “sé” (self). In linguistica, la teoria della cortesia ne trarrà la nozione di faccia (v. Brown e Levinson, 1987). Le sue riflessioni sull’interazione nello spazio pubblico (Goffman, 1963, 1971) lo porteranno a distinguere l’interazione non focalizzata, che si verifica quando persone co- presenti si limitano a esibire disattenzione civile per l’altro (“civil inattention”), dall’interazione focalizzata, definita da un focus di attenzione condiviso. Il passaggio dall’interazione non focalizzata all’interazione focalizzata si configura, insomma, come superamento della disattenzione civile, come apertura dell’incontro sociale per cui persone co-presenti diventano co-partecipanti (v. De Stefani e Mondada, 2018). Decisivo per la linguistica, tra molti altri contributi, l’ultimo volume pubblicato da Goffman, Forms of Talk (1981),20 in cui lo studioso sottopone a un’analisi accurata i ruoli del “parlante” e del “ricevente” che nei modelli di comunicazione precedenti (ad es. Jakobson, 1960) venivano dati per scontati. Le analisi di Goffman, che si basano per lo più sull’osservazione diretta, non registrata, hanno elevato l’interazione sociale quotidiana a oggetto di studio scientifico. Un altro sociologo influente, poiché aprirà la strada all’etnometodologia, è Alfred Schütz. Sarà proprio l’impostazione fenomenologica dei suoi studi, così come l’interesse del sociologo per l’esperienza sociale ordinaria, a renderlo attraente agli occhi di Harold Garfinkel, stimolando la nascita dell’etonometodologia e dell’analisi conversazionale, come spieghiamo nel paragrafo che segue. 3. ANALISI CONVERSAZIONALE Le origini epistemologiche dell’analisi conversazionale sono radicate nell’etnometodologia, un approccio in forte contrasto con la sociologia americana dell’epoca, cioè una “sociologia particolare” (Fele, 1999) che Harold Garfinkel propone nel volume Studies in Ethnomethodology (1967). Ispirandosi alla fenomenologia nella sua espressione sociologica (Schütz, 1932) e filosofica (Husserl, 1935; Wittgenstein, 1953 tra altri), Garfinkel opera una svolta radicale nei confronti del funzionalismo allora imperante nella sociologia americana e 19 Goffman diresse inizialmente anche la tesi di Harvey Sacks (v. § 2.3.), che però fu conclusa nel 1966 sotto la direzione di Aaron Cicourel, a causa dei dubbi di Goffman nei confronti del metodo di Sacks (cfr. Schegloff, 1992: xxiv, n. 18). 20 Sarà Franca Orletti a curare la traduzione italiana del volume, pubblicata con il titolo Forme del parlare. Bologna: il Mulino, 1987.
di cui Talcott Parsons, relatore della tesi di dottorato di Garfinkel, era uno dei maggiori esponenti. All’analisi formale dell’ordine sociale di Parsons, Garfinkel oppone una sociologia basata sull’osservazione empirica, volta a studiare i metodi che i membri di una comunità pongono in essere nel costituire l’ordine sociale, e nel cui raggio d’interesse principale si trovano le pratiche degli individui, che sono metodiche, pubbliche e rendicontabili (“accountable”). Harvey Sacks conobbe Garfinkel nel 1959 alla Harvard University, dove seguiva un seminario di Parsons (v. Schegloff, 1992: xiii), e a partire dal 1963 Sacks e Garfinkel applicarono i principi dell’indagine etnometodologica a dati conversazionali, analizzando le chiamate telefoniche al Los Angeles Suicide Prevention Center. I dati telefonici permisero ai due studiosi di analizzare, in modo dettagliato, le pratiche con cui gli interattanti costruiscono l’ordine sociale, localmente, servendosi di un’unica modalità, ovvero la voce; l’interesse primario, va ricordato, era puramente sociologico e consisteva nell’analizzare il modo in cui gli interattanti producono, parlando, azioni socialmente rilevanti. Fu però Emanuel A. Schegloff, nella sua tesi di dottorato del 1967, a proporre una prima analisi basata su una collezione sistematica di estratti – nel caso specifico, oltre 500 occorrenze di aperture telefoniche –, che gli permise di illustrate l’organizzazione sequenziale del parlato-in-interazione. Sin dai primi lavori, insomma, Sacks e Schegloff analizzano problemi sociologici basandosi sull’osservazione di pratiche linguistiche. L’empirismo radicale dell’analisi conversazionale contrastava però non solo con la ricerca sociologica contemporanea, ma anche con gli approcci linguistici dominanti all’epoca, in primis con la grammatica generativa di Chomsky (1965), ma anche con la teoria degli atti linguistici di Austin (1962) e Searle (1969). Consapevoli dell’essenziale novità che rappresentava il loro approccio, i pionieri dell’analisi conversazionale si rivolsero quindi a un pubblico di linguisti: l’articolo programmatico di Sacks, Schegloff e Jefferson (1974) sarà pubblicato in una delle riviste più prestigiose del campo, Language, e avrà un impatto immediato e considerevole sui linguisti americani ed europei, stabilendo la conversazione come oggetto di studio linguistico. Anche in Italia, di lì a poco, sarebbero affiorate, in parte parallelamente all’analisi della lingua parlata (cfr. § 1) i primi studi sulla conversazione. Durante l’VIII Congresso internazionale di studi della Società Linguistica Italiana, tenutosi a Bressanone nel 1974, Franca Orletti avrebbe infatti proposto una comunicazione intitolata Problemi di analisi conversazionale (Orletti, 1977), introducendo in tal modo il nuovo paradigma nella (socio)linguistica italiana. 3.1. Una precisazione terminologica Negli studi di lingua italiana si nota un’oscillazione terminologica che interessa proprio il nome della disciplina che fornisce gli strumenti metodologici alla linguistica interazionale – di cui si tratterà nel successivo paragrafo –, indicata talora come analisi conversazionale, talora come analisi della conversazione. Se analisi conversazionale è l’etichetta che Orletti (1977) sceglierà per presentare l’approccio ai colleghi linguisti, i sociologi etnometodologici italiani preferiranno analisi della conversazione (Fele, 1990) – in modo del tutto parallelo a quanto si osserva ad esempio in francese, dove accanto a analyse conversationnelle, etichetta usata prevalentemente da ricercatori di formazione linguistica (ad es. Mondada, 2000), esiste anche la dicitura analyse de conversation (ad es. Bonu, 1992), spesso usata da chi enfatizza la
dimensione sociale della disciplina.21 Non si tratta però di un uso chiaramente distinto, e molti linguisti – ma anche e soprattutto gli psicologi – sembrano prediligere analisi della conversazione. In inglese prevale conversation analysis, anche se non manca chi parla di conversational analysis. Secondo Schegloff et al. (2002: 3) conversation analysis rinvia all’approccio emerso in ambito etnometodologico, mentre conversational analysis può essere usato per i lavori che analizzano l’uso conversazionale della lingua (e si citano come esempi Paul Grice, John J. Gumperz, Evelyn Hatch e Deborah Tannen). Lynch (2019: 186) ricorda però come, quando Sacks era ancora in vita, alcuni suoi colleghi preferissero parlare di conversational analysis poiché l’espressione permetteva di enfatizzare l’aspetto endogeno dell’analisi che gli stessi partecipanti compionono mentre interagiscono.22 In effetti, come segnala anche Margutti (2013: 832), in italiano analisi della conversazione potrebbe suggerire che l’oggetto di studio sia la “conversazione” – una lettura che forse si applica ai primi lavori (che vertevano, appunto, su chiamate telefoniche), ma che non regge dinanzi alla varietà di interazioni studiate, né ai fenomeni analizzati, che esulano dalle mere risorse linguistiche interessandosi anche di pratiche ‘incorporate’ (embodied). Di fronte a questo dubbio, il termine analisi conversazionale presenta i seguenti vantaggi: a) permette di evitare una lettura che identificherebbe la “conversazione” come genere privilegiato dell’analisi, b) enfatizza, nella migliore tradizione etnometodologica, che l’analisi non è svolta solo dai ricercatori che studiano i dati a posteriori, ma dai partecipanti stessi, nel momento del loro interagire (v. Lynch, 2019), conferendo accountability alle proprie azioni, c) permette, infine, di rinviare all’analisi collettiva – e quindi conversazionale – dei dati, in particolare nell’ambito delle cosiddette data sessions. Queste ultime rappresentano un metodo di discussione e disamina dei dati ampiamente diffuso in ambito conversazionale, che consiste nel sottoporre a visione ripetuta (o ascolto ripetuto) un frammento di dati, con l’obiettivo di trarne un’analisi che rispetti la rilevanza emica dei fenomeni osservati e che sia condivisa dagli analisti compresenti. 4. LA LINGUISTICA INTERAZIONALE Nel 2001 Margret Selting e Elizabeth Couper-Kuhlen pubblicano un volume intitolato Studies in Interactional Linguistics. Il titolo è programmatico poiché colloca senza ombra di dubbio gli studi di orientamento etnometodologico e interazionale nell’ambito della linguistica. Nella visione delle studiose, la linguistica interazionale studia la lingua in quello che è considerato l’habitat naturale del suo uso, ovvero l’interazione sociale. Dall’analisi conversazionale il nuovo orientamento disciplinare prende l’attenzione per i dettagli della conversazione (pause, interruzioni, sovrapposizioni, vocalizzazioni, ecc.), così come il metodo dell’analisi sequenziale e situato del parlato-in-interazione. Ma essa si rifà anche alla linguistica funzionale (Halliday, 1973; Givón, 1979, tra molti altri), da cui riprende concetti linguistici e 21 Troviamo analisi conversazionale, ad esempio, in Orletti (1977), Skytte (1996: 318, n. 11), Franceschini (1998), Bercelli (1999), Segre (2007: 10), De Stefani (2011), mentre analisi della conversazione è usato da Zorzi Calò (1990), Fele (1990, 1999, 2007), Voghera (1992: 48), Duranti (1992: 17), Marcarino (1997), Fasulo e Galatolo (2004). Altri autori, ad esempio Pallotti (1999), non esitano a alternare le due diciture. 22 “Sacks […] is […] credited […] with being the founder of conversation analysis, though during his lifetime it was often called conversational analysis – which some of us preferred as a way to highlight the way analysis was endogenous to the production of conversation.”
grammaticali. L’impresa non è priva di difficoltà poiché combina un approccio che analizza i dati da un punto di vista emico (l’analisi conversazionale) con categorie analitiche etiche, ovvero definite dagli analisti (come “clausola”, “costruzione marcata” per rimanere nell’ambito della sintassi). Tuttavia, lo stesso Schegloff (1996) ha dimostrato come l’alternanza dei turni di parola sia resa possibile attraverso l’analisi sintattica e prosodica del turno-in-corso, che i partecipanti svolgono in tempo reale (online secondo Auer, 2009). Di fatto, non sono rari gli studi di orientamento interazionale che illustrano la rilevanza di certe unità grammaticali per gli interattanti, a partire da Charles Goodwin, che nel suo prionieristico lavoro del 1979 (Goodwin, 1979) mostra come un parlante che produce una “frase” si orienti alle conoscenze che presuppone presenti nei partner conversazionali a cui sono rivolti i vari segmenti del proprio turno. Altrettanto pionieristico poi, senz’altro in ambito italiano, il saggio di Duranti e Ochs (1979) sulla dislocazione a destra nella conversazione ordinaria. Vanno anche ricordati, per la sintassi, i lavori di Fox (1987) sull’anafora, Lerner (1991) sulla costruzione if/then (‘se/allora’), Ford (1993) sulle clausole avverbiali e Hopper (1987) sulla grammatica emergente. Un impulso importante giunge inoltre dalle ricerche sulla fonetica e sulla prosodia del parlato conversazionale, portate avanti, ad esempio, da French e Local (1983) per l’inglese britannico (v. Barth-Weingarten et al., 2010 per una panoramica sul tema). Come spiegano Couper-Kuhlen e Selting (2018: 18) la linguistica interazionale è necessaria, da un lato, per contrastare concezioni della lingua non-interazionali – che continuano a riconoscere nell’uso della lingua una mera applicazione (performance in termini chomskyani) di un sistema linguistico soggiacente –, dall’altro lato per differenziarsi dall’analisi conversazionale, interessata secondo le autrici a descrivere il costituirsi dell’ordine sociale nell’interazione, laddove la linguistica interazionale studia dapprima la lingua – nel suo uso- in-interazione. 4.1. Per una panoramica degli studi sull’italiano In Italia, gli studi di orientamento interazionale si affermano dapprima nell’ambito della (socio)linguistica, sulla scia dell’articolo di Orletti (1977), e di seguito anche nella sociologia e nella psicologia sociale. In ambito linguistico, l’interesse crescente per la conversazione e l’interazione si manifesterà attraverso una serie di volumi collettanei e monografie dedicati all’argomento (Orletti, 1983, 1994a, 2000; Zorzi Calò, 1990; Bazzanella, 1994, 2002; Galatolo e Pallotti, 1999; Fasulo e Galatolo 2004) e sarà tra l’altro documentato da alcune rassegne degli studi conversazionali in Italia (Orletti, 1994b; Fatigante, 2004; Margutti, 2013). Per quanto riguarda il focus dell’analisi, si osserva come la ricerca italiana abbia privilegiato alcuni specifici contesti sociali, primo fra tutti l’interazione in classe, che è stata affrontata tanto in L1 quanto in contesto multilingue, e sia relativamente a istruzione primaria e secondaria, sia in ambito universitario (Bazzanella, 1980; Orletti, 1986; Ciliberti e Anderson, 1999; Fele e Paoletti, 2003; Ciliberti et al., 2003; Margutti, 2006, 2007a, 2010, 2016; Baraldi, 2007; Veronesi, 2007, 2016; Spreafico e Veronesi 2012; Margutti e Drew 2014). A livello di interazione in classe, inoltre, non sono mancati gli studi conversazionali sull’insegnamento dell’italiano L2, come documentato ad esempio in Zorzi (1996), Cacchione (2014), Ferroni (2017; 2019), Diadori (2017) e Kunitz (2018a, 2018b).
Ugualmente indagati risultano gli incontri di servizio e i contesti commerciali (Collovà e Petrini, 1981-1982; Aston, 1988; Zorzi Calò et al., 1990; De Stefani, 2011; Ticca, 2012; De Stefani, 2019; cfr. anche, per lo specifico di interazioni plurilingui in contesto universitario, Varcasia, 2010, come pure, relativamente a trattative d’affari e fiere commerciali, Merlino, 2009 e Piccoli, 2017) e la comunicazione in ambito medico (Baraldi e Gavioli, 2013; Galatolo e Margutti, 2016; Galatolo e Cirillo, 2017; Sterponi et al., 2019). A ciò si affianca l’attenzione per i contesti di migrazione e di mediazione linguistica, quest’ultima svolta da interpreti professionisti o da partecipanti all’interazione non formati a tale scopo (Pugliese e Veschi, 2006; Ciliberti, 2007; Margutti, 2007b; Gavioli, 2009, 2016; Pasquandrea, 2011, 2012; Merlino e Mondada, 2013; Veronesi, 2013; Davitti e Pasquandrea, 2017; Pugliese, 2017; cfr. anche Polselli, 2008 e Caruana e Klein, 2009). Le chiamate telefoniche (istituzionali), infine – un contesto d’interazione storico nell’ambito dell’analisi conversazionale –, si rivelano essere un campo d’indagine consolidato anche in area italiana (Bercelli e Pallotti, 2002; in prospettiva comparata: Thüne e Leonardi, 2003; Varcasia, 2013; in ottica glottodidattica Varcasia, 2019; in programmi radiofonici e televisivi: Fele, 1993; Sobrero, 1997). Se nell’ambito della ricerca sui disturbi del linguaggio sembra consolidarsi sempre più l’attenzione verso la dimensione dialogica e interazionale, come evidenziato da Carla Bazzanella (cfr. anche Cacchione, 2010), risultano invece ancora poco rappresentati gli studi conversazionali sull’interazione in famiglia, analizzata però nel dettaglio in Fasulo e Pontecorvo (1999), Pontecorvo e Arcidiacono (2007), Pauletto (2017) e, con focus su code- switching e identità, in Pasquandrea (2007). Poco visibile, a tutt’oggi, pare inoltre l’interesse per indagini di stampo dichiaratamente conversazionale sull’interazione mediata da computer e smartphone o tra interattanti umani e non umani, da tempo oggetto di analisi a livello internazionale all’interno del paradigma (cfr. ad es. Meredith, 2019) – ma di cui si può ipotizzare l’emergere in un imminente futuro, alla luce della sempre maggiore rilevanza assunta anche in Italia dall’interazione digitale e da forme di comunicazione mediata sincrone e quasi-sincrone, tanto nella vita privata quanto in quella professionale ed educativa. Per quanto riguarda invece lo studio dei rapporti che intercorrono tra grammatica e interazione (v. Orletti, 2004) – focus privilegiato della linguistica interazionale, come già accennato – la ricerca applicata a dati conversazionali italiani ha affrontato una varietà di tematiche che spazia da costruzioni sintattiche come la dislocazione a destra (Duranti e Ochs, 1979; Monzoni, 2005), le frasi scisse (De Stefani, 2009), i temi sospesi (Calaresu, 2018), l’uso del pronome noi (vs. Ø) (Bazzanella, 2014), o i turni co-costruiti (Arcidiacono e Pontecorvo, 2007; Orletti, 2008; Biazzi, 2009), all’interesse per la grammaticalizzazione, o perlomeno sedimentazione, di locuzioni come piuttosto che (Bazzanella e Cristofoli, 1998) e nel senso (che) (De Stefani, 2020). L’attenzione verso i rapporti tra grammatica e interazione, tuttavia, pare ancora poco consolidata in ambito italiano, specie considerando che questa costituisce invece il cuore della interactional linguistics in ambito anglosassone, con esiti di grande rilevanza per la comprensione del ricorso situato che i parlanti fanno delle risorse grammaticali; si tratta dunque di un campo che merita senza dubbio di essere ulteriormente e più sistematicamente indagato, non da ultimo anche riguardo a fonetica e prosodia del parlato conversazionale, del tutto inesplorate per la lingua italiana da una prospettiva di grammatica-in-interazione.
Similmente, quasi inesistenti figurano le analisi di orientamento interazionale che vertono
sulle altre varietà storiche della penisola italiana: a questo proposito, il volume di Sobrero
(1992) su Il dialetto nella conversazione rappresenta un’eccezione esemplare (ma vedi
Paternostro, 2013, come pure Pauletto e Ursi, i.c.s.).23
Per contro, estremamente ricca e variegata risulta la ricerca sui segnali discorsivi, sia in
generale, sia con indagini focalizzate su una o più risorse linguistiche (Berretta, 1984;
Bazzanella, 1985, 1986, 1995, 2006, 2015; Stame, 1999; Pauletto e Fatigante, 2015; Pugliese,
2015; De Stefani, 2016; Pauletto, 2016), tanto che questo ambito, grazie anche agli
innumerevoli lavori di Carla Bazzanella, un caposaldo sul tema, si profila quello con una più
ampia tradizione di ricerca in Italia.
Rispetto inoltre al versante pragmatico della linguistica interazionale, si osserva come la
ricerca si sia concentrata principalmente sul formato sintattico dei turni di parola, esaminando
come i partecipanti si servono della lingua per compiere azioni pratiche quali domande e
richieste (Rossano, 2010; Rossi, 2015, 2017; cfr. anche Margutti, 2006), inviti (De Stefani,
2018; Margutti e Galatolo, 2018), istruzioni (De Stefani e Gazin, 2014; Simone e Galatolo,
2020), valutazioni (Fasulo e Monzoni, 2009; cfr. anche Margutti e Drew, 2014), lamentele
(Monzoni, 2009) e rimproveri (Margutti, 2007a, 2011).
Infine, – in questa rassegna che, lungi dall’essere esaustiva, mirava a identificare gli
argomenti più indagati da ricercatrici e ricercatori che lavorano sull’italiano – si nota negli
ultimi anni un’attenzione crescente per gli aspetti ‘incorporati’ (embodied) dell’interazione. In
quest’ottica, la voce non costituisce che una risorsa tra molte altre che gli individui usano per
interagire. Sono altrettanto rilevanti i gesti (Kendon, 1995; Sciubba, 2010), lo sguardo
(Rossano, 2012; Orletti, 2015), il movimento nello spazio (Veronesi, 2007; De Stefani e
Gazin, 2014; Simone e Galatolo, 2020), la manipolazione di oggetti (De Stefani, 2011, 2019;
Pasquandrea, 2011; Klein e Pasquandrea, 2013; Demo e Veronesi, 2019), l’olfatto e il gusto.
Una simile concezione ‘olistica’ consente, da un lato, di studiare anche pratiche interazionali
non vocali (come ad es. la conversazione nella Lingua Italiana dei Segni; cfr. Gianfreda,
2011); dall’altro lato permette di vedere come gli interlocutori strutturino i propri turni di
parola in modo riflessivo e situato, adattandosi via via alle contingenze interazionali che
emergono nel tempo, e offrendo dunque una prospettiva che studia il linguaggio – per
riprendere le parole delle fondatrici della linguistica interazionale – nell’interazione sociale
quale habitat naturale del suo uso, e che può offrire, in ultima analisi, una vera grammatica
dell’interagire.
5. BIBLIOGRAFIA
AA. VV. (1970), Lingua parlata e lingua scritta. Convegno di studi, 9-11 novembre 1967. Palermo:
Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani.
AA. VV. (1977), Atti del seminario sull’italiano parlato (Firenze, Accademia della Crusca, 18-20
ottobre 1976). Studi di Grammatica Italiana 6.
Antonini A. (21777), Nuovo dizzionario italiano-tedesco e tedesco-italiano. Caspar Fritsch: Lipsia.
Arcidiacono F. e Pontecorvo C. (2007), “La co-costruzione del turno dei bambini autistici. Interventi
dei genitori e dei fratelli nelle conversazioni familiari a tavola”, Rivista di Psicolinguistica
Applicata 7(3): 81-89.
23
È pur vero che alcuni autori analizzano dati con tratti marcatamente regionali (v. ad es. Rossi, 2015),
focalizzandosi tuttavia più sulle dimensioni interazionali che sugli aspetti di variazione.Ascoli G. I. (1873), Archivio Glottologico Italiano 1. Roma/Torino/Firenze: Loescher.
Aston G. (a cura di) (1988), Negotiating Service. Studies in the Discourse of Bookshop Encounters.
Bologna: Clueb.
Auer P. (1991), “Vom Ende deutscher Sätze”, Zeitschrift für germanistische Linguistik 19(2): 139-
157.
Auer P. (2009), “On-line syntax: Thoughts on the temporality of language”, Language Sciences 31: 1-
13.
Auer P. (2015), “Reflections on Hermann Paul as a usage-based grammarian”. In: P. Auer e R. W.
Murray (a cura di), Hermann Paul’s ‘Principles of Language History’ Revisited. Berlin: De
Gruyter, 177-207.
Austin J. L. (1962), How to do Things with Words. Oxford: Clarendon Press.
Bachtin M. M. (1929), Problemy tvorchestva Dostoevskogo. Leningrad: Priboi.
Baraldi C. (a cura di) (2007), Dialogare in classe: la relazione tra insegnanti e studenti. Roma:
Donzelli.
Baraldi C. e Gavioli L. (2013), “La mediazione nell’interazione centrata sul paziente: il caso delle
domande del medico”, Salute e Società 12(1): 94-109.
Barth-Weingarten D., Reber E. e Selting, M. (a cura di), Prosody in Interaction.
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Bazzanella C. (1980), La sociolinguistica in classe: problemi e ricerche nella scuola media
dell’obbligo. Roma: Bulzoni.
Bazzanella C. (1985), “L’uso dei connettivi nel parlato: alcune proposte”. In: A. Franchi De Bellis e L.
M. Savoia (a cura di), Sintassi e morfologia della lingua italiana d’uso: teorie e applicazioni
descrittive. Roma: Bulzoni, 83-94.
Bazzanella C. (1986), “I connettivi di correzione nel parlato: usi metatestuali e fatici”. In: K. Lichem,
E. Mara e S. Knaller (a cura di), Parallela 2. Aspetto della sintassi dell’italiano contemporaneo.
Tübingen: Narr, 35-45.
Bazzanella C. (1994). Le facce del parlare: un approccio pragmatico all’italiano parlato.
Firenze/Roma: La Nuova Italia.
Bazzanella C. (1995), “I segnali discorsivi”. In: L. Renzi, G. Salvi e A. Cardinaletti (a cura di),
Grande grammatica italiana di consultazione. Bologna: il Mulino, vol. 3, 225-257.
Bazzanella C. (a cura di), (2002), Sul dialogo: contesti e forme di interazione verbale. Guerini:
Milano.
Bazzanella C. (2006), “Discourse markers in Italian: Towards a ‘componistional’ meaning”. In: K.
Fischer (a cura di), Approaches to Discourse Particles. Amsterdam: Elsevier, 449-464.
Bazzanella C. (2014), “Grammar and interaction: Unmarked and marked uses of the first person plural
in Italian”. In: T.-S. Pavlidou (a cura di), Constructing Collectivity: ‘We’ across Languages and
Contexts. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 83-104.
Bazzanella C. (2015), “Segnali discorsivi a confronto. Dati e teoria, un percorso integrato”. In M.
Borreguero Zuloaga e S. Gómez-Jordana Ferary (a cura di), Marqueurs du discours dans le
langues romanes. Limoges: Lambert-Lucas, 37-50.
Bazzanella C. e Cristofoli M. (1998), “‘Piuttosto che’ e le alternative non preferenziali: un mutamento
in atto?”, Quadernos de filología italiana 5: 267-278.
Bell A. M. (1867), Visible Speech. The Science of Universal Alphabetics. London: Simkin, Marshall &
Co.
Bercelli F. (1999), “Analisi conversazionale e analisi dei frame”. In: G. Pallotti e R. Galatolo (a cura
di), La conversazione. Un’introduzione allo studio dell’interazione verbale. Milano: Raffaello
Cortina Editore, 89-117.
Bercelli F. e Pallotti G. (2002), “Conversazioni telefoniche”. In: C. Bazzanella (cura di), Sul dialogo.
Contesti e forme di interazione verbale. Milano: Guerini, 177-192.
Berretta M. (1984), “Connettivi testuali in italiano e pianificazione del discorso”. In: L. Còveri (a cura
di), Linguistica testuale. Atti del convegnl SLI (Genova 1981). Roma: Bulzoni, 237-354.
Berretta M. (1994), “Il parlato italiano contemporaneo”. In: L. Serianni e P. Trifone (a cura di), Storia
della lingua italiana. Torino: Einaudi, vol. 2, 239-290.
Berruto G. (1985), “Per una caratterizzazione del parlato: l’italiano parlato ha un’altra grammatica?”
In: G. Holtus e E. Radtke (a cura di), Gesprochenes Italienisch in Geschichte und Gegenwart.
Tübingen: Narr, 120-151.Biazzi M. (2009), “Sintassi nell’interazione e competenza interazionale in L2. Il caso delle co-
costruzioni”. In: C. Consani, C. Furiassi, F. Guazzelli e C. Perta (a cura di), Atti del 9°
Congresso dell’Associazione di Linguistica Applicata. Perugia: Guerra Edizioni, 261-282.
Boas F. (1911), “Introduction”. In: Handbook of American Indian Languages. Bureau of American
Ethnology. Bulletin 40. Washington: Government Printing Office, vol. 1, 1-83.
Boas F. (1934), Geographical Names of the Kwakiutl Indians. New York: Columbia University Press.
Bonu B. (1992), “L’analyse de conversation: une discipline de l’action sociale”, Quaderni 17: 51-62.
Bopp F. (1816), Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der
griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache. Frankfurt am Main:
Andreäsche Buchhandlung.
Brown P. e Levinson S. (1987), On Politeness. Some Universals in language Use. Cambridge:
Cambridge University Press.
Cacchione A. (2010), “Il parlato schizofrenico. Una proposta di analisi conversazionale per seguire le
piste topicali”. In: M. Pettorino, A. Giannini e F. M. Dovetto (a cura di), La Comunicazione
Parlata 3, Atti del III congresso internazionale del Gruppo di Studio sulla Comunicazione
parlata, vol. 2, Napoli: Università degli studi di Napoli l’Orientale, 403-423.
Cacchione A. (2014), “L’analisi della conversazione nativo-non nativo per la valutazione e
l’apprendimento in linguistica acquisizionale e glottodidattica: osservazioni e spunti da tre casi
di studio tra Spagna e Italia”, Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata 43(3): 465-510.
Caffi C. (2007), “La pragmatica a venire di Leo Spitzer”. In: L. Spitzer, La lingua italiana del dialogo,
a cura di C. Caffi e C. Segre. Milano: il Saggiatore, 15-35.
Calaresu E. M. (2018), “Grammaticalizzazioni polifoniche o ‘verticali’ e sintassi dialogica. Dagli
enunciati-eco ai temi sospesi: l’infinito anteposto in strutture del tipo ‘mangiare, mangio’”. In:
P. Greco, C. Vecchia e R. Sornicola (a cura di), Strutture e dinamismi della variazione e del
cambiamento linguistico. Napoli: Giannini, 505-521.
Cardona G. R. (1976), Introduzione all’etnolinguistica. Bologna: il Mulino.
Caruana S. e Klein G. (2009), “Costruzione conversazionale dell’‘essere-straniero’ in istituzioni in
Italia e a Malta”. In: L. Mariottini, E. Sciubba e M. Fatigante (a cura di), Lingua e società.
Scritti in onore di Franca Orletti per il suo sessantesimo compleanno. Milano: Franco Angeli,
306-316.
Cesarotti M. (1785 [1969]), Saggio sulla filosofia delle lingue. Milano: Marzorati.
Chomsky N. (1965), Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge MA: MIT Press.
Ciliberti A. (2007) (a cura di), La costruzione interazionale di identità: repertori linguistici e pratiche
discorsive degli italiani in Australia. Milano: FrancoAngeli.
Ciliberti A., Anderson L. (1999) (a cura di), Le forme della comunicazione accademica. Ricerche
linguistiche sulla didattica universitaria in ambito umanistico. Milano: FrancoAngeli.
Ciliberti A., Pugliese R. e Anderson L. (2003), Le lingue in classe: Discorso, apprendimento,
socializzazione. Roma: Carocci.
Collovà P. e Petrini D. (1981-1982), “Lingua, dialetto e commutazione di codice: interazioni verbali in
un negozio del luganese”, Rivista Italiana di Dialettologia 5-6: 257-293.
Couper-Kuhlen E. e Selting M. (2018), Interactional Linguistics: Studying Language in Social
Interaction. Cambridge: Cambridge University Press.
Coupland J. (2000), Small Talk. Harlow: Longman.
Cresti E. (1987), “L’articolazione dell’informazione nel parlato”. In: AA. VV., Gli italiani parlati.
Firenze: Accademia della Crusca, 27-90.
Davitti E. e Pasquandrea S. (2017), “Embodied participation: What multimodal analysis can tell us about
interpreter-mediated encounters in pedagogical settings”, Journal of Pragmatics 107: 105-128.
Demo H. e Veronesi D. (2019), “Universal Design for Learning nelle interazioni in classe, tra
pedagogia speciale e analisi della conversazione”. In: D. Ianes (a cura di), Didattica e
Inclusione Scolastica, Milano: Franco Angeli, 31-50.
De Stefani E. (2009), “Le strutture grammaticali come epifenomeni dell’interazione sociale?
Riflessioni sull’uso delle costruzioni scisse nel parlato conversazionale italiano e francese”. In:
A. Ferrari (a cura di), Sintassi storica e sincronica dell’italiano: Subordinazione,
coordinazione, giustapposizione. Firenze: Franco Cesati, vol. 3, 1615-1631.Puoi anche leggere