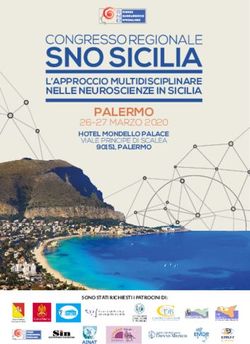Pedagogia speciale: approcci metacognitivi e cooperative - 4 Settembre 2020 ARIANNA TADDEI
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Pedagogia speciale:
approcci metacognitivi e
cooperative
4 Settembre 2020
ARIANNA TADDEI
UNIVERSITA’ DI MACERATAIndicazioni didattiche Materiali di studio: ØNicoletta Rosati (2017), Metacooperative Learning. Percorso di ricerca e didattica nella scuola dell'infanzia. Anicia, Roma , Pagin.e: 9-196 ØSlides messe a disposizione dal docente Data e modalità di esame: 23 ottobre h.14-19 (orale online).
Quali aspettative da questo
insegnamento?
Attività su MENTIMETER:
Elencare tre aspettative: Che cosa vi aspettate di imparare
da questo insegnamento? Elencare le vostre tre aspettative
principali.La pedagogia speciale
garantisce a tutti:
• Il principio di educabilità
• La maggior autonomia e partecipazione sociale possibile
• Prospettiva progettuale dell’intervento educativo tra scuola e extra-
scuolaConcetto di disabilità
La disabilità è un concetto in evoluzione Di seguito i quattro approcci interpretativi della disabilità: 1. Assistenziale II. Sociale III. Bio-psico-sociale ICF IV. Fondato sui diritti umani
I. L’approccio medico/assistenziale Il problema viene individuato nella persona che presenta la menomazione, sulla base della convinzione che sia questa stessa condizione di malattia a determinare l’esclusione sociale e la necessità di ricevere delle cure mediche ed assistenziali.
II. Il modello sociale Agli inizi degli anni ‘70 si sviluppa la teorizzazione di un modello sociale della disabilità (Olivier 1981), caratterizzato: dalla differenza tra menomazione (condizione biologica) e disabilità (condizione sociale); dalla distinzione con il modello medico che individua i limiti nel deficit della persona; dalla rilevazione della condizione di oppressione lamentata e sperimentata dalle persone disabili nella società”
Il nuovo approccio culturale alla disabilità evidenzia come questa sia il risultato dell’incontro della persona con deficit con il contesto sociale che si presenta come inadeguato ad accoglierla.
III. Il modello bio-psico-sociale (ICF OMS, 2001) Il funzionamento o la disabilità di una persona è la risultante di diversi fattori: condizioni fisiche e dotazione biologica fattori contestuali (ambientali e personali). Nella dinamica dialogica di questi fattori c’è il corpo con proprie strutture e funzioni, capace di svolgere attività personali e di sviluppare partecipazione sociale. La salute non può essere vista come assenza di malattia, ma va percepita come realizzazione del proprio funzionamento nei vari contesti di vita.
Schema del modello ICF
Condizioni fisiche Comprende malattie (acute o croniche), disturbi, lesioni o traumi. Può inoltre comprendere altre circostanze biologicamente significative come la gravidanza, l’invecchiamento, un’anomalia congenita o una predisposizione genetica. Le condizioni di salute vengono codificate secondo i criteri dell’ICD-10 (OMS, 2007).
Funzioni corporee Le funzioni corporee sono le funzioni fisiologiche dei vari sistemi corporei (comprese le funzioni mentali). Le menomazioni sono problemi nella funzione del corpo, intesi come una deviazione o una perdita significativa.
Tipologie di funzioni Funzioni mentali Funzioni sensoriali e dolore Funzioni della voce e dell’eloquio Funzioni dei sistemi cardiovascolare, ematologico, immunologico e dell’apparato respiratorio. Funzioni dell’apparato digerente e dei sistemi metabolico ed endocrino Funzioni genitourinarie e riproduttive Funzioni neuro-muscoscheletriche e correlate al movimento Funzioni della cute e delle strutture correlate (OMS, 2007)
ICF – CY (OMS, 2007) E’ stato sviluppato per rispondere all’esigenza di una versione dell’ICF che potesse essere universalmente utilizzata per bambini e adolescenti nei settori della salute, dell’istruzione e dei servizi sociali La classificazione deve riflettere i cambiamenti associati allo sviluppo e deve cogliere le caratteristiche dei diversi ambienti e gruppi di età (Ianes, Cramerotti, 2011).
IV. L’approccio fondato sui diritti umani Questo approccio ha affrontato tra le varie problematiche, quelle in particolare legate all’uguaglianza e alla cittadinanza delle persone disabili, questioni che, sulla scia dell’attivismo politico, a partire dagli anni ’60, sono state oggetto di interesse anche da parte del mondo accademico e della politica.
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità La Convenzione ONU (2006) afferma la dignità delle persone con disabilità, oltre che il diritto all’uguaglianza di tutte le libertà fondamentali e definisce la disabilità come il risultato dell’interazione tra menomazioni e barriere sociali, attitudinali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione.
Approccio fondato sui diritti
umani
Secondo la Convenzione sui Diritti delle Persone
con Disabilità (ONU, 2006):
«Le persone con disabilità includono quanti
hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali
o sensoriali a lungo termine che in interazione
con varie barriere possono impedire la loro
piena ed effettiva partecipazione nella società
su una base di eguaglianza con gli altri» (Art.1).Art.24 (CRPD): istruzione b) le persone con disabilità possano accedere ad un’istruzione primaria inclusiva, di qualità e gratuita e ad un’istruzione secondaria su base di eguaglianza con gli altri e all’interno delle comunità in cui esse vivono; c) un accomodamento ragionevole venga fornito per andare incontro alle esigenze individuali; d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione; e) efficaci misure di supporto individualizzato siano fornite in ambienti che ottimizzino il programma scolastico e la socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena inclusione.
La prospettiva dell’inclusione La Dichiarazione di Salamanca (1994) ufficializza per la 1° volta il termine inclusione in ambito educativo e sociale Da un’idea di educazione speciale, rivolta strettamente agli studenti con disabilità si passa al concetto di un’educazione per tutti che trova spazio nella scuola di tutti, accogliendo le molteplici diversità (psicofisiche, culturali e socio-economiche etc.).
La prospettiva dell’inclusione Il corpo docente cerca risposte educative adeguate alle singole diversità, attraverso l’utilizzo consapevole ed equilibrato di interventi didattici basati sia sull’individualizzazione sia sulla personalizzazione. La prospettiva inclusiva sostiene la visione di una scuola che sia un diritto per tutti.
Il concetto di inclusione •guarda alla globalità delle sfere educativa, sociale e politica; •prende in considerazione tutti gli alunni/studenti; •interviene prima sui contesti e poi sull’individuo
Prospettiva di Empowerment
Prospettiva che valorizza cosa lo studente sa e può fare
per aiutarlo a crescere in quel contesto, attivando quindi
un processo di empowerment.
https://www.youtube.com/watch?v=hGvyJB09oScEmpowerment: acquisizione di
potere
L’empowerment è un processo dinamico e quotidiano che presenta
risvolti individuale e sociali.
Risvolti individuali Risvolti sociali
La persona con disabilità La persona con disabilità è
scopre e rafforza le proprie coinvolta nella
capacità, aumentando la partecipazione sociale,
percezione delle culturale e comunitaria che
potenzialità e evolvono all’interno delle
dell’autostima comunità e dei luoghi di
appartenenzaAttività in Mentimeter Funzioni dell’insegnante di sostegno
Possibili Parole chiave dell’approccio inclusivo SoS-Tenere l’inclusione scolastica promuovendo una rete di sostegni So-Stare nelle differenze per l’inclusione
SoS-Tenere l’inclusione
scolastica
Rimozione
delle barriere
Dalla logica Alla logica
del sostegno dei sostegni Adozioni di
facilitatoriSoS-Tenere l’inclusione
scolastica
Le agenzie
Insegnante Le famiglie educative
di sostegno del
e insegnanti territorio
curricolari
I compagni Gli
di classe Le figure specialisti
ausiliarie
nella scuolaSo-Stare nelle differenze per
includere. Competenze chiave
Saper accogliere
Saper promuovere il
Saper osservare dialogo dentro la
classe e fuori la classe
Saper ascoltare
Saper lavorare con i
Saper progettare
colleghi (collegialità)
Saper valutareAttività di gruppo 30 minuti In base alle vostre conoscenze o quello che immaginate, in che modo gli approcci metacognitivo e cooperativo facilitino il processo di inclusione, su quali dimensioni lavorano, in che senso hanno un valore o una funzione inclusiva? Fare anche degli esempi
Dimensioni individuali e sociali
dell’apprendimento
Approccio metacognitivo Approccio cooperativo
Imparare Imparare
ad con
imparare
Sviluppo dell’autonomia e
della propria Capacità di socializzazione
consapevolezza dei propri e di co-costruzione
meccanismi di dell’apprendimento
apprendimentoPuoi anche leggere