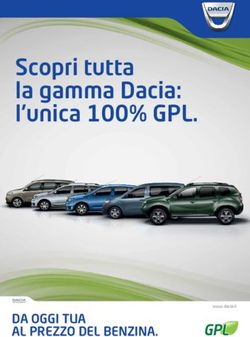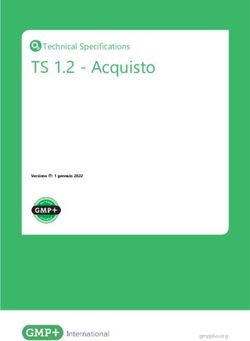OPZIONI E PROSPETTIVE PER IL TRASPORTO MARITTIMO AEREO E STRADALE AL 2030 E AL 2050 - RAPPORTO RIE PER UNEM
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
OPZIONI E PROSPETTIVE
PER IL TRASPORTO MARITTIMO,
AEREO E STRADALE
AL 2030 E AL 2050
RAPPORTO RIE PER UNEMOpzioni e prospettive per il trasporto marittimo, aereo e stradale al 2030 e al 2050 Il presente studio è stato condotto da RIE-Ricerche Industriali ed Energetiche in collaborazione con il Prof. Ing. Bruno dalla Chiara, Professore Ordinario di Sistemi di Trasporto presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino e l’Ing. Andrea Rosa, esperto di modellistica matematica dei trasporti. Si ringraziano i componenti del Gruppo Strategico “Carburanti ed Energie Alternative” istituito nel 2018 da Unione Petrolifera, ora Unione Energie per la Mobilità – unem, e i partecipanti ai Workshop organizzati dal Gruppo: Trasporto Marittimo Gianpiero De Cubellis (Warstilia) Fabio Faraone (Confitarma) Franco Porcellacchia (Carnival Corporation) Giovanni Vallarino (DNV GL) Trasporto Aereo Giovanni Barraco (Direzione Nazionale Navigazione ENAC) Davide Chiaramonti (Università di Firenze) Antonio De Palmas (Presidente BOEING Italia) Davide Faedo (Innovhub) Luigi Nunziata (Fuel Management Alitalia) Trasporto Stradale Carlo Beatrice (CNR – Istituto Motori – Napoli) Andrea Bottazzi (TPER Bologna) Sabrina Caputi (Toyota) Dario Cingolani (LC3 Trasporti) Filippo Colzi (RSE) Giovanni Coppola (Enel X) Maurizio Delfanti (RSE) Antonino Genovese (ENEA) Cristina Maggi (H2IT) Carlo Mannu (Bosch Italia) Angelo Moreno (H2IT) Fernando Ortenzi (ENEA) Alberto Pisoni (General Motors) Emanuele Proia (ASSTRA) Andrea Ricci (SNAM for Mobility) Ernesto Rossi (Scania) Massimo Santori (CNH Industrial – IVECO) Alba Soler (Concawe) Ezio Spessa (Politecnico di Torino) ottobre 2020 Il progetto grafico è di RIE-Ricerche Industriali ed Energetiche
Indice
Introduzione 2. La normativa ambientale e climatica
per i trasporti su strada 39
Obiettivi dello studio e metodologia 6 2.1. La normativa europea sugli agenti
inquinanti 39
2.2. Non solo inquinanti: le emissioni
Il trasporto marittimo al 2030 di CO2 del settore 40
e al 2050, opzioni e prospettive 2.3. DAFI e RED II: la spinta normativa
1. Il trasporto marittimo nel post-2020 8 verso i carburanti alternativi 41
1.1. I limiti IMO al contenuto di zolfo: 2.4. Il PNIEC italiano e la declinazione
si apre una nuova fase 9 degli obiettivi di DAFI e RED II 42
1.2. Perseguire l’obiettivo di 3. Alternative a confronto: costruzione
decarbonizzazione al 2050: del metodo 43
verso nuovi fuels 10 4. Analisi multi-criteri nel trasporto
2. Alternative a confronto: costruzione stradale leggero: metodologia e risultati 46
del metodo ed esiti 12 4.1. Le alternative nel trasporto
2.1. Gli esiti dell’AMC al 2030 14 stradale leggero 47 3
2.1.1. Analisi di sensitività al 2030 16 4.2. Gli esiti dell’AMC al 2030 48
2.2. Gli esiti dell’AMC al 2050 17 4.2.1 Analisi di sensitività al 2030 50
2.2.1. Analisi di sensitività al 2050 19 4.3. Gli esiti dell’AMC al 2050 52
Pillole 20 4.3.1. Analisi di sensitività al 2050 52
Bibliografia 23 5. Analisi multi-criteri nel trasporto
pesante: metodologia e risultati 55
5.1. Le alternative nel trasporto pesante 56
Il trasporto aereo al 2030 5.2. Gli esiti dell’AMC al 2030 58
e al 2050, opzioni e prospettive 5.2.1. Analisi di sensitività al 2030 59
1. Il trasporto aereo tra Covid, ripartenza 5.3. Gli esiti dell’AMC al 2050 60
e obiettivi ambientali 24 5.3.1. Analisi di sensitività al 2050 61
1.1. Gli aspirational goals per il clima 25 6. Analisi multi-criteri nel Trasporto
2. Alternative a confronto: costruzione Pubblico Locale: metodologia e risultati 63
del metodo ed esiti 27 6.1. Le alternative nel Trasporto
2.1. Gli esiti dell’AMC al 2030 30 Pubblico Locale 64
2.1.1. Analisi di sensitività al 2030 31 6.2. Gli esiti dell’AMC al 2030 66
2.2. Gli esiti dell’AMC al 2050 32 6.2.1. Analisi di sensitività al 2030 68
2.2.1. Analisi di sensitività al 2050 33 6.3. Gli esiti dell’AMC al 2050 68
Pillole 34 6.3.1. Analisi di sensitività al 2050 69
Bibliografia 37 Pillole 72
Bibliografia 77
Il trasporto stradale al 2030
e al 2050, opzioni e prospettive Appendice
1. L’evoluzione del trasporto stradale tra Il metodo AMC 78
normativa, tecnologia e comportamenti 38 La costruzione delle matrici di decisione 79Introduzione
Il sistema dei trasporti svolge un ruolo fon- I trasporti, primo settore economico al mon-
4 damentale nello sviluppo, nella modernizza- do, sono tipicamente energy intensive e carat-
zione e nella qualità della vita di ogni società; terizzati da una forte dipendenza dal consumo
condiziona la competitività delle economie e il di petrolio, con riferimento a tutte le differenti
loro benessere; consente l’imprescindibile in- modalità: aerea, stradale, marittima. Su scala
tegrazione dei mercati nell’era della globalizza- mondiale, infatti, il peso dei prodotti petrolife-
zione, pur salvaguardando e talvolta rendendo ri nei consumi finali di energia dei trasporti si
prioritarie le logiche “g-local”; da ultimo, ma più attesta al 92% (2018), arrivando ad assorbire
che mai importante, mette in gioco valori pri- poco più della metà della domanda globale di
mari, quali il diritto alla mobilità e alla libertà di questa fonte primaria e a costituirne il principa-
circolazione delle persone e dei beni, che nel le driver di crescita.
2020 hanno assunto un’importanza evidente Una correlazione storica, quella tra petrolio e
in conseguenza dell’adozione diffusa di misure domanda di mobilità che, stando alle previsioni
di lockdown volte a contenere la propagazione dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE)
dei contagi da Covid-19. contenute nel World Energy Outlook 2019, non
4.000 4.000 Fig. 1 – Consumi
Petrolio Elettricità Biocarburanti Altri carburanti
finali di energia
3.500 3.500
del settore
3.000 3.000 trasporti
nel mondo
2.500 2.500
(mil. tep)
2.000 2.000
1.500 1.500
1.000 1.000
500 500
0 0
2010 2018 2025 2030 2035 2040
Fonte: IEA, World Energy Outlook 2019.Fig. 2 – Consumi 450 450
Petrolio Elettricità Biocarburanti Altri carburanti
finali di energia
400 400
del settore
trasporti 350 350
in Europa 300 300
(mil. tep)
250 250
200 200
150 150
100 100
50 50
0 0
2010 2018 2025 2030 2035 2040
Fonte: IEA, World Energy Outlook 2019.
verrà meno nel medio-lungo periodo. Anche al prossima al 100% in quello aereo e marittimo;
2040 i combustibili liquidi saranno la fonte di ciò evidenzia già di per sé le difficoltà connesse
alimentazione prevalente del sistema, pur con a una sensibile evoluzione del sistema trasporti
una graduale riduzione dell’incidenza del petro- nel suo complesso.
lio che, per quanto in crescita in termini assolu- La sfida di questo decennio consiste, dun-
ti, è atteso portarsi su scala globale all’82% del que, nel creare le basi per una diversificazio-
consumo finale espresso dal settore. ne delle fonti energetiche rispetto al petrolio,
Restringendo il perimetro di interesse all’Eu- facendo tuttavia attenzione anche al rischio di
ropa, la dinamica differisce in parte. Su scala perdere i benefici connessi alle economie di
europea, la mobilità impiega oltre 11 milioni scala che il quasi-monopolio di questa fonte
di persone e contribuisce per quasi il 5% alla ha nel tempo (un secolo) generato. Nel Libro
formazione del Prodotto Interno Lordo. Anche bianco dell’Unione Europea, “Roadmap to a 5
qui, la dipendenza dal petrolio risulta evidente Single European Transport Area – Towards a
e in linea con il dato mondiale (92% dei consu- competitive and resource efficient transport sy-
mi finali nel 2018). Tuttavia, le previsioni deli- stem” (2011) è infatti espressamente indicata
neano una traiettoria decrescente dei consumi la frase «The challenge is to break the transport
energetici del settore già a partire dal decennio system’s dependence on oil without sacrificing
2020 (al netto dell’effetto pandemia), caratte- its efficiency and compromising mobility».
rizzata da una progressiva contrazione della Tuttavia, il settore conoscerà un’ineludibi-
richiesta di petrolio sia in termini assoluti che le trasformazione il cui driver principale è e
relativi: secondo l’AIE, al 2040 il peso del petro- sarà rappresentato dalla definizione, a livello
lio sarà pari al 76% della domanda di energia mondiale, europeo e nazionale, di obiettivi e
proveniente dai trasporti, un calo di 16 pun- normative sempre più ambiziosi e stringen-
ti percentuali rispetto al 2018 ascrivibile alle ti volti a favorire la riduzione delle emissioni di
misure di miglioramento dell’efficienza, all’uso anidride carbonica (CO2) e la sostanziale eli-
crescente di carburanti gassosi e allo sviluppo minazione delle particelle inquinanti (NOx, PM,
della mobilità elettrica oppure elettrificata, spe- CO, HC). La spinta normativa verso una ridu-
cie nei trasporti su gomma. zione dell’impatto ambientale del sistema dei
L’Italia dovrebbe seguire la dinamica attesa trasporti, così come la necessità di limitarne
per l’Unione Europea, con una dipendenza dal la vulnerabilità rispetto a possibili interruzioni
petrolio che resta dominante pur riducendosi, o rischi nella fornitura della materia prima da
come emerge anche dalla traiettoria delineata cui oggi il settore dipende in modo dominante,
nel Piano Integrato Nazionale Energia e Clima troveranno supporto anche nei cambiamenti
(PNIEC) al 2030. Tuttavia, a prescindere dalla tecnologici e, nel caso specifico del segmento
riduzione più o meno spinta che si verificherà stradale, anche in quelli relativi al comporta-
– resa ancor più incerta dal Covid-19 e dalla mento degli utenti. La sfera tecnologica afferi-
conseguente crisi economica mondiale – oc- sce: ai progressi nei motori convenzionali, che
corre avere bene a mente la condizione da cui si prevede siano in grado di conseguire livelli
si parte, rappresentata da una quota del petro- di emissione di agenti inquinanti trascurabi-
lio superiore al 90% nel trasporto stradale e li nel prossimo decennio e livelli di efficienzache si tradurranno in minori consumi; alla pene- considerando diversi criteri di giudizio, indi-
trazione di combustibili alternativi sempre più viduati tenendo conto delle particolarità di cia-
sostenibili (biocarburanti, GNL, e-fuels, idroge- scun segmento e con l’intento di comprendere
no), specie di quelli disponibili a livello locale; specifiche macro-dimensioni di valutazione:
a una crescente elettrificazione della mobilità. sociale-lavorativa (economie di scala nella
La sfera comportamentale attiene, invece, alla produzione del carburante e lato motore, de-
correzione di dinamiche inerziali sintetizzabi- carbonizzazione della filiera); economica (inve-
li nel prevalere de lla mobilità individuale su stimento medio per il mezzo, costo di esercizio,
quella collettiva. Per sostenere quella trasfor- costo di produzione e costo finale del carbu-
mazione verso cui si orientano le politiche cli- rante, investimenti per la creazione dell’infra-
matiche e ambientali, saranno quindi necessari struttura di rete, etc.); energetica (rendimento
grandi progetti di investimento nella ricerca e del motore, densità energetica del carburante/
sviluppo, nella realizzazione di nuove piattafor- vettore, autonomia del mezzo, sviluppo della
me produttive, nella costruzione di nuove infra- rete di rifornimento/ricarica, etc.); ambienta-
strutture lungo l’intera catena del valore delle le (emissioni di CO2 lungo l’intero ciclo di vita,
diverse opzioni tecnologiche. emissioni di inquinanti); disponibilità e sicu-
rezza (volumi disponibili della materia prima
e del prodotto finale nella catena di approvvi-
Obiettivi dello studio gionamento delle diverse tipologie di alimenta-
e metodologia zione). Per il trasporto su strada è stata anche
considerata una dimensione personale, relati-
Lo studio svolto, e di cui si intende qui ripor- va al condizionamento della mobilità, e quindi
tare una ragionata e ampia sintesi, ambisce a alla libertà di movimento o di programmazione
delineare la possibile evoluzione del mix di di un servizio legata all’uso di una determinata
carburanti/sistemi di propulsione che carat- tecnologia.
terizzerà il sistema dei trasporti nelle sue tre L’AMC si sintetizza in una matrice, denomi-
principali declinazioni – marittimo, aereo e stra- nata matrice di decisione, nella quale per ogni
6 dale – agli orizzonti 2030 e 2050, avendo bene opzione carburante/powertrain presa in esame
a mente lo stato dell’arte e il quadro normativo (righe della matrice) sono state riportate le sti-
di riferimento, aspetti in grado di influenzare me, quantitative o qualitative, relative a ciascun
– seppur in modo differente – i futuri sviluppi criterio considerato (colonne della matrice).
del settore: da un lato per l’inerzia dettata dal- L’elemento generico della matrice, relativo alla
lo status quo, tale da rallentare la migrazione i-esima alternativa e al j-esimo criterio di giudi-
verso opzioni alternative specie in un orizzonte zio, è costituito dalla misura della rispondenza
ravvicinato quale il 2030; dall’altro, per la ne- di quella alternativa a quel criterio: dalla misu-
cessità di ottemperare alle richieste normative, ra, cioè, del contributo che quell’alternativa dà
fortemente improntate alla progressiva decar- al raggiungimento dell’obiettivo di cui il criterio
bonizzazione del sistema. di valutazione rappresenta lo strumento inter-
Per svolgere questo esercizio prospettico, pretativo. I criteri possono avere un’importan-
pur nei limiti e incertezze ad esso correlati za diversa che viene espressa attraverso op-
specie in un momento storico come quello at- portuni pesi. Ciò è rilevante perché, specie in
tuale, si è fatto ricorso a un’analisi multi-cri- presenza di sensibilità politiche o decisionali
teri (AMC) – più dettagliatamente descritta diverse, si possono costruire “batterie” di pesi
in appendice – attraverso la quale sono state volte a valutare gli effetti sui risultati di sensibili-
comparate, in base ai possibili fattori che in- tà differenti a un certo criterio. Una particolare
fluenzano la scelta, diverse opzioni di alimenta- combinazione dei pesi dei criteri costituisce, in
zione/propulsione che potranno avere un ruolo sostanza, un “punto di vista”: decisori diversi,
nei prossimi trent’anni in ciascuno dei diversi infatti, possono avere punti di vista differenti,
segmenti di trasporto considerati. L’analisi mul- oppure lo stesso decisore può ritenere oppor-
ti-criteri permette di confrontare e ordinare, tuno sondare più punti di vista.
mediante opportuni criteri e relativi pesi, un in- Per ciascun segmento di trasporto sono
sieme di alternative, specie quando gli elementi state così costruite due matrici di decisione
da prendere in considerazione sono molteplici – una per l’orizzonte 2030 e una per il 2050
e tra loro molto diversi (ad esempio economi- – nelle quali per ogni opzione sono state ripor-
ci, prestazionali, ambientali). La comparazione tate le stime, quantitative o qualitative, relative
tra le opzioni alternative viene quindi effettuata a ciascun criterio di giudizio. Le stime sonol’esito combinato di una ricerca di tipo desk, 1 a 10) nella valutazione delle alternative, ope-
consistente nella disamina della principale let- rando le opportune distinzioni tra 2030 e 2050.
teratura internazionale e delle statistiche/pro- Per i segmenti marittimo e aereo – stante la
iezioni più autorevoli, nonché di un approccio loro natura globale – il perimetro geografico as-
di tipo field, basato su informazioni desunte sunto a riferimento nella presente analisi è ine-
da contatti diretti con i principali stakeholders, vitabilmente quello mondiale; per il segmento
quali esponenti di associazioni di categoria, stradale invece, a sua volta sotto-segmentato
costruttori di navi, aeromobili e veicoli, esperti nei tre settori del trasporto leggero, pesante e
accademici e ricercatori in materia di nuovi car- del trasporto pubblico locale (TPL), lo studio
buranti/sistemi di propulsione. Per individuare svolto ha riguardato l’Italia.
la documentazione più significativa e gli interlo- L’analisi multi-criteri è stata costruita ed ela-
cutori più adeguati allo scopo, si è fatto prima- borata da RIE-Ricerche Industriali ed Energe-
rio riferimento agli attori istituzionali e aziendali tiche in collaborazione con il Prof. Ing. Bruno
che hanno partecipato ai Workshop organizzati dalla Chiara, Professore Ordinario di Sistemi di
dal Gruppo Strategico “Carburanti ed Ener- Trasporto presso il Dipartimento di Ingegneria
gie Alternative” istituito da Unione Energie dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrut-
per la Mobilità - unem. Proprio a seguito dei ture del Politecnico di Torino e con l’Ing. An-
contributi dei diversi partecipanti ai Workshop drea Rosa, esperto di modellistica matematica
è stato possibile assegnare un peso ad ogni dei trasporti. La lavorazione delle matrici è sta-
criterio (batteria di pesi), in modo da definirne ta effettuata attraverso il modello matematico
il livello di importanza (espresso con un voto da ELECTRE II.
7Il trasporto marittimo
al 2030 e al 2050
opzioni e prospettive
1. Il trasporto marittimo che le merci trasportate con questa modalità
nel post-2020 possano raddoppiare nei prossimi due decen-
ni e con esse, in assenza di interventi mirati e
8 significativi, le esternalità ambientali. Da qui,
Nel trasporto intercontinentale e continen- l’attenzione sempre più forte ed evidente verso
tale delle persone, il segmento marittimo ha obiettivi improntati a una crescente sostenibili-
perso da decenni quell’egemonia conservata tà e decarbonizzazione del settore.
fino a metà del XX secolo, di fatto soppiantato In tal senso, il 2020 rappresenta per l’indu-
dallo sviluppo del trasporto aereo; altrettanto, stria navale un anno di profondo cambiamento.
invece, non può dirsi sul fronte merci, dove il L’entrata in vigore della nuova normativa IMO
trasporto via nave rappresenta il settore a (International Maritime Organization) a partire
maggior supporto del commercio mondiale. dal 1° gennaio – con l’introduzione di un Global
Con 11 miliardi di tonnellate di merci trasporta- Sulphur Cap dello 0,5% massimo per i bun-
te (2018), questo segmento assorbe circa l’80% ker marini – segna l’inizio di una trasformazione
in termini di volume e oltre il 70% in termini di significativa per il trasporto marittimo, con si-
valore dei beni scambiati su scala globale. gnificative ripercussioni sia sulle attività di
È, inoltre, il minor contribuente all’inquina- bunkeraggio sia sulle scelte di investimento
mento globale derivante dai sistemi di traspor- di breve-medio termine degli armatori.
to. Per le sue caratteristiche, infatti, la nave Ma il 2020 verrà ricordato anche per l’impatto
costituisce la modalità di trasporto a minor determinato dalla pandemia da Covid-19 e dal-
impatto emissivo (emissioni per tonnellata di le conseguenti misure di lockdown intraprese
merce trasportata per km percorso) tra quelle in diverse aree del mondo, che hanno colpito il
dotate di motore a combustione a bordo e, in settore trasporti più di qualsiasi altro comparto
alcuni casi, l’unica possibile. Lo è per prodot- economico. L’interruzione di diverse attività indu-
ti poco o per nulla compatibili con il trasporto striali e la limitazione della mobilità delle perso-
aereo, come ad esempio per il grano destinato ne si sono riversate in primis sul segmento della
alla produzione giornaliera di pane che può es- crocieristica e dei traghetti, mentre il trasporto
sere trasportato esclusivamente via mare. merci ha riportato una contrazione più moderata
Tuttavia, il continuo incremento e la rapida e concentrata sulle attività delle navi container.
crescita dei volumi scambiati via nave re- Tuttavia, anche se il breve termine sarà inevi-
gistrata nell’ultimo ventennio porta a stimare tabilmente compromesso, è piuttosto probabileIl 2020 segna l’inizio di una importante trasformazione
che porterà, nel lungo periodo, dal predominio
di una singola fonte a un futuro multi-fuel
che – a pandemia finita – il trend di crescita at- 1.1. I limiti IMO al contenuto
teso in epoca pre-Covid riprenderà la sua cor- di zolfo: si apre una nuova fase
sa, pur con tempi e intensità ad oggi ancora
incerti. La congiuntura attuale non costituisce, L’IMO ha iniziato ad occuparsi del conte-
pertanto, un impedimento all’evoluzione del nimento dell’impatto ambientale del settore
settore, ma può esercitare su di essa un’im- marittimo negli anni ‘60 del secolo scorso. La
portante influenza a un orizzonte ravvicinato principale regolamentazione di riferimento per
quale è il 2030 che, peraltro, risente della forte la prevenzione dell’inquinamento causato dalle
inerzia che contraddistingue questa modalità navi è contenuta nella Convenzione MARPOL
di trasporto – soprattutto in termini di vita utile del 1973 e nelle sue successive modifiche (Fig.
del naviglio (30-35 anni), modalità e tipologie di 1). Con l’adozione dell’Annex VI nel 1997, la
rifornimento, competenze acquisite da decenni Convenzione ha fornito una base internaziona-
lato manutenzione a bordo. Se è quindi logico le giuridicamente accettata per la tutela dell’in-
attendersi che nel decennio in corso gli armatori quinamento dell’aria.
si adegueranno ai nuovi vincoli normativi com- Il focus primario della regolamentazione
piendo scelte che in larga parte non compor- IMO riguarda lo zolfo, un elemento naturale
tano modifiche tecniche di rilievo rispetto allo presente in tutti i combustibili fossili. Nel 2005
status quo, al 2050, invece, il ragionamento si è entrato in vigore il primo limite globale per
sposta sulle nuove costruzioni che – in ragione il contenuto di zolfo nei carburanti marini, pari
della progressiva decarbonizzazione del set- al 4,5% m/m (massa per massa); a partire dal
tore dei trasporti, motivata e regolamentata 2012, la soglia è stata ridotta al 3,5%, rimanen-
su scala europea e internazionale – tenderanno do il riferimento vigente sino al 1° gennaio 2020. 9
a ricorrere in misura crescente a combustibili/ Da quella data, l’entrata in vigore di un nuovo
vettori energetici low carbon, la cui catena di cap massimo dello 0,5%1 ha segnato l’avvio di
approvvigionamento e le relative economie di una fase “a basso contenuto di zolfo” per la
scala e di competenze devono essere in parte flotta navale mondiale.
o interamente costruite. Il passaggio a combustibili a basso tenore
L’analisi svolta ha come obiettivo principale di zolfo rappresenta indubbiamente una sfida,
quello di indicare, nei due orizzonti temporali non solo in mare ma anche nella catena di ap-
di riferimento, l’ordine di preferibilità (o di sur- provvigionamento dei fuels richiesti dalle navi.
classamento) delle alternative di alimentazione/ Due le conseguenze dirette e tra loro correlate
powertrain considerate, tenendo conto dei nu- del cambiamento in atto:
merosi elementi che incidono sulle dinamiche • La domanda di carburanti navali si modi-
specifiche del settore. Le analisi di sensitività ficherà significativamente dal 2020 in poi,
condotte hanno lo scopo precipuo di individua- con impatto sui prezzi relativi dei diversi
re potenziali leve in grado di orientare la scelta tipi di bunker. Da un lato, si assisterà alla
tra le diverse opzioni percorribili. forte contrazione del consumo di prodotti
Fig. 1 – Le MARPOL Annesso VI
tappe dell’IMO
in materia 1973 1997 2000 2005 2010 2011 2012 2015 2016 2020
energetica
e ambientale
Contenuto di zolfocon tenore di zolfo al 3,5%, tipicamente olio ne cui si aggiungono i relativi costi di manu-
combustibile pesante noto come Heavy Fuel tenzione e gestione. Optare per tecnologie
Oil (HFO), sinora il più utilizzato; dall’altro, “nuove”, che impiegano fuels non tradizio-
si modificheranno le dinamiche produttive nalmente petroliferi, rappresenta ad oggi
delle raffinerie in ragione di un significati- una scelta praticabile ma più onerosa; scelta
vo aumento della domanda di combustibili che, sul lungo periodo, potrà invece risultare
IMO-compliant. Lo spread di prezzo tra le determinante nel conseguimento degli obiet-
diverse tipologie di combustibile – determi- tivi di decarbonizzazione proposti dall’IMO.
nato dalle differenti dinamiche di domanda
e offerta – potrebbe essere una variabile
importante per gli armatori e tale da con-
1.2. Perseguire l’obiettivo di
dizionare, almeno in parte, le loro scelte di
decarbonizzazione al 2050:
breve-medio periodo.
verso nuovi fuels
• Gli armatori si troveranno comunque di
fronte a un incremento dei costi, di in- In un orizzonte di più lungo respiro quale il
vestimento e/o operativi, in ragione delle 2050, il focus si sposta verso la progressiva ri-
scelte che la regolamentazione impone loro duzione dell’intensità carbonica del trasporto
di fare. Nelle aree di controllo delle emissio- marittimo. Nell’aprile 2018, l’IMO ha lanciato la
ni (ECAs - Emission Control Areas), le navi GHG Emission Initiative che declina in ambito
Il Global Sulphur Cap dello 0,5% è una sfida
sia per le raffinerie sia per gli armatori che vedranno
aumentare i costi di investimento e operativi
sono già obbligate a utilizzare bunker a bas- marittimo gli impegni internazionali di decarbo-
sissimo tenore di zolfo (0,1%); tuttavia, la de- nizzazione assunti con l’Accordo di Parigi, in li-
10 finizione di un cap dello 0,5% su scala glo- nea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (13°
bale determina giocoforza un aumento dei e 14°) dell’ONU. L’iniziativa, assumendo come
costi, seppur differenziato a seconda dell’op- riferimento il 2008, mira a ridurre l’intensità car-
zione di alimentazione considerata. Utilizzare bonica delle flotte navali internazionali di alme-
prodotti petroliferi sulphur compliant implica no il 40% entro il 2030 e del 70% entro il 2050.
maggiori costi del combustibile ma nessun Inoltre, entro il secolo corrente, il settore dovrà
investimento in conto capitale (CAPEX) per tendere all’obiettivo Zero GHG emissions, con
l’armatore, mentre la scelta di continuare a la tappa intermedia al 2050 di dimezzamento
utilizzare HFO richiede una spesa iniziale delle emissioni complessive di gas serra del
legata all’installazione di appositi impianti settore marittimo, sempre rispetto all’anno base
depuratori (scrubber) dei fumi di combustio- 2008 (Fig. 2). In questa fase, gli Stati partecipa-
Fig. 2 – Strategia
2013 IMO per la
Energy Efficiency Design Index (EEDI) Business as usual
riduzione delle
Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)
emissioni di gas
2018 serra
Initial GHG strategy
Strategia IMO
2008 2015 2020 2025 2030 2050 2100
anno
base
–10% –20% –30% –40% intensità carbonica –70%
emissioni totali –50% –100%Al 2030 la decarbonizzazione del trasporto marittimo
muoverà in buona parte dal ripensamento dell’ecosistema
di navigazione nel suo complesso
no alla definizione della strategia inviando pro- • sull’interruzione dell’uso dei motori termi-
poste concrete per il raggiungimento dell’ambi- ci durante la fase di fermo in banchina, in
zioso target, non ancora vincolante. virtù della dotazione della stessa di sistemi
A prescindere dall’effettiva modalità di imple- di alimentazione elettrica per i sotto-servizi
mentazione di un così ambizioso obiettivo, oc- di bordo durante le fasi di carico/scarico e,
corre riflettere sulle principali leve che orien- in genere, di ormeggio (cold ironing o hore
teranno l’industria navale lungo la traiettoria di connection, shore-to-ship power-SSP, alter-
decarbonizzazione delineata dall’IMO. native maritime power-AMP);
Nel breve-medio termine, la riduzione delle • sull’ibridizzazione del powertrain per le
emissioni climalteranti potrà solo in parte de- imbarcazioni nelle quali predominano i ser-
rivare da maggiori sforzi in termini di effi- vizi (trasporto pubblico su vie d’acqua, tra-
cienza energetica. I motori navali, infatti, sono ghetti, navi da crociera, nautica da diporto
già oggi molto efficienti, con rendimenti anche e applicazioni similari), mediante l’affianca-
prossimi al 50%, ben superiori a quelli dell’in- mento di un motore elettrico con batteria al
dustria automobilistica. motore termico, da impiegare anche come
Ulteriori sforzi in tal senso, considerato l’at- ausilio nelle fasi di accelerazione.
tuale preponderante impiego di bunker marini In sostanza, al di là degli interventi sull’im-
derivati dal petrolio, possono certamente con- pianto motoristico e sui relativi carburanti, oc-
tribuire a ridurre le emissioni ma non nella mi- corre rivedere l’ecosistema della navigazio-
sura richiesta dall’IMO. Pertanto, risulterà fon- ne al fine di ridurre i tempi di utilizzo del motore
damentale lavorare contemporaneamente su stesso o migliorarne l’efficienza.
più fronti: Al 2050, invece, il contributo più rilevante al 11
• in primis sulla velocità di navigazione, con- processo di decarbonizzazione del trasporto
siderando che in condizioni di funzionamen- marittimo proverrà dalla diversificazione delle
to a regime costante la potenza richiesta alimentazioni/powertrain per la propulsio-
dall’elica è all’incirca proporzionale al cubo ne delle navi, tenendo conto delle emissioni
della velocità; di CO2 legate all’intero ciclo di vita dei fuels2.
• sulla gestione delle spedizioni, in termini di Le tecnologie alternative a minori emissioni di
frequenza, di livello di riempimento dei na- ossidi di carbonio sono oggi significativamente
tanti e di ottimizzazione dei carichi (es. de- più costose di quelle oil-fuelled. Tuttavia, è ra-
posito in porto e successivo prelievo in virtù gionevole attendersi che i costi relativi segui-
di logiche di smistamento definite in base ranno un trend decrescente all’aumentare
alle rotte e alla saturazione della stiva); delle economie di scala e, quindi, con il con-
• sull’aerodinamica dello scafo e dell’opera solidamento di filiere di approvvigionamento ad
morta (parte emersa della nave); oggi pressoché inesistenti o circoscritte a spe-
• sull’integrazione di vele e rotori affinché cifiche regioni. Di certo, per rendere queste op-
contribuiscano attivamente alla parte pro- zioni tecnicamente fattibili ed economicamente
pulsiva; sostenibili saranno determinanti misure re-
• sull’adozione di sistemi di rotta intelligenti golatorie conservative nel tempo e oppor-
con i quali si tiene conto anche del livello tuni meccanismi di incentivazione, quali ad
di congestione del porto per programmare esempio la definizione di uno standard qualita-
l’arrivo in banchina, azzerando attese non tivo per i carburanti low carbon che consenta di
operative; ridurne l’intensità carbonica in modo graduale.
Al 2050 un contributo rilevante proverrà dalla
diversificazione delle alimentazioni/powertrain
verso soluzioni low carbon2. Alternative a confronto: sono state strutturate in base a 15 criteri (Tab.
costruzione del metodo ed esiti 2), individuati tenendo conto delle particolarità
del settore e con l’intento di comprendere i fat-
tori più importanti afferenti a cinque macro-di-
In considerazione del contesto e dello scena- mensioni: sociale-lavorativa; economica; ener-
rio regolamentare delineato, la presente analisi getica; ambientale; di sicurezza e disponibilità
si focalizza su sei soluzioni tecnologiche al- energetica. Per individuare la documentazione
ternative (e loro possibili evoluzioni) che po- più significativa e gli interlocutori più adegua-
tranno avere un ruolo nel trasporto marittimo al ti, si è fatto primario riferimento agli attori isti-
2030 e al 2050 (Tab. 1). tuzionali e aziendali che hanno partecipato al
La comparazione tra le sei opzioni conside- Workshop sul trasporto marittimo del 3 apri-
rate è stata effettuata attraverso un’analisi mul- le 2019, organizzato dal Gruppo Strategico
ti-criteri che ha portato all’elaborazione di due “Carburanti ed Energie Alternative” istituito
matrici di decisione (2030 e 2050). Le matrici da unem.
Tab. 1 – Alternative considerate nell’AMC applicata al trasporto marittimo
Alternative Descrizione
Comprendono prodotti di diversa natura quali:
(a) gasolio marino: distillato a bassissimo contenuto di zolfo attualmente
impiegato in ambito ECA e negli stazionamenti in porto; non presenta
Combustibili petroliferi con problemi di disponibilità ma è più costoso dell’olio combustibile tradizionale;
tenore di zolfo ≤0,5% – Motori (b) distillati pesanti: componenti per blend alternativi più difficilmente
a combustione interna (MCI) destinabili alla produzione di gasolio; costo inferiore rispetto al gasolio
tradizionali marino ma disponibile solo presso le raffinerie con grado di conversione
medio-alto;
(c) Ultra Low Sulphur Fuel Oil: opzione meno costosa rispetto alle altre ma
con potenziali criticità circa i volumi disponibili
12
Olio combustibile pesante
Bunker marino tradizionale con formulazione simile a quella degli oli
(HFO) con tenore di zolfo 3,5%
combustibili; noto anche come Heavy Fuel Oil (HFO)
e scrubber – MCI tradizionali
Si ottiene sottoponendo il gas naturale, dopo opportuni trattamenti
di depurazione e disidratazione, a successive fasi di raffreddamento
GNL – MCI con alimentazione e condensazione. Il prodotto che ne deriva si presenta come un liquido
per GNL inodore e trasparente costituito da una miscela composta prevalentemente
da metano e avente una temperatura di ebollizione di circa -160 °C a
pressione atmosferica
È il più semplice degli alcoli, è liquido a temperatura e pressioni normali,
ed è quindi facile da stoccare e da trasportare, ma è tossico. Il metanolo
Metanolo – MCI con
può essere prodotto a partire da differenti feedstock, principalmente gas
alimentazione per metanolo
naturale e carbone, ma anche da fonti rinnovabili o direttamente dalla CO2
catturata dalle centrali elettriche (idrogenazione dell’anidride carbonica)
Powertrain ibridi – Combustibili
petroliferi con tenore di zolfo
Questa opzione si differenzia dalla prima in relazione al powertrain e non
≤0,5% con motore elettrico e
alla fonte di alimentazione
batteria accoppiati a un MCI
(ambiti specifici)
Gli e-fuels sono combustibili di sintesi ottenuti dall’idrogeno (“verde”
e “blu”), a sua volta prodotto tramite elettrolisi dell’acqua, utilizzando
Nuovi combustibili (e-fuels) elettricità da fonti rinnovabili e anidride carbonica catturata da impianti
o vettori energetici industriali o direttamente dall’aria. L’ammoniaca è un composto di azoto con
(prevalentemente ammoniaca, formula chimica NH3, caratterizzato da un’alta concentrazione di idrogeno e
tradizionale ed e-ammoniaca) – quindi di energia. Si presenta come un gas incolore, tossico, in grado di
MCI o fuel cell con ibridizzazione diventare liquido a una temperatura di circa -77° C e gassoso a -33° C e
elettrica dove utile può essere sintetizzato da due degli elementi più comuni sulla Terra: l’azoto
dell’aria e l’idrogeno dell’acqua (o del metano). È ricompresa tra gli e-fuels
quando prodotta per sintesi da idrogeno e da azoto ottenuto dall’atmosferaLa caratterizzazione delle alternative consi- (MCI) alimentata da bunker marini a basso
derate in termini di proprietà fisiche, variabili tenore di zolfo. Al 2019, su un totale di circa
economiche e impatto ambientale ha permesso 70.000 imbarcazioni soggette alla regolamen-
di attribuire un giudizio ai criteri della matrice di tazione IMO, circa 60.000 sono in grado di uti-
decisione nei due orizzonti di riferimento e di lizzare combustibili petroliferi conformi al Glo-
formulare considerazioni relative all’evoluzione bal Sulphur Cap; circa 3.800 sono equipaggiate
attesa del fuel mix del settore, avendo bene a con scrubber e quindi continuano a impiegare
mente la situazione da cui si parte. il bunker marino tradizionale (HFO); circa 500
Qualsiasi analisi di tipo prospettico deve in- sono le navi alimentate a GNL, considerando
fatti tener conto della condizione di partenza: sia quelle già operative sia quelle in procinto
nella fattispecie, risulta determinante conosce- di esserlo; indicativamente 400 presentano
re l’attuale incidenza delle diverse alterna- powertrain ibridi, mentre solo qualche decina
tive rispetto alla configurazione standard impiega metanolo o nuovi combustibili/vettori
Tab. 2 – Dimensioni e criteri dell’AMC
Dimensione Criterio Descrizione
Si riferisce all’esistenza di un consolidato sistema di
produzione del carburante/vettore energetico e di
Dimensione 1. Economia di scala manutenzione del tipo di motore: esperienza, personale e
socio- capacità, impianti e loro diffusione
economico-
lavorativa Si riferisce a quanto è possibile che venga decarbonizzata
2. Decarbonizzazione filiera la filiera per effetto della decarbonizzazione della
produzione
Dato numerico di riferimento che intende misurare il punto
3. Quantità motori attuale di "ancoraggio" dato dalla flotta attuale, cioè l'inerzia di
trasformazione delle flotte
Indicatore del tempo necessario alla sostituzione delle flotte
4. Tasso di sostituzione navi
con un determinato tipo di propulsore
13
Indicatore dell'ordine di grandezza dell'investimento
Dimensione 5. CAPEX armatori necessario per costruire una nave con un dato tipo di
economica alimentazione/motore (situazioni confrontabili)
Indicatore del costo operativo dovuto all'uso di un dato tipo
6. OPEX armatori
di alimentazione/motore in situazioni confrontabili
Investimenti per la produzione di un dato tipo di carburante/
7. CAPEX produttori
vettore energetico
Costi operativi per la produzione di un dato tipo di
8. OPEX produttori
carburante/vettore energetico
9. Rendimento del motore (tank to Rendimento energetico della trasformazione da
Dimensione propeller) combustibile/vettore energetico a energia alle eliche
Energetica 10. Rendimento del processo well Rendimento energetico dal processo produttivo del
to tank combustibile/vettore energetico al serbatoio
11. CO2 locale (tank to propeller) Emissioni di CO2 riferite a tank to propeller
Emissioni di CO2 riferite alla fase well to tank o production
12. CO2 well to tank to tank quando il vettore energetico venga prodotto e non
Dimensione
estratto
ambientale
Indicazione della possibilità che il combustibile/vettore
13. Potenzialità di rispetto delle
energetico soddisfi eventuali future norme più stringenti su
norme su inquinamento locale
inquinanti come NOx, SO2, particolati
Rappresenta la disponibilità in natura a costi accettabili
Dimensione 14. Disponibilità in natura della materia prima da cui si ottiene il carburante/vettore
sicurezza energetico
e disponibi-
lità energe- 15. Disponibilità nel Rappresenta la disponibilità del carburante/vettore
tica processo produttivo (incluso energetico nei porti e in generale nelle filiere produttive
approvvigionamento navi) industriali4.500 4.500 Fig. 3 – Naviglio
attuale: le
alimentazioni
alternative al fuel
3.000 3.000 a basso tenore
di zolfo
(unità)
1.500 1.500
0 0
HFO GNL Powertrain Nuovi vettori Metanolo
con scrubber ibridi o combustibili
(es. idrogeno)
Nota: la figura riporta il dimensionamento della flotta esistente in base al combustibile, al vettore energetico
impiegati e dotazione di sistema post-combustione di controllo dei fumi.
Fonte: DNV GL AFI 2020.
energetici quali l’idrogeno (in quest’ultimo caso Ultra Low Sulphur Fuel Oil). Il maggior costo
si tratta di prototipi). Dato il punto di partenza, i per l’armatore o la compagnia di navigazione è,
giudizi contenuti nella matrice di decisione con- quindi, principalmente di tipo operativo in rela-
siderano spesso il fuel a basso tenore di zolfo zione alla maggiore onerosità di questi prodotti
e quello tradizionale (3,5%) come le tipologie di rispetto all’olio combustibile a medio o alto te-
alimentazione di riferimento rispetto a cui valu- nore di zolfo. Lato produzione, l’industria della
tare le altre (Fig. 3). raffinazione mondiale si è da tempo strutturata
per soddisfare la richiesta di tali bunker e con-
tinua ad orientarsi in tale direzione attraverso
2.1. Gli esiti dell’AMC al 2030 investimenti in impianti di conversione e desol-
14
forazione; le fasi di stoccaggio e distribuzione
In base ai pesi assegnati ai diversi criteri possono invece contare su un sistema infra-
all’orizzonte 2030, l’AMC restituisce un ordine strutturale ampio e diffuso su scala globale. A
di surclassamento in cui prevale nettamente fronte degli indiscutibili vantaggi in termini eco-
l’opzione “Combustibili petroliferi con teno- nomici, prestazionali e infrastrutturali, i combu-
re di zolfo ≤0,5%”, seguita da “Olio combu- stibili a basso tenore di zolfo non rappresentano
stibile pesante (HFO) con tenore di zolfo 3,5% l’opzione ottimale sul versante delle emissioni
e scrubber” (Tab. 3). Nei prossimi dieci anni, climalteranti. Se gli ossidi di zolfo vengono
una variabilità sostanzialmente limitata nel ren- automaticamente ridotti di oltre l’85% renden-
dimento dei motori termici, l’attuale ripartizione
del naviglio – in termini di tipologie di moto- Tab. 3 – Ordine di surclassamento delle
rizzazione e alimentazione – e la presenza di alternative al 2030 con la batteria di pesi base
economie di scala consolidate nella produzione
1 Combustibili petroliferi con tenore di zolfo
di un determinato combustibile/vettore energe-
≤0,5% – MCI tradizionali
tico sono fattori che continueranno ad avere
un’elevata incidenza sulle scelte degli armatori 2 Olio combustibile pesante (HFO) con tenore
di zolfo 3,5% e scrubber – MCI tradizionali
e condizionano l’esito dell’AMC.
La maggior parte delle navi può, già oggigior- 3 GNL – MCI con alimentazione per GNL
no, impiegare combustibili a basso tenore di 4 Powertrain ibridi – Combustibili petroliferi
zolfo (IMO 2020-compliant): per gli armatori/ con tenore di zolfo ≤0,5% con motore
compagnie di navigazione il loro utilizzo non elettrico e batteria accoppiati a un MCI
comporta nuovi investimenti in conto capitale in (ambiti specifici)
quanto non sono necessari adattamenti motori- 5 Metanolo – MCI con alimentazione per
stici particolari. È tuttavia necessaria una certa metanolo
attenzione per evitare fenomeni di incompatibi- 6 Nuovi combustibili (e-fuels) o vettori
lità, instabilità e contaminazione in ragione del- energetici (prevalentemente ammoniaca
la diversa natura dei prodotti che rientrano in tradizionale ed e-ammoniaca) – MCI o fuel
tale categoria (gasolio marino, distillati pesanti, cell con ibridizzazione elettrica dove utiledo più agevole controllare anche le emissioni penetrazione su più ampia scala è fortemente di NOx e di particolato, per quanto attiene alla collegata alla diffusione territoriale di depositi e CO2 non ci saranno sostanziali cambiamenti ri- impianti di rifornimento. Ad oggi, solo in alcune spetto all’impiego di HFO tradizionale, a parte parti del mondo sussiste questa disponibilità e una modesta riduzione associata a una più fa- si ritiene che anche tra dieci anni – considerati cile ottimizzazione della combustione. Tuttavia, i tempi di autorizzazione e costruzione di ter- in un orizzonte di medio periodo quale il 2030, minali e depositi nonché il loro elevato costo questo aspetto non incide sull’ordinamento re- di investimento – la situazione non sarà molto stituito dall’AMC in quanto più che compensato diversa da quella attuale. Peraltro, anche ipotiz- dai numerosi aspetti premianti sopra riportati. zando un aumento della disponibilità di GNL nei Nel decennio in corso, inoltre, la riduzione delle porti all’orizzonte 2030 il risultato non cambia. emissioni di gas serra potrà essere parzialmen- In conclusione, nonostante il GNL sia un’alter- te conseguita attraverso il miglioramento delle nativa a minori emissioni di gas serra rispetto ai tecniche di navigazione operative e gestionali. combustibili oil-based – specie se si eliminano i Gran parte delle considerazioni espresse rilasci di metano sia a monte che durante la fase per i combustibili petroliferi IMO 2020-com- di combustione – lo scenario delineato dall’AMC pliant valgono anche per l’opzione “Olio com- non gli assegna il ruolo di soluzione tecnologica bustibile pesante (HFO) con tenore di zolfo dominante al 2030, anche se il numero di navi 3,5% più scrubber” che, infatti, si posiziona che vi faranno ricorso è previsto crescere. al secondo posto nell’ordine di surclassamen- L’alternativa “Powertrain ibridi” – motore to risultante dall’AMC. In questo caso, occorre termico alimentato da combustibile petrolifero precisare come il maggior costo per l’armatore con tenore di zolfo ≤0,5%, accoppiato a un mo- o compagnia di navigazione sia legato essen- tore elettrico – merita una precisazione ai fini zialmente all’installazione dello scrubber, ne- della corretta lettura dell’ordinamento delle pre- cessaria per rispettare il Global Sulphur Cap ferenze restituito dall’AMC. Adottata su meno dello 0,5%. Il tempo di ritorno dell’investimento dell’1% del naviglio esistente, questa soluzione è in genere contenuto (1-2 anni) ma la relativa tecnologica mista di trazione e propulsione è economicità di questa scelta si scontra con re- più adatta per navi che svolgono servizi brevi 15 strizioni ambientali che vietano, in alcune zone, (es. traghetti, trasporto locale), eventualmente l’uso di determinate tipologie di scrubber e con per la nautica da diporto, o laddove il consu- la tendenziale incapacità dell’offerta di simili im- mo di elettricità a bordo diviene importante ri- pianti di far fronte a una domanda supposta in spetto al consumo energetico complessivo (es. continua crescita. In termini di future disponi- navi per crociere o navi con impianti di refri- bilità, al tema relativo allo scrubber si affianca gerazione). Pertanto, questa alternativa – che quello della produzione di olio combustibile a presenta indubbi vantaggi dal punto di vista del medio-alto tenore di zolfo, attesa ridursi forte- rendimento solo dove dominano accelerazioni mente in ragione del ri-orientamento delle raffi- frequenti, con evidenti benefici in termini di im- nerie verso prodotti IMO 2020-compliant. patto ambientale – può essere vista come una L’alternativa “GNL” – un combustibile di sottoclasse particolare della tipologia “Com- per sé privo di emissioni di zolfo e quindi IMO bustibili petroliferi con tenore di zolfo ≤0,5%” 2020-compliant – poggia su una tecnologia or- e “Olio combustibile pesante e scrubber” per- mai consolidata in termini di produzione e di ap- ché, di fatto, per la motorizzazione termica si plicazione al settore navale. Tuttavia, la sua dif- usano gli stessi motori e gli stessi combustibili. fusione è ad oggi molto limitata (circa 500 navi Anche in prospettiva, la sua penetrazione ri- al 2019, considerando anche quelle ancora marrà contenuta e vincolata al tipo di servizio non operative), a sottolineare la forte inerzia del che effettua la nave. In questa sede viene co- comparto rispetto a nuovi tipi di alimentazione munque considerata come alternativa distinta che richiedono appositi impianti di stoccaggio perché l’analisi è stata impostata per tipo di mo- e/o rifornimento. La terza posizione assegnata- torizzazione e di combustibile/vettore energeti- gli dall’AMC all’orizzonte 2030 è principalmen- co, tralasciando – per ragioni di semplificazione te ascrivibile agli elevati costi che questa scel- – l’ambito di lavoro dei diversi tipi di naviglio. Ad ta comporta sia per gli armatori/compagnie di ogni modo, l’ibridizzazione va vista come ben- navigazione (una nave a GNL costa circa il 15- venuta, anche nel breve-medio termine: nel tra- 20% in più rispetto a una nave gemella alimen- sporto marittimo, il ricorso a questa tipologia di tata con bunker petroliferi) sia per i produttori alimentazione aumenterà sino a coprire, secon- a monte. Dipende, inoltre, dal fatto che la sua do fonti informali, il 10% del naviglio al 2030.
In ultima posizione figurano le alternative “Me- degli esiti significa una relazione di surclassa-
tanolo” e “Nuovi combustibili (e-fuels) o vet- mento forte, quindi robusta al variare della sen-
tori energetici (prevalentemente ammonia- sibilità che un valutatore può avere nei confronti
ca)” in quanto rappresentano soluzioni ad oggi di un determinato peso (percezione ambientale,
molto limitate o del tutto assenti. Considerata la finanziaria, etc.). Anche l’impiego di pesi uguali
forte inerzia del settore legata ai tempi di ricam- per tutti i criteri restituisce l’ordine di preferenza
bio del naviglio (30-35 anni), sono tecnologie delineato nel caso base. Questo insieme di risul-
che al 2030 non riusciranno a conoscere una tanze sottende una distinzione sufficientemente
diffusione di rilievo. Il decennio in corso dovrà o netta delle prestazioni delle diverse alternative.
potrà semmai servire per testare attentamente Più in dettaglio, si espongono le analisi di
un interesse che, specie per nuovi vettori ener- sensitività effettuate. Diminuendo l’importanza
getici come l’ammoniaca (tradizionale ed dell’effetto dell’economia di scala e della com-
Al 2030 il fuel mix del settore è in larga parte
predeterminato dall’attuale consistenza del naviglio
e dalla possibilità di sfruttare impianti, dotazioni
tecnologiche e competenze consolidate
e-ammoniaca) sembra essere alto. L’impiego posizione attuale del naviglio, il GNL sale al
di un nuovo combustibile di sintesi, dato il ne- primo posto mentre le rimanenti alternative
cessario allungamento della catena energetica non variano il loro posizionamento rispetto al
che questo comporta, richiede una valutazione caso base (Tab. 4). Un simile esito sta ad indi-
ampia e non limitata al solo rendimento della care come l’attuale consistenza della flotta e
combustione a bordo natante; occorre conside- i lunghi tempi di sostituzione delle navi sia-
rare anche la possibilità di produrlo partendo no criteri in grado di incidere sullo scenario
da fonti rinnovabili, i suoi costi, la sua densità delineabile per il 2030 in ragione della for-
16 energetica, la relativa massa e l’autonomia rag- te inerzia del settore. Contemporaneamen-
giungibile con i serbatoi (nel caso dell’ammo- te, l’esistenza di competenze e conoscenze
niaca), onde impattare il meno possibile sulla consolidate, spesso legata a una filiera di ap-
programmazione delle navigazione, degli or- provvigionamento diffusa su scala mondiale, si
meggi, nonché sulla dotazione di impianti per tradurrebbe in una significativa crescita del na-
il rifornimento presso le banchine. Occorre poi viglio alimentato a GNL, rendendolo una valida
tenere conto del fatto che, negli ultimi 50 anni, soluzione ponte per la transizione del trasporto
il motore delle navi è stato ottimizzato per la- marittimo verso gli obiettivi di decarbonizzazio-
vorare con combustibili a base carboniosa con ne proposti dall’IMO.
caratteristiche di lubrificazione, densità, visco-
sità e con effetti di corrosione a caldo e a fred- Tab. 4 – Ordine di surclassamento al 2030 con
do ormai noti. Gli interrogativi da porsi circa gli riduzione del 50% dei pesi relativi a effetto
effetti associati a un radicale cambiamento del scala e motori attuali
combustibile/vettore energetico sono quindi
1 GNL – MCI con alimentazione per GNL
molteplici e la mancanza di esperienza e com-
petenze consolidate pone la loro concorrenzia- 2 Combustibili petroliferi con tenore di zolfo
≤0,5% – MCI tradizionali
lità su orizzonti temporali maggiori di dieci anni.
3 Olio combustibile pesante (HFO) con tenore
di zolfo 3,5% e scrubber – MCI tradizionali
2.1.1. Analisi di sensitività 4 Powertrain ibridi – Combustibili petroliferi
al 2030 con tenore di zolfo ≤0,5% con motore
elettrico e batteria accoppiati a un MCI
Nella lettura dei risultati dell’AMC è oppor- (ambiti specifici)
tuno ricordare che l’ordinamento proposto è 5 Metanolo – MCI con alimentazione per
quello che meglio soddisfa i criteri individuati metanolo
con i pesi base ad essi attribuiti. Nella maggio- 6 Nuovi combustibili (e-fuels) o vettori energetici
ranza dei casi, detto ordinamento permane an- (prevalentemente ammoniaca, tradizionale
che operando variazioni dei pesi3, effettuate per ed e-ammoniaca) – MCI o fuel cell con
testare la sensitività dei risultati: un’invarianza ibridizzazione elettrica dove utileLa posizione del GNL rispetto al caso base serra, tanto da favorire l’emergere e la progres-
migliora anche se si aumenta del 50% il peso siva diffusione di nuovi combustibili o di vettori
del criterio relativo alle emissioni locali. In tale energetici atti ad assecondare sia il conteni-
evenienza, il GNL si posiziona al secondo po- mento delle immissioni locali in atmosfera, sia
sto perché la sua combustione presenta minori delle emissioni a dispersione estesa su scala
emissioni di CO2 tank to propeller (Tab. 5). planetaria. Tre decenni sono infatti un arco di
tempo durante il quale anche soluzioni ad oggi
Tab. 5 – Ordine di surclassamento al 2030 scarsamente sperimentate o del tutto inesplo-
con aumento del 50% del peso assegnato rate nella navigazione possono ritagliarsi un
a CO2 locale ruolo di rilievo, conseguendo gradualmente
quelle economie di scala (di produzione e ma-
1 Combustibili petroliferi con tenore di zolfo
nutenzione) e di apprendimento che permette-
≤0,5% – MCI tradizionali
rebbero un progressivo contenimento dei costi
2 GNL – MCI con alimentazione per GNL relativi all’intera catena del valore.
3 Olio combustibile pesante (HFO) con tenore Pertanto, le alternative prese in considera-
di zolfo 3,5% e scrubber – MCI tradizionali zione al 2050 si differenziano in parte da quelle
4 Powertrain ibridi – Combustibili petroliferi analizzate al 2030. Nella fattispecie, anche sulla
con tenore di zolfo ≤0,5% con motore scorta delle indicazioni del gruppo di lavoro, è
elettrico e batteria accoppiati a un MCI stata eliminata l’opzione “Olio combustibile con
(ambiti specifici) tenore di zolfo al 3,5% e scrubber”, ipotizzando
5 Metanolo – MCI con alimentazione per che a quell’orizzonte non venga più prodotto
metanolo in conseguenza del completo ri-orientamento
6 Nuovi combustibili (e-fuels) o vettori energetici delle raffinerie verso soluzioni a minor impatto
(prevalentemente ammoniaca, tradizionale ambientale. Si è ritenuto, inoltre, ragionevole
ed e-ammoniaca) – MCI o fuel cell con inserire l’eventuale installazione di scrubber,
ibridizzazione elettrica dove utile presumibilmente anche più avanzati rispetto
a quelli in produzione oggi, su quelle navi che
Non si assiste a nessuna variazione rispetto saranno ancora alimentate con combustibili pe- 17
all’ordinamento base variando – sia in aumento troliferi a basso tenore di zolfo, assumendo la
sia in diminuzione – il peso dei criteri legati ai co- possibile richiesta di azzeramento delle emis-
sti per gli armatori o a quelli per i produttori a sioni solforose (e quindi l’inasprimento della re-
monte (CAPEX e OPEX). Analogamente, modifi- golamentazione IMO-2020).
cando i pesi legati a sicurezza e disponibilità o L’analisi multi-criteri restituisce un ordine di
raddoppiando il peso del criterio “potenzialità di surclassamento in cui i combustibili petroliferi
rispetto delle norme su inquinamento locale” con contenuto di zolfo ≤0,5% e i nuovi combu-
– quindi portandolo allo stesso livello dei criteri stibili (e-fuels)/vettori energetici (prevalente-
più importanti – il risultato non cambia. Sono sta- mente ammoniaca, tradizionale ed e-ammonia-
te eseguite analisi di sensitività anche variando ca) vengono ordinati ex aequo (Tab. 6).
le stime dei valori attribuiti alle alternative su al-
Tab. 6 – Ordine di surclassamento delle
cuni criteri (disponibilità in natura e nel processo alternative al 2050 con la batteria di pesi base
produttivo, economie di scala, CAPEX produttori
di carburanti/vettori energetici) senza conseguire 1 Nuovi combustibili
esiti significativamente differenti da quello base (e-fuels) o Combustibili
che può, pertanto, considerarsi robusto. vettori energetici petroliferi con
(prevalentemente tenore di zolfo
ammoniaca, tradizionale ≤0,5% – MCI
2.2. Gli esiti dell’AMC al 2050 ed e-ammoniaca) – tradizionali
MCI o fuel cell con eventualmente
ibridizzazione elettrica con scrubber
In un orizzonte temporale di trent’anni, è ra- dove utile
gionevole attendersi modifiche di rilievo rispet-
2 Powertrain ibridi – Combustibili petroliferi con
to al fuel mix attuale e a quello ipotizzato per tenore di zolfo ≤0,5% con motore elettrico e
il breve-medio termine, in risposta a possibili batteria accoppiati a un MCI (ambiti specifici)
e attesi inasprimenti della regolamentazione
3 GNL – MCI con alimentazione per GNL
internazionale sulle emissioni e a interventi
normativi su scala continentale; questi potran- 4 Metanolo – MCI con alimentazione per
no riguardare sia gli inquinanti locali sia i gas metanoloPuoi anche leggere