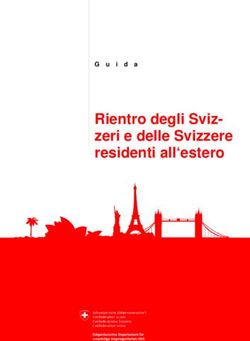OLTRE LE PAROLE: COMPRENDERE IL MUTISMO SELETTIVO - Giuliano Cuoghi Psicologo Psicoterapeuta - dd castel maggiore
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
OLTRE LE PAROLE:
COMPRENDERE IL MUTISMO SELETTIVO
Giuliano Cuoghi
Psicologo Psicoterapeuta
Centro Terapia Cognitiva di Bologna (www.ctc.bo.it)
Docente presso la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (www.sbpc.it)Un po’ di storia… 1877: “afasia volontaria” (Kussmal) 1934: “mutismo elettivo” (Tramer) 1980: “persistente rifiuto di parlare” (DSM-III) 1983: “mutismo selettivo” (Hasselman) 1994: “costante incapacità di parlare” (DSM-IV)
Criteri diagnostici secondo il DSM-V (2013) A. costante incapacità di parlare in situazioni sociali specifiche in cui ci si aspetta che si parli (per esempio a scuola), nonostante si sia in grado di parlare in altre situazioni; B. la condizione interferisce con i risultati scolastici e con la comunicazione sociale; C. la durata della condizione è di almeno 1 mese (non limitato al primo mese di scuola); D. l’incapacità di parlare non è dovuta al fatto che non si conosce la lingua, o non si è a proprio agio con il tipo di linguaggio richiesto dalla situazione sociale; E. la condizione non è meglio spiegata da un disturbo della comunicazione e non si manifesta esclusivamente durante il decorso di disturbi dello spettro autistico, schizofrenia o altri disturbi psicotici.
Caratteristiche associate eccessiva timidezza, imbarazzo sociale, isolamento, clinging —> ansia sociale negativismo ansia da prestazione e perfezionismo accessi di collera e comportamenti oppositivi difficoltà scolastiche occasionalmente, disturbi della comunicazione
“Il silenzio non è assenza ma presenza”
Epidemiologia e decorso La prevalenza del disturbo è di circa 7 bambini su 1000. Il 60% circa sono di sesso femminile. L’età di insorgenza si colloca tipicamente tra i 3 e i 6 anni di età, anche se il disturbo è più spesso individuato e riconosciuto in età scolare (tra i 6 e gli 8 anni). La prognosi è variabile: il disturbo può persistere per alcuni mesi oppure cronicizzarsi, continuando per diversi anni. Può evolvere in un Disturbo da Ansia Sociale.
Quali sono le cause del Mutismo Selettivo?
FATTORI PREDISPONENTI
- vulnerabilità all’ansia, timidezza, ipersensibilità;
- storia familiare di timidezza, ansia, o mutismo selettivo;
- scarsa socializzazione della famiglia;
- difficoltà di linguaggio;
- bilinguismo (specialmente quando connesso a una situazione di isolamento sociale).
TRIGGERS
- ingresso alla scuola materna/primaria;
- trasferimenti e traslochi;
- reazioni negative alle parole del bambino (ad es. prese in giro, urla, risate).
FATTORI DI MANTENIMENTO
- diagnosi errata o tardiva;
- isolamento sociale della famiglia;
- contesto familiare caratterizzato da dipendenza, iper-protettività e iper-sostegno;
- innalzamento dei livelli d’ansia nel bambino, attraverso un clima di pressione e colpevolizzazione;
- abilità nel comunicare attraverso messaggi non-verbali;
- sfiducia nella possibilità di superare il disturbo.…e il trauma?
Situazioni difficili per il bambino con MS la scuola… parlare al telefono parlare del Mutismo Selettivo, anche in famiglia feste e ricorrenze in cui si incontrano persone che possono fare domande domande sul sintomo (“Oggi a scuola hai parlato?”) incontri inattesi con conoscenti negozi ascensore momenti di separazione dal genitore attività extra-scolastiche (soprattutto se l’adulto di riferimento non viene avvisato del disturbo)
I modelli esplicativi del MS (I)
Percezione di pericolo nelle situazioni sociali
(paura per la realtà sociale esterna, non familiare)
Attivazione del sistema neurovegetativo (ad es. postura rigida, volto inespressivo)
Inibizione comportamentale: il “congelamento” della produzione verbale è una
reazione istintiva, una strategia di difesa di fronte all’incapacità percepita di
affrontare le richieste ambientaliI modelli esplicativi del MS (II)
Expectation of speech
Anxiety
Relief Avoidance
Negative reinforcementLA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO
DI JOHN BOWLBYGli studi etologici ci dimostrano che: l’attaccamento è un legame predeterminato predisposto a svilupparsi spontaneamente (ovviamente ogniqualvolta le condizioni lo permettano); il bisogno di vicinanza affettiva è importante tanto quanto l’alimentazione.
Il sistema motivazionale dell’attaccamento
Quando ti trovi in difficoltà - per stanchezza,
paura, dolore, etc. - mantieniti vicino o ripristina
la vicinanza ad un membro conosciuto del tuo
gruppo sociale che ti appaia più forte o più saggio
i comportamenti di attaccamento dunque non sono sempre
visibili, ma sono evidenti in momenti di stress, paura e disagio.La teoria dell’attaccamento viene assunta come trama concettuale di riferimento per comprendere lo sviluppo infantile all’interno di una dinamica continua tra bisogno di dipendenza e bisogno di autonomia (esplorazione).
ATTACCAMENTO ESPLORAZIONE EQUILIBRIO —> ATTACCAMENTO SICURO
Il concetto di BASE SICURA e PORTO SICURO
…”fornire una base sicura da cui il bambino possa
partire per affacciarsi al mondo esterno e un porto
sicuro a cui possa ritornare sapendo che sarà il
benvenuto, nutrito sul piano fisico ed emotivo,
confortato se triste, rassicurato se spaventato […]
consiste nell’essere disponibili, pronti a rispondere
quando chiamati in causa, per incoraggiare o dare
assistenza, ma intervenendo attivamente solo quando è
chiaramente necessario”.
John BowlbyLa valutazione dell’attaccamento
(Mary Ainsworth e Patricia Crittenden, 1980)(grazie a Davide Osenda per le illustrazioni)
Modalità di chiusura evitante
Il bambino si comporta come se la tendenza fosse quella di non
influenzare il campo intersoggettivo circostante, non perturbarlo,
per non esporsi alle relazioni ritenute minacciose. Le emozioni
prevalenti sottese all’ansia sono la paura e la vergogna.
il silenzio può svolgere la funzione di controllo del Sè
(autosufficienza/compiacenza)Modalità di chiusura coercitiva
Il bambino suscita nell’adulto risposte prevedibili che soddisfano i
suoi bisogni. Le emozioni prevalenti sottese all’ansia sono la
paura (modalità passiva: atteggiamenti disarming, richieste
implicite di conforto, etc.) e la rabbia (modalità attiva:
atteggiamenti oppositivi, proteste, etc.).
il silenzio può svolgere la funzione di controllo della relazione e
dell’ambiente circostante“Il mutismo è una forma di controllo, che non deve essere inteso in maniera intenzionale o vendicativa, ma come manifestazione di uno stato d’ansia e della difficoltà a gestire le proprie emozioni” (Elisa Shipon-Blum, 2010)
Rezzonico, Iacchia et al. (2018) propongono la definizione clinica di “chiusura espressiva” o “mutismo situazionale”: “si passa dal concetto di “selettività”, che orienta l’attenzione alla persona in riferimento alle proprie azioni e vede i contesti come contenitori passivi, al concetto di “situazionalità”, che sposta il focus della riflessione clinica sulla situazione entro cui compare il sintomo, intesa come insieme complesso di relazioni e significati che lo mantengono e amplificano. Il mutismo passa dall’essere visto come una caratteristica prevalentemente individuale a caratteristica relazionale, che comprende le modalità con cui la persona si è costruita il proprio modello di interazione sociale.
Tutto quello che non dobbiamo fare…!
LA PSICOTERAPIA DEL BAMBINO CON MS
“…sognando gli altri come ora non sono:
ciascuno cresce solo se sognato”
Danilo Dolci“Ti accetto esattamente così come sei: io so che tu sai parlare, e credo che presto tu sarai in grado di farlo ovunque”: la legittimazione dei meccanismi di auto-protezione del bambino e il ruolo delle (nostre!) aspettative Il “terapeuta imperfetto” e la self-disclosure Assessment: analisi storica e funzionale del sintomo Il set di “regole interne” del bambino: quali sono i criteri interni della selettività? Visione “tutto-o-nulla” del disturbo Abbassare il livello di ansia: l’alfabetizzazione emotiva e le tecniche CBT Esposizione graduale: piccoli passi…grande pazienza! Sistemi Motivazionali Interpersonali (SMI) cooperativo ed esplorativo —> L’approccio multi-situazionale: il coinvolgimento di genitori e insegnanti Arteterapia, musicoterapia, psicomotricità, etc. Trattamento farmacologico?
IL LAVORO CON I GENITORI
“Lavorare con un bambino in difficoltà significa
lavorare con una madre [con due genitori] in difficoltà”
John Bowlby“Noi non vediamo le cose come sono: noi vediamo
le cose come siamo”
Anaïs NinLa “musica dello squalo”
(Powell, Cooper, Hoffman e Marvin, 2014)
Quando si attiva la musica dello
squalo, noi veniamo “deviati
dall’amigdala” (Goleman, 1995),
e - in preda al nostro stato
mentale - perdiamo di vista il
bambino.La “colonna sonora” che sentiamo dentro di noi determina quali bisogni del bambino vengono percepiti come sicuri e quali come pericolosi. Modelli Operativi Interni (MOI) e memoria procedurale (implicita)
Le modalità di parenting osservabili nel genitore sono frutto della
sua storia evolutiva, che si esprime nell’attuale in un particolare
stato mentale, caratterizzato da livelli più o meno buoni di
integrazione del sé, di mentalizzazione in prima e in terza
persona e quindi di mind-mindedness (o insightfulness), cioè di
orientamento alla mente del proprio figlio”.
(Lambruschi e Lionetti, 2015)Mind-mindedness (Meins, 1997) Insightfulness (Oppenheim, 2002)
Le schede ABC
(analisi funzionale)
(mentalizzazione in terza persona)
(mentalizzazione in prima persona)
IL MUTISMO SELETTIVO A SCUOLA
“Non ci sono motivi filosofici, scientifici o morali perché
la scuola debba diventare un luogo di sofferenza”
Pierre VayerL’insegnante come “co-terapeuta”
La costruzione di un team
“mentalizzante”La priorità è creare una relazione “rilassata”
tra bambino e contesto scolastico
(insegnanti e compagni): lo scopo che
dobbiamo porci è questo, non la
verbalizzazione!
Se il clima cambia in senso tranquillizzante e
coinvolgente, l’apertura e la parola
arrivano…
—> diamo l’esempio!Le difficoltà del bambino con MS a scuola
l’inserimento
l’ingresso del mattino
il “circle time”
la ricreazione
la valutazione dell’apprendimento
l’educazione motoria
le esibizioni in pubblico (recite, saggi, etc.)
l’ingresso di nuove figure in classeQualche consiglio agli insegnanti (1) qual é il set di “regole interne” del bambino? Mettiamoci in una posizione “osservativa” e sospendiamo l’azione. impariamo a vedere quel che c’è e non quel che manca: non focalizziamoci solamente sulla parola e non facciamo sentire le nostre aspettative al bambino; facciamo il possibile per far sentire il bambino a suo agio e rilassato: l’obiettivo è ridurre l’ansia; non mostriamo eccessivo entusiasmo per qualunque verbalizzazione dovesse verificarsi: comportiamoci come se nulla fosse accaduto, e normalizziamo anche le eventuali reazioni dei compagni; evitiamo il ricorso a punizioni, ricatti, inganni o premi pur di far parlare il bambino; ridurre il più possibile il contatto visivo con il bambino permette di diminuire sia la sua ansia, sia la sensazione di essere sotto pressione;
Qualche consiglio agli insegnanti (2) aiutiamo il bambino dando risposte opportune a chi gli chiede “Perchè non parli?”: “Francesco sa parlare benissimo, ma in certe occasioni le parole gli si incastrano in gola”; diamo la possibilità al bambino di esprimersi anche non verbalmente (ad es. coi gesti, o attraverso un sistema di carte con parole e immagini), senza sostituirci a lui nel dare risposte; diamo spazio alla creatività e a forme di comunicazione alternativa: disegno, pittura, musica, teatro… cerchiamo di aumentare l’autostima del bambino attraverso attività mirate (ad es. piccoli compiti e incarichi di fiducia che facciano sentire il bambino capace); favoriamo l’interazione sociale con i pari, (inizialmente privilegiando attività in coppia o in piccolo gruppo); incentiviamo l’esplorazione e l’autonomia;
Valutare la capacità di comunicazione del bambino:
la scala di comunicazione SM-SCCS (Shipon-Blum, 2010)
LIVELLO 0
Assenza di comunicazione (verbale e non verbale) del bambino:
non reagisce, non prende iniziative;
resta immobile, senza espressione, irrigidito.
LIVELLO 1
Comunicazione non verbale del bambino:
1A, risponde indicando con il dito, o annuendo con la testa, con gesti o scrivendo;
1B, prende l’iniziativa (attira l’attenzione di un’altra persona puntando, indicando, alzando la
mano, picchiettando sulla spalla di qualcuno, o porgendo una nota scritta, etc.)
Per passare dal livello 1 al livello 2 è necessario un intermediario verbale (mediatore).
LIVELLO 2
Comunicazione verbale del bambino.
2A, reagisce producendo suoni come mugugni, linguaggio infantile, versi di animali, gemiti,
sussurri, parole;
2B, inizia lo scambio attirando l’attenzione di un’altra persona producendo un suono qualsiasi.Programma di introduzione progressiva
della parola a scuola
(associazione “Ouvrir La Voix”, 2009)
A. Abituare il bambino a parlare a scuola per mezzo di un
intermediario verbale (solitamente, un genitore);
B. Non appena il bambino parla, ed è a suo agio a scuola con il
genitore, si può iniziare a introdurre altre persone, “trasferendo”
la parola ad altre persone diverse dal genitore (compagni,
insegnanti, etc.);
C. Allontanamento progressivo del genitore, affinché il bambino
possa relazionarsi autonomamente a scuola.Programma di introduzione progressiva
della parola a scuola:
le 4 fasi
1. Introduzione della parola all’interno del contesto scolastico;
2. Introduzione progressiva dei compagni di classe;
(anche in parallelo)
3. Introduzione progressiva dell’insegnante;
4. Presenza in contemporanea dei compagni e dell’insegnante.È importante offrire al bambino delle
occasioni regolari in cui frequentare i suoi
compagni di classe, per esempio a casa sua o
al parco…
…e gli insegnanti?1. Il bambino parla in casa, ma non a scuola. A
scuola sembra molto in ansia, e a volte rifiuta di
Mutismo assoluto a scuola. andarci.
Il bambino parla in casa, ma non a scuola. Inizia
2. a rilassarsi e a partecipare - non verbalmente -
Partecipazione non verbale rilassata. alle attività scolastiche. Parla della scuola in
maniera positiva.
Il bambino parla a scuola quando si trova
3. completamente da solo con un genitore, in un
luogo in cui i compagni e gli insegnanti non
Il bambino parla ad un genitore a scuola. possono né vederlo né sentirlo (spesso
bisbigliando).
4. Il bambino parla a scuola con un genitore, e i
Il bambino parla e i suoi coetanei possono compagni possono vederlo - ma non sentirlo -
vederlo mentre parla. in quanto egli bisbiglia.
5. Il bambino parla normalmente a scuola con un
genitore. Gli altri bambini possono vederlo e
Il bambino parla e i suoi coetanei possono ascoltarlo. Il bambino non parla direttamente ai
sentirlo. compagni e all’insegnante.6. Il bambino parla a un genitore, che riporta il
messaggio a un compagno che si trova vicino a
Il bambino parla a un suo compagno tramite il lui. Il compagno può eventualmente ascoltare e
genitore. rispondere direttamente al bambino.
7. Il bambino parla a scuola con un compagno,
spesso durante l’intervallo. Non parla con gli
Il bambino parla ad un compagno. insegnanti.
8. Il bambino parla a scuola con diversi compagni,
Il bambino parla a diversi compagni di classe. ma non con gli insegnanti.
9. Il bambino inizia a parlare con un insegnante,
Il bambino parla con un insegnante. oltre che con diversi compagni.
10. Il bambino parla con la maggior parte degli
adulti e dei compagni; la conversazione ha un
Discorso normale. tono normale.Esempi di attività: passo dopo passo… far rumore con uno strumento musicale o un oggetto; far rumore con il proprio corpo (ad es. battere le mani); far rumore con la bocca ma senza vocalizzare (ad es. soffiare, schioccare la lingua, sbadigliare); riprodurre versi di animali; riprodurre suoni di oggetti; riprodurre una lettera (ad es. la “A”) impiegando le labbra ma non la voce, poi la voce ma non le labbra; riprodurre una lettera con voce e labbra; pronunciare le vocali o le sillabe; rispondere “sì” o “no”; contare insieme; contare a turno, alternati; leggere insieme una parola; rispondere a domande facilissime (ad es. “Quanti anni hai?”, oppure “Quanto fa 2+2?”).
LETTURE CONSIGLIATE
Associazione Italiana Mutismo Selettivo - A.I.Mu.Se
www.aimuse.itNon si vede bene che con il cuore:
l’essenziale è invisibile agli occhi
(Antoine de Saint-Exupéry)GRAZIE PER L’ATTENZIONE giuliano.cuoghi@gmail.com Tel. 349 6046678
Puoi anche leggere