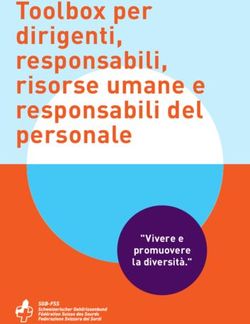Lo sviluppo sostenibile in breve 2015 - 17 indicatori chiave per misurare il progresso
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
21
Sviluppo sostenibile e disparità regionali
e internazionali
736-1500
Lo sviluppo sostenibile
in breve 2015
17 indicatori chiave per misurare il progresso
Ufficio federale di statistica UST
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE
Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC
Ufficio federale dell‘ambiente UFAM
Neuchâtel, 2015Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i
propri bisogni.
Far fronte ai bisogni del presente significa garantire la qualità di vita delle
generazioni attuali nei numerosi ambiti che questa nozione comprende (con-
dizioni di vita materiale, salute, qualità dell’ambiente ecc.).
Per soddisfare i nostri bisogni attuali non si deve però mettere in pericolo la
qualità di vita delle generazioni future né nuocere alle persone che vivono al
giorno d’oggi, in Svizzera o altrove. Proprio per questo lo sviluppo sosteni-
bile tenta di favorire una suddivisione equa delle risorse su scala regionale
e globale.
Il presente opuscolo mostra a che punto si trova la Svizzera sulla via dello svi-
luppo sostenibile. Si articola attorno a quattro domande fondamentali riguar-
danti lo sviluppo sostenibile e fornisce elementi di risposta concisi e facilmente
comprensibili. Queste informazioni sono fornite da 17 indicatori chiave tratti
dal sistema di indicatori MONET.
Per maggiori dettagli sulla definizione di sviluppo sostenibile e sul
contesto in cui questo concetto è nato, si veda a pagina 22.
Un indicatore chiave può rappresentare un gruppo di indicatori e con-
sente di mettere in risalto in modo semplificato le grandi tendenze e
gli aspetti salienti di un fenomeno.
MONET è un sistema di indicatori per il monitoraggio dello sviluppo
sostenibile. Pensato per informare la popolazione e gli attori politici,
offre circa 75 indicatori regolarmente aggiornati. Il sistema si basa su
una serie di principi che traducono gli obiettivi dello sviluppo sosteni-
bile in richieste concrete.
Ulteriori informazioni su MONET: www.monet.admin.ch
2Sulla strada dello sviluppo sostenibile ?
La società svizzera sta procedendo in direzione di uno sviluppo sostenibile ?
A questo proposito le quattro domande seguenti risultano fondamentali:
Soddisfacimento dei bisogni –
qual è la nostra qualità di vita al giorno d’oggi ?
Un reddito sufficiente, la salute, il sentimento di sicurezza: sono tutti biso-
gni che, quando soddisfatti, contribuiscono al benessere della popolazione.
Uno degli obiettivi centrali dello sviluppo sostenibile è quello di permettere a
tutti di vivere degnamente e di godere di una buona qualità di vita.
Equità –
come sono distribuite le risorse ?
La nozione di sviluppo sostenibile si basa sull’esigenza di equità. Ciò signi-
fica garantire a tutte le persone l’accesso equo a importanti risorse quali,
per esempio, la formazione, il reddito, la salute e l’aria pulita. La lotta con-
tro diseguaglianze e povertà dev’essere condotta su scala nazionale e inter-
nazionale.
Preservazione del capitale –
cosa consegniamo ai nostri figli ?
Sviluppo sostenibile vuol dire anche consumare in misura tale da non pre-
giudicare le risorse necessarie ai nostri figli e ai nostri nipoti. La qualità di
vita delle generazioni future dipende in gran parte dallo stato delle risorse
ambientali, economiche e sociali che consegneremo loro, in Svizzera e nel
mondo.
Sganciamento delle risorse –
quanto siamo efficienti nel loro sfruttamento ?
Nell’ottica dello sviluppo sostenibile, è necessario soddisfare i nostri bisogni
nei limiti tollerati dall’ambiente. Favorire uno sviluppo economico e sociale
senza portare detrimento all’ambiente implica l’adozione di modalità di pro-
duzione e di consumo più razionali ed efficienti.
3Siamo sulla buona strada ?
L’andamento di ogni indicatore è rappresentato dai simboli sotto riportati, che derivano dal
confronto tra l’evoluzione auspicata (freccia bianca su fondo blu) e quella osservata (frec-
cia nera su fondo bianco).
positivo (verso lo sviluppo sostenibile
negativo (contrario allo sviluppo sostenibile)
nessun cambiamento sostanziale
L’andamento degli indicatori è analizzato a partire dal 1992 (anno in cui si è tenuto il Ver-
tice della Terra organizzato dalle Nazioni Unite) fino all’ultimo valore disponibile. Per le serie
più recenti, l’analisi risale all’anno del primo dato disponibile. L’inizio del periodo conside-
rato è contrassegnato nei grafici dal simbolo , qualora non coincidesse con l’inizio del
periodo indicato.
Soddisfacimento dei bisogni – qual è Evoluzione Valuta- Pag.
la nostra qualità di vita al giorno d’oggi ? auspicata/osservata zione
La salute della popolazione migliora 5
Il redditi aumentano 6
Aumentano le condanne per reati violenti gravi 7
Cresce il tasso di disoccupati ai sensi dell’ILO 8
Equità – come sono distribuite Evoluzione Valuta- Pag.
le risorse ? auspicata/osservata zione
Il tasso di povertà diminuisce 9
L’aiuto pubblico allo sviluppo aumenta 10
Il divario salariale tra donne e uomini tende
11
lentamente a ridursi
Preservazione del capitale – Evoluzione Valuta- Pag.
cosa consegniamo ai nostri figli ? auspicata/osservata zione
Migliorano le capacità di lettura dei giovani 12
Dopo una fase di aumento, il debito pubblico ritorna
13
al di sotto dei livelli del 1992
La quota degli investimenti sul prodotto interno lordo
14
ristagna
Il numero di persone impiegate nella scienza e nella
15
tecnologia aumenta
Aumentano le popolazioni di uccelli nidificanti 16
Le superfici d’insediamento occupate pro capite
17
aumentano
Sganciamento delle risorse – quanto siamo Evoluzione Valuta- Pag.
efficienti nel loro sfruttamento ? auspicata/osservata zione
Nessun cambiamento significativo dell’intensità
18
del trasporto merci
La quota dei trasporti pubblici aumenta 19
Cala il consumo di energia pro capite 20
Diminuisce l’intensità materiale 21
4Satisfaction des besoins
Soddisfacimento dei bisogni
– quelle
– qualestè notre
la nostra
qualité
qualità
de vie
di vita
aujourd’hui
al giorno
? d’oggi ?
Salute
La salute della popolazione migliora
La salute va protetta e promossa
Chi si sente sano è spesso più contento di chi è malato o disabile. Al con-
tempo è anche più produttivo. A trarre profitto di una lunga vita in buona
salute non sono soltanto le persone direttamente interessate, ma anche l’e-
conomia e la società.
Speranza di vita in buona salute
Speranza di vita alla nascita, in anni
80
70
67,5 68,7 69,4 70,3 67,7 67,9
60 63,9 65,3 65,2 64,7
50
40
30
20
10
0
1992 1997 2002 2007 2012
Uomini Donne
2012: interruzione della serie temporale dovuta a una revisione del questionario
Fonte: UST – Indagine sulla salute in Svizzera (ISS) © UST, Neuchâtel 2015
• Tra 1992 e 2007, la speranza di vita in buona salute è aumentata di 5 anni
per le donne e di 5,5 anni per gli uomini.
• Nel 2012, corrispondeva a 67,9 anni per le donne e a 67,7 anni per gli
uomini. I dati non possono essere confrontati con quelli degli anni pre-
cedenti.
• Nel 2012, la speranza di vita in generale era di 84,7 anni per le donne e
di 80,5 anni per gli uomini.
5Soddisfacimento dei bisogni – qual è la nostra qualità di vita al giorno d’oggi ?
Reddito
I redditi aumentano
A ogni persona va garantita innanzitutto la possibilità di soddisfare
i propri bisogni primari. Un certo spazio di realizzazione dev’essere
dato però anche ai bisogni secondari
Bisogni primari materiali, quali il cibo, il vestiario o l’alloggio possono essere
soddisfatti soltanto se si dispone di mezzi finanziari sufficienti, nella mag-
gior parte dei casi provenienti dal reddito. Anche alcuni bisogni non mate-
riali, quali la formazione o la salute, sono difficili da coprire se non si pos-
siede il denaro necessario.
Reddito disponibile equivalente
Reddito mensile disponibile equivalente medio a prezzi del 2012, in franchi
5000
4000
3000
2000
1000
0
1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: UST – Indagine sul budget delle economie domestiche (IBED) © UST, Neuchâtel 2015
• Tra il 1998 e il 2006 non è stato registrato alcun incremento sensibile
del reddito mensile disponibile equivalente medio. A partire dal 2006 si
osserva una tendenza al rialzo.
• Nel 2012, il 20% della popolazione più benestante disponeva di un red-
dito 4,5 volte superiore rispetto a quello del 20% della popolazione meno
abbiente.
6Soddisfacimento dei bisogni – qual è la nostra qualità di vita al giorno d’oggi ?
Sicurezza
Aumentano le condanne per reati violenti gravi
La sicurezza fisica fa parte dei bisogni primari
Il numero di condanne per reati commessi con violenza grave (reati che col-
piscono la vita o l’integrità corporale) illustra il grado di soddisfacimento
di questo bisogno.
Reati violenti
Condanne per reati consumati gravi (omicidio, lesioni personali gravi,
violenze carnali, rapine con violenza, presa di ostaggi)
300
250
200
150
100
50
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2013
Fonte: UST -– Statistica delle condanne penali (SCP) © UST, Neuchâtel 2015
• Il numero di condanne per reati commessi con violenza grave è aumen-
tato dai 115 casi registrati nel 1990 ai 142 casi nel 2013.
• Nel 2013, il 43,7% delle 142 condanne per reati con violenza grave erano
condanne per violenza carnale, il 35,9% per lesioni personali gravi, il 16,9%
per omicidio, il 2,8% per rapine con violenza e il 0,7% per presa di ostaggi.
• L’andamento è legato ai cambiamenti che avvengono nel contesto penale
(per esempio, la violenza domestica è perseguita d’ufficio a partire
dal 2004) e anche a una maggiore consapevolezza del problema della
violenza, che incoraggia le vittime a denunciare i reati e a fare perseguire
penalmente gli autori.
• Tuttavia è probabile che gli atti di violenza domestica come pure la vio-
lenza carnale non sempre vengano denunciati.
7Soddisfacimento dei bisogni – qual è la nostra qualità di vita al giorno d’oggi ?
Disoccupazione
Cresce il tasso di disoccupati ai sensi dell’ILO1
Le persone che lo desiderano dovrebbero poter soddisfare i propri
bisogni grazie a un impiego valorizzante
Nei Paesi sviluppati la disoccupazione è una delle principali cause di povertà
e di esclusione sociale. La statistica dei disoccupati ai sensi dell’ILO com-
prende tutte le persone disoccupate e in cerca di lavoro ed è pertanto più
ampia della spesso citata statistica dei disoccupati iscritti, che considera
soltanto le persone in cerca di lavoro registrate presso gli Uffici regionali
di collocamento (URC).
Tasso di disoccupati ai sensi dell’ILO
Quota di disoccupati ai sensi dell’ILO rispetto alla popolazione attiva
5%
4%
3%
2%
1%
0%
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2014
Fonte: UST – Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) © UST, Neuchâtel 2015
• Dal 1991 al 2014, il tasso di disoccupati ai sensi dell’ILO è globalmente
aumentato e ha visto importanti fluttuazioni; nel 2014 ha raggiunto il 4,4%.
• Il tasso di disoccupati ai sensi dell’ILO dipende in buona parte dalla
congiuntura.
• Nel 2014, più di 208’000 persone erano disoccupate.
• Tra i giovani attivi (15–24 anni), il tasso di disoccupati ai sensi dell’ILO è
mediamente quasi il doppio (7,7% nel 2014) di quello della popolazione
attiva in età lavorativa (15–64 anni).
1
1
ILO: International Labour Office (Ufficio internazionale del lavoro)
8Equità – come sono distribuite le risorse ?
Povertà
Il tasso di povertà diminuisce
Una vita dignitosa deve essere libera dalla povertà
Una vita libera dalla povertà richiede innanzitutto i mezzi necessari per sod-
disfare i bisogni primari (cibo, vestiario, alloggio e cure mediche primarie).
Oltre a questi vanno considerati anche altri bisogni – come i contatti inter-
personali e la partecipazione alla vita attiva.
Tasso di povertà
Parte della popolazione residente permanente che vive al di sotto della soglia
di povertà
20%
15%
10%
5%
0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Senza considerare l’affitto fittizio
Fonte: UST – Redditi e condizioni di vita in Svizzera (SILC) © UST, Neuchâtel 2015
• Dal 2007 al 2012 la percentuale di persone colpite dalla povertà è pas-
sata dal 9,3 al 7,7%.
• Nel 2012 in Svizzera più di 590’000 persone vivevano al di sotto della
soglia di povertà. In quell’anno la soglia di povertà ammontava in media a
2200 franchi al mese per un’economia domestica composta da una sola
persona e a 4050 franchi al mese per un’economia domestica composta
da due adulti e due bambini di meno di 14 anni.
• I gruppi di popolazione maggiormente colpiti dalla povertà sono le fami-
glie composte da un solo genitore (nel 2012 il 16,5% viveva al di sotto
della soglia di povertà), le persone senza attività professionale (15,7%)
e le persone senza formazione postobbligatoria (13,9%).
9Equità – come sono distribuite le risorse ?
Aiuto allo sviluppo
L’aiuto pubblico allo sviluppo aumenta
La povertà nei Paesi in via di sviluppo va combattuta
Il diritto a una vita dignitosa, libera dalla povertà non è un concetto valido
unicamente per la Svizzera. Ai sensi dello sviluppo sostenibile, le risorse
dovrebbero essere rese adeguatamente accessibili anche alle persone dei
Paesi più poveri.
Aiuto pubblico allo sviluppo
Rispetto al reddito nazionale lordo* (in precedenza prodotto nazionale lordo)
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2013
* Reddito nazionale lordo calcolato secondo il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali 1995 (SEC95)
2011, 2012, 2013: provvisorio
Fonti: Direzione dello sviluppo e della cooperazione © UST, Neuchâtel 2015
• La quota dell’aiuto allo sviluppo sul reddito nazionale lordo (RNL) svizzero
è rimasta pressoché invariata nel corso degli anni 1990 ed è leggermente
cresciuta all’inizio del nuovo millennio. Nell’ultimo decennio, all’aiuto allo
sviluppo è stato destinato in media lo 0,41% del RNL.
• Nel 2013 il potere pubblico svizzero ha devoluto più di 2,9 miliardi di fran-
chi all’aiuto allo sviluppo.
• Il contributo della Svizzera è inferiore allo 0,7% del RNL richiesto dall’ONU.
10Equità – come sono distribuite le risorse ?
Uguaglianza
Il divario salariale tra donne e uomini tende lentamente
a ridursi
Ogni essere umano dovrebbe poter beneficiare degli stessi diritti e
delle stesse opportunità. Le risorse devono essere ripartite equamente
Se per lo stesso lavoro due persone ricevono un salario differente, significa
che vengono lesi i loro diritti e opportunità. Una discriminazione delle donne
a livello salariale è spesso indice anche di altre disparità, come un accesso
a posizioni influenti reso maggiormente difficoltoso.
Differenze salariali secondo il sesso
Differenza salariale* tra uomini e donne rispetto al salario mensile lordo
degli uomini, settore privato
25%
23,8
22,9
20% 21,5 21,5 20,9
19,9 19,4
19,1 18,9
18,4
15%
10%
5%
0%
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
* Valori in base al salario mediano
Fonte: UST – Rilevazione della struttura dei salari (RSS) © UST, Neuchâtel 2015
• Complessivamente, tra il 1994 e il 2012 le disparità salariali tra donne e
uomini nel settore privato si sono lievemente ridotte.
• Nel 2012, nel settore privato le donne guadagnavano mensilmente in
media 1236 franchi meno degli uomini, vale a dire circa il 19% in meno.
• Tale differenza può essere ricondotta in parte al fatto che le donne eserci-
tano più spesso professioni a basso reddito, hanno una formazione meno
elevata e dispongono di minore esperienza professionale.
• Ma il salario degli uomini rimane mediamente superiore a quello delle donne
anche a parità di formazione e di posizione professionale. Secondo le ana-
lisi, il 40% della differenza salariale può essere considerata ascrivibile a
una discriminazione legata al sesso.
11Preservazione del capitale – cosa consegniamo ai nostri figli ?
Capacità di lettura dei giovani
Migliorano le capacità di lettura dei giovani
Le capacità di assimilare ed elaborare informazioni vanno coltivate,
la competitività della Svizzera va preservata e potenziata
I giovani che non comprendono affatto testi scritti, o la cui capacità di assi-
milarli è insufficiente, spesso mostrano maggiori difficoltà nel gestire cam-
biamenti sociali in maniera costruttiva. Ma anche la forza innovativa e la com-
petitività dell’economia dipendono dal livello di formazione della popolazione.
Competenza in lettura dei quindicenni
Quota dei quindicenni che raggiungono almeno il livello di competenza 2
in lettura (su una scala daPreservazione del capitale – cosa consegniamo ai nostri figli ?
Indebitamento pubblico
Dopo una fase di aumento, il debito pubblico ritorna
al di sotto dei livelli del 1992
Il margine di manovra delle future generazioni non va ristretto
Si parla di «indebitamento elevato» quando, a causa dei debiti accumulati,
uno Stato non riesce più ad ottemperare ai propri compiti centrali o vi rie-
sce soltanto limitatamente. Un elevato livello d’indebitamento se da un lato
pesa sulla società odierna dall’altro grava anche sulle generazioni future poi-
ché il pagamento degli interessi impegna risorse finanziarie non trascurabili.
Tasso d’indebitamento delle amministrazioni pubbliche
Debito lordo cumulato della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni
(senza le assicurazioni sociali) rispetto al prodotto interno lordo
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2013
2013: valore stimato
Fonte: AFF – Statistica finanziaria © UST, Neuchâtel 2015
• Negli anni 1990, la quota d’indebitamento pubblico è aumentata consi-
derevolmente. Tuttavia, negli ultimi anni è stato possibile ridurre l’indebi-
tamento.
• Nel 2013, l’indebitamento complessivo di Confederazione, Cantoni e
Comuni ammontava a oltre 219 miliardi di franchi.
• Più della metà dei debiti sono della Confederazione, quasi un quarto dei
Cantoni e circa un quinto dei Comuni.
13Preservazione del capitale – cosa consegniamo ai nostri figli ?
Investimenti
La quota degli investimenti sul prodotto interno lordo
ristagna
L’efficienza economica della società va preservata e migliorata
Produrre beni e servizi a sufficienza è una premessa indispensabile per
un’economia che voglia dirsi competitiva. Indispensabili per tale produzione
sono gli investimenti, per esempio in edifici, impianti e mezzi di trasporto.
Quota del prodotto interno lordo per gli investimenti
Formazione lorda di capitale fisso rispetto al prodotto interno lordo
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
2012 e 2013: provvisorio
Fonte: UST – Contabilità nazionale © UST, Neuchâtel 2015
• Dal 1995, la quota degli investimenti sul prodotto interno lordo è rimasta
pressoché invariata.
• Nel 2013, gli investimenti ammontavano a quasi 144 miliardi di franchi.
14Preservazione del capitale – cosa consegniamo ai nostri figli ?
Innovazione e tecnologia
Il numero di persone impiegate nella scienza e nella
tecnologia aumenta
L’efficienza economica della società va preservata e migliorata
La ricerca e la tecnologia sono i principali motori dell’innovazione, la quale,
a sua volta, costituisce una premessa importante per garantire l’efficienza
economica di un Paese sul lungo termine. Disporre di personale specializzato
in tale ambito significa anche promuovere la competitività della Svizzera.
Risorse umane in scienza e tecnologia (S-T)
Quota di persone formate e attive in S-T rispetto alla popolazione
attiva occupata
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Fonte: UST – Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) © UST, Neuchâtel 2015
• Dagli inizi degli anni 1990, la quota di personale formato e attivo nel
campo della scienza e della tecnologia sull’insieme degli occupati è cre-
sciuta notevolmente.
• Nel 2013 erano 1’098’000 le persone formate e attive nel campo della
scienza o della tecnologia, vale a dire circa un quarto del totale degli
occupati.
• Quest’evoluzione mostra la volontà di adattamento della Svizzera alla sem-
pre più dinamica competitività internazionale.
15Preservazione del capitale – cosa consegniamo ai nostri figli ?
Biodiversità
Aumentano le popolazioni di uccelli nidificanti
La varietà della natura va preservata
La diversità biologica è importante sotto vari aspetti: garantisce per esem-
pio non solo l’equilibrio tra ecosistemi ma anche un potenziale di risorse nel
campo dei medicamenti. La varietà della flora e della fauna può essere sal-
vaguardata soltanto preservando la diversità degli spazi vitali come boschi,
prati, superfici coltive.
Popolazioni di uccelli nidificanti
Evoluzione delle popolazioni di uccelli nidificanti in Svizzera
Indice 1990=100
140
120
100
80
60
40
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2013
Uccelli nidificanti regolari (173 specie) di cui su Lista Rossa (41 specie)
Fonte: Stazione ornitologica svizzera di Sempach © UST, Neuchâtel 2015
• Se si considerano le 173 specie valutabili sul totale delle 176 specie di
uccelli nidificanti regolarmente in Svizzera, negli ultimi 20 anni si nota
una tendenza positiva. Il basso valore del 2009 è riconducibile all’inverno
2008–2009 particolarmente rigido. Malgrado l’inverno 2009–2010 nuo-
vamente freddo e nevoso, molte specie hanno parzialmente compensato
le perdite di effettivi del 2010.
• L’andamento delle 41 specie minacciate riportate nella Lista Rossa è
segnato da fluttuazioni significative e, nel periodo complessivo, tende
al calo. A lungo termine l’andamento degli effettivi delle specie riportate
nella Lista Rossa indica il grado di efficacia delle misure intraprese per la
protezione delle specie minacciate.
• La Lista Rossa contiene le specie in pericolo e le specie rare. Un criterio
importante per l’inserimento di una specie nella Lista Rossa è la diminu-
zione della sua popolazione.
16Preservazione del capitale – cosa consegniamo ai nostri figli ?
Superfici edificate
Le superfici d’insediamento occupate pro capite
aumentano
Le risorse vitali naturali vanno conservate a lungo termine
Il suolo costituisce una delle principali risorse vitali sia per l’uomo che per
animali e piante. La costruzione d’insediamenti, di strade e di impianti indu-
striali comporta inevitabilmente una perdita di importanti biotopi e di super-
fici agricole – processo difficilmente reversibile e pertanto con conseguenze
sulle generazioni future.
Superfici d’insediamento pro capite
Aree edificate, aree industriali, superfici d’insediamento speciali,
zone verdi e di riposo nonché superfici del traffico, in m2/abitante
500
400
401 407
387
300
200
100
0
1979/85 1992/97 2004/09
Fonte: UST – Statistica della superificie, STATPOP © UST, Neuchâtel 2015
• Tra gli anni 1980 e la seconda metà degli anni 2000, la superficie edifi-
cata pro capite è aumentata di più del 5%. L’espansione complessiva è
del 23,4%, il che corrisponde a 584 km2, ovvero un’area equivalente alla
superficie del lago Lemano.
• Verso la fine degli anni 2000, circa 407 m2 di suolo erano utilizzati come
superficie d’insediamento pro capite (dimensione corrispondente alla
superficie di circa due campi da tennis).
• L’aumento della superficie edificata pro capite è dovuto soprattutto all’uti-
lizzo di superfici dedicate all’alloggio sempre più grandi. La superficie abi-
tativa è infatti cresciuta del 44% durante il periodo considerato.
• Circa la metà delle superfici d’insediamento è coperta da edifici, il 30%
è occupato da superfici di trasporto e poco più del 6% è adibito a zone
verdi e di riposo.
• I risultati per il periodo 2004–2009 mostrano che la crescita delle super-
fici d’insediamento è stata meno marcata che in passato.
17Sganciamento delle risorse – quanto siamo efficienti nel loro sfruttamento ?
Trasporto merci
Nessun cambiamento significativo dell’intensità
del trasporto merci
Il carico ambientale dovuto alle sostanze inquinanti va ridotto
Un’economia che vuol essere funzionale è legata ineluttabilmente al tra-
sporto merci. Tuttavia, il trasporto merci, in particolare quello motorizzato,
comporta problemi come rumore, inquinamento e dispendio di risorse.
L’obiettivo consiste quindi nel contenere il più possibile il peso del trasporto
merci rispetto all’intera produttività economica.
Intensità del trasporto merci
Prestazioni di trasporto nel traffico merci (strada e ferrovia) in rapporto
al PIL ai prezzi dell’anno precedente, anno di riferimento 2005,
in tonnellate-chilometro/franchi
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2013
2013: provvisorio
Fonti: UST – Statistica dei trasporti; UST, SECO – Contabilità nazionale © UST, Neuchâtel 2015
• Tra la metà degli anni 1990 e la metà degli anni 2000, le prestazioni del
trasporto merci sono cresciute maggiormente rispetto all’economia nazio-
nale. In altre parole, per ogni franco guadagnato dovevano essere traspor-
tati sempre più beni su distanze crescenti.
• Dal 2006 l’intensità del trasporto merci tende a diminuire.
• Nel 2013, le prestazioni di trasporto merci sulle strade e sulle ferrovie
hanno superato i 29 miliardi di tonnellate-chilometro.
• Mentre agli inizi degli anni 1970 ancora circa tre quinti del trasporto
merci veniva effettuato su rotaia, nel 2013 tale proporzione si era ridotta
a due quinti.
18Sganciamento delle risorse – quanto siamo efficienti nel loro sfruttamento ?
Transporto persone
La quota dei trasporti pubblici aumenta
Il carico ambientale dovuto all’inquinamento deve essere ridotto
quanto più possibile
La mobilità costituisce un bisogno basilare dell’uomo e al tempo stesso una
premessa necessaria per un’economia efficiente. In tale contesto diventa
decisiva la scelta dei mezzi di trasporto: spostarsi con i mezzi pubblici, in
bicicletta o a piedi non solo è più ecologico, ma è anche salutare.
Ripartizione modale del trasporto persone
Quota dei trasporti pubblici sul totale del trasporto persone su strada e ferrovia,
in % di persone-chilometri
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Fonte: UST – Statistica dei trasporti © UST, Neuchâtel 2015
• La quota dei trasporti pubblici sul trasporto totale continua a crescere dal
1998 e nel 2012 ammontava al 20,6%.
• Tra il 1998 e il 2012, il numero totale di chilometri percorsi pro capite è
aumentato di più del 25%.
• La quota delle persone-chilometro del traffico lento (spostamenti in bici-
cletta o a piedi) sul traffico totale è del 6,7%. Il mezzo di locomozione di
gran lunga più utilizzato per il trasporto persone è quindi l’automobile.
19Sganciamento delle risorse – quanto siamo efficienti nel loro sfruttamento ?
Consumo di energia
Cala il consumo di energia pro capite
Le risorse rinnovabili e non rinnovabili vanno impiegate con par-
simonia
L’energia è una risorsa indispensabile al funzionamento della nostra società.
La disponibilità di energia e la perennità dell’approvvigionamento vanno per-
tanto garantite. Al contempo, la produzione e il consumo di energia, rinno-
vabile o non rinnovabile, hanno effetti negativi quali l’emissione di gas serra
o di inquinanti atmosferici, la produzione di rifiuti non degradabili o l’impatto
esercitato sui corsi d’acqua o sul paesaggio.
Consumo di energia
Consumo finale di energia pro capite, in chilowattore
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2013
Fonti: UST – STATPOP; UFE – Statistica globale dell’energia © UST, Neuchâtel 2015
• Il consumo finale di energia pro capite è diminuito dal 1990, ma rimane
a un livello molto elevato.
• Il consumo annuo raggiunge più di 30’000 chilowattora pro capite, ossia
l’equivalente di circa 3600 litri di benzina.
• In seguito all’aumento della popolazione, il consumo finale assoluto di
energia è aumentato del 12,8% dal 1990. Nel 2013, il consumo totale
ammontava a 895’990 terajoule, ossia quasi 29 milioni di m3 di benzina
o a quanto possono contenere più di 366’000 vagoni cisterna.
20Sganciamento delle risorse – quanto siamo efficienti nel loro sfruttamento ?
Consumo di materiali
Diminuisce l’intensità materiale
I flussi di materiali e di energia vanno ottimizzati, le risorse naturali
salvaguardate in modo durevole
Una dematerializzazione della nostra società e, di conseguenza, una dimi-
nuzione delle pressioni ambientali esercitate dalle attività economiche e
umane, costituiscono un traguardo importante sulla via dello sviluppo soste-
nibile. Il fabbisogno totale di materiale (TMR) di un Paese comprende tutti
i flussi diretti in entrata (estrazioni indigene di biomassa e di minerali più
le importazioni) e i flussi indiretti (estrazioni indigene non utilizzate e flussi
nascosti legati alle importazioni). L’intensità materiale è calcolata dividendo
il TMR per il prodotto interno lordo.
Intensità materiale
Volume totale di materiale che entra nel ciclo economico (TMR) in rapporto
al prodotto interno lordo reale (PIL)
Indice 1990 = 100
105
100
95
90
85
80
75
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
2011 e 2012: provvisorio
Fonti: UST – Contabilità ambientale; UST, SECO – Contabilità nazionale © UST, Neuchâtel 2015
• L’intensità materiale della Svizzera ha oscillato tra il 1992 e il 2012 e
segue in generale una tendenza al ribasso.
• Nel 2012, il fabbisogno totale di materiale era di 331 milioni di tonnellate,
ovvero 41 tonnellate pro capite.
21Che cosa significa «sviluppo sostenibile» ? Il concetto di sviluppo sostenibile nell’accezione impiegata al giorno d’oggi è stato descritto per la prima volta nel 1987 nel Rapporto Brundtland della Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo ed è definito nel modo seguente: «lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni». A questa definizione il Rapporto Brundtland ha aggiunto due elementi fonda- mentali: dare la precedenza ai bisogni essenziali delle persone (in particolare quelle più povere) e tener conto dei limiti di capacità del nostro ambiente. Nel 1992, il Vertice della Terra di Rio ha stabilito le basi per la realizza- zione politica dello sviluppo sostenibile, proponendo l’Agenda 21 (pianifi- cazione delle azioni da intraprendere nel XXI secolo). Nel 2012, alla Con- ferenza Rio+20, si sono rinnovati gli impegni presi vent’anni prima e sono state definite le fasi successive per uno sviluppo sostenibile nel rapporto «The Future We Want». A livello nazionale, nel 1992 la Svizzera si è impegnata a definire e portare avanti una politica di sviluppo sostenibile che, dal 1997, si è concretizzata nella «Strategia per uno sviluppo sostenibile» del Consiglio federale, perio- dicamente aggiornata. L’ultima versione contiene un piano d’azione per la legislatura 2011–2015. Lo sviluppo sostenibile è stato inoltre inserito nella revisione della Costituzione federale del 1999 (art. 2 e 73). Nella politica federale, i tre «pilastri» tradizionali dello sviluppo sostenibile (società, ambiente ed economia), ampiamente utilizzati a partire dal Ver- tice della Terra del 1992, sono stati riformulati in tre obiettivi qualitativi: • la solidarietà sociale; • la responsabilità ecologica; • l’efficienza economica. Questi obiettivi sono interconnessi e possono essere rappresentati mediante tre cerchi che s’intersecano. Le intersezioni tra i cerchi simbolizzano la necessità, per lo sviluppo sostenibile, di conciliare questi tre obiettivi a volte contraddittori. In maniera più ampia, lo schema tridimensionale esprime la sfida che lo sviluppo sostenibile deve affrontare: tenere in considerazione la qualità di vita delle generazioni attuali, la preservazione delle risorse per le generazioni future, i bisogni di equità (intersezioni tra l’obiettivo di soli- darietà sociale e gli altri due obiettivi) e la necessità di impiegare le risorse in modo razionale (intersezione tra l’obiettivo di responsabilità ecologica e quello dell’efficienza economica). Lo schema alla pagina seguente mostra il posizionamento dei 17 indicatori chiave in relazione ai tre obiettivi qualitativi e alle loro intersezioni. 22
Panoramica degli indicatori chiave secondo i tre
obiettivi qualitativi
Povertà
Capacità di lettura dei giovani
Sicurezza Salute
Solidarietà
sociale
Disoccupazione
Reddito Uguaglianza
Aiuto allo sviluppo
Trasporto persone Investimenti
Superfici edificate
Innovazione e tecnologia
Biodiversità Indebitamento pubblico
Trasporto merci
Consumo di materiali
Responsabilità Consumo di energia
ecologica
Efficienza
economica
23Ulteriori informazioni:
Per maggiori informazioni su MONET: www.monet.admin.ch
• Tutti gli indicatori online.
• I 45 principi che indicano la strada da seguire per andare verso uno svi-
luppo sostenibile.
• Il cruscotto che permette di visualizzare in un batter d’occhio i progressi
effettuati nelle dieci sfide chiave della Strategia per uno sviluppo sosteni-
bile 2012–2015 del Consiglio federale.
Informazioni complete sulla politica in materia di sviluppo sostenibile in
Svizzera: www.are.admin.ch/svilupposostenibile
Pubblicazioni:
UST, ARE, UFAM, DSC: Rapporto sullo sviluppo sostenibile 2012,
Neuchâtel 2012
Consiglio federale svizzero: Strategia per uno sviluppo sostenibile
2012–2015, Berna 2012
UST, ARE, UFAM, DSC: Sviluppo sostenibile – Statistica tascabile 2014,
Neuchâtel 2014
UST, ARE, UFAM, DSC: Monitoraggio dello sviluppo sostenibile –
La Svizzera in un mondo globalizzato, Neuchâtel 2008
Editore: Ufficio federale di statistica (UST)
Redazione: 5. edizione; Davide Molinari, Laure Alizée Tallent, UST
Grafica/layout: Sezione DIAM, Prepress / Print, UST
Illustrazione UST; concezione: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne;
di copertina: foto: © Anetta – Fotolia.com
Traduzioni: Servizi linguistici dell’UST; disponibile in versione PDF
o cartacea in tedesco, francese, italiano e inglese
Informazioni: Ufficio federale di statistica, Sezione Ambiente,
sviluppo sostenibile, territorio, Vincent Willi,
tel. 058 467 24 44, monet@bfs.admin.ch
Ordinazioni: Numero di ordinazione: 736-1500, gratuito,
tel. 058 463 60 60, fax: 058 463 60 61,
order@bfs.admin.ch
24Puoi anche leggere