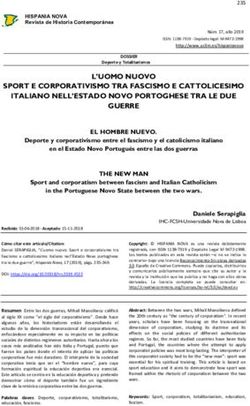Le Radici del Terzo Reich - A cura di Luigi Valente 1 - Istituto Liberale Italiano
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Le Radici del Terzo Reich
A cura di Luigi Valente
12
INDICE
Premessa 5
La nascita della Repubblica di Weimar 9
L’indigesto trattato di Versailles 14
Hitler 16
La rivoluzione legale di Hitler 26
Le ragioni del successo del nazionalsocialismo 33
Il militarismo tedesco 38
Conclusione 42
Note 44
Bibliografia 45
34
PREMESSA
La storia dell’ascesa del nazismo in una delle nazioni
culturalmente più avanzate d’Europa è spesso sovrapposta
alla storia politica di Adolf Hitler e del Partito Nazionalsocia-
lista Tedesco dei Lavoratori (NSDAP) di cui egli fu Führer dal
1921 alla sua morte, avvenuta nel 1945.
Questo induce a credere che il nazismo fosse stato un
fenomeno indotto dall’alto da questo demone, Adolf Hitler
appunto, capace prima di conquistarsi il consenso di quasi la
metà degli elettori tedeschi, e poi di trascinare in guerra una
intera generazione.
Invece, come scrisse lo storico britannico Rohan Butler
già prima della Seconda guerra mondiale, «I nazisti non
avrebbero mai potuto ottenere il consenso del popolo tedesco
imponendo un regime totalmente estraneo alla mentalità te-
desca; ci riuscirono, invece, risvegliando nel profondo lo spi-
rito tedesco» 1.
Hitler fu anzi l’uomo tipico del primo dopoguerra tede-
sco: soldato nella Prima guerra mondiale arruolatosi volonta-
riamente alla ricerca di una gloria vaga e non ancora ben
chiara nella sua giovane mente, si ritrovò dopo la guerra a vi-
vere in una società dove i reduci non avevano alcun ruolo.
Questi uomini brutalizzati dal conflitto, spesso mutilati,
dalle menti offuscate dall’orrore, avevano perduto lavoro, af-
fetti, casa, e prospettive. In più, subivano l’onta di una pace
che vedeva nella sola Germania la colpevole del conflitto,
1 Rohan D’O. Butler. The Roots of National Socialism, 1783 – 1933, p. 284,
Faber & Faber, Londra, 1941
5ritrovandosi dunque nella posizione di essere i diretti respon-
sabili di quei 16 milioni di morti tra il 1914 e il 1918.
«I legami patologici, individuali e sociali, tra Hitler e la
società del dopoguerra che lo portò alle stelle, si possono fa-
cilmente individuare sotto i più svariati aspetti. Entravano in
gioco la convinzione della propria superiorità che si era vista
improvvisamente frustrata, le aspirazioni e i desideri inappa-
gati, l’incapacità di affrontare un’esistenza autoresponsabile,
l’astio che nasceva dalla costrizione a vivere in condizioni mi-
serrime (donde la ricerca di oggetti su cui poter riversare la
colpa dei propri insuccessi), i vaneggiamenti e le illusioni che
impedivano qualsiasi impostazione pratica dell’esistenza e
che crearono quella maschera umana in cui entrambi si rico-
noscevano: lui e l’epoca» 2.
Come il giovane Adolf, milioni di altri individui si ritro-
varono a fare i conti con un destino irrimediabilmente se-
gnato dalla guerra. Segnato non solo nelle mancanze, ma an-
che nel modo di leggere la società.
Non è un caso se l’organizzazione interna del NSDAP
rispecchiava in qualche modo quella di un reggimento: il
Führer – questo il titolo ufficiale scelto da Hitler sia come se-
gretario del partito sia, successivamente, come capo di stato e
di governo – non poteva essere messo in discussione, la sua
parola nel partito era legge. Non era neanche un caso se dopo
la guerra nacquero in tutta la Germania gruppi paramilitari
composti principalmente da ex soldati che continuavano a vi-
vere in comunità, dividere i pasti nello stesso luogo, darsi
gradi e decorazioni, e obbedire a ufficiali e quadri di partito.
2 Joachim C. Fest. Il volto del Terzo Reich, p. 15, Garzanti, Milano, 1977
6La guerra aveva insegnato a questi uomini a vivere in un
modo soltanto, e costoro cercavano di riprodurre quello stile
di vita al quale erano ormai abituati e nel quale si sentivano a
proprio agio. E non è neanche un caso se nel gigantesco caos
post-bellico vennero alla ribalta personaggi assolutamente
improbabili, come Hitler stesso, ma anche come Heinrich
Himmler, di mestiere allevatore di polli 3, divenuto leader
delle SS e uno degli uomini più potenti della Germania nazi-
sta.
«Una moltitudine innumerevole di esistenze sradicate,
minacciate dalla guerra e dalle sue conseguenze economiche
e sociali, o gettate alla deriva, si riversò nel Paese. Nel crollo
di un intero ordinamento, il tipo del fallito ebbe la possibilità
di ricominciare da capo. Il punto zero al quale la società si
vide rigettata procurò una chance storica alle esistenze man-
cate. Questa fu l’ora di Adolf Hitler» 4.
Questa situazione drammatica fu una condizione neces-
saria, ma non da sola sufficiente, a dar vita al Terzo Reich, o
Terzo Impero Tedesco 5. Vedremo dunque cos’altro contribuì
a condurre il popolo tedesco sulla «via della schiavitù», ricor-
dando che la storia della Repubblica di Weimar e dell’ascesa
del nazismo è la storia della nascita di ogni dittatura.
Non vi sono elementi, alla base dei totalitarismi coevi al
Terzo Reich o successivi, che non si possano ritrovare anche
nella storia della Germania tra il 1918 e il 1945. Per questo
3 Joachim C. Fest. Il volto del Terzo Reich, p. 187, Garzanti, Milano, 1977
4 Joachim C. Fest. Il volto del Terzo Reich, p. 28, Garzanti, Milano, 1977
5Rohan D’O. Butler, nel suo The Roots of National Socialism, 1783 – 1933,
lo definisce «Third German Empire»
7motivo l’approfondimento di quei trent’anni di brutalità è di
fondamentale importanza per chiunque abbia a cuore la pre-
servazione della libertà.
Non vanno biasimati gli uomini e le donne del tempo
che non si accorsero di quanto stava accadendo, ma vanno
biasimati i nostri contemporanei che si rifiutano di imparare
dalla storia.
8LA NASCITA DELLA
REPUBBLICA DI WEIMAR
L’Impero tedesco, alla fine della Prima guerra mondiale,
si presentava come una confederazione di 25 stati legati da
una serie di trattati di sottomissione al Regno di Prussia. Il re
di Prussia, in virtù di ciò, era anche Imperatore (Kaiser) e capo
supremo dell’esercito imperiale. L’esercito era diventato
nell’ultimo secolo l’istituzione più temuta e rispettata dell’Im-
pero tedesco. La sua fedeltà all’Imperatore era indiscutibile e
la popolazione era consapevole che ogni tentativo di rivolta
sarebbe stato prontamente soffocato nel sangue. Le cose cam-
biarono nel novembre del 1918, quando quel medesimo eser-
cito che aveva garantito l’ordine nell’Impero ne segnò anche
la rovina.
A guerra ormai perduta, il Comando supremo dell’Eser-
cito aveva deciso di inviare la flotta tedesca in un ultimo scon-
tro con la Royal Navy, la marina inglese. I marinai, ormai
esausti e per nulla intenzionati a morire per una guerra già
perduta, si ribellarono a Kiel. Nel giro di pochi giorni la ri-
volta si estese in tutto l’esercito e in tutta la Germania. Il 9
novembre 1918 la rivolta arrivò a Berlino, dove la maggio-
ranza socialdemocratica del Reichstag (il parlamento tedesco)
pretese l’abdicazione dell’Imperatore Guglielmo II. Questi
tentennò e chiese al generale Wilhelm Groener se fosse possi-
bile sedare le rivolte con l’esercito. Il generale ammise che
parte dell’esercito era ormai dalla parte dei rivoltosi, quindi a
Guglielmo II non restò che abdicare.
A quel punto si creò un vuoto di potere e una situazione
di completa incertezza. La maggioranza socialdemocratica al
9Reichstag aveva chiesto l’abdicazione dell’Imperatore, ma
non aveva alcuna intenzione di trasformare l’Impero tedesco
in una repubblica sovietica come voleva l’ala più estrema
della sinistra.
Il rischio di una dissoluzione dell’Impero in varie re-
pubbliche sovietiche era reale. Già il 7 novembre 1918 in Ba-
viera era stata proclamata una repubblica sovietica guidata
dal socialista indipendente Kurt Eisner. Il 9 novembre, a Ber-
lino, dal palazzo dell’Imperatore, la Lega Spartachista gui-
data da Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht si apprestava a
proclamare repubblica sovietica l’intero Impero.
«I socialisti radunati nel Reichstag erano costernati di
fronte a un simile pericolo. Urgeva quindi prendere qualche
iniziativa per precedere gli “spartachisti”. Scheidemann 6
ebbe una felice ispirazione e, senza consultare i compagni di
partito, s’affacciò alla finestra sulla Königsplatz, dove era af-
fluita una grande folla, e senza più indugi, come se l’idea gli
fosse venuta in mente proprio in quel momento, proclamò la
Repubblica. Il sellaio Ebert era su tutte le furie: egli aveva spe-
rato di poter salvare in qualche modo la dinastia degli Ho-
henzollern. Così, in modo quasi fortuito, era nata la Repub-
blica tedesca» 7.
Friedrich Ebert, socialdemocratico, divenne Cancelliere
della nuova Repubblica. L’esercito non stette a guardare.
«La notte del 9 novembre 1918, poche ore dopo la “pro-
clamazione” della Repubblica, il telefono di Ebert squillò nel
6 Philipp Heinrich Scheidemann (1885-1939) uno dei maggiori espo-
nenti del Partito Socialdemocratico (SPD)
7 William L. Shirer. Storia del Terzo Reich. Einaudi. Edizione del Kindle.
10suo ufficio della Cancelleria del Reich a Berlino. Era un tele-
fono speciale, collegato per mezzo di una linea privata e se-
greta al comando supremo avente sede a Spa. Ebert era solo.
Appena ebbe sollevato il ricevitore una voce all’altra estre-
mità del filo disse: “Parla Groener”. […] Ora, nel momento
più difficile per la loro patria, essi presero contatto attraverso
un telefono segreto: il capo socialista e il vicecomandante
dell’esercito tedesco stipularono un patto che doveva essere
decisivo per le sorti della nazione. Per molti anni il pubblico
non ne seppe nulla. Ebert si impegnò a soffocare l’anarchia e
il bolscevismo e a mantenere l’esercito con tutte le sue tradi-
zioni. Dal canto suo Groener dava l’assicurazione che l’eser-
cito avrebbe aiutato il nuovo governo a consolidarsi e a con-
seguire i suoi obiettivi. […] L’esercito tedesco era salvo, ma la
Repubblica appariva irrimediabilmente condannata nel
giorno stesso della sua nascita. Tutti i generali, salvo l’onesto
Groener e pochi altri, non l’avrebbero mai servita lealmente,
e alla fine, guidati da Hindenburg, l’avrebbero tradita conse-
gnandola ai nazisti» 8.
L’esercito tenne fede al patto, aiutò il governo a soppri-
mere ogni rivolta con l’aiuto dei gruppi paramilitari (Frei-
korps) che erano andati formandosi su tutto il territorio tede-
sco. Questi gruppi raccoglievano per lo più reduci di guerra
che, come già detto, cercavano un loro posto nella nuova re-
pubblica e affiancavano spesso e volentieri l’esercito regolare
nella soppressione delle rivolte di stampo bolscevico.
La già menzionata repubblica sovietica proclamata in
Baviera, nel frattempo battezzata Repubblica Bavarese dei
8 William L. Shirer. Storia del Terzo Reich. Einaudi. Edizione del Kindle.
11Consigli, fu infatti rovesciata da una massiccia offensiva
dell’esercito tedesco e di diversi freikorps dal 29 aprile al 2
maggio 1919.
Tra il 10 e il 17 gennaio 1919, sempre con un’operazione
congiunta tra esercito regolare e gruppi paramilitari di destra,
furono sconfitti gli spartachisti; Rosa Luxemburg e Karl Lie-
bknecht furono prima arrestati e poi uccisi dagli ufficiali della
Garde-Kavallerie-Schützen-Division.
Altre operazioni simili videro collaborare il neonato go-
verno a guida socialdemocratica con i gruppi paramilitari
(quasi tutti di ispirazione nazionalista e di estrema destra) con
l’obiettivo comune di salvare la repubblica dal bolscevismo.
Nel frattempo, il 9 gennaio 1919 si tennero le elezioni
per l’Assemblea costituente e i risultati rivelarono una sor-
presa: i socialdemocratici, in maggioranza assoluta durante
della guerra, avevano raccolto in realtà solo una maggioranza
relativa. I partiti moderati di centro o nazionalisti di destra
rappresentanti del ceto medio ebbero un peso decisivo nel re-
digere la costituzione. Il 31 luglio 1919, a Weimar, l’Assem-
blea approvò la costituzione: informalmente, dunque, la
nuova Germania repubblicana venne chiamata Repubblica di
Weimar, pur conservando ufficialmente il nome di Deutsches
Reich, cioè “Reame tedesco”, e tale resterà fino al 1945.
La nuova costituzione era il «documento più democra-
tico e più liberale fra tutti quelli che avevano visto la luce nel
XX secolo. Teoricamente rasentava quasi la perfezione, conte-
neva articoli ammirevoli e ingegnosi che sembrava potessero
garantire il funzionamento di una democrazia pressoché
ideale. L’idea di un governo ministeriale era stata presa in
prestito dall’Inghilterra e dalla Francia, quella di una forte
presidenza popolare dagli Stati Uniti, quella del referendum
12dalla Svizzera. Venne stabilito un sistema molto accurato e
complicato di rappresentanza proporzionale e di elezioni per
lista, allo scopo di evitare la dispersione dei voti, garantendo
inoltre alle piccole minoranze il diritto di essere rappresentate
al parlamento. Il tenore della costituzione di Weimar offriva
grandi speranze agli spiriti sinceramente democratici. Il po-
polo era stato dichiarato sovrano: “il potere politico proviene
dal popolo”. Uomini e donne acquistavano il diritto di voto a
vent’anni: “Tutti i tedeschi sono uguali dinanzi alla legge…
La libertà dell’individuo è inviolabile… Ogni cittadino tede-
sco ha il diritto… di esprimere liberamente la propria opi-
nione… Tutti i tedeschi godono del diritto di libera associa-
zione… Tutti gli abitanti del Reich godono di completa libertà
di religione e di coscienza…” Nessun uomo al mondo
avrebbe potuto essere più libero di un cittadino tedesco, e
nessun governo avrebbe potuto essere più democratico e li-
berale. Almeno sulla carta 9».
Almeno sulla carta, appunto. Come vedremo, la carta
costituzionale di Weimar aveva delle criticità non indiffe-
renti.
9 William L. Shirer. Storia del Terzo Reich. Einaudi. Edizione del Kindle.
13L’INDIGESTO TRATTATO
DI VERSAILLES
Mentre in Germania si succedevano rivoluzioni e con-
trorivoluzioni, nel gennaio del 1919 si teneva in Francia la
Conferenza di pace di Parigi con la quale i Paesi vincitori della
Prima guerra mondiale cercarono di dare un assetto stabile
all’Europa.
Il presidente americano Woodrow Wilson aveva propo-
sto quattordici punti sui quali riorganizzare il Vecchio Conti-
nente tra i quali il principio di autodeterminazione dei popoli
secondo il quale ad ogni Stato avrebbe dovuto corrispondere
una sola nazione. Il principio non fu applicato alla lettera, ma
giustificò lo smantellamento del territorio tedesco.
La Prussia in particolare si ritrovò divisa in due dalla
Polonia, ma sul territorio del vecchio Impero tedesco nac-
quero anche Cecoslovacchia, Regno dei Serbi Croati e Sloveni,
Estonia, Lettonia e Lituania. La Cecoslovacchia era in netta
contraddizione con il principio degli stati-nazione immagi-
nati da Wilson poiché riuniva diverse nazionalità tra le quali
quella boema, quella slava, e alcune minoranze tedesche.
Anzi, proprio il principio degli stati-nazione sarà utilizzato da
Hitler come pretesto per annettere parte della Cecoslovacchia
e l’Austria, come ricorda lo storico Eric J. Hobsbawm: «Adolf
Hitler, applicando sino alle estreme conseguenze i principi
nazionalisti, pianificò l'annessione alla Germania di tutti i ter-
ritori fuori dai confini della madrepatria abitati da tedeschi, e
14avviò a soluzione finale l'eliminazione degli Ebrei» 10.
Oltre alle notevoli perdite territoriali, alla Germania fu
imposto di ridurre il suo esercito a soli 100.000 effettivi,
un’entità più simbolica che di reale utilità, e le fu vietato di
possedere aerei e carri armati.
Da quando gli inglesi avevano introdotto i carri armati
nella Prima guerra mondiale (1916) tutte le potenze europee
si erano rese conto che la nuova corsa agli armamenti avrebbe
riguardato principalmente i mezzi corazzati. Senza i carri ar-
mati nessun esercito aveva speranza di vittoria, per cui il di-
vieto di costruire carri armati imposto alla Germania suonava
proprio come una vera e propria condanna a morte in caso di
una nuova guerra.
La peggiore delle condizioni fu tuttavia il pagamento
dei danni di guerra il cui ammontare fu fissato con una con-
ferenza ad hoc tenutasi a Genova nel 1922: 132 miliardi di mar-
chi oro. Una somma insostenibile per qualunque Paese. La
Germania, in quanto stato sconfitto, non fu neanche ammessa
a negoziare, ma fu invitata solo al momento della ratifica dei
trattati di pace.
Sul piano internazionale la Germania ne uscì completa-
mente isolata, considerata l’unica responsabile della Prima
guerra mondiale e messa consapevolmente nella condizione
di non poter crescere economicamente e militarmente. Qua-
lunque stato di quelli circostanti, persino il più piccolo,
avrebbe potuto invaderla e occuparla pressoché senza per-
dite.
10 Eric J. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismo dal 1780, Einaudi, Torino,
1991.
15HITLER
La carriera politica di Adolf Hitler ebbe inizio nella Re-
pubblica Bavarese dei Consigli (Bayerische Räterepublik), la
repubblica di stampo sovietico proclamata in Baviera
dall’ebreo Kurt Eisner il 7 novembre 1918.
Durante la Prima guerra mondiale Hitler era stato pro-
mosso al grado di caporale e decorato con la croce di ferro,
raramente concessa ai soldati di truppa. I suoi superiori, tut-
tavia, non avevano di lui una buona opinione: «Il suo aiutante
di allora ha affermato che tutti i suoi superiori erano d’ac-
cordo che non si potesse nominare sottufficiale quest’uomo
indubbiamente coraggioso, ma troppo strano. Stando al loro
giudizio, egli sarebbe stato incapace di farsi rispettare» 11.
I suoi stessi compagni «deridevano il suo importuno
sfoggio di zelo nel prendere interesse alle sorti della guerra.
Nessuno gli si accostava: a detta di tutti egli era l’eccentrico,
lo svanito» 12.
Ora, a guerra finita e dopo una breve convalescenza
nell’ospedale di Pasewalk a causa di una infezione agli occhi
dovuta ai gas usati in guerra, lo strano caporale non aveva un
luogo in cui tornare. «Ormai prossimo ai trent’anni, privo di
istruzione, di lavoro e di prospettive, unico suo progetto era
di restare il più a lungo possibile nell’esercito, che era stata la
sua casa e per lui aveva provveduto fin dal 1914» 13. Tornò
11 Joachim C. Fest. Il volto del Terzo Reich, p. 27, Garzanti, Milano, 1977
12 Joachim C. Fest. Il volto del Terzo Reich, p. 27, Garzanti, Milano, 1977
13 Ian Kershaw. Hitler. Giunti. Edizione del Kindle.
16quindi a Monaco, in quella Baviera che aspirava a diventare
una repubblica sovietica.
Di questa fase della sua vita si sa poco perché egli stesso
non volle mai approfondirla. Si crede che avesse sostenuto, in
un primo momento, le idee socialdemocratiche o addirittura
quelle filosovietiche dell’USPD.
«In una consegna ordinaria del battaglione di smobilita-
zione, datata 3 aprile 1919, il nome di Hitler è indicato come
rappresentante (Vertrauensmann) della sua compagnia. In
realtà, è molto probabile che avesse ricoperto tale posizione
sin dal 15 febbraio. Fra i compiti dei Vertrauensleute vi era la
collaborazione con l’ufficio propaganda del governo sociali-
sta allo scopo di trasmettere materiale “educativo” alla
truppa. Le prime funzioni politiche di Hitler furono dunque
assolte per conto del regime rivoluzionario guidato da SPD e
USPD» 14.
Questo dettaglio, lungi dall’essere insignificante, fa
comprendere come l’esercito fosse tenuto in grande conside-
razione non soltanto dal futuro regime nazista, ma da ogni
governo sorto sul territorio dell’ex Impero tedesco. La ragione
di tanta attenzione all’educazione politica delle truppe è da
ricercarsi nel tentativo di assicurarsene la fedeltà. Senza l’ap-
poggio dell’esercito, nessuna entità politica avrebbe potuto
sopravvivere in Germania, a maggior ragione una repubblica
sovietica. La grandissima varietà di gruppi paramilitari di
estrema destra rendeva lo scenario tedesco molto pericoloso
per socialisti e comunisti.
Quando la Repubblica Bavarese dei Consigli fu
14 Ian Kershaw. Hitler. Giunti. Edizione del Kindle.
17rovesciata e la Baviera fu riannessa alla Repubblica di Wei-
mar, si presentò per il nuovo governo bavarese la necessità di
educare le truppe all’antibolscevismo e al nazionalismo tede-
sco. Adolf Hitler, che aveva ormai maturato esperienza nello
spionaggio interno all’esercito, fu assegnato ai servizi infor-
mativi e di propaganda al comando del capitano Mayr. Que-
sti ebbe un ruolo fondamentale nella formazione politica del
futuro dittatore. Hitler frequentava con particolare interesse i
corsi di formazione politica organizzati dal capitano e si fece
presto notare come un fervente oratore, antisemita, naziona-
lista e antibolscevico. Questo gli valse l’incarico che gli cam-
biò la vita… e che la cambiò a milioni di Europei.
Il 12 settembre 1919, Hiter fu inviato da Mayr ad assi-
stere a una riunione del Partito dei lavoratori tedeschi (DAP)
fondato dal fabbro Anton Drexler. Il partito, come miriadi di
altri partitini che sorsero in Baviera in quegli anni, si riuniva
in una sala della birreria Sterneckerbräu a Monaco. I pochi
membri erano operai o piccoli borghesi preoccupati dalla mi-
naccia bolscevica proveniente dalla Russia. «La principale fi-
nalità di questo partito era la costituzione di un “socialismo
nazionale guidato esclusivamente da capi tedeschi” e mirante
alla “nobilitazione del lavoratore tedesco”: al posto della so-
cializzazione propugnava la partecipazione ai profitti, chie-
deva la formazione di una comunità nazionale e formulava
“il suo diritto e dovere” di educare i cittadini all’idealismo per
elevarli ad una più alta concezione del mondo e della vita» 15.
Nonostante l’audacia dei suoi proponimenti, il piccolo
Partito dei lavoratori tedeschi era pressoché sconosciuto
15 Joachim C. Fest. Il volto del Terzo Reich, p. 33, Garzanti, Milano, 1977
18all’opinione pubblica ed era più simile a un piccolo club pri-
vato.
Quel 12 settembre il Partito aveva invitato Gottfried Fe-
der, filosofo ed economista pangermanista che Adolf Hitler
aveva già ascoltato con molto interesse durante i corsi di for-
mazione nell’esercito. La missione di Hitler era semplice-
mente quella di tenere d’occhio il partito per assicurarsi che
non fosse pericoloso per la Repubblica, ma si lasciò trascinare
dal dibattito e prese la parola con veemenza. Drexler lo notò
subito e fu subito colpito da quell’omuncolo pallido capace di
attirare l’attenzione con i suoi discorsi. Lo invitò a partecipare
alle future riunioni e gli fece recapitare la tessera n. 555 del
DAP. Qui un curioso aneddoto che Joachim Fest riporta: i
membri del DAP non erano così tanti, ma per ragioni di mar-
keting le tessere erano numerate a partire dalla 501 così da far
credere che il partito fosse molto più grande. Non è ben chiaro
se la decisione di iscriversi al partito fosse stata dello stesso
Hitler o se gli fu ordinato dal capitano Mayr per spiare meglio
il DAP, ma è certo che Hitler continuò a frequentare le riu-
nioni e divenne l’oratore più apprezzato. Incoraggiato dai
suoi primi successi, Hitler lasciò l’esercito il 31 marzo 1920
per dedicarsi a tempo pieno all’attività politica.
«Senza l’opera da talent scout assolta dal capitano Mayr,
probabilmente di Hitler non si sarebbe mai sentito parlare. In-
vece, benché solo su marginali palchi di birreria, adesso poté
diventare agitatore politico e propagandista a tempo pieno fa-
cendo uso, per guadagnarsi da vivere, del suo unico vero ta-
lento: parlare» 16.
16 Ian Kershaw. Hitler. Giunti. Edizione del Kindle.
19Negli anni a seguire, il Partito (che nel frattempo era
stato rinominato Partito nazionalsocialista dei lavoratori te-
deschi, NSDAP) ricevette l’appoggio e i finanziamenti di nu-
merosi industriali bavaresi preoccupati dalle agitazioni bol-
sceviche provenienti dalla Russia e dalla stessa Germania.
Appena un anno prima la stessa Baviera aveva rischiato di
trasformarsi in una repubblica sovietica, e la borghesia aveva
ancora ben vivo il ricordo.
«Incommensurabile fu l’impatto che gli eventi occorsi
fra il novembre 1918 e il maggio 1919, e la Räterepublik in
particolare, ebbero sull’opinione pubblica bavarese. Come
minimo, il capoluogo lo visse come un periodo caratterizzato
da libertà limitata, grave carenza di cibo, censura della
stampa, scioperi generali, confisca di generi alimentari, car-
bone e capi di vestiario, e generalizzato stato di disordine e
caos. Ma, fatto di ben più duratura importanza, esso si im-
presse nella memoria popolare come una “signoria del ter-
rore” imposta da elementi stranieri al servizio del comunismo
sovietico. L’immagine, forgiata e ampiamente sostenuta dalla
propaganda di destra da un capo all’altro del Reich non meno
che nella stessa Baviera, era quella di forze aliene, bolsceviche
e giudaiche, che prendevano il controllo dello stato, minaccia-
vano le istituzioni, le tradizioni, l’ordine e la proprietà cau-
sando uno stato di anarchia che avvantaggiava unicamente i
nemici della Germania. Vera vincitrice delle catastrofiche set-
timane della Räterepublik fu la destra radicale, che aveva ri-
cevuto il combustibile per infiammare il terrore e l’odio anti-
comunista tra contadini e ceto medio della Baviera. E soprat-
tutto, l’estrema violenza usata dalle forze controrivoluziona-
rie aveva finito per essere accettata quale legittima reazione
alla percepita minaccia bolscevica, diventando da ora in poi
20un aspetto costante della scena politica. Chiusa la parentesi
socialista, negli anni a venire la Baviera divenne una rocca-
forte del conservatorismo e un punto di richiamo per gli estre-
misti di destra da un capo all’altro della Germania. Questa la
cornice in cui poté avvenire la “formazione di Adolf Hit-
ler”» 17.
Oltre a Ian Kershaw, anche lo storico Eric J. Hobsbawm
vede nel nascere dei movimenti bolscevichi e operai una delle
cause, ma non la sola, della pronta adesione alla destra radi-
cale avutasi in Germania. La reazione dell’estrema destra
«non era solo una risposta contro il bolscevismo, ma contro
tutti i movimenti, in ispecie quelli organizzati dalla classe
operaia, che minacciavano l’ordine sociale o che potevano es-
sere accusati di averlo fatto crollare» 18. Fu in questi anni de-
cisivi che si formò una prima identità del NSDAP. A aderirvi
furono personalità divenute successivamente famose, come
Rudolph Hess, il generale Ludendorff, Hermann Goering,
Heinrich Himmler.
Il partito era capace di raccogliere uomini e donne di
ogni estrazione sociale; solo gli operai sembravano poco inte-
ressati, nonostante la denominazione del partito facesse
espresso riferimento ai “lavoratori”. Sempre nel 1920, il
NSDAP si dotò del proprio gruppo paramilitare, le SA, che
avevano il compito di proteggere le riunioni del partito e di
disturbare le riunioni dei partiti avversari, ma agivano spesso
di propria iniziativa e divennero ben presto un vero e proprio
partito nel partito.
17 Ian Kershaw. Hitler. Giunti. Edizione del Kindle.
18 Eric J. Hobsbawm. Il secolo breve, p. 153, BUR Storia, Bergamo, 2006
21Intanto, la Germania si avviava verso uno dei peggiori
disastri economici della storia. Il 5 maggio 1921 fu presentato
al governo tedesco il conto per le riparazioni di guerra: 132
miliardi di marchi. La situazione economica tedesca era disa-
strata e il governo non poteva aumentare ulteriormente la tas-
sazione. La risposta fu dunque quella di stampare ulteriore
moneta per poter far fronte alle rate da versare ai Paesi vinci-
tori della Prima guerra mondiale.
La sfrenata stampa di moneta da parte della Reichsbank
portò alla svalutazione del Papiermark, il marco tedesco, alla
quale seguì un forte aumento dei prezzi. I lavoratori sciope-
rarono in tutta la Germania chiedendo salari più alti, e questi
furono concessi perché la moneta svalutata era molto più a
buon mercato: lo stato poteva stamparla, gli industriali invece
convertivano i loro dollari in carta straccia e pagavano grosse
somme che in realtà consentivano ai lavoratori di vivere ap-
pena.
«Il marco, come abbiamo visto, aveva incominciato a
svalutarsi nel 1921, con un cambio di 75 marchi per un dol-
laro; l’anno successivo il cambio scese a 400 marchi e all’inizio
del 1923 a 7.000. […] Il soffocamento dell’economia tedesca
affrettò precipitosamente il collasso finale del marco. In se-
guito all’occupazione della Ruhr, nel gennaio 1923 si ebbe il
crollo, con 18.000 marchi equivalenti a un dollaro; il 1° luglio
con 160000; il 1° agosto con un milione di marchi. Nel novem-
bre, allorché Hitler credette che la sua ora fosse scoccata, il
dollaro si quotava a quattro miliardi di marchi, e a partire da
allora le cifre si tramutarono in migliaia di miliardi. La mo-
neta tedesca aveva perso ogni valore. Il potere d’acquisto dei
salari e degli stipendi si era ridotto a zero. I risparmi della
22classe media e della classe lavoratrice furono spazzati via» 19.
Risalgono al 1923 la maggior parte delle foto, famosis-
sime, che ritraggono bambini giocare con blocchi di Papier-
mark perché meno costosi dei giocattoli, o lavoratori recarsi a
fare la spesa con carretti carichi di banconote. Il problema
toccò anche gli stati dell’Intesa che, a causa dell’inflazione,
erano stati defraudati con pagamenti in carta straccia e, so-
prattutto, non potevano aspettarsi ulteriori pagamenti da una
nazione in rovina.
Su iniziativa britannica, fu istituita una commissione
presieduta dal banchiere Charles G. Dawes che risolse il pro-
blema alleggerendo le rate tedesche e proponendo al governo
tedesco di istituire una nuova moneta legata al valore
dell’oro. Nel 1924 iniziò il corso legale del Reichsmark, mo-
neta che fu subito apprezzata in Europa e negli Stati Uniti,
tanto che una enorme quantità di capitali esteri affluì in Ger-
mania segnando una forte crescita economica.
È comune la convinzione che la repubblica di Weimar
fosse la “Germania buona” che Adolf Hitler e la sua volontà
di potenza portarono alla corruzione, al militarismo e alla
guerra. In realtà, già nel 1922 la repubblica di Weimar stava
trattando in segreto proprio con la temuta Unione Sovietica
per aggirare il divieto di costruire carri armati e velivoli da
guerra. Il risultato fu il Trattato di Rapallo (1922, da non con-
fondersi con l’omonimo del 1920) con il quale l’Unione Sovie-
tica rinunciava alle riparazioni di guerra dovute dalla Germa-
nia, e in cambio la Germania si impegnava a inviare i suoi tec-
nici e i suoi ufficiali in territorio sovietico per sperimentare
19 William L. Shirer. Storia del Terzo Reich. Einaudi. Edizione del Kindle.
23congiuntamente nuovi carri armati e nuovi velivoli.
Il risultato fu l’apertura di tre diverse scuole militari in
suolo russo, dove tedeschi e russi collaboravano alle spalle
dell’ignaro occidente: una scuola per le sperimentazioni sui
gas a Saratov, una scuola di addestramento aeronautico a Li-
petsk, e una scuola di addestramento per carristi e sperimen-
tazione di nuovi carri sul fiume Kama 20. La tradizione mili-
tare della Germania non poteva essere fermata da un trattato
internazionale, né i socialdemocratici al governo avevano in-
tenzione di reggere le sorti di una nazione potenzialmente
preda di chiunque volesse invaderla.
Quindi se da un lato la Germania stava assecondando
l’Intesa, dall’altro già progettava di superare il Trattato di
Versailles.
Fino al 1923, Hitler era stato convinto che l’unico modo
per prendere il potere in Germania sarebbe stato un colpo di
stato alla testa di truppe d’assalto paramilitari o di reparti
dell’esercito fedeli al nazionalsocialismo.
In carcere, dopo il fallito colpo di stato del 1923, maturò
quella che fu definita “rivoluzione legale”. Hitler si rese conto
che senza l’appoggio dell’esercito era pressoché impossibile
controllare lo stato, ma anche che la via legale per il potere gli
offriva la possibilità di legittimarsi sia agli occhi del popolo
sia a quelli della comunità internazionale.
D’altronde la costituzione di Weimar offriva qualche
appiglio anche per chi, come lui, mirava ad avere un potere
pressoché totale sulla nazione. Fu a questo punto che Hitler
20 Samuel W. Mitcham, Jr. The Panzer Legions. Greenwood Press West-
port, London, 2001
24iniziò ad organizzare il partito come uno stato nello stato,
aprendo sedi in ognuno degli stati confederati della Germa-
nia. Lo scopo era quello di avere una struttura di potere e uo-
mini chiave già pronti quando sarebbe stato il momento di
salire al potere.
Per ragioni di brevità e per non divagare eccessivamente
nella trattazione storica che non è il punto di questo scritto,
passeremo a trattare gli eventi chiave che portarono Adolf
Hitler a divenire cancelliere del Reich e poi anche capo dello
stato.
25LA RIVOLUZIONE LEGALE DI HITLER
Nel 1929 si ebbe il crollo di Wall Street negli Stati Uniti.
Dopo l’introduzione del Reichsmark legato al valore dell’oro
e la stabilizzazione dell’economia tedesca, dagli Stati Uniti
erano arrivati numerosi investitori. La crisi del ’29, quindi,
colpì duramente anche la Germania, la cui crescita economica
era fortemente legata a quella degli Stati Uniti. L’economia
ebbe un’altra dura battuta d’arresto e la disoccupazione di-
venne dilagante nel Paese.
Nel 1930 il governo tedesco era composto da una coali-
zione di quattro partiti, tutti favorevoli all'ordinamento de-
mocratico: i Socialdemocratici, il Centro, il Partito Democra-
tico e il Partito Popolare. Come capo del governo c'era il so-
cialdemocratico Hermann Muller. Quando la disoccupazione
cominciò a salire, tre dei quattro partiti nella coalizione di
Muller iniziarono a fare pressioni per fare tagli alla spesa pub-
blica. I socialdemocratici non erano d'accordo perché signifi-
cava tagliare anche i sussidi per i disoccupati, e tradire quindi
i suoi stessi elettori. Questo portò a una crisi di governo, ma
nel Reichstag (la camera bassa del parlamento) non vi era una
nuova maggioranza che sostenesse un nuovo governo, quindi
si tornò alle elezioni in quello stesso anno.
I risultati, in ordine dall'estrema sinistra all'estrema de-
stra, furono questi:
• Partito Comunista Tedesco (KPD) 13%
• Partito Socialdemocratico (SPD) 24%
• Partito Democratico (DDP) 4%
• Partito di Centro (DZP) 15%
• Partito Popolare (DVP) 5%
• Partito Popolare Nazionale Tedesco (DNVP) 7%
26• Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori
(NSDAP) 18%
• Altri partiti 14%
Stando così le cose, trovare una maggioranza nel Reich-
stag era ancora impossibile. I partiti più moderati infatti dete-
nevano poco meno del 50% dei seggi, per cui avrebbero do-
vuto cercare alleati nei partiti estremisti, che sapevano benis-
simo di aver gonfiato le loro fila proprio grazie alla crisi dei
primi: quindi non avrebbero mai ceduto alle loro lusinghe.
Questa situazione di stallo portò il presidente del Reich
Hindenburg a ricorrere ai poteri speciali previsti dall'articolo
48:
«Il presidente [del Reich] può prendere le misure neces-
sarie al ristabilimento dell’ordine e della sicurezza pubblica,
quando essi siano turbati o minacciati in modo rilevante, e, se
necessario, intervenire con la forza armata. A tale scopo può
sospendere in tutto o in parte la efficacia dei diritti fondamen-
tali stabiliti dagli articoli 114, 115, 117, 118, 123, 124 e 153».
In poche parole, il nuovo governo (presieduto da Hein-
rich Bruning) avrebbe governato tramite decreti approvati
dal presidente del Reich. Formalmente la Germania avrebbe
avuto ancora un Cancelliere, ma sarebbe stato poco più che
uno strumento del presidente. Questo dava un grande peso
politico alla cerchia dei consiglieri del presidente. Durante
questo nuovo governo, la situazione sociale ed economica
non migliorò affatto. Le misure economiche adottate, tra le
quali una sospensione dei pagamenti delle riparazioni di
guerra, non riuscirono a innescare la crescita. L'inflazione
continuava ad aumentare e nelle strade scorrazzavano gruppi
paramilitari di ogni tipo che si scontravano. Le violenze creb-
bero di anno in anno, così come i morti nelle strade.
27Nel 1932, si ebbe un primo tentativo di Hitler di scalare
il potere. Il mandato settennale di Hindenburg scadeva, e si
andò quindi a nuove elezioni per il presidente del Reich. Hit-
ler si candidò contro Hindenburg e prese 13 milioni di voti,
contro i 19 milioni di Hindenburg. Nonostante la vittoria,
Hindenburg era consapevole che la popolarità di Hitler stava
salendo pericolosamente. Insoddisfatto di Bruning, il presi-
dente Hindenburg lo congedò, e affidò la formazione di un
nuovo governo a Franz von Papen su spinta di uno dei suoi
più fidati consiglieri, von Schleicher. L'idea di Schleicher era
quella di continuare con l'esperienza del "governo presiden-
ziale", relegando il Reichstag a un ruolo marginale. Per fare
ciò, tuttavia, aveva bisogno di un governo con un forte ap-
poggio popolare, e pensò subito ai nazisti.
Ma il governo di von Papen non incontrò alcuna mag-
gioranza in parlamento e, ancora una volta, furono indette
nuove elezioni per il Reichstag (nel 1932 si voterà tre volte:
una volta per il presidente del Reich e due volte per il Reich-
stag). In questa nuova consultazione il partito Nazionalsocia-
lista uscirà fortemente rinforzato: dal 18% del 1930, arriverà
al 37,8%. Hitler, pur approvando l'idea di formare un governo
con von Papen, non voleva assolutamente avere un ruolo di
supporto. Pretendeva di essere Cancelliere. Hindenburg dal
canto suo non si fidava minimamente di Hitler e voleva ten-
tarle tutte prima di consegnargli le chiavi del governo. Così,
nel novembre 1932, si tornò a votare per la seconda volta per
il Reichstag: il partito Nazionalsocialista prenderà il 33% dei
voti. Stavolta il Cancelliere sarebbe stato lo stesso Schleicher,
il fidato consigliere di Hindenburg, ma i nazisti ancora una
volta si rifiutarono di prendere parte a un governo alla cui
guida non ci fosse Hitler.
28Quindi von Papen arrivò da Hindenburg con una pro-
posta: avrebbe collaborato con Hitler in un nuovo governo
presidenziale; Hitler sarebbe stato Cancelliere, e von Papen
vicecancelliere.
Sebbene si racconti che nel gennaio 1933 "Hitler salì al
potere", come se fosse stato consacrato dittatore della Germa-
nia, ciò che accadde davvero fu che Hitler divenne Cancelliere
a capo di un governo di coalizione in cui solo 3 ministri su 12
erano nazisti. Inoltre, era ancora un governo presidenziale:
ciò significa che ogni atto del governo andava approvato dal
presidente del Reich in base all'articolo 48 comma 2. Il piano
di Hitler era trovare il modo di avere la maggioranza nel Rei-
chstag così da poter bypassare Hindenburg; e, più ambiziosa-
mente, mirava ai due terzi del Reichstag, così da poter addi-
rittura emendare la costituzione di Weimar. L'occasione fu
data dal Partito Comunista il 27 febbraio 1933.
Il comunista Marinus van der Lubbe appiccò l'incendio
al Reichstag (alcuni credono che fosse stato pagato dal partito
nazista) e diede a Hitler l'occasione per fomentare la paura
verso l'insorgere dei comunisti. La classe media era ovvia-
mente terrorizzata dai comunisti, e avrebbe accettato ogni
cosa pur di non vederli arrivare al potere. Hitler dunque per-
suase Hindenburg a emanare un decreto per la sospensione
dei diritti di base, come la libertà di parola e quella di assem-
blea (sempre grazie all'articolo 48).
Questo decreto significava che il governo poteva ordi-
nare lo scioglimento di ogni organizzazione o associazione re-
putata pericolosa per lo Stato... e fece sciogliere il Partito Co-
munista. Il 5 marzo 1933 si tornò al voto per cercare di dare
una maggioranza a questo nuovo governo. Il partito nazio-
nalsocialista ottenne il suo risultato migliore alle elezioni:
2944%. Ma la loro alleanza con il partito nazionalista porterà il
governo guidato da Hitler ad avere una maggioranza del 52%
nel Reichstag.
Finalmente Hitler era libero dal presidente Hindenburg.
In più, agli 81 deputati eletti del Partito Comunista non fu
permesso di sedere nel Reichstag in quanto il loro Partito era
stato sciolto, per cui la maggioranza guidata da Hitler salì al
60%. La morte definitiva della democrazia in Germania si
ebbe il 23 marzo 1933, con il cosiddetto "decreto dei pieni po-
teri" (Il nome ufficiale era "Legge a rimedio dell'afflizione sof-
ferta dal Popolo e dal Reich"). Accadde che Hitler aveva biso-
gno, per ottenere appunto i pieni poteri, di poter emendare la
costituzione. Con il 60% dei seggi in parlamento non poteva
ancora, poiché erano richiesti i due terzi. Ottenne però l'ina-
spettato appoggio del Partito di Centro, la cui ala Cattolica
era grata a Hitler per aver scongiurato il pericolo comunista.
Quindi, con la sua maggioranza qualificata dei due terzi, Hit-
ler poté approvare il decreto che permetteva al Cancelliere di
dichiarare lo stato di emergenza e assumere su di sé anche i
poteri del Reichstag, sospendendo dunque la democrazia.
A questo punto Hitler aveva davvero i pieni poteri. Mise
fuori legge tutti i partiti al di fuori del partito Nazionalsocia-
lista, che quindi fu l'unico ammesso nel Reichstag. I campi di
concentramento sorsero come funghi già dai primi giorni del
marzo 1933, a meno di due mesi dal cancellierato di Hitler.
Inizialmente si trattava di campi di detenzione allestiti in
scantinati, vecchi complessi industriali o ex carceri. La ge-
stione era affidata interamente alle SA, che reclutavano crimi-
nali, reduci di guerra, sbandati, galeotti e ogni sorta di per-
sona disposta a torturare il prossimo. Gli arresti erano del
tutto illegali, ma nessuno poteva opporsi perché la
30detenzione era spacciata per “custodia protettiva” (Schu-
tzhaft): in altre parole, giornalisti, oppositori, ebrei, zingari,
venivano posti in custodia per proteggerli dal clima di odio
che imperversava in Germania. La giustizia penale era stata
“amministrativizzata”. Si poteva arrestare per ordine di qua-
lunque autorità locale senza passare per la magistratura che,
pur essendo in parte simpatizzante per l’estrema destra, era
comunque inaffidabile perché non pienamente sotto il con-
trollo del partito.
«Affidandosi agli arresti di massa non regolamentati
dalla legge, i nazisti seguirono le orme di altri rivoluzionari:
volevano distruggere i nemici prima che questi potessero pas-
sare al contrattacco. Tale strategia richiedeva un’azione radi-
cale, trascurando i princìpi legali e le scartoffie. Anni dopo,
Himmler si vantò del fatto che nel 1933 i nazisti avevano di-
strutto “l’organizzazione asociale giudaico-comunista”, to-
gliendo dalle strade le persone “in modo del tutto illegale”.
In realtà, la maggior parte dei sospetti era stata formalmente
tenuta in quella che, eufemisticamente, era chiamata “deten-
zione preventiva” (Schutzhaft), una forma di detenzione a
tempo indeterminato basata sul Decreto presidenziale per la
protezione del popolo e dello Stato. Questo decreto, appro-
vato dal gabinetto di Hitler il 28 febbraio 1933 in risposta al
rogo del Reichstag, aveva sospeso le libertà civili di base e,
per dirla con le parole dello studioso di scienze politiche Ernst
Fraenkel, emigrato dalla Germania, era diventato una sorta di
“carta costituzionale del Terzo Reich”, giustificando ogni
sorta di abuso di potere, compresa la negazione della libertà
personale senza supervisione dell’autorità giudiziaria né ap-
pello. […] Il terrore che cresceva dal basso e il caos che lo ac-
compagnava vennero efficacemente descritti dalle parole di
31un esasperato SA-Gruppenführer all’inizio di luglio 1933:
“Tutti arrestano tutti, scavalcando la procedura ufficiale, tutti
minacciano tutti di detenzione preventiva, tutti minacciano
tutti di spedirli a Dachau”. Si produsse quindi un parapiglia
senza regole, mentre sempre più funzionari di Stato e di par-
tito sfruttavano le opportunità di un terrore virtualmente
senza limiti» 21. L'ultimo step, ancora legale, si ebbe il 19 ago-
sto 1934, dopo la morte di Hindenburg avvenuta il 2 agosto.
Ormai in potere di fare qualunque cosa con il decreto dei
pieni poteri, Hitler assunse su di sé anche i poteri di presi-
dente del Reich e comandante supremo dell'esercito. All'eser-
cito fu imposto di giurare fedeltà non alla Germania, ma a
Hitler in persona. La nuova carica di Hitler non sarà più sol-
tanto "Cancelliere", ma Führer und Reichskanzler, cioè Fuhrer
(guida) e Cancelliere del Reich.
21 Nikolaus Wachsmann. KL. Storia dei campi di concentramento nazisti,
Mondadori, Milano, 2016
32LE RAGIONI DEL SUCCESSO DEL
NAZIONALSOCIALISMO
Chi ha avuto l’ardire di leggere fin qui avrà in qualche
modo già intuito quali sono le ragioni che condussero milioni
di tedeschi nelle braccia del “rassicurante” nazionalsociali-
smo.
Spesso si tende ad associare il nazionalsocialismo al
“grande capitale”, credendo, erroneamente, che esso fosse
null’altro che un’invenzione di banchieri e grandi industriali
per soggiogare la classe operaia. Come già detto, i grandi in-
dustriali tedeschi finanziarono fin dall’inizio il NSDAP tro-
vandovi una valida alternativa alle varie correnti di ispira-
zione marxista o bolsceviche.
Tra i due mali, il “grande capitale” scelse quello che
sembrava il minore, ma non per questo si può credere che in-
dustriali, imprenditori e banchieri fossero felici del pro-
gramma del NSDAP che prevedeva la partecipazione dello
stato ai profitti delle aziende.
«Il grande capitale può venire a patti con qualunque re-
gime che non intenda effettivamente espropriarlo, e dunque
ogni regime deve venire a patti con esso» 22.
D’altra parte, prima di presentarsi come una “terza via”
che prevedeva una sorta di capitalismo di stato, il nazional-
socialismo ebbe al suo interno almeno due anime, una ricon-
ducibile a Adolf Hitler e una seconda espressa dal fondatore
Drexler e più tardi, in parte, anche da Otto Strasser. Questa
22 Eric J. Hobsbawm. Il secolo breve, BUR, Milano, 2006
33seconda anima “di sinistra” non vedeva nel bolscevismo una
minaccia, ma anzi vedeva in esso un alleato.
Strasser aveva ideato un mondo simil-feudale in cui
tutte le terre sarebbero state espropriate e assegnate a conta-
dini-soldati. I grandi centri urbani sarebbero stati spopolati in
favore di piccoli centri rurali a misura d’uomo. La Germania
sarebbe stata una grande federazione capace di raccogliere
tutti i popoli di etnia germanica. Gli interessi dei grandi capi-
tali esteri, rappresentati dagli ebrei principalmente, non pote-
vano far altro che corrompere questo mondo idilliaco in cui
lo spirito germanico avrebbe trovato piena realizzazione. Jo-
seph Goebbels, il famoso ministro della propaganda nazista,
era un simpatizzante di questa corrente agli albori della sua
carriera politica.
«In una lettera aperta indirizzata “a un amico della sini-
stra”, egli elencava tutta una serie di principi e atteggiamenti
nazismo e comunismo avevano in comune, fra cui la convin-
zione della necessità di soluzioni sociali, l’avversione verso la
borghesia e “il sistema menzognero” e, infine, la “lotta per la
libertà” […] “Voi e io” così Goebbels concludeva la sua lettera
“ci combattiamo a vicenda senza essere nemici, e in questo
modo non arriveremo mai allo scopo. Forse l’ora del pericolo
ci unirà. Forse…!”» 23 .
Il nemico comune dei comunisti e dei nazisti era il si-
stema economico e di pensiero liberale rappresentato dalla
Gran Bretagna e dagli Stati Uniti, ma anche dagli ebrei, con-
siderati estranei alla cultura germanica e portatori di valori
23 Joachim C. Fest. Il volto del Terzo Reich, pp. 142-143, Garzanti, Milano,
1977
34internazionalisti (come il libero mercato) disgreganti. Tutta-
via, la borghesia poteva sopportare le “stravaganze” antise-
mite del NSDAP se in cambio questo offriva sicurezza e sta-
bilità dopo anni di colpi di stato, anarchia, freikorps sguinza-
gliati nelle strade, crisi economiche devastanti e scioperi ge-
nerali di ispirazione bolscevica. Probabilmente per i tedeschi
dell’epoca fu uno scambio equo, soprattutto se si considera
che l’antisemitismo era un sentimento ampiamente diffuso
nell’Europa centro-orientale e nei ceti contadini e operai della
Germania.
Non va sottovalutata, al di là delle esigenze immediate
di sicurezza e stabilità, anche la narrazione pangermanista ed
eroica che Hitler seppe costruire estrapolandola dallo spirito
tedesco. L’idea di una Germania unita che comprendesse tutti
i popoli germanici non fu certamente un’idea del Novecento,
ma trova le sue origini nel secolo precedente. Nella conce-
zione nazionalsocialista, la “nazione” era intesa come “na-
zione-ethnos”, cioè un legame quasi spirituale che univa tutti
gli appartenenti alla stessa stirpe.
Non è un caso se la ricerca degli ebrei non poté limitarsi
all’invenzione di alcuni parametri fisici che identificavano
l’ebreo, ma andò oltre, alla ricerca della discendenza e degli
antenati. In questa narrazione, il tedesco era appartenente a
una razza superiore che aveva bisogno di essere riunificata in
una Grande Germania, e in questo senso la repubblica di Wei-
mar era un tradimento al Volk, al popolo germanico intero,
poiché aveva suddiviso ulteriormente la Germania. Le scuole
e i movimenti giovanili dalla metà dell’Ottocento avevano co-
struito il mito della Grande Germania, e nel Novecento que-
sto era ancora vivo.
«Mossi dall'impazienza tipica dell'età, i giovani
35divennero l'avanguardia di una rivoluzione prettamente ger-
manica, e le autorità scolastiche non perdettero occasione per
favorire questa presunta soluzione della crisi del pensiero te-
desco. Dopo il 1918, il Movimento giovanile proseguì i tenta-
tivi da esso iniziati nel periodo prebellico, andando alla ri-
cerca di nuove forme sociali e politiche che, a suo giudizio,
meglio corrispondessero alle aspirazioni pangermaniche. Si
trattava di un movimento prettamente tedesco, di un vero mi-
crocosmo della moderna Germania, che, a partire dai primi
anni del 1900, seppe accaparrare la fantasia e la dedizione dei
giovani, lungo un arco di sviluppo cui mise termine la con-
quista nazista del potere. Se dapprima i giovani si erano ra-
dunati al semplice scopo di compiere escursioni in campagna,
ben presto le loro attività si caricarono di sottintesi ideologici:
ricostruire il Volk secondo principi più genuini e naturali di
quelli del modernismo. Negli anni prebellici, gli aderenti al
movimento ammontavano a circa sessantamila; dopo la
guerra, si raggiunse e superò la cifra di centomila. Era questa
l'élite della gioventù borghese, e il movimento ebbe un'in-
fluenza formativa su molti dei leader intellettuali nati tra il
1880 e il 1920» 24.
In un simile sistema di pensiero, il liberalismo non po-
teva trovare alcun posto. L’individuo non poteva esistere
senza il legame con la comunità, e la comunità si sarebbe di-
sgregata se l’individuo avesse perseguito soltanto il proprio
interesse. Inoltre, l’idea di uno stato debole, poco interventi-
sta, poco attivo nella società e nell’economia, spaventava par-
ticolarmente i tedeschi timorosi delle rivoluzioni bolsceviche
24 George L. Mosse. Le origini culturali del Terzo Reich, Il Saggiatore, Mi-
lano, 2015
36e oppressi dal pagamento dei debiti di guerra. Il forte statali-
smo del primo dopoguerra era figlio anche della guerra
stessa.
«La Grande Guerra, mobilitando e riorganizzando in
forme inedite le risorse umane ed economiche dei paesi belli-
geranti, spingendo i governi a dotarsi di poteri e di strumenti
di intervento mai sperimentati prima, ha inferto un colpo
forse mortale all’economia di mercato, tradizionalmente in-
tesa come organismo capace di autoregolarsi» 25.
La promessa di uno stato forte e autoritario non poteva
che tranquillizzare i tedeschi, più che spaventarli. Difatti, nes-
sun partito della repubblica di Weimar aveva nel proprio
nome la parola “liberale”, poiché nessuno contemplava l’idea
di ridurre la presenza dello stato nell’economia e nella vita
dei cittadini.
25 Sabbatucci Giovanni. Il fallimento del liberalismo e la crisi del primo do-
poguerra.
37IL MILITARISMO TEDESCO
Non è possibile comprendere alcuni eventi che segui-
rono la fine della Prima guerra mondiale se non si va alle ra-
dici del militarismo prussiano.
«Ciò che caratterizza il militarismo è il ruolo preminente
che il sistema militare assume nella vita della nazione. Anche
in tempo di pace l’esercito è visto come l’anello più saldo
dello stato; i sudditi devono assoggettarsi al potere statale
come soldati all’ordine di un comandante. Nel militarismo
non esiste libertà, ma solo obbedienza e disciplina» 26.
Fin dal XVIII secolo il militarismo prussiano caratte-
rizzò la vita politica dell’Impero tedesco. Il Regno di Prussia
era la più potente delle entità statali che formavano l’Impero
tedesco. L’imperatore, infatti, ricopriva sia la carica di impe-
ratore dei tedeschi sia quella di re di Prussia. L’esercito impe-
riale stesso era composto, in realtà, per la maggior parte
dall’esercito prussiano e assoggettato al corpo ufficiali prus-
siano.
Il militarismo prussiano nacque in risposta a due di-
verse esigenze. La prima era quella di garantire all’impera-
tore una forza armata abbastanza fedele da sedare le rivolte
popolari senza unirsi ad esse; la seconda era quella di fron-
teggiare i grandi eserciti di leva dell’era napoleonica, uniti
non solo dalla paga e dal timore del bastone degli ufficiali, ma
anche dall’idea di nazione e da una comunanza di visioni con
l’imperatore.
26 Ludwig von Mises. In nome dello Stato, p. 36, Rubbettino Editore, So-
veria Mannelli, 2012
38Puoi anche leggere