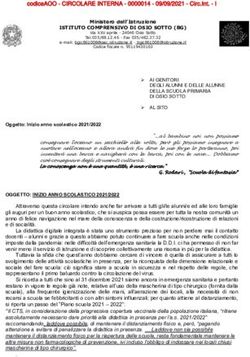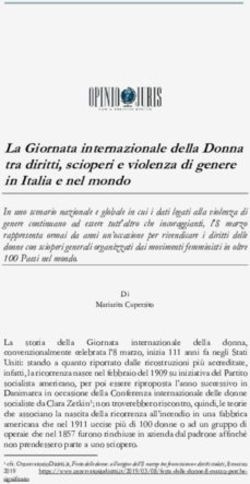La ricostruzione post sisma in Italia: dal com'era dov'era alle 'new towns' - Amazon ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
La ricostruzione post sisma in Italia: dal com’era dov’era alle ‘new towns’ Il 24 agosto, come è noto, un sisma ha colpito i territori del Centro Italia, tra cui Amatrice, Arquata del Tronto, Accumoli, Pescara del Tronto. Alcune di queste località sono state parzialmente distrutte, inducendo le autorità a istituire immediatamente misure per la ricostruzione, identificate nel cosiddetto piano ‘Casa Italia’. Ma la storia italiana, un Paese che ha il primato dei terremoti distruttivi in Europa e che, putroppo, non sempre ha riservato ai territori colpiti soluzioni urbanistiche adeguate, per le ragioni più disparate. Per fornire a chiunque una serie di strumenti storici, con l’obiettivo di stimolare il dibattito sulle soluzioni di ricostruzione post sisma più adeguate, iniziamo oggi un ‘viaggio’ a puntate raccontando i casi più eclatanti di ricostruzione post sisma in Italia. Il territorio italiano ha il primato dei terremoti in Europa: ben 500 sismi distruttivi su 1.300 avvenuti nel II millennio nel Mediterraneo centrale. Oltre al cataclisma di Messina del 1908 e la trentina di fenomeni più gravi degli ultimi 150 anni, 7 terremoti rilevanti sono avvenuti dal 1968 al 2012, a cui va aggiunto il recente sisma nell’Italia centrale. La lunga storia di terremoti in quasi tutte le regioni d’Italia riflette le diverse realtà territoriali, economiche e sociali della penisola e gli approcci politici e culturali che hanno ispirato e gestito i processi di ricostruzione. Al di là degli scandali, delle inadempienze e del malaffare, sotto il profilo strategico-progettuale si sono confrontati due modelli di fondo: le “città nuove” e il “dov’era, com’era”.
Le città nuove La concezione di “città nuova”, costruita di solito in siti diversi da quelli originali, risale ai cinque catastrofici terremoti avvenuti nella Calabria meridionale nel 1783. Il riformismo illuministico dell’epoca promosse progetti di sviluppo urbanistico in aree da secoli ai margini della vita sociale ed economica del Regno di Napoli: città a forma di stella oppure ortogonali, con strade larghe e costruzioni concepite dentro simmetrie e misure fino ad allora sconosciute nella regione. Questo modello venne applicato anche in seguito in varia misura, fino alla soluzione radicale di Messina (però nello stesso sito storico) e più recentemente, in una versione parziale e incompiuta, dopo il terremoto del 2009 in Abruzzo. Com’era, dov’era Ricostruire “come era, dove era” in zone sismiche e a forte rischio-idrogeologico, è sempre relativo, data la necessità di
usare materiali di qualità e tecniche edilizie antisismiche e regole costruttive necessariamente diverse da quelle del passato. Nella pratica, l’aspirazione a rimanere fedeli al disegno originario è sempre ridimensionata da considerazioni sulla sicurezza, la comodità e le altre esigenze di modernità necessarie al rilancio dei territori interessati. Il caso più significativo è quello del terremoto del 1976 in Friuli. Nei luoghi del terremoto, si è deciso paese per paese, zona per zona, in base ai danni e al carattere del territorio, se ricostruire in loco o altrove e con quali materiali e tipologia abitativa. Il risultato è stato positivo grazie alla partecipazione consapevole della comunità. Il futuro delle comunità Nella decisione di dove e come ricostruire, il problema centrale è sempre il futuro delle comunità, legato alla struttura produttiva e alle dinamiche demografiche nei territori interessati. Ricostruire piccoli borghi montani com’erano, come in Umbria dopo i terremoti del 1979 e del 1997, ma senza servizi, in un contesto di progressivo abbandono, ha portato al loro spopolamento. Nel Belice, colpito dal sisma del 1968, il degrado strutturale e demografico era talmente avanzato già prima dell’evento distruttivo, che nemmeno si è cercato di riformare i vecchi paesi, puntando su nuovi agglomerati privi di identità ma “valorizzati” con interventi artistici d’avanguardia, come a Gibellina. Prevenzione, emergenza, ricostruzione: i modelli gestionali I terremoti sono stati anche stimolo per innovare strumenti tecnici e gestionali per la prevenzione, l’emergenza e la ricostruzione. Sul campo, si sono applicati di volta in volta modelli in una gamma che va dalla totale centralizzazione statale alla delega e sussidiarietà degli enti locali, con il corollario normativo di leggi ad hoc e deroghe a quelle esistenti. Sul piano della prevenzione, dopo il terremoto in Puglia del 2002, si sono rinnovati completamente i criteri di
mappatura e di valutazione del rischio sismico e la normativa per le scuole. Sul piano dell’intervento d’emergenza, dopo il terremoto in Irpinia, si è cominciato a costruire seriamente il servizio di protezione civile nazionale. Sul piano della ricostruzione, il solo caso “chiuso” è quello del Friuli post 1976, mentre il piano più fallimentare riguarda il sisma avvenuto in Irpinia nel 1980. Tempi politici e tempi urbanistici L’evento terremoto mette in risalto la nota “lentezza” e “inerzia” del fatto architettonico e urbano, a fronte dell’esigenza di tempi rapidi nel ripristino di una normalità dignitosa per le popolazioni colpite e di un tessuto produttivo in grado di assicurare identità e sviluppo territoriale. Questa contraddizione ha spesso portato a squilibri nelle procedure di pianificazione e costruzione, causando, nel modello “città nuove”, la realizzazione di abitazioni e strutture presto obsoleti o addirittura mai usati: palestre, palazzetti dello sport, case popolari, uffici pubblici, scuole in prossimità di centri storici fantasma in attesa di ripristino. D’altra parte, nel modello “dov’era, com’era”, la “resilienza” delle comunità e dei territori – la capacità cioè di riorganizzare la propria vita in rapporto a un cambiamento improvviso e imprevisto dovuto, in questo caso, a un disastro naturale – si è ridotto a volte alla conservazione di una tradizione stilistico-formale, senza un’adeguata valutazione costi/benefici non solo sentimentali ma anche e soprattutto in relazione alla funzionalità e alla sostenibilità delle strutture urbane e delle loro connessioni su scala locale e globale. Approfondimenti
eBook - Terremoti: obblighi e responsabilità Raffaele Guariniello L'e-book si propone un obiettivo avvincente ed ambizioso: quello di dare un contributo alla discussione attualmente in corso nel Paese sui terremoti, e di dissipare con le parole della Cassazione alcuni deleteri, controproducenti equivoci purtroppo diffusi in argomento. Wolters Kluwer Acquista su shop.wki.it Il destino del paesaggio italiano I terremoti (ma potremmo estendere il discorso alle trasformazioni strutturali generate da eventi disastrosi innescati dal cambiamento climatico) impongono anche riflessioni sulla configurazione del paesaggio italiano e sul futuro dei piccoli centri urbani che lo caratterizzano. Dei 60 milioni di italiani, ormai 22 vivono in 14 città e la tendenza segue quella globale dell’inurbamento, nonostante il diffuso ed eccellente patrimonio di borghi, monasteri, mura, scorci, arte, cultura, tradizioni che lentamente si svuota e scompare nel paesaggio contemporaneo. Rianimare i luoghi sconvolti dai sismi, spesso già logorati dalla marginalizzazione, richiede progetti di area vasta, orientati al recupero e rilancio della produzione economica e di quella culturale, spesso strettamente intrecciate per la presenza, nelle zone colpite, di beni artistici e di siti di interesse storico e culturale, come nei casi dei terremoti in Abruzzo, in Umbria e, da ultimo, nell’Italia centrale.
I costi dei terremoti
L’analisi dei costi economici complessivi dei terremoti
considera un insieme di oneri che comprendono in primo luogo:
• il ripristino del patrimonio abitativo e degli edifici
pubblici;
• i danni alle infrastrutture (rete viaria e ferroviaria,
sistema idraulico, rete idrica, fognature, gas e rifiuti);
• i danni al patrimonio storico e artistico;
• i danni alle attività produttive (industria, servizi e
agricoltura).
Inoltre vanno considerati:
• gli effetti dei mancati guadagni per le aziende
sull’occupazione,
• gli sgravi fiscali e le esenzioni dalle imposte,
• i costi per la governance che comprende la gestione
burocratico-amministrativa ed i costi per il personale
aggiuntivo a termine,
• gli aggravi di spesa corrente per servizi pubblici, come
quelli per l’attivazione di presidi medici e di assistenza a
gruppi con fragilità (anziani) o per cure eseguite a domicilio
o ricoveri in strutture regionali, come pure le esenzioni dal
pagamento del ticket,
• le risorse necessarie per consentire la ripresa
dell’attività scolastica, con soluzioni alternative per le
scuole gravemente danneggiate.
Costi attualizzati terremoti in Italia 1968 -2012
Periodo di Importo
Evento Anno attivazione attualizzato 2014
interventi (mln €)
Valle del Belice 1968 1968-2028 9.179
Friuli (*) 1976 1976-2006 18.540
Irpinia 1980 1980-2023 52.026Marche Umbria
1997 1997-2024 13.463
(*)
Puglia Molise
2002 2002-2023 1.400
(*)
Abruzzo (**) 2009 2009-2029 13.700
Emilia (**) 2012 2012 13.300
Totale 121.608
(*) Dati a consuntivo sulle risorse effettivamente stanziate
dallo Stato
(**) Previsioni di spesa delle autorità locali preposte alla
ricostruzione
Fonte: Elaborazione Centro Studi CNI su dati Ufficio Studi
Camera dei Deputati, Regione Emilia Romagna, Commissario
delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo
Nelle prossime puntate:
2. Messina 1908. La città che visse due volte
3. Belice 1968.
4. Friuli 1976.
5. Irpinia 1980.
6. Umbria-Marche 1997.
7. Puglia-Molise 2002.
8. Pianura Padana 2012.
ApprofondimentieBook - Sostenibilità in edilizia Giorgio Tacconi Questa guida offre un panorama del “sistema di regole per l’edilizia sostenibile” risultante dall’intreccio tra norme istituzionali obbligatorie e non obbligatorie, su scala europea, nazionale, regionale e locale. Wolters Kluwer Acquista su shop.wki.it
Puoi anche leggere