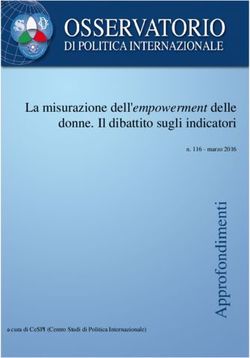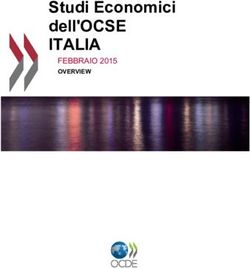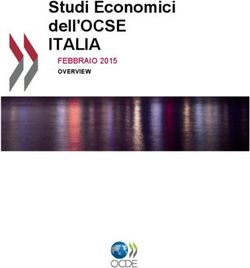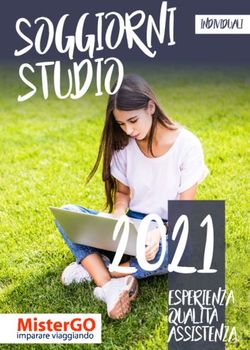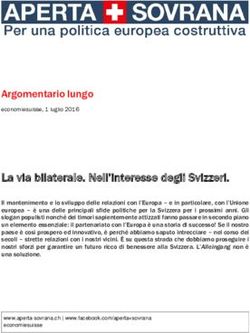LA CRISI DEI PARTITI E LA DE-POLITICIZZAZIONE DELLO SPAZIO POLITICO. QUALI RISCHI PER LA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA? - Rubbettino editore
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
QUADERNI DI SCIENZA POLITICA - ISSN 1124-7959 Anno XXV - n. 1 Aprile 2018
LA CRISI DEI PARTITI E LA DE-POLITICIZZAZIONE
DELLO SPAZIO POLITICO. QUALI RISCHI PER LA
DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA?
di Eugenio Salvati
A proposito di: Peter Mair, Governare il vuoto. La fine della
democrazia dei partiti, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016.
Introduzione ra scomparsa nel 2011.
Il libro che Rubbettino ha tradotto e
Il lavoro postumo di Peter Mair Go- dato alle stampe nel 2016 è la prima
vernare il vuoto. La fine della demo- edizione italiana di Ruling the Void.
crazia dei partiti, è un libro che ha The Hollowing of Western Demo-
il pregio, ormai sempre più raro, di cracy, pubblicato nel 2013, e compo-
invitare il lettore a compiere una ri- sto sia dai capitoli originali dell’ul-
flessione articolata su un tema di am- timo volume a cui stava lavorando
pio respiro, utilizzando un approccio Mair, sia da articoli che toccano gli
rigorosamente scientifico ma intelligi- stessi temi al centro del libro allo-
bile ad un pubblico più vasto della cer- ra in cantiere. Come scrive Mulhern
chia degli specialisti. In questo caso il nella prefazione, il testo unisce le due
tema ampio e fondamentale è quello tipologie di scritti «con l’obiettivo di
della crisi dei partiti e della democra- creare una versione coerente, sebbene
zia rappresentativa, così come indica- necessariamente incompleta, del libro
to in modo evidente dal sottotitolo che che aveva in mente»(1).
non lascia spazio a equivoci di sorta. Il libro si compone di quattro ricchi
Al centro della riflessione di Mair capitoli e questa analisi, al fine di dare
c’è il tentativo di fornire un’analisi una lettura più esaustiva possibile del
in grado di spiegare il perché del de- testo, si atterrà a tale scansione, se-
clino strutturale della partecipazione guendo la linea del ragionamento im-
politica nelle democrazie europee. postato da Mair. Nonostante la natura
Mai come in questi ultimi anni la pre- postuma del lavoro e l’ampiezza con-
occupazione di Mair si sta rivelando tenutistica dei capitoli, il libro di Mair
concreta e attuale; un tema che pur-
troppo il politologo irlandese non ha
avuto tempo e modo di sviscerare in
(1)
Peter Mair, Governare il vuoto. La fine
della democrazia dei partiti, Soveria
profondità, a causa della sua prematu- Mannelli, Rubbettino, 2016, p. XI.148 EUGENIO SALVATI
è segnato da un filo rosso che rac- 1. Una democrazia senza partiti e
coglie tutti gli argomenti e che con- senza cittadini?
sente al lettore di avere un’idea il più
completa possibile dei cambiamenti e Compiendo uno sforzo di sintesi po-
delle trasformazioni che stanno stra- tremmo dire che il libro di Mair porta
volgendo le democrazie europee, ma il lettore a chiedersi se siamo arrivati
non solo. Infatti uno dei pregi del li- ad una fase storica in cui i partiti non
bro è proprio quello di costruire con sono più essenziali alla fisiologia de-
meticolosità un’analisi che trascende mocratica e se gli stessi cittadini stia-
le tendenze empiricamente acclarate no vivendo una fase di riflusso verso
nei paesi dell’Europa occidentale, per la dimensione privata e individuale.
essere applicata anche ad altri contesti La democrazia può funzionare senza
come quelli delle nuove democrazie i partiti? O meglio, quale genere di
dell’Europa orientale o del continen- partiti operano nella complicata real-
te americano. Questo articolo ha però tà della democrazia contemporanea,
l’ambizione, partendo dallo spunto sempre più vittima della disaffezione
fornito dal volume di Mair, di non dei cittadini?
limitarsi ad una semplice recensione I partiti che governano le nostre de-
del testo ma di affrontare in modo mocrazie sembrano sempre più parti-
analitico i temi proposti dallo studio- ti senza “un popolo”, organizzazioni
so irlandese che si confronta con temi ormai incapaci di adempiere a quella
delicati per il futuro delle nostre de- funzione di collegamento tra politica
mocrazie. istituzionale e partecipazione/inte-
Il libro si concentra in particolare sul resse popolare. Citando il lavoro di
tema del declino della partecipazione Schattschneider The semi sovereign
popolare, visto tramite la lente della people(2), che si interroga su quan-
trasformazione dei partiti di massa ta parte del processo decisionale in
e del vuoto che questo cambiamento politica sia effettivamente controlla-
ha creato nelle società e nei sistemi bile dal singolo cittadino, sia a cau-
politici europei, soffermandosi poi sa dell’opacità dei processi di policy
su come questo vuoto venga attual- making sia per la loro complessità(3),
mente riempito dai partiti populisti
(una parte del testo che purtroppo è (2)
Elmer E. Schattschneider, The
solo abbozzata ma che avrebbe meri- semi-sovereign people. A realist’s view of
tato maggiore esaustività). Infine, ma democracy in America, Wadsworth, New
York, 1960.
non per importanza, Mair affronta il (3)
Il tema del controllo popolare sul pro-
tema scottante dell’Unione Europea cesso decisionale, in tutte le sue forme, è
e dell’integrazione sovranazionale, sterminato ed è alla base di ampi dibat-
di come questo passaggio politico ab- titi dato che molti studiosi tendono ad
bia alimentato questo allontanamento individuare la qualità del governo con la
congruenza rispetto alle preferenze degli
dalla politica e di come stia svuotando elettori, ossia con la cosiddetta responsi-
i nostri sistemi democratici. veness. Cfr. Robert S. Erikson, GeraldLA CRISI DEI PARTITI E LA DE-POLITICIZZAZIONE DELLO SPAZIO POLITICO 149
Mair si domanda se ormai anche la Le dimensioni rappresentanza, re-
semplice semi-sovranità non sia altro sponsiveness e accountability e il
che una chimera. modo in cui interagiscono tra loro per
Il concetto di semi-sovranità ci con- tramite dei partiti politici ci dicono
duce al primo tema sul tappeto, ossia molto di come funziona una democra-
quali forme può assumere il rapporto zia, di come è costruito il rapporto tra
tra governati e governanti, una rela- cittadini e istituzioni e qual è la fisio-
zione che tendenzialmente vede al logia della competizione politica nel
centro proprio i partiti politici come mercato elettorale; insomma, di come
organizzazioni in grado di fornire da si articola concretamente il rapporto
una parte rappresentanza e dell’altra tra politica e cittadini.
accountability. Questi due elementi Uno degli elementi che secondo Mair
sono diventati sempre più connessi più influisce sulle modalità di questo
nella politica democratica(4) e sembra rapporto è il grado di indifferenza del
complicato solo pensare di poterli demos verso la politica – e la demo-
scindere, pena un calo effettivo nel crazia –, che può essere considerato
rendimento democratico del sistema. dannoso quanto l’ostilità palese verso
A questo va aggiunta la funzione di ri- la politica – e i politici – perché l’a-
spondenza, o responsiveness, da parte patia tendenzialmente colpisce una
dei governanti rispetto alle domande, porzione molto più ampia di cittadini.
alle preferenze e agli input provenien-
ti dalla società e che la politica do- tologica sul rapporto tra preferenze degli
vrebbe essere poi in grado di tradurre elettori e rispondenza dei partiti rispetto
a tali input è sterminata, mi limito quindi
in output(5). a segnalare solo alcuni lavori che hanno
posto particolare enfasi sull’importan-
C. Wright e John P. McIver, Statehouse za di tale legame per il funzionamento
Democracy: Public Opinion and Policy della democrazia. Cfr. Anthony Downs,
in the American States, Cambridge, An Economic Theory of Democracy,
Cambridge University Press, 1993; John New York, HarperCollins, 1957; Robert
Matsusaka, Popular Control of Public A. Dahl, Polyarchy, Participation
Policy: a Quantitative Approach, in « and Opposition, New Haven, CT, Yale
Quarterly Journal of Political Science», University Press, 1971; Jeffrey E. Cohen,
V, 2010, pp. 133-67. Presidential Responsiveness and Public
(4)
Sul rapporto tra rappresentanza e account- Policy Making, Ann Arbor, University
ability cfr. tra gli altri: Hanna F. Pitkin, of Michigan Press, 1997; Sara B. Hobolt
The Concept of Representation, Berkeley, e Robert Klemmensen, Government
University of California Press, 1967; Responsiveness and Political
Johannes Pollak, Contested Meanings Competition in Comparative Perspective,
of Representation, in «Comparative in « Comparative Political Studies»,
European Politics», V, 2007, pp. 87-103; XXXXI, 2008, 3, pp. 309-337; Richard
Nadia Urbinati e Mark E. Warren, Rose, Responsible Party Government in
The Concept of Representation in a World of Interdependence, in Luciano
Contemporary Democratic Theory, in Bardi, Stefano Bartolini e Alexander
«Annual Review of Political Science», H. Trechsel (a cura di), The Role of
XI, 2008, pp. 387-412. Parties in Twenty-First Century Politics,
(5)
Anche in questo caso la letteratura poli- New York, Routledge, 2015, pp. 21-37.150 EUGENIO SALVATI
Il combinato disposto di indifferen- crazia costituzionale e democrazia
za e ostilità, conduce ad una sorta di popolare.
alienazione del cittadino dalla sfera L’idea è che esistano due dimensioni
pubblica; cittadino che considera lo democratiche separate ma collega-
spazio politico sempre più estraneo te, ossia da un lato si trova lo spazio
alla sua individualità e spesso anche definito dall’insieme delle istituzioni,
ai suoi interessi, ed è portato a vede- dalle regole del gioco e dalle garanzie
re i partiti come strumenti obsoleti e costituzionali, mentre sull’altro ver-
funzionali alla perpetuazione degli sante si trova la dimensione democra-
interessi di un determinato strato del- tica che accentua il ruolo del popolo e
la società, ossia della classe politica. la partecipazione dei cittadini.
Considerando la tripartizione pro- Nella nostra democrazia queste due
posta da Katz e Mair rispetto all’or- dimensioni hanno vissuto in perfetto
ganizzazione partitica che vede la equilibrio grazie al ruolo dei partiti di
distinzione tra partito nella società, massa, facendo sì che fosse garantito
partito come organizzazione centrale il pieno funzionamento democratico
e partito nelle istituzioni(6), sembre- tramite l’interazione tra istituzioni,
rebbe che agli occhi dei cittadini sia la norme e partecipazione popolare.
terza faccia ad avere avuto il soprav- Secondo Mair queste due dimensio-
vento, facendo saltare l’equilibrio tra i ni si stanno sempre più divaricando
tre aspetti che sembra essere essenzia- portando alla separazione tra prassi
le affinché i partiti non smarriscano il e regole democratiche e coinvolgi-
loro ruolo articolato e complesso di mento popolare, conducendo così, nei
collegamento tra masse e istituzioni. fatti, ad un modello di democrazia
In questo quadro il punto di cadu- formale basata sul rispetto dei diritti
ta è rappresentato dal rifiuto sempre individuali (politici, civili e sociali).
più marcato dei cittadini verso quella Il rafforzamento e la centralità date
che Mair definisce come la politica alle sulle strutture formali, fa sì che
convenzionale, fatta dal circuito par- ci sia una parte del circuito politico
titi, istituzioni e personale politico. che, per reazione, pone l’accento sulla
Un versante che a sua volta sembra necessità di procedere verso una for-
sempre meno capace, almeno nei suoi ma democratica fondata sul primato
interpreti più tradizionali, di riportare popolare e che assume la forma della
al centro della scena politica il demos. democrazia populistica di cui parlava
Qui Mair enuclea il primo passaggio Dahl(7).
fondamentale nell’economia della sua
tesi, ossia il ricorso alla diade demo- (7)
Sul tema del governo da parte d el po-
polo e l’accento posto sulla suprema-
(6)
Richard Katz e Peter Mair, The zia del demos – o dell’ethnos a seconda
Evolution of Party Organizations in dell’enfasi posta sul popolo come citta-
Europe: The Three Faces of Party dinanza o come comunità nazionale – ri-
Organization, in «American Review of mando ad alcuni lavori particolarmente
Politics», XIV, 1993, pp. 593-617. illuminanti. Robert A. Dahl, The PastLA CRISI DEI PARTITI E LA DE-POLITICIZZAZIONE DELLO SPAZIO POLITICO 151
Questo è il contesto che stimola il razionalità tecnocratica; una crisi che
ricorso a forme di rappresentanza a sua volta alimenta prepotentemente
antipolitica (o sarebbe meglio dire questo scollamento.
antipartitica) come quella populista Nel momento in cui i partiti non sono
che vede nel ricorso alle virtù del po- più in grado di svolgere il loro ruolo
polo la sola alternativa possibile per da tramite tra cittadini e istituzioni
democrazie vittime delle élites, con perché non sono più radicati nella so-
movimenti populisti che eticizzano cietà ma solo nelle istituzioni, entra
la distinzione tra masse e gruppi di- in crisi il buon funzionamento di ele-
rigenti, con le prime considerate come menti cardine delle democrazie come
un unicuum e corpo della nazione, e il coinvolgimento elettorale e l’ac-
le seconde considerate come un cor- countability. La rappresentanza degli
po estraneo rispetto alla nazione stes- interessi diffusi cede il posto a quella
sa(8). Speculare a questa visione, come degli interessi particolari e organizza-
scrive Caramani, è l’approccio tecno- ti, e la responsiveness si trova sempre
cratico alla politica che vede lo svuo- più in tensione con la responsibility(10),
tamento di aspetti come quello della ossia con la necessità che hanno i po-
responsiveness e dell’accountability, litici di non rispondere semplicemen-
in virtù di un’idea per cui sono le élit- te alle domande a breve termine degli
es a sapere cosa è giusto e preferibile elettori ma di tenere in considerazione
per gli interessi della nazione(9). i bisogni di medio – lungo periodo e
All’interno di questo quadro, segnato le richieste esterne, ossia le domande
dallo scollamento tra procedure/ga- provenienti dai mercati, dagli attori
ranzie costituzionali e partecipazione/ internazionali e – nel caso di molti pa-
ruolo dei cittadini, si può comprende- esi europei – dall’UE.
re la crisi strutturale dei partiti che si L’indebolimento dei partiti ha quin-
trovano stretti tra illusione populista e di un’influenza sul rendimento delle
istituzioni democratiche e sulla forma
and Future of Democracy, paper n. 5, della democrazia, dato che la demo-
Centro Interdipartimentale di Ricerca crazia è impensabile senza l’apporto
sul Cambiamento Politico, Università di strutturale dei partiti, che garantisco-
Siena, 1999; Yves Mény e Yves Surel (a
no trasparenza, competizione politica
cura di), Democracies and the Populist
Challenge, Palgrave, Basingstoke, 2002; (all’interno di un contesto di libere
Pierre A. Taguieff, L’illusion Populiste, elezioni), accesso alle cariche e rap-
Paris, Berg International Editeurs, 2002: presentanza(11). Ecco da dove sorge
trad. it., L’illusione populista, Milano,
Bruno Mondadori, 2003.
(8)
Daniele Caramani, Will vs Reason: (10)
Luciano Bardi, Stefano Bartolini e
The Populist and Technocratic Forms Alexander H. Trechsel, Responsive
of Political Representation and Their and Responsible? The Role of Parties in
Critique to Party Government, in Twenty-First Century Politics, in Luciano
«American Political Science Review», Bardi, Stefano Bartolini e Alexander
CXI, 2017, pp. 54-67. H. Trechsel (a cura di), op. cit., pp. 1-18.
(9)
Daniele Caramani, op. cit. (11)
Richard Katz e William Crotty,152 EUGENIO SALVATI
la preoccupazione di Mair: ci stiamo dei cittadini, al collegamento politi-
spostando verso forme nuove di de- co tramite i partiti e il sistema della
mocrazia? Verso un assetto diverso diade rappresentanza-accountability,
nell’equilibrio dei poteri e nella distri- per piegarsi tutto sulla dimensione
buzione dell’autorità? dell’output, ossia sulla bontà delle po-
L’approdo ad una nuova nozione di litiche prodotte, così come teorizzato
democrazia fondata su una diversa da Scharpf per l’Unione Europea(13).
fonte di legittimità, non più legata al Qui emerge con forza l’annoso tema
consenso e alla partecipazione – alla del contrasto tra conoscenza e politica
sovranità popolare – perché i cittadini e del confronto tra tecnici e politici;
si chiudono nel privato e i partiti si as- il confronto tra un’idea di società che
serragliano nelle istituzioni, è diven- tendenzialmente si guida da sola e si
tata secondo Mair più che una remota affida a chi dispone di conoscenze
eventualità. tecniche per compiere scelte com-
A tal proposito Mair pensa evidente- plesse(14), e invece un’idea di società
mente alla funzione delle istituzioni compenetrata dalle organizzazioni
non-maggioritarie, concetto a cui si è politiche, con queste ultime a cui sono
affidato Majone per spiegare il ruolo devolute la gestione del governo e le
sempre più preponderante delle élites scelte politiche rilevanti. Il contrasto
tecnocratiche e dell’UE. Il ruolo di è quindi tra democrazia (e istituzioni)
tali istituzioni è legato alla necessità de-politicizzata contro democrazia
di potenziare la capacità decisiona- politicizzata; o se si preferisce, per
le e l’efficacia realizzativa puntando usare un gergo ormai caro alla scienza
alla de-politicizzazione e favorendo il politica, è il contrasto tra governance
rafforzamento, per l’appunto, di istitu- e government.
zioni non-maggioritarie come quelle Un contrasto in cui potrebbero però
sovranazionali, rafforzando quello farsi largo forme ancora più ibride,
che Majone ha definito lo Stato Rego- modelli in cui alla preminenza della
latore(12). La legittimità delle istituzio- conoscenza e della tecnica, si possono
ni politiche perde la sua componente associare degli aspetti plebiscitari utili
legata agli input, ossia alle richieste a paventare una patina di consenso e
di parziale mobilitazione diffusa, utile
Introduction, in Richard Katz e William a coprire un governo decisamente più
Crotty (a cura di), Handbook of Party
Politics, London, Sage, 2006, pp. 1-4.
(12)
Giandomenico Majone, The Rise of the (13)
Fritz W. Scharpf, Games Real Actors
Regulatory State in Europe, in «West Play, Boulder, Westview, 1997; Id.,
European Politics», XVII, 1994, pp. 77- Governing in Europe, Oxford, Oxford
101; Id., Regulating Europe, London, University Press, 1999; Vivienne
Routledge, 1996; Id., Deficit democra- Schmidt, Democracy and legitimacy
tico, istituzioni non maggioritarie ed il in the European Union revisited: input,
paradosso dell’integrazione europea, output and throughput, in «Political
in «Stato e Mercato», LXVII, 2003, pp. Studies», LXI, 2013, pp. 2-22.
3-38. (14)
Daniele Caramani, op. cit.LA CRISI DEI PARTITI E LA DE-POLITICIZZAZIONE DELLO SPAZIO POLITICO 153
sbilanciato verso la dimensione teco- Per quel che concerne la disaffezione
nocratico/burocratica. popolare verso gli strumenti della po-
litica, Mair si sofferma su tre indicato-
ri per valutare, con metodo comparato,
2. La fine del coinvolgimento popo- cosa sta accadendo nelle democrazie
lare europee. Il primo indicatore è quella
della partecipazione elettorale. Il dato
Al centro dell’analisi che compie Mair che emerge dalla ricerca empirica è
in questa sezione del libro, c’è il tema che a partire dagli anni Novanta si è
dello svuotamento sostanziale dello avuto un calo del voto, seppure con-
spazio politico tra partiti e cittadi- tenuto, in tutte le grandi democrazie
ni, ossia quello spazio dove avviene europee. L’elemento più interessan-
l’interazione tra politica e società. Il te non è dato tanto dalla consistenza
luogo in cui, teoricamente, i partiti nell’incremento del tasso di astensio-
dovrebbero raccogliere domande, so- ne, quanto piuttosto il fatto che questo
stegno e offrire rappresentanza, rispo- è un dato generalizzato nelle grandi
ste ed essere accountable. Ma è anche democrazie occidentali, che comincia
lo spazio della competizione politica e in un ben preciso momento storico ed
del conflitto, quel mercato elettorale(15) è costante nel tempo, delineando così
dove gli imprenditori politici dovreb- un trend ben consolidato. Mair spiega
bero “collocare il loro prodotto”, ossia questo calo con diverse ipotesi tra cui,
offrire delle risposte alle domande del oltre al più ovvio venir meno del voto
cittadino – elettore, mobilitando così di appartenenza veicolato dai grandi
il consenso. partiti di massa e costruito attorno ad
Come spiega Mair, lo svuotamento di ideologie forti, il peso di una nuova ge-
questo spazio avviene in due direzio- nerazione che tende ad essere estranea
ni: da una parte i cittadini rifiutano il ai processi elettorali e di partecipazio-
modello politico tradizionale, abban- ne. Questo spiegherebbe anche il dato
donano la partecipazione e i partiti, dell’aumento costante dell’astensione
spinti dalla sfiducia, dall’ostilità o dal dato il peso elettorale crescente nel
disinteresse, mentre dall’altra parte i corpo elettorale di queste nuove gene-
leader politici si chiudono all’interno razioni poco propense alla partecipa-
delle istituzioni, seguendo il modello zione. L’altro elemento è quello della
del cartel party, ossia l’occupazione scarsa salienza delle issue in gioco;
delle istituzioni associata ad una bas- come scrive Franklin la partecipazio-
sa competizione inter-partitica(16). ne difficilmente può essere slegata dal
peso e dal valore dei temi sul piatto,
(15)
Renato Mannheimer e Giacomo Sani, Il non potendo considerare tutte le issue
mercato elettorale. Identikit dell’elettore come uguali, oppure che i program-
italiano, Bologna, Il Mulino, 1987.
(16)
Richard Katz e Peter Mair, Changing
Models of Party Organization and Party Party, in «Party Politics», I, 1995, 1, pp.
Democracy: the Emergence of the Cartel 5-28.154 EUGENIO SALVATI
mi politici possano essere realmente l’affidarsi con maggior propensione
slegati da un qualsivoglia ancoraggio al voto “casuale”. In questa situazione
valoriale(17). In questo caso, seguendo gli elettori diventano più contendibili,
la tesi della de-politicizzazione a cui definendo così un mercato elettorale
pensa Mair, appare difficile che temi in cui risulta più interessante e pro-
importanti tornino prepotentemente ficuo per nuovi imprenditori politici
sulla scena perché i partiti mainstre- affacciarsi sulla scena, una condizio-
am sono poco interessati a politicizza- ne che alimenta il deallineamento nei
re issue altamente conflittuali, il che sistemi partitici: questo è il caso, ad
alimenta, di fatto, l’indebolimento dei esempio, dell’irruzione vincente dei
partiti tradizionali. nuovi partiti populisti.
L’altro indicatore individuato da Mair Direttamente legato all’alta volatili-
è quello dell’instabilità elettorale, os- tà, troviamo l’indicatore della fedeltà
sia il livello di stabilità nelle prefe- partitica, che misura il senso di appar-
renze politiche degli elettori. Questo tenenza e di vicinanza a determinati
indicatore misura il tasso di volatilità partiti politici. La diminuzione della
elettorale, quindi il livello di cambia- fedeltà ad un partito e quindi il calo
mento nelle scelte partitiche espresse nel voto di appartenenza, segnala la
dagli elettori al momento delle elezio- fine di dinamiche di voto rigide e, as-
ni. Il dato rilevato da Mair è che anche sociato all’alta volatilità, dimostra che
in questo caso, è a partire dagli anni gli elettori sono molto più disposti a
Novanta che si registra un aumento nel valutare tutto l’ampio spettro di pro-
tasso di volatilità elettorale (in media poste elettorali che si trovano dinanzi
del 10%), distribuito quasi egualmen- al momento del voto. Come sottolinea
te nelle grandi democrazie europee, Mair, questo si associa inevitabilmen-
anche in questo caso in modo costan- te a scelte fatte sempre più a ridosso
te nel tempo. Questo tasso di volati- del giorno delle elezioni, elemento
lità fa sì che le scelte elettorali siano che aumenta il tasso di imprevedibi-
difficilmente prevedibili e alquanto lità elettorale (come ci dimostrano i
incostanti, risultando più suscettibili recenti e reiterati fallimenti dei son-
all’influenza di diversi fattori. La vo- daggi pre-voto), e individua un’altra
latilità diventa quindi un’altra faccia forma di allontanamento rispetto ad
dell’insoddisfazione verso la politica un coinvolgimento politico più inten-
tradizionale che se per alcuni si tra- so, strutturato e stabilizzato.
duce nel rifugio nel non voto, per altri Il calo della fedeltà partitica si associa
diventa la ricerca del cambiamento, quindi ad una notevole diminuzione
nel tasso di adesione ai partiti, con
(17)
Mark Franklin, The Dynamics of una contrazione vistosa nella platea
Electoral Participation, in Lawrence dei iscritti alle grandi organizzazioni
LeDuc, Richard G. Niemi e Pippa Norris di massa (un dato che riguarda anche
(a cura di), Comparing Democracies 2:
New Challenges in the Study of Elections altri corpi intermedi come i sindacati
and Voting, London, Sage, pp. 148-67. e le grandi associazioni di categoria).LA CRISI DEI PARTITI E LA DE-POLITICIZZAZIONE DELLO SPAZIO POLITICO 155
Se diminuisce la disponibilità ad im- attraverso i partiti, si traduce nella
pegnarsi nell’arena politica è evidente relazione diretta fra leader e opinione
che partecipare attivamente a tutta pubblica attraverso i media. Una rela-
quella serie di attività che definiscono zione a senso unico, in cui vengono
la militanza partitica, diventa un peso veicolati messaggi e spot a cittadini
che i cittadini sono sempre meno di- sempre più spettatori e sempre meno
sposti a sopportare. Anche in questo attori, destinatari di un “prodotto po-
caso il dato è strutturale e coinvolge litico” con il quale difficilmente pos-
tutte le maggiori democrazie europee, sono interagire. Questo nuovo spazio
segnando un trend nell’emorragia di mediatico ingrandisce quindi le ten-
iscritti ai partiti cominciato negli anni sioni scaricate sul governo rappresen-
Novanta, subito dopo la fine della po- tativo e sulla funzione dei partiti, sul
litica ideologica e dei blocchi. loro ruolo di corpi intermedi sempre
L’insieme di questi indicatori ci con- più privati di questa funzione.
sente di capire il livello di disaffezione Colpisce in particolare la data di inizio
dei cittadini nei confronti dei partiti e di questo percorso: gli anni Novanta.
della politica convenzionale e il modo Non casualmente l’inizio di quella de-
in cui i cittadini-elettori si stanno ri- cade è segnato dalla fine della politica
traendo dallo spazio politico. Dai dati ideologica e del mondo diviso in bloc-
presentati da Mair emerge in modo chi, quindi l’avvio dello “spaesamen-
lampante un trend comune e costante to” per la conclusione di esperienze
in quasi tutte le democrazie europee valoriali e ideologiche che offrivano
rispetto all’abbandono della sfera pub- rifugio, sicurezza e identità agli in-
blica. Una forma di exit che concerne dividui. Ed è l’inizio di quella che, in
non solo la militanza attiva nei partiti, uno sforzo interpretativo di fenomeni
ma anche la disponibilità ad impiega- di lungo periodo, è stata definita come
re il proprio tempo per informarsi e/o “la fine della storia”(19); una fine se-
discutere dei temi, più o meno impor- gnata dal presunto trionfo del modello
tanti, che occupano l’agone politico. della democrazia liberale. In realtà,
Un abbandono della politica che si ri- paradossalmente, questi sono gli anni
flette nella destrutturazione dell’elet- in cui abbiamo assistito allo svuota-
torato, con i cittadini che diventano mento della democrazia in termini di
sempre meno attori dei processi po- partecipazione popolare e in cui, con-
litici abbracciando quel cambiamento testualmente, si è raggiunto l’apice nel
che Manin ha definito come la nascita livello di atomizzazione delle società
della democrazia del pubblico(18); la occidentali, con il rafforzamento del
crisi della rappresentanza strutturata ruolo dell’individuo rispetto a quello
(18)
Bernard Manin, The Principles of
Representative Government, Cambridge, (19)
Francis Fukuyama, The End of History
Cambridge University Press, 1997: trad. and the Last Man, New York, Free Press,
it., Principi del Governo rappresentativo, 1992: trad. it., La fine della storia e l’ulti-
Bologna, Il Mulino, 2010. mo uomo, Milano, Rizzoli, 1992.156 EUGENIO SALVATI
della comunità, e di conseguenza con costruite a Bruxelles, istituzioni che
l’indebolimento dei corpi interme- faranno sentire tutto il loro peso tec-
di come modello organizzativo delle nocratico sugli stati nazionali in occa-
comunità. Questa nuova centralità sione delle sfide cominciate nel 2008
dell’individuo posto al centro della con la grande crisi economica.
scena come singolo (utente, consu- La risposta a tale spaesamento è stata
matore, spettatore, produttore ecc...) fornita dai nuovi attori politici, defi-
è stata alimentata anche dal crollo niti tutti genericamente come partiti
delle identità collettive (come pro- populisti in una notte in cui tutte le
dotto dell’ideologia, della religione, mucche sono nere, che ottengo sem-
dell’appartenenza nazionale, ecc...), di pre più successo grazie alla loro capa-
cui si è cominciato a percepire plasti- cità di dare rappresentanza a bisogni
camente l’assenza all’indomani dello marginalizzati e nel fornire identità a
scoppio della grande crisi economica, soggetti cresciuti in un sistema basato
che non casualmente è una crisi che su di un individualismo estraniante.
intreccia le crisi del sistema economi- L’identità e l’appartenenza ad una co-
co del capitalismo finanziario, dei re- munità più ampia e ben riconoscibile
gimi democratici e della loro capacità (spesso anche perché messa in con-
di rispondere efficacemente alle nuove trasto con altri gruppi ad es. gli im-
sfide globali, e dei modelli di gover- migrati, le élites, i politici ecc...) sono
nance territoriali e della produzione due beni rientrati prepotentemente al
economica. centro dei sistemi politici occidentali.
Gli anni Novanta sono anche gli anni
del Trattato di Maastricht, del podero-
so rilancio dell’integrazione europea 3. La sfida al governo di partito
sulla base del Mercato Unico e della
costruzione delle basi per approdare Il capitolo inerente la crisi del governo
alla moneta unica, all’inizio del nuovo di partito si apre con una riflessione
secolo. L’illusione che uno spazio eco- sul modo in cui sono cambiati i siste-
nomico comune potesse essere suffi- mi di partito, in particolare per l’affie-
ciente nel tenere insieme paesi diversi volirsi – o il venire meno – della forte
senza il collante definito dall’appar- polarizzazione ideologica sulla quale
tenenza ad uno spazio politico comu- si erano edificati i sistemi di partito
ne(20). Insomma, per utilizzare i con- dell’Europa occidentale nell’ultimo
cetti di Mair, è l’avvio della stagione cinquantennio. In particolare il cam-
della de-politicizzazione incarnata biamento più consistente si è avuto in
dalle istituzioni non-maggioritarie quei partiti che si collocavano nella
parte estrema del continuum politico
(20)
Hagen Schulz-Forberg e Bo Str Åth, destra/sinistra, su posizioni ideologi-
The Political History of European che fortemente polarizzate e che sono
Integration: The Hypocrisy of
Democracy-Through-Market, Abingdon, stati identificati come partiti anti-si-
Routledge, 2010.LA CRISI DEI PARTITI E LA DE-POLITICIZZAZIONE DELLO SPAZIO POLITICO 157
stema(21). Questi partiti hanno ormai co ma anzi, paradossalmente, dicono
rinunciato a proporre un’alternativa di volerlo rivitalizzare rimettendo al
sistemica, ossia un cambio radicale centro della scena politica il popolo
del regime politico nella sua forma e e, in qualche modo, le procedure de-
nei suoi valori politici dominanti(22), mocratiche in grado di incarnarne la
rientrando pienamente nell’alveo del- volontà(24).
la competizione interpartitica di tipo Sul tema dell’integrazione sovrana-
sistemico, dove i partiti tendono a dif- zionale, questi partiti di destra si col-
ferenziarsi più che altro per la loro po- locano su posizioni dichiaratamente
sizione centrale o periferica rispetto euroscettiche perché vedono l’UE
alla possibilità di formare un governo come strumento di indebolimento del-
oppure per la loro genesi e organiz- la sovranità nazionale e quindi di mar-
zazione (cito ad esempio i partiti mo- ginalizzazione dei cittadini(25). In par-
vimento o i partiti personali)(23). Sia a te questa critica è condivisa anche da
destra che a sinistra non abbiamo più alcuni partiti di estrema sinistra, che
partiti che si rifanno a dottrine poli- attaccano l’UE come prodotto dell’i-
tiche strutturate per proporre una ra- deologia neoliberista(26), che avrebbe
dicale alternativa di sistema, quanto come scopo ultimo la marginalizza-
piuttosto vediamo imprenditori politi- zione del popolo e della sua volontà:
ci che utilizzano un linguaggio e una su questo punto, la critica alla margi-
forma di comunicazione populista, nalizzazione del ruolo dei cittadini e
in varianti di destra e di sinistra, per della volontà popolare, c’è un chiaro
ri-mobilitare quegli elettori che sono punto di contatto tra i populismi di
usciti dallo spazio politico e dal mer- destra e sinistra.
cato elettorale. Il depotenziamento della carica an-
Ad esempio è il caso dei partiti di ti-sistemica ha fatto sì che questi par-
estrema destra cresciuti negli ultimi titi moderassero le loro richieste, oc-
anni, i quali incarnano istanze nazio- cupando uno spazio elettorale ben più
naliste, identitarie e a tratti xenofobe ampio, avvicinandosi così ai partiti
ma che, nei fatti, non si propongono
come nemici del sistema democrati- (24)
Piero Ignazi, The Silent Counter-
Revolution. Hypotheses on the
Emergence of Extreme Right-Wing
(21)
Giovanni Sartori, Parties and Party Parties in Europe, in «European Journal
Systems. A Framework for Analysis, of Political Research», XXII, 1992, pp.
Cambridge, Cambridge University Press, 3-34; Cas Mudde, Populist Radical
1976. Right Parties in Europe, Cambridge,
(22)
Sul tema del regime politico e in senso più Cambridge University Press, 2007;
ampio della struttura politica, rimando a Catherine E. De Vries e Erika Edwards,
Mario Stoppino, Potere e teoria politica, Taking Europe to Its Extremes: Extremist
Milano, Giuffrè, 2001. Parties and Public Euroscepticism, in
(23)
Sul tema dei partiti, dei loro model- «Party Politics», XV, 2009, pp. 5-28.
li e delle loro organizzazioni rimando (25)
Piero Ignazi, op. cit.; Cas Mudde, op. cit.
all’esaustivo manuale curato da Katz e (26)
Catherine E. De Vries e Erika Edwards,
Crotty, op. cit. op. cit.158 EUGENIO SALVATI
tradizionali. Paradossalmente il tema elettorali, il calo della polarizzazione
della carica anti-sistema potrebbe es- ideologica e la contestuale maggiore
sere collocato nell’arena sovranazio- contendibilità dell’elettorato, hanno
nale, dove questi partiti hanno invece contribuito ad aumentare il numero di
una posizione più radicale, ossia pre- partiti potenzialmente coalizionabili e
dicano e si adoperano per la fine del ha reso la prospettiva della conquista
processo d’integrazione e per la di- del governo, un orizzonte allargato a
struzione dell’UE(27). tutti i partiti dell’arco istituzionale.
Contestualmente a questa dinamica, Se a questo aggiungiamo che i nuovi
i partiti mainstream hanno avviato partiti populisti e avversari della poli-
una sorta di ritirata dalla società per tica convenzionale stanno aumentan-
trincerarsi negli spazi della politica do esponenzialmente i loro consensi
istituzionale. La politica delle frat- grazie alla sempre minore diversità
ture sociali sembra ampiamente in valoriale e programmatica dei partiti
crisi e alla polarizzazione ideologica tradizionali che non sono più in grado
è subentrata la depoliticizzazione, di essere alternativi tra loro, capiamo
quella che nel libro Mair indica a più come i sistemi di partito siano sogget-
riprese come la cifra definitoria dello ti a continue scosse e instabilità.
stato della democrazia in Europa. Il In particolare è proprio la maggiore
trasferimento di responsabilità verso opacità nelle differenze tra i partiti
le istituzioni non maggioritarie e le mainstream e la tendenziale conver-
istituzioni sovranazionali, garantisce genza delle loro politiche, favorita an-
ai governi non solo la possibilità di che dal ruolo di guardiano dell’UE, ad
prendere decisioni impopolari nelle avere diminuito la capacità di attra-
sedi comunitarie e/o in condivisione zione e di coinvolgimento dei partiti
con le istituzioni sovranazionali, ma rispetto all’elettorato che, come spie-
fornisce anche un utilissimo capro gato precedentemente, si smobilita, o
espiatorio per scelte che non sono ha preferenze estremamente volatili
elettoralmente premianti(28). oppure premia scelte radicalmente al-
Il fatto che i partiti abbiano cominciato ternative.
ad intensificare la competizione verso Proprio quest’ultima eventualità sem-
il centro dell’elettorato, l’indeboli- bra dirci che i partiti, almeno in linea
mento dei tradizionali insediamenti teorica, sono ancora importanti e che
la crisi strutturale contemporanea è
(27)
Eugenio Salvati, Anti-systemic or oppo- più che altro una crisi dei partiti di
sition parties within the EP? The case of
cartello, eredi delle grandi famiglie
the Five Star Movement and Syriza, pa-
per presentato al Convegno “European politiche europee. I partiti non solo
Democracy under Stress”, Università di hanno il compito di promuovere scelte
Torino, 13-14 gennaio 2017. di policy alternative, ma sono anche
(28)
Eugenio Salvati, Il deficit democratico gli unici attori in grado di raccogliere
e il ruolo del Parlamento Europeo. Quali
problemi ancora aperti?, in «Il Politico», e processare preferenze diverse pro-
LXXXI, 2016, pp. 52-83. venienti dalla società; i partiti sonoLA CRISI DEI PARTITI E LA DE-POLITICIZZAZIONE DELLO SPAZIO POLITICO 159
forti e radicati quando sono in grado bile di frazioni di un elettorato sempre
di raccogliere e interpretare gli orien- più segmentato; frazioni che comun-
tamenti e le preferenze delle loro basi que sono portatrici di interessi diversi,
sociali(29). spesso non conciliabili.
Come rileva correttamente Mair, nel Scrive Mair che alla volatilità del voto
momento in cui queste basi sociali si corrisponde in modo abbastanza chia-
sfaldano, in parte perché la società ro anche la volatilità dei partiti, un
tende ad atomizzarsi e i corpi inter- elemento che produce «(...) una com-
medi perdono la capacità di connette- petizione politica ormai caratterizzata
re le varie parti del tessuto sociale, e dalla concorrenza tra partiti che mi-
in parte perché i partiti non riescono rano ad essere socialmente inclusivi e
più a rappresentare tali basi, diventa alla ricerca del supporto di elettorati
complicato raccogliere le preferenze socialmente amorfi»(31).
della società e tradurle in politiche. In questo quadro, come rilevato pri-
Gli stessi partiti perdono la capacità ma, i limiti posti dall’UE tramite i
di costruire piattaforme alternative vincoli rappresentati dai parametri
basate, appunto, su bisogni diversi e economico - finanziari che restrin-
contrapposti. gono i margini di discrezionalità
Nel momento in cui la società si ato- delle politiche realizzabili, rendono
mizza e i partiti non riescono più a complicato differenziare tra partiti e
proporsi come alternativi sulla base di governi, e trasformano il già comples-
una visione della società ben precisa, so modello dell’accountability in un
questi ultimi cercano di raccogliere esercizio quasi impraticabile. Il dato
il consenso più ampio possibile e si rilevante è per Mair il fatto che i parti-
muovono oltre quelli che possono es- ti, avendo come solo e unico orizzonte
sere gli steccati definiti da basi sociali quello del governo, tendono ad essere
diverse e ben delineate, portando al più disponibili, anche nel quadro di
parossismo il modello del partito “pi- competizioni bipolari, a condividere
gliatutti”(30). I partiti cercano di essere l’impegno di governo, i programmi, le
attraenti per il maggior numero possi- agende elettorali e persino gli elettori,
dato che spesso i partiti mainstream
(29)
Hans Keman, Policy-Making Capacities si contendono lo stesso bacino eletto-
of European Party Government, in Kurt rale. Il risultato è che lo spazio politi-
Luther e Ferdinand Müller-Rommel co, in particolare il mercato elettorale,
(a cura di), Political Parties and Political
Development, Princeton, Princeton
non è più l’arena del confronto e del
University Press, 2002, pp. 207-45. conflitto ma l’alveo di una competi-
(30)
Otto Kirchheimer, The Transformation zione a bassissima intensità; una pras-
of the Western European Party Systems, si che inevitabilmente alimenta l’apa-
in Joseph LaPalombara e Myron
Weiner (a cura di), Political Parties
tia elettorale e, come reazione, apre un
and Political Development, Princeton, grande spazio competitivo per nuovi
Princeton University Press, 1966, pp. 177-
200. (31)
Peter Mair, op. cit., p. 63.160 EUGENIO SALVATI
imprenditori dalle posizioni più radi- attentamente in rassegna alcuni ap-
cali. In questo contesto dobbiamo al- procci definitori che, seppur enfatiz-
lora porci la domanda se il populismo zando con maggior attenzione alcune
sia una patologia dei nostri sistemi de- caratteristiche peculiari – per Rose il
mocratici, come tendono ad asserire processo decisionale, per Katz il re-
soprattutto i leader politici dei partiti clutamento del personale di governo
maggiori elettoralmente “assediati” e la distribuzione del patronage e per
da questi nuovi attori, o se l’onda po- Thomassen il ruolo delle elezioni(33)
pulista non sia una sorta di risposta ad –, sostanzialmente condividono l’ap-
una democrazia competitiva che ha proccio e molti tratti definitori. Que-
smesso di essere “competitiva” e che sto consente a Mair di individuare gli
quindi ha visto entrare in crisi uno dei elementi comuni a tutte e tre le defini-
motori principali che ne consentono il zioni e mettere un punto chiarificatore
buon funzionamento. su come definire il modello del gover-
In questo bisogna inserire anche il no di partito.
declino della massima espressione Secondo Mair ci troviamo dinanzi
della capacità dei partiti di governare ad una forma di governo di partito
società e istituzioni, ossia il governo quando: «(...) un partito o un blocco
di partito(32). Nel libro Mair passa di partiti ottiene il controllo dell’ese-
cutivo come risultato di elezioni com-
(32)
La letteratura inerente il governo di petitive; quando i leader politici sono
partito, sia dal punto di vista dell’inqua- reclutati da e attraverso i partiti; quan-
dramento concettuale che dell’analisi do i partiti (principali) o i movimenti
empirica, è ovviamente vasta. Mi limi-
to ad indicare alcuni lavori che hanno
alternativi in competizione offrono
maggiormente contribuito a definirne i agli elettori delle chiare alternative
contorni concettuali, cfr.: Richard Rose, politiche; quando la politica pubblica
The Problem of Party Government, New è determinata dal partito o dai partiti
York, Free Press, 1974; Francis Castles e
Rudolf Wildenmann (a cura di), Visions
che controllano l’esecutivo e quando
and Realities of Party Government, quest’ultimo viene considerato re-
Berlin, De Gruyter, 1986; Richard Katz sponsabile per le sue politiche attra-
(a cura di), Party Government: European verso i partiti»(34).
and American Experience, Berlino, De
Mair passa in rassegna le condizioni
Gruyter, 1987; Mauro Calise, Il Governo
di partito. Antecedenti e conseguenze di indebolimento del governo di parti-
in America, Bologna, Il Mulino, 1989; to, associandole alle debolezze ormai
Jacques Thomassen, Empirical Research
Into Political Representation: Failing
Democracy or Failing Models, in Mark e Maurizio Cotta (a cura di), Party and
Kent M. Jennings e Thomas E. Mann (a Government, London, Macmillan, 1996;
cura di), Elections at Home and Abroad: Jean Blondel e Maurizio Cotta (a cura
Essays in Honor of Warren Miller, Ann di), The Nature of Party Government,
Arbor, Michigan University Press, 1994, New York, Palgrave, 2000.
pp. 237-265; Salvatore Vassallo, Il (33)
Richard Rose, op. cit., Richard Katz, op.
Governo di Partito in Italia (1943-1993), cit., e Jacques Thomassen, op. cit.
Bologna, Il Mulino, 1994; Jean Blondel (34)
Peter Mair, op. cit., pp. 70-71.LA CRISI DEI PARTITI E LA DE-POLITICIZZAZIONE DELLO SPAZIO POLITICO 161
strutturali dei partiti che governano le di cui parlano Poguntke e Webb(36).
democrazie europee. In particolare, I partiti sono sempre più controllati da
se guardiamo alle diverse condizio- singole leadership (più o meno) cari-
ni, possiamo osservare come il tema smatiche, che ne gestiscono in modo
della leadership e della selezione del- centralizzato il funzionamento o ne
la stessa – ma anche, ovviamente, dei sono addirittura proprietari, come nel
quadri intermedi della classe politica caso paradigmatico del partito perso-
– non passa più attraverso lo stretto nale di Berlusconi(37) o del Movimento
controllo partitico, alquanto indeboli- Cinque Stelle di Grillo(38). In questo
to, anche a causa del rapporto sempre contesto i partiti sono ovviamente più
più diretto e meno mediato tra lea- deboli ed organizzativamente incapa-
dership e cittadini(35). I partiti come ci di mettere in campo proposte real-
corpi intermedi non solo tra società e mente alternative, la competizione può
istituzioni, ma anche come strumen- essere accesa seguendo i dettami della
to di collegamento tra consenso e le- democrazia del pubblico di Manin, ma
adership sono sempre meno efficaci, ciò non significa che i programmi e le
ricalcando quel cambiamento che, in policies siano diverse e contrapposte.
chiave sistemica, sta accadendo ai si- Questo porta direttamente alla forma
stemi parlamentari con la cosiddetta del governo di cartello di cui scrivono
presidenzializzazione degli esecutivi, Katz e Mair, che nei fatti indebolisce
una delle condizioni del governo di
(35)
Il tema della leadership e del suo rappor- partito perché mina alle fondamenta il
to con i partiti, le istituzioni, i cittadini concetto stesso di “alternativa”, con-
e il consenso è sterminato e declinato
sotto molteplici punti di vista. Mi li-
tribuendo anche a svuotare di senso la
mito ad elencare alcune letture utili per partecipazione degli elettori al merca-
inquadrare il problema nei termini del to elettorale.
rapporto tra partito e leadership e il ruo- Le stesse politiche pubbliche risento-
lo del primo nel veicolare il consenso.
Cfr. Luciano Cavalli, Il capo carisma-
no di questa condizione di alternativa
tico, Bologna, Il Mulino, 1981; Luciano spesso solo formale, che si somma alla
Cavalli, Governo del leader e regime ben più pressante presenza delle isti-
dei partiti, Bologna, Il Mulino, 1992; tuzioni non – maggioritarie e dell’UE
Sergio Fabbrini, Il principe democra-
che hanno tolto parte sostanziale del
tico, Roma-Bari, Laterza, 1999; Mauro
Calise, Il partito personale, Roma-Bari, controllo della produzione politica
Laterza, 2000; Thomas Poguntke e dalle mani dei governi nazionali, per
Paul D. Webb, The Presidenzialization of spostarne parte in quelle delle agenzie
Politics: a Comparative Study of Modern
neutrali.
Democracies, Oxford, Oxford University
Press, 2005; Fabio Bordignon, Il partito
del Capo. Da Berlusconi a Renzi, Rimini, (36)
Thomas Poguntke e Paul D. Webb, op.
Maggioli, 2013; Eugenio Salvati, Matteo cit.
Renzi: a New Leadership Style for the (37)
Mauro Calise, Il partito personale, cit.
Italian Democratic Party and Italian (38)
Piergiorgio Corbetta e Elisabetta
Politics, in «Modern Italy», XXI, 2016, Gualmini (a cura di), Il Partito di Grillo.
pp. 7-18. Bologna, Il Mulino, 2013.162 EUGENIO SALVATI
Con condizioni strutturali di queste in questi anni, segmentando il campo
tipo è inevitabile che anche l’ultimo politico in modo da renderlo estrema-
dei criteri del governo di partito, os- mente particolarizzato e frammenta-
sia quello dell’accountability, venga to, con partiti talmente deboli da non
meno, destinato a crollare sotto i col- essere in grado di fare sintesi e fun-
pi di una competizione tra alternative gere da collettore di queste molteplici
sempre più offuscate e dallo sposta- domande sociali.
mento di alcune competenze verso un Questo per Mair dimostra come le
centro politico sovranazionale che per condizioni base del governo di partito
come è strutturato risulta scarsamente siano minate e come secondo lui stia-
accountable(39). no acquisendo peso altre forme di go-
Mair spiega convincentemente che verno che, citando Rose, individua nel
queste condizioni si sono progressi- governo per inerzia e nel governo am-
vamente indebolite perché si è inde- ministrativo(41). A queste forme è giu-
bolito un prerequisito alla base del sto aggiungere quella dell’UE che non
funzionamento del sistema, ossia la sostituisce direttamente il modello di
contrapposizione fondata su di una governo nazionale ma gli si affianca e,
singola dimensione ideologica. Nel nei fatti, lo svuota di parte delle sue
momento in cui sono rientrate in gio- competenze. Lo Stato Regolatore eu-
co più fratture al posto della singola ropeo non è in grado di compiere po-
divisione destra/sinistra, è diventato litiche estrattive e redistributive, e per
complesso per i partiti garantire ai di più limita anche i governi naziona-
cittadini rappresentanza e accounta- li nell’espletare al meglio queste due
bility realmente efficaci. Per garantire funzioni, che invece sono fondamen-
rappresentanza, controllo popolare e tali nel definire i compiti dello stato
messa in atto di politiche pubbliche moderno. I governi nazionali hanno
realmente alternative è necessaria una minori risorse e libertà di manovra
«sorta di chiarezza che è intrinseca- e trovandosi dinanzi a processi poli-
mente non disponibile in un conte- tici sempre più complessi da gestire,
sto multidimensionale»(40). Conclude tendono ancora di più a delegare – in
Mair che solo la vecchia frattura de- modo più o meno volontario - respon-
stra/sinistra era in grado di rendere sabilità alla struttura sovranazionale
conto di questa complessità e garan- dell’UE, o per l’appunto al modello di
tire un punto di riferimento stabile e governance incarnato dalle agenzie,
chiaro, data la sua elasticità nell’as- dalle authority e dalle istituzioni non
sorbire altre fonti di conflitto – centro/ maggioritarie.
periferia, fede/secolarizzazione, città/
campagna – che invece sono riesplose
(41)
Richard Rose, The Variability of Party
(39)
Eugenio Salvati, Il Deficit Democratico Government: a Theoretical and Empirical
e il Ruolo del Parlamento Europeo, cit. Critique, in «Political Studies», XVII,
(40)
Peter Mair, op. cit., p. 76. 1969, pp. 413-45.LA CRISI DEI PARTITI E LA DE-POLITICIZZAZIONE DELLO SPAZIO POLITICO 163
4. Il disimpegno delle élites che portò nell’arena pubblica le grandi
masse organizzandone la partecipa-
Abbiamo visto come al centro della zione politica.
tesi di Mair ci sia l’idea dello svuota- In questo modo le divisioni sociali
mento dello spazio politico: uno svuo- hanno contribuito a formare le identi-
tamento che avviene con l’abbandono tà partitiche e hanno permesso ai par-
della sfera pubblica da parte dei citta- titi di portare domande e istanze nel
dini ma anche con il disimpegno della sistema politico; domande ovviamen-
classe politica. Ed è di questo secondo te organizzate all’interno di un corpo
elemento che tratteremo ora. dottrinario e valoriale strutturato e
Precedentemente ho cercato di porre in grado di fornire ai propri aderenti
l’attenzione sull’importanza delle basi una visione del mondo ordinata, or-
sociali definite come essenziali nel ganizzata e onnicomprensiva. Questo
percorso di rafforzamento dei partiti scambio intenso tra partiti e società ha
all’interno della politica di massa. Di quindi garantito ai partiti e alle loro
fatto le solide comunità politiche rap- élites di avere delle «reti indipenden-
presentate dai partiti politici organiz- ti di fedeltà partitiche»(43) sulle quali
zati e strutturati, si reggevano su co- mobilitare il consenso elettorale e la
munità sociali definite al cui interno partecipazione politica attiva.
gli individui condividevano tutta una Questo sistema organizzativo permet-
lunga serie di esperienze non stretta- teva un elevatissimo livello di rappre-
mente politiche ma personali e sociali. sentatività a scapito di una maggior
Questi momenti della vita individuale capacità espansiva nell’elettorato, ed
erano organizzati non semplicemente un alto grado di accountability della
dai partiti ma da organizzazioni come classe politica: questo perché i parti-
i sindacati, le chiese o i centri sociali; ti dovevano rappresentare delle classi
quasi tutte strutture che erano in lega- sociali ben definite, degli interessi e
me diretto e persino simbiotico con i dei bisogni chiari e dovevano quindi
partiti tanto da esserne, in alcuni casi, rendere conto a questi gruppi delle
delle affiliazioni dirette. Questa strut- scelte politiche fatte. Un modello che
tura permetteva ai partiti di massa di ha nei fatti implementato la legittimità
penetrare la società in modo capillare dei partiti di massa ma anche dell’am-
e organizzato, di seguire i suoi iscritti biente istituzionale nel quale erano
in un percorso che andava, realmente, chiamati ad operare.
dalla culla alla tomba. Tale insieme Il primo elemento che ha scardinato
di rapporti organizzati e di compe- questo modello è quello dell’emer-
netrazione tra basi sociali fortemente sione del partito pigliatutti, che aveva
identificate e partiti, definì il modello l’ambizione di espandersi nel corpo
del partito ad integrazione sociale(42), elettorale indebolendo il versante del-
(42)
Sigmund Neumann, Modern Political Press, 1956.
Parties, Chicago, University of Chicago (43)
Peter Mair, op. cit., p. 85.Puoi anche leggere