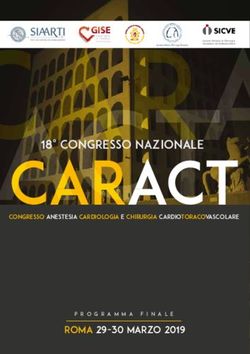Il neonato con grave cerebropatia: dopo la TIN quale trattamento?
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Bosisio Parini 11 ottobre 2008
Il neonato con grave cerebropatia:
dopo la TIN quale trattamento?
Anna Cavallini, Rosario Montirosso,
Renato Borgatti
R
Reparto
t di NNeuropsichiatria
i hi t i e N
Neuroriabilitazione
i bilit i
Età Evolutiva - IRCCS E. Medea - Bosisio PariniIl neonato con grave cerebropatia, a lungo accolto in una TIN,
prima di tornare a casa può aver bisogno di un periodo di
ricovero in una struttura ospedaliera che si proponga come
“realtà intermedia” tra la terapia intensiva e il territorio.
Il ricovero presso il nostro reparto trova indicazione per :
1. Valutazione ed avvio trattamenti in ambito neuromotorio, neurovisivo,
psicosensoriale.
psicosensoriale
2. Valutazione e trattamento complicanze neurologiche (es. epilessia).
3 Valutazione e impostazione programma alimentare (svezzamento
3. (svezzamento,
sondino, PEG).
pp gg e sostegno
4. Appoggio g alla coppia
pp g genitoriale.1 Alcune riflessioni come “cornice teorica” su cui inserire la
1.
nostra attività
1 Tra
1. T contenimento
t i t ed
d espulsione,
l i pensiero
i ed
d azione.
i
2. Il Modello di regolazione reciproca (MRM)
2. La nostra breve esperienza raccontata ripercorrendo i
momenti del ricovero:
1. L’ingresso
2 La
2. L permanenza ((valutazioni
l t i i e ttrattamenti)
tt ti)
3. Le dimissioni
3. Alcune considerazioni per concludere1.1 mente e pensiero
Per Bion la mente umana nei confronti di
emozioni, pensieri, esperienze che la
attraversano è in grado di recepire messaggi e
tollerare frustrazioni assorbendoli e
metabolizzandoli in una sorta di digestione
psicologica
i l i senza attivarei processii espulsivi
l i i di
tipo
p proiettivo
p legati
g alle ansie persecutorie.
p
funzione del “contenimento”1.1 mente e pensiero
Viceversa in condizioni di stress psichico
p
possono prevalere modalità di funzionamento
della mente caratterizzate dalla
frammentazione dei messaggi, delle emozioni
e dei pensieri che la attraversano
attraversano.
In questa condizione nessuna sofferenza
psichica può essere tollerata ma deve essere
immediatamente espulsa e proiettata
all’esterno1.1 mente e pensiero
In questa condizione qualunque messaggio
proveniente dal mondo esterno perde le sue
caratteristiche complessive mantenendo
soltanto quegli aspetti settoriali consonanti con il
mondo interno e con le esigenze persecutorio-
proiettive
i i d dell soggetto.1.1 mente e pensiero
Per Bion è possibile il passaggio da uno
stato mentale all’altro e ogni individuo
compie questo percorso con modalità e
caratteristiche che variano da soggetto a
soggetto
tt e, per lo
l stesso
t soggetto,
tt a
seconda dei vari momenti in cui si trova ad
agire e delle condizioni di stress emozionale
che deve affrontare.1.1 mente e pensiero
La condizione di nascita pretermine
pretermine, la
presenza di una grave cerebropatia, il lutto per
il bi
bimbo
b ttanto
t atteso
tt e sognato,
t lla presenza di
gravi limitazioni, rappresentano condizioni di
grave sofferenza psichica che spingono il
genitore a funzionare p
g più che altro secondo un
modello mentale dove prevale la frantumazione
e l’espulsione
l espulsione e molto meno il contenimento
contenimento.1.1 mente e pensiero
In questo stato mentale è ben difficile per il
genitore attribuire un senso ad i vari elementi
che caratterizzano la nuova esperienza che si
trova a vivere.
Anche gli operatori che vengono a contatto e
condividono con i genitori un’esperienza così
carica
i di sofferenza
ff e di morte
t più
iù ffacilmente
il t
tenderanno a funzionare secondo questa
modalità di pensiero.1 1 mente
1.1 t e pensiero
i
Il bi
bisogno di ““agire”
i ” iin contrasto
t t con il
“pensare”, la messa in atto di molteplici
interventi settoriali e tra loro poco integrati
sono quindi rischi a cui facilmente si può
andare in corso.1.2 mutuall regulation
l model
d l
Sistemi
Semplici Complicati
Lineari Lineari
L
I-S-U
Causa/effetto
Complessi complesse procedure
di analisi/sintesi
Glouberman S, Zimmerman B. Complicated and complex systems: what would successful
reform of Medicare look like? Commission on the Future of Health Care in Canada, 200 2
http://www.healthandeverything.org/pubs/Glouberman_E.pdf1 2 mutual regulation model
1.2
Sistemi complessi
Sono diversi dai precedenti. Uno degli aspetti centrali infatti è
che il loro funzionamento implica una dinamica che è molto di
più della sommatoria dell
dell’azioni
azioni delle singole parti costituenti il
sistema. In questo senso la loro attività produce delle
proprietà emergenti. Queste proprietà non possono essere
previste dalla conoscenza dei singoli elementi che costituiscono
il sistema, per quanto accurata questa conoscenza sia. Ad
esempio: l’attività cerebrale.1 2 mutual
1.2 t l regulation
l ti model
d l
Un sistema complesso:
(Rocha, 1999)
Include elementi tra loro interconessi in modo dinamico;
L’attività è di carattere non lineare (ovvero non derivabile dalla
somma dell’attività dei singoli componenti);
È in grado di scambiare energia con l’esterno
l esterno, ma di
mantenere una coerenza sistemica;
Può raggiungere livelli di complessità crescente;
Sviluppa auto
auto-organizzazione.
organizzazione.1.2 mutuall regulation
l model
d l
Lo sviluppo psichico umano può essere concepito come un
sistema complesso.
Schore (1997) sostiene che l’auto-organizzazione è processo
intrinseco nello sviluppo cerebrale
cerebrale.
Tuttavia,, i processi
p di auto-organizzazione
g che incrementano
la complessità hanno limiti che pongono una soglia alla
complessità massima del sistema (Tronick, 2008).1.2 mutual regulation model
Tronick (2008) suggerisce che come un qualsiasi sistema
biologico aperto nel corso dello sviluppo psichico,
l’individuo deve acquisire energia dall’ambiente per
mantenere e aumentare la propria coerenza
coerenza, e
complessità.
Dal punto di vista psichico nei primi mesi di vita tale energia
è costituita prevalentemente da scambi emozionali che
assumono significato all’interno della relazione madre-
bambino.
Per questa ragione l’auto-organizzazione cerebrale si
presenta nel contesto di una relazione con un Altro
diverso da Sé e un altro cervello.1 2 mutual
1.2 t l regulation
l ti model
d l
Nei primi mesi di vita il principale ruolo di un Altro da
Sè è assicurare
i un livello
li ll di ffunzionamento
i t ottimale
tti l
attraverso il supporto ai processi di regolazione
biologica ed emozionale.
Ecco perché i processi di auto
auto-regolazione
regolazione sono
esperienza-dipendenti e in particolare sono in
rapporto con la qualità delle esperienze affettive
implicate nella relazione precoce madre-bambinoIl cargiver primario svolge una funzione di
“cervello/mente esterna” che non solo
stimola il cervello/mente del bambino, ma
ne favorisce l’auto-regolazione.Ri
Riassumendo
d
La mente umana è normalmente in grado di dare significato alle
diverse esperienze, azioni, emozioni, eventi …. che l’attraversano
In condizioni di stress questa funzione aggregazione/contenimento
può venir meno e prevalgono modalità di funzionamento che
privilegiano la framentazione dei messaggi
messaggi.
Lo sviluppo psichico può essere considerato un sistema
complesso in grado di auto-regolarsi. I processi di autoregolazione
sono in stretta dipendenza con le esperienze ambientali ed in
particolare con le esperienze emozionali che caratterizzano la
relazione
l i madre-bambino
d b bi2 La nostra esperienza
Dal 2004 abbiamo progressivamente
aperto il nostro reparto all’accoglimento
dei neonati (169 - agosto 08).
36 settimane e.g.
e g l’età del più piccolo
20 i trasferimenti direttamente dalle TIN
per un progetto condiviso prima
dell’inserimento nel territorio
Lecco, Como (VD e SA), Monza, Milano
Buzzi, Rho, Magenta le TIN invianti2 La nostra esperienza
La permanenza in reparto è variabile (3-4 settimane) ed è
più in funzione del bisogno della mamma/famiglia di
sentirsi p
pronta p
piuttosto che p
per la necessità di effettuare
un vero intervento “intensivo” sul bambino
La dimissione avviene solo
quando è stato attivato un
servizio di “rete” territoriale che
accolga madre e bambino e
fornisca loro tutti gli aiuti
necessari (dimissione protetta)2.1 L’ ingresso
L’impatto con il reparto ….
….. qui non è come in patologia neonatale dove i bambini
nelle loro incubatrici sembrano tutti uguali …
… è l’impatto con la disabilità2.1 L’ ingresso
… genitori che restano chiusi in camera
e non parlano
l con le
l altre
lt mamme
… il confronto li spaventa
….. dottoressa
d tt ss mi mio fi
figlio
li nnonn ssaràà mi
mica come
m i bambini
b mbini che
h
ricoverate qui, vero?
… il confronto li conforta
… dottoressa non capisco come fanno ad essere così serene
(riferito alle mamme dei bambini più grandi ricoverati)2.1 L’ ingresso
una camera singola per …
•… consentire una maggior intimità con il proprio bimbo
•… provare a fare come a casa propria
• dare spazio alla famiglia allargata
•…2.1 L’ ingresso
La prima notte …
… dottoressa questa sera sarà la prima volta che dormo con lui
• la difficoltà di rimanere con il proprio bimbo da sole
•…
•… l’emergere
g di fantasie di inadeguatezza
g
•… l’emergere di fantasie di morte
… sancisce un passaggio2.2 la permanenza
Il primo periodo, subito seguente l’ingresso in reparto,
viene dedicato alla messa in atto delle diverse
valutazioni indispensabili per un primo bilancio dei
bisogni clinici del bambino e la programmazione degli
interventi riabilitativi
Se per i medici e i terapisti la fase di valutazione
risponde alla necessità di effettuare un bilancio clinico
per il genitore spesso è la prima occasione per
“pensare
pensare ad un bambino nella sua pienezza
pienezza” e non solo
come una serie di parametri bio-fisiologici.Il protocollo prevede la valutazione degli 2.2 la permanenza
aspetti
tti neuromotori
t i
•Visita neurologica
•Visita
Vi it fisiatrica
fi i t i
•Valutazioni fisioterapista
aspetti
p alimentari
•Visita pediatrica •Visita chirurgo pediatra
•Visita foniatrica con •Videofluoroscopia
FEES
•Valutazione logopedica
•Valutazioni dietologica2.2 la permanenza
aspetti sensoriali visivi
•Visita oculistica
•Valutazione ortottica
•Valutazione della funzione visiva
•Esami elettrofisiologici
aspetti sensoriali uditivi
•Visita audiologica
•ABR soglia
aspetti neurofisiopatologici
•EEG veglia sonno
•Video-poligrafia2.2 la permanenza
Se ppresenti
ese problemi
p ob e specifici
spec c
•Visita genetica clinica
•Visita ortopedica
p
•Visita cardiologica
•Visita chirurgo maxillo-faciale
Vengono inoltre sempre previsti
•Colloqui con assistente sociale
•Osservazioni psicologiche
dell’interazione madre-bambino e colloqui
psicologici
Spesso
p ricerca di un sostegno
g ppsicologico
g “informale”
… dottoressa ieri sera però non è venuta2.2 la permanenza
Supe ata la
Superata a fase
ase ddi valutazione
a uta o e viene
e e dato a
avvioo ag
agli
interventi riabilitativi programmati in base alle specifiche
necessità:
trattamento fisiochinesiterapico
stimolazioni plurisensoriali
stimolazioni visive
stimolazioni miorali o avvio allo svezzamento dalla
nutrizione enterale2.2 la permanenza
TUTTE LE VALUTAZIONI ED I TRATTAMENTI VENGONO
ESEGUITI IN PRSENZA DELLA MAMMA2.3 la dimissione
Laaddimissione
ss o e viene
e ep programmata
og a ata pe
per te
tempo
po e co
concordata
co data co
con
la famiglia.
Sempre è preceduta da una serie di contatti che l’assistente
sociale intrattiene, insieme alla famiglia, con le strutture
territoriali
Il medico prende sempre contatti telefonici con il pediatra di
famiglia e con i colleghi NPI della UO territoriale in modo da
dimettere il bambino con appuntamenti
pp e i nominativi dei
referenti già definiti.
Se vi è la necessità di presidi (aspiratore, pompa per la
nutrizione, sondino nasogastrico, PEPMask,..), vengono
prescritti prima della dimissione e quando consegnati ai
genitori viene effettuato in reparto l’addestramento
l addestramento dei genitori
all’uso.2.3 la dimissione
Nei
e cas
casi domiciliati
do c at nelle
e e vicinanze
c a e ssi a avvia
auun pe
percorso
co so
ambulatoriale presso l’ Istituto che, indicativamente, prevede:
•FKT 2-3 volte/settimana
•stimolazioni plurisensoriali 1-2 volte/settimana
•stimolazioni visive 1
1-2
2 volte/settimana
•stimolazioni miorali insegnate alla mamma da eseguire più
volte al dì con supervisione
p logopedica
g p settimanaleConcludendo ….
Farsi carico di un bambino molto piccolo in condizioni precarie per la
sopravvivenza perché affetto da una grave cerebropatia con conseguente
compromissione multisistemica rappresenta un compito molto oneroso.
Laa multiproblematicità
u t p ob e at c tà (problemi
(p ob e motori,
oto , alimenatari,
a e ata , sensoriali
se so a etc
etc..)) cche
e
caratterizza questa condizione può facilmente indurre il clinico ad attivare
interventi settoriali colludendo così con istanze di frammentazione proprie o
del genitore.
genitore
Il reparto può rappresentare un luogo di riparazione, il luogo dove il
genitore può ricominciare a pensare al proprio figlio non tanto come la
somma di singoli problemi ma come persona, oggetto di cure ed
attenzioniOSSERVARE ASPETTARE E DOMANDARSI
OSSERVARE,
(UN APPROCCIO PER LAVORARE CON I BAMBINI E I LORO GENITORI)
(mutuato
( t t da d Nancy
N JJ. C
Cohen
h della
d ll Hincks-Dellcrest
Hi k D ll tCCentre University
t & U i it off T
Toronto)
t )
Struttura dell’intervento
dell intervento con bambini da 0 a 30 mesi:
– Colloqui psicologici con la madre preliminari;
– Video-registrazione dell’interazione madre-bambino sia in
scambi liberi che in situazioni di stress controllato (still-face);
( );
– Le video-registrazioni sono riviste e discusse con la madre, al
fine di analizzare i comportamenti del bambino
bambino, della madre
stessa e il tipo di interazione.Obiettivi dell’intervento per le madri con bambini di pochi mesi: ¾Favorire una regolazione emozionale che permetta di sviluppare o ampliare le “finestre temporali“ di contatto con il bambino mentre è in uno stato di veglia attiva; ¾Riconoscere e sintonizzarsi sui specifici segnali inviati dal bambino; ¾Individuare modalità appropriate e sensibili per rispondere ai messaggi del bambino.
Aiutare il genitore a riconoscere:
¾ se il bambino mostra preferenze per certi stimoli (oggetti
animati, inanimati);
¾ i segnali proto-linguistici (es., protrusione della lingua,
movimenti buccali, vocalizzazioni);
¾ i comportamenti di auto-acquietamento (es., suzione non
nutritiva, auto-contatto,
auto contatto, evitamento dello sguardo, ecc.);
¾ i segnali di disagio minori (es.: rigurgiti, sbadigli, cambi di
colore
l della
d ll pelle,
ll ecc.);
)
¾ i segnali
g di disagio
g maggiori
gg (es.:
( agitazione,
g , aumento attività
motoria, ecc.).Puoi anche leggere