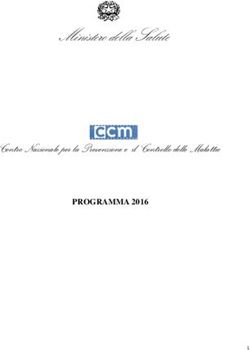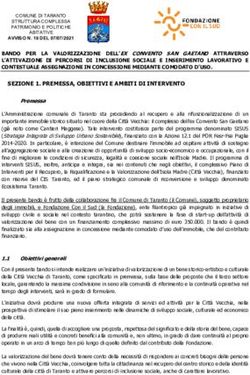Il Museo Nazionale di Ravenna - L'immagine della città e l'opera della Soprintendenza
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
questa iniziativa è stata possibile grazie al contributo di:
Alla scoperta della città
Inizia dal Museo Nazionale di Ravenna, il nostro viaggio dentro
le istituzioni culturali della città, pensato per offrire ai cittadini ra-
vennati la storia e l’evoluzione della nostra città, rimasta per molti
Il Cigno GG Edizioni ancora misteriosa, spesso inafferrabile nella complessità storica, e
Roma artistica che la caratterizza. Arte, cultura, storia, sono aspetti che
permeano la vita di una città, ma affinché diventino patrimonio
Il Museo Nazionale
della comunità, necessitano di un filo conduttore che li unisca, che
li sappia valorizzare e rendere fruibili ai cittadini. La nostra città
è ricca di siti in grado di farci conoscere il passato e interpretare il
presente, e dare un senso alle profonde emozioni che ciascuno di
di Ravenna
noi prova, quando si sofferma ad osservare ogni angolo di questa
città. Avere gli strumenti giusti per leggere Ravenna, attraverso chi
ne conserva la storia o pezzi di storia, vuole essere un contributo,
che con questo percorso intendiamo offrire ai nostri cittadini.
In questo viaggio, non potevamo che partire dal Museo Nazionale,
L’immagine della città legato da uno stretto rapporto di reciprocità alla città, nel rappre-
sentarne la fervida attività di ricerche, scavi e restauri.
e l’opera della Soprintendenza
Antonella Ranaldi (Soprintendente per i Beni architettonici e pae-
saggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini)
Uno stretto rapporto di reciprocità lega il Museo Nazionale alla città e
alla Soprintendenza, tanto da potersi dire che il Museo ne costituisce
una delle anime, nel rappresentarne la fervida attività di ricerche,
scavi e restauri. Le collezioni appaiono al visitatore una silloge di
opere e testimonianze materiali, eccelse e minori, per lo più di au-
tori ignoti, provenienti dalle collezioni storiche, raccolte in un luogo
eccezionale ed esemplare.
Istituito già nel 1885, il Museo venne trasferito nel 1913-1914 nella sua
prestigiosa sede nell’ex monastero benedettino di San Vitale, aperta al pubblico e inau-
gurata nel 1921 in occasione del VI centenario dantesco. Il nucleo primitivo del patrimonio
museale è costituito dalle collezioni formate, durante il Settecento, dai monaci camaldolesi di
Classe poi arricchito attraverso donazioni, acquisizioni, ritrovamenti e scavi. Il Museo si presenta
come un insieme di raccolte eterogenee, riconducibili a tre gruppi fondamentali: lapidario, re-
perti da scavo e collezioni d’arte. Il lapidario, esposto per la maggior parte nei due chiostri del
monastero, è costituito da un’interessante raccolta di sculture, epigrafi, stele funerarie e reperti
lapidei scultorei ed architettonici romani, paleocristiani, bizantini, romanici, gotici, che, seguendo
il percorso all’ombra dei portici dei chiostri, mostrano i diversi stili fino all’età moderna, rinasci-
mentale e barocca. Se ne colgono gli apporti e le influenze, il legame con i luoghi di provenienza
e con la storia della città. Nel Refettorio, collocato tra il II e il III chiostro, si trova l’importante ciclo
di affreschi del Trecento, capolavoro di Pietro da Rimini, staccati dall’antica chiesa di Santa Chiara
in Ravenna.
Nei piani superiori sono esposti mate-
Soprintendente Antonella Ranaldi riali provenienti dai maggiori monu-
menti di Ravenna, qui raccolti quando
la Soprintendenza provvedeva al loro
restauro, tra i quali spiccano le preziose
testimonianze dei monumenti paleo-
cristiani e bizantini (riconosciuti nel
1996 dall’Unesco Patrimonio dell’U-
manità) - rappresentativi del volto della
città dei secoli V e VI, capitale impe-
riale e città cosmopolita. Seguono le
collezioni e le raccolte d’arte cosiddetta
minore, bronzetti e placchette, avori,
icone, armi e armature, ceramiche,
monete, la cui collocazione per generi
ne rappresenta la formazione ama-
toriale e classificatoria settecentesca
e anteriore, da parte soprattutto dei
monaci camaldolesi di Classe.
Portale di ingresso al Complesso
di San Vitale e al MuseoIl Luogo, la Storia Il Museo fa parte del Complesso di San Vitale, compreso tra le antiche mura della città a ovest e a nord sul margine di largo Giustiniano, via San Vitale a sud, via Galla Placidia a est. Entrando dal bel portale settecentesco su via San Vitale, tra alberi secolari, il monumentale platano, tigli e pini, simbolo di Ravenna, grandi basolati di recupero, che interrompono il verde prato, tra sarcofagi sparsi, ci si imbatte nei luoghi che, più degli altri, testimoniano il passato aureo e imperiale di Ravenna, il Mausoleo di Galla Placidia dei primi decenni del V secolo, la basilica ottagonale di età giustinianea della metà del VI secolo e il monastero annesso. (Figg. 1-3) Il Monastero dal luogo di provenienza, si unisce il godimento Nel 999 la concessione di Ottone III a costruire dell’atmosfera claustrale, nel percorrere gli am- un chiostro ne attesta la sua origine, fissando in bienti abbaziali organizzati intorno all’infilata dei quegli anni la presenza ininterrotta dei benedet- tre chiostri. Nel primo detto “della cisterna” tini in San Vitale, fino alla confisca napoleonica (Fig. 4), si ritrovano le tracce dell’antico monastero nel 1798 (21 agosto). Nel 1472 papa Sisto IV unì il di età ottoniana, nelle bifore e monofore arcuate monastero alla congregazione di Santa Giustina. e nella stratificazione di strutture sovrapposte La Ravenna del periodo veneziano si manifesta nell’ambiente ad est del chiostro, che con ogni nel portichetto d’ingresso a colonne scolpite e probabilità era la sala del capitolo del primo tortili in Rosso di Verona. Sull’architrave del monastero benedettino. Tra i maestosi tassi portale d’ingresso si legge l’iscrizione ripresa che ombreggiano il secondo chiostro, detto il da Virgilio che segnava l’ingresso al monastero “claustro novo” di Andrea Da Valle, al centro benedettino con il monito della Sibilla cumana vigila la statua di papa Clemente XII di Antonio Procul o procul este profani (via via lontano da Bracci del 1738 (Fig. 6), molto apprezzata nelle qui, o profani). guide storiche e dai viaggiatori di Ravenna nella Superato l’androne si incontra il primo chiostro sua originaria collocazione in piazza del Popolo. della fine XV inizi del XVI secolo (non risparmiato Separato dal refettorio, segue il terzo chiostro dalle ricostruzioni dovute al crollo del campanile detto “dell’orto” iniziato sempre nella seconda Fig. 1 - Planimetria Complesso San Vitale nel 1668 e ai bombardamenti dell’ultima guerra), metà del XVI secolo, come fanno intendere al arricchito nell’impronta veneziana rinascimen- piano superiore della manica lunga sull’ala ovest tale da Giuseppe Gerola nel 1910 negli apparati le decorazioni geometriche ad intonaco dipinto decorativi delle cornici intorno alle porte sul che simulano un rivestimento lapideo a punta Fig. 2 - Nella posizione del II chiostro insisteva il quadriportico antico antistante lato est in stile lombardesco (provenienti dalla di diamante. a San Vitale, disegno ricostruttivo Classense) e della vera di pozzo al centro portata Il monastero continuò a crescere nel XVII e nel 1916 dalla casa Saporetti di Ravenna. Segue XVIII secolo, quando vi risiedevano circa un il secondo chiostro con serliane nel portico, centinaio di persone, di cui metà religiosi, nei opera del 1562 di Andrea da Valle, proto di Santa nuovi ambienti del dormitorio dell’architetto Giustina a Padova. bresciano Antonio Giuseppe Soratini, camaldolese Esso ricalca ad una quota più alta l’antico qua- di Classe, sul lato est del III chiostro, nelle celle driportico che insisteva davanti al nartece di e nelle gallerie della manica lunga a ovest, negli San Vitale. Salendo per lo scalone settecentesco, annessi ambienti di servizio. Rappresentato nella opera di Benedetto Fiandrini, situato in posizione sua interezza e funzioni nella pianta del 1798 nodale tra il I e il II chiostro, al piano di sopra dell’abate Benedetto Fiandrini, appena prima inoltre si entrava al matroneo. La comunicazione della confisca napoleonica (Fig. 5), venne salvato, tra il chiostro e la chiesa venne inoltre potenziata grazie all’azione della Soprintendenza, dagli usi nei lavori di ripristino del nartece d’ingresso alla incongrui e devastanti, che si preannunciavano basilica compiuti negli anni Trenta del secolo con l’insediamento militare della caserma Gorizia scorso sul lato est del portico, mentre si proce- e dopo la Seconda guerra con l’occupazione di deva ad abbassare il livello del pavimento della porzioni del complesso da parte degli sfollati. basilica alla sua quota antica. All’apprezzamento degli oggetti esposti, con i Fig. 3 - Ingresso al Museo dal portichetto limiti talvolta della loro decontestualizzazione e dal giardino di San Vitale
L’istituzione museale
Il Museo Nazionale fu istituito nel 1885 con Regio Decre- Enrico Pazzi perseguì il suo progetto, coinvolgendo ragione stessa della sua istituzione nel suo legame
to n. 3323 del 25/7/1885, che assumeva la convenzione non solo le istituzioni, ed in particolare il Ministero con il Museo e con la città. Il Regio Decreto n. 496 del
stipulata tra Comune e Stato in quello stesso anno (3 della Pubblica Istruzione, nelle figure di Guido Baccelli 2 dicembre 1897, con cui il Ministro Codronchi istituì
marzo 1885), in cui le due istituzioni si impegnarono e Giuseppe Fiorelli, ma anche i privati cittadini, come il la speciale Soprintendenza per la conservazione e la
con forza di legge a reciproci obblighi, fissando le con- conte Ferdinando Rasponi e la famiglia Lovatelli, che si manutenzione dei monumenti di Ravenna, la prima in
dizioni per il successivo incremento delle collezioni pregiarono di arricchire il Museo di lasciti e donazioni. Italia, inizia richiamando il precedente Regio Decreto
museali. Esso fu concepito come il luogo destinato a Nel 1898 il Museo fu consegnato da Enrico Pazzi al più n. 3323 del 25 luglio 1885, con cui era stata approvata la
rappresentare la storia artistica della città, nella sua giovane Corrado Ricci, che nella sua qualità di Soprin- convenzione tra il Ministero della Pubblica Istruzione
particolare investitura di storia patria nazionale, per tendente assunse la direzione del Museo insieme alla ed il Comune di Ravenna, per l’istituzione del Museo
la peculiarità e unicità delle testimonianze soprattutto guida della novella Soprintendenza. Nazionale di Ravenna. Il Regio Decreto del 2 dicembre
bizantine, raccogliendo in deposito perpetuo gli oggetti Sia il Museo che gli Uffici della Soprintendenza condivi- 1897 affidava quindi alla Soprintendenza la direzione
del quale disponeva il Comune e quelli che si sareb- dono la propria sede, intorno ai chiostri rinascimentali del Museo Nazionale, fissandone i compiti istituzio-
bero rinvenuti o acquistati in futuro. Confluiva nella del monastero. Ai piani superiori del primo chiostro nali: da una parte, la conservazione e l’incremento
novella istituzione statale il Museo dell’ex monastero si trovano gli Uffici e la Biblioteca; al piano terra del degli oggetti raccolti nel Museo Nazionale, dall’altra
camaldolese di Classe in città (municipalizzato nel primo chiostro e sui due livelli del secondo si esten- la conservazione e la manutenzione dei monumenti
1804), poi Museo Civico Bizantino voluto dallo scultore de il Museo. La continuità fisica del luogo, attuata da ravennati.
ravennate Enrico Pazzi e allestito nell’attigua chiesa Giuseppe Gerola in piena sintonia con Corrado Ricci, Due realtà quindi tra loro strettamente connesse, che
di San Romualdo, dove dal 1884 al 1887 si svolsero i si rafforza nei suoi presupposti storici, caratterizzando caratterizzeranno nel tempo l’azione della Soprinten-
lavori di adattamento a museo. dal suo nascere la Soprintendenza di Ravenna e la denza di Ravenna.
Fig. 4 - I Chiostro
Fig. 5
Pianta di Benedetto Fiandrini del Complesso
Monastico di San Vitale nel 1798
Fig. 6 - II ChiostroPotenzialità
e strategie future
Riprendendo le parole di Annoni all’apertura del Museo in primo luogo nei contatti padovani con l’abbazia
nel 1921 mi sento di condividerne l’opinione: di Santa Giustina a cui era annesso il monastero. Il
Per me il Museo di Ravenna ha da rendere l’immagine programma di interventi, da eseguirsi passo dopo
della città nel suo evolversi ed essere quasi il comple- passo, investe l’organizzazione del Museo, in linea
mento necessario e la testimonianza dell’opera della con la sua organizzazione iniziale per farne un polo
Soprintendenza (Museo 1921). culturale, ricreativo e turistico. Si è iniziato nel 2011
(settembre) con la riapertura della Sala della Porta
Rispetto al tema più ampio dei monasteri e conventi Aurea, riportando poi l’ingresso verso la città da via
dismessi a seguito delle confische napoleoniche, l’e- San Vitale, dal portichetto veneziano, originario in-
sempio di Ravenna è senz’altro positivo, nelle scelte gresso all’abbazia e al Museo (aprile 2013). Si è lavorato
storiche di destinare a Biblioteca Civica, il complesso in linea con l’impostazione iniziale, capovolta e poco
metabolizzata dallo spostamento
dell’ingresso dapprima portato
nell’ala settecentesca (cd Museo
Basso) e negli anni Novanta sul
Fig. 8 - San Giorgio e il Drago
lato opposto, su via Fiandrini, che
ha provocato infatti un capovol-
gimento del senso di percorrenza programma degli interventi (Fig. 11)
delle collezioni lapidarie. 1) Nuovo ingresso su via San Vitale aperto in aprile
Prossimamente si aprirà una nuo- 2013: Biglietteria, bookshop, punto informativo e
va sala lapidaria con le sculture saletta per proiezioni (in corso di ultimazione)
di età classica che raccolgono 2) Spazi espositivi: a settembre 2013 apertura nuova
opere alloggiate al primo piano sala lapidaria nel I chiostro
e importanti opere provenienti 3) Segnaletica e Differenziazione percorsi: breve,
dai depositi del Museo, alcune “I capolavori del Museo Nazionale”, medio e lungo
ben note, altre del tutto inedite.
con relative piante di orientamento, guida al museo
Si è così recuperata la storia della
Scultura lapidaria e architet- e percorsi tematici
tonica nella disposizione delle 4) Restauro scalone di Benedetto Fiandrini
Fig. 7 - Transenne marmoree
opere distribuite nel I e II chiostro, 5) Allestimento Sezione Monumenti paleocristiani
camaldolese di Classe in città, a Museo Nazionale di dall’età classica, intorno al I chiostro, seguendone e bizantini di Ravenna, I piano: sala introduttiva
Ravenna, il complesso benedettino di San Vitale, a cui l’evoluzione della produzione e degli stili nel tempo, con apparati multimediali e proiezioni, sala delle
si aggiunge la Pinacoteca e attuale MAR - Museo d’Arte dal tardo antico all’età bizantina, nel portico sud del II tecniche costruttive, dei vetri, di San Vitale, della
della città di Ravenna, nell’abbazia di Santa Maria in chiostro, attraversando le prolifiche immaginifiche e Sinopia e nuova sezione su Teodorico.
Porto, fino alle sistemazioni più recenti nei recuperati rare testimonianze di età medioevale che affollano il 6) Sezione Archeologia del territorio (in collabo-
chiostri di San Francesco e nel complesso agostiniano portico ovest, per arrivare in continuità cronologica al razione e a cura della Soprintendenza per i Beni
di San Nicolò destinato alla mostra permanente Tamo Refettorio con gli affreschi provenienti da Santa Archeologici)
sui mosaici. Chiara, capolavoro del Trecento di Pietro da Ri- 7) TERZO CHIOSTRO Sistemazione giardino lapi-
Quanto al Museo Nazionale, nel ritrarre l’immagine mini (Figg. 9-10-19). Si continua sul portico nord con
dario con ristorazione
della città nel suo evolversi e nel rendere testimonianza l’età moderna, d’influenza lombardesca e veneziana.
dell’opera della Soprintendenza, come diceva Annoni L’Archeologia del territorio verrà incrementata in una
nel 1921, è ben da comprendersi il luogo eccezionale in sezione speciale a cura della Soprintendenza per i Beni Percorso breve
cui si trova, la relazione che fisicamente e storicamente Archeologici, nella Tinazzara al piano terra. Il poten- Orienta la visita al Museo, selezionando i suoi capola-
instaura con San Vitale, rafforzando in modo strategico ziamento e l’organizzazione dei percorsi continuerà vori e permettendo nello stesso tempo di percorrerlo
la sua originaria connotazione di Museo bizantino, come al primo piano nel percorso dedicato ai Monumenti per intero nel suo ordinamento eterogeneo e per
identitario della città e dei suoi monumenti paleocri- paleocristiani e bizantini, attraverso le testimo- questo più difficile da comprendere nelle diverse
stiani e bizantini. Riconosciuti dal 1996 patrimonio nianze degli otto monumenti che rendono Ravenna tipologie delle cose raccolte. Si selezionano le opere
dell’Umanità, essi sono distribuiti nella città, ma non nota al mondo, riconosciuti dall’Unesco Patrimonio non quindi per escluderne altre, ma per far compren-
possono essere presenze a sé stanti e isolate, ma fare dell’Umanità (Fig. 7), diramandosi poi nei percorsi già dere le molteplici e varie identità di cui il Museo è
sistema, come indica il Piano di Gestione Unesco. Essi organizzati delle collezioni storiche, Tessuti, Avori, espressione, ricercandone un filo conduttore. La
da soli non dispongono di spazi adeguati per l’acco- Bronzetti, Icone, Armi e armature, Ceramiche e provenienza ravennate delle opere di rinvenimento
glienza del pubblico - ormai requisito di sostenibilità e dipinti, Monete al mezzanino.
e scavo si intreccia infatti con la cultura antiquaria
miglioramento dell’offerta dei siti di interesse culturale L’ala su via Fiandrini potrà essere meglio apprezzata
e turistico. Il Museo Nazionale nella sua posizione ridando continuità allo straordinario sviluppo spaziale e con l’attitudine propria al collezionismo maturata
per molti versi strategica accanto a San Vitale, dotato della manica lunga illuminata alla due estremità da nell’ambiente colto dei due insediamenti religiosi
di un ampio parcheggio pubblico, gode degli spazi e grandi bifore del monastero (lunga ca. 80 m), desti- camaldolesi e benedettini.
strutture necessari per farne un vero polo museale nata a Mostre temporanee, come quelle in corso. Il
per la città, in un luogo simbolico per eccellenza e Battistero Neoniano. Uno sguardo attraverso i disegni
ameno da percorrere e visitare. e i materiali della Soprintendenza e Riccardo Licata e i
L’anima colta del Museo deriva dalle sue collezioni maestri del mosaico, interessante confronto tra mosaico
storiche, ancora in buona parte da esplorare per risalire antico e contemporaneo.
alla provenienza e alle vicissitudini nel tempo - spesso Il visitatore potrà quindi essere meglio guidato alla
ignote - delle testimonianze raccolte, per raccontarne la scoperta dei capolavori e delle raccolte e delle collezioni
storia e con essa la storia della città impressa nelle sue tematiche. Dovrà valorizzarsi la sua ambientazione nei
pietre e marmi erratici. La stessa storia del monastero chiostri in relazione al luogo eccezionale in cui sorge il
e dei suoi spazi va esplorata e ricostruita nella com- Museo e rafforzarsi il suo legame con la basilica di San
plessa gestione territoriale dei possedimenti e nella Vitale, intorno alla quale si sviluppò il monastero. E
rete di contatti tra le abbazie benedettine cassinesi, ulteriormente ampliato negli spazi ancora non aperti al
pubblico del terzo chio-
stro, sistemato a giar-
dino lapidario, il Museo
potrà anche dotarsi di
quei servizi al pubblico
di ristorazione, informa-
zione, libreria, rivolti ad
una frequentazione più
estesa, di tipo ricreativo
e culturale.
Figg. 9-10 - Affreschi di Pie-
tro Da Rimini provenienti
dalla Chiesa di Santa Chiara
a RavennaLe collezioni
si reperivano nei lavori in corso diretti dalla
Soprintendenza; così entrarono nel Museo la
grande croce in bronzo sulla cuspide del tetto di
San Vitale, sostituita in loco nel 1911 da una copia
con il gallo in cima; le transenne di San Vitale e
quella di San Michele in Africisco (Fig. 7); la tran-
senna di finestra della cripta di Sant’Apollinare
in Classe, nella Sala delle transenne; la porzione
di muratura ad archetti con bacini ceramici del
campanile di Sant’Apollinare Nuovo, qui portata
da Gerola mentre eseguiva i lavori di consolida-
mento del campanile; i materiali degli scavi del
cosiddetto Palazzo di Teodorico condotti tra il
1908 e il 1914, nella Sala di Teodorico. Entrarono
poi nel Museo le cinque erme, copie romane
del II secolo di originali greci, due di Milziade,
Carneade, Epicuro, Dioniso-Platone, rinvenute
fortuitamente in mare, impigliate nelle reti dei
pescatori nel 1936 e negli anni successivi, tra
Porto Corsini e la foce del Reno. (Fig. 15)
Nel 1964-1977 il Museo fu gestito dalla Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici, che arricchì le
collezioni con i materiali rinvenuti negli scavi sia
fortuiti che programmati, tra cui l’importante
Fig. 12 - Apoteosi di Augusto testa turrita “Tyche” rinvenuta casualmente
nel 1972. Per molti anni il Museo rimase chiu-
Nel Museo si coglie l’immagine della città nella provenienza ravennate delle so al pubblico, per ritornare poi nel 1977 alla
opere, antiquaria, bizantina, medioevale e moderna, ad origine o acquisita at- competenza della Soprintendenza per i Beni
traverso l’attitudine a raccogliere e preservare, nello spirito illuministico di cui è Architettonici.
espressione il cospicuo e diversificato nucleo delle collezioni Classensi - terracotte, Ognuno si adoperò nell’unire collezioni e rin-
avori, bronzetti, icone, ceramiche - per impulso soprattutto di Pietro Canneti, a venimenti provenienti dal territorio ravennate,
cui si integra la permanenza delle importanti opere della collezione di antichità resi fruibili al pubblico e agli specialisti in un
dei monaci benedettini cassinesi di San Vitale. In essa spiccano i due bassorilievi sistema museale complesso e diversificato per la
dell’Apoteosi di Augusto (Fig. 12), nel I chiostro, trovato negli scavi del XVI secolo disomogeneità dei materiali esposti, terrecotte,
nell’area tra San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia, e il sarcofago della Traditio marmi, e pigrafi, elementi architettonici, mo-
legis di età paleocristiana (Fig. 13), esposto nel II chiostro, entrambi già allocati nel saici, stoffe, bronzetti, avori, icone, ceramiche,
armature, monete.
Fig. 14 - Statua colonna
Si perseguì un’idea di Museo che cresce nel
tempo, attraverso successive migrazioni di
oggetti provenienti da vari luoghi della città, in linea con gli enunciati del Regio
Decreto del 1885 di istituzione del Museo. La sua storia segue un filo rosso che
arriva alle più vicine e spettacolari acquisizioni e musealizzazioni conclusesi nel
1995: la sinopia dell’abside di Sant’Apollinare in Classe e gli affreschi di Pietro da
Rimini nel Refettorio provenienti da Santa Chiara. Come riferisce Anna Maria
Iannucci (Soprintendente dal 1992 al 2007), “la superficie museale è passata da
1.500 mq nel 1977 ad oltre 5000 mq nel 1990”, attraverso una serie di mostre ed
esposizioni divenute permanenti negli allestimenti di: icone (1979); ceramiche
(1982); monete (1983); bronzetti e placchette rinascimentali (1985); farmacia (1986);
oploteca (1989); avori bizantini e medievali (1990).
ALCUNI CAPOLAVORI DEL MUSEO NAZIONALE
COLLEZIONE LAPIDARIA Età classica (I Chiostro)
Erma di Milziade Roma, marmo, II secolo d.C.
Bassorilievo di Augusto, marmo, 42 - 43 d.C. (Fig. 12)
Stele di Publio Longidieno Ravenna, pietra d’Istria, prima metà del I sec. d.C.
Tardo antico e Medioevo (II Chiostro e Refettorio)
Sarcofago detto della “Traditio legis” marmo, inizio del V secolo (Fig. 13)
Statue colonna marmo, dal monastero benedettino di San Vitale, metà o terzo
quarto del XII secolo (Fig. 14)
TRECENTO - Affreschi di Pietro da Rimini
dalla chiesa di Santa Chiara, primo quarto del XIV secolo (Figg. 9-10-19)
Fig. 13 - Sarcofago della “Traditio legis”
vestibolo della Sagrestia di San Vitale, accanto alla basilica nell’edificio sul lato est
MONUMENTI PALEOCRISTIANI E BIZANTINI
Rilievo con Ercole e la cerva marmo, provenienza ignota; già nella Cattedrale,
del I chiostro abbattuto nel 1901 durante i lavori condotti da Ricci di liberazione
dono Rasponi, VI secolo (Fig. 18)
dell’esterno di San Vitale.
Transenne marmoree marmo, da S. Vitale e da S. Michele in Africisco,
A questi notevolissimi esempi si aggiungono quelli sempre benedettini del museo
lapidario nel protiro medioevale di San Vitale abbattuto nel 1890, che erano nella VI secolo (Fig. 7)
Cella dell’esarca Isacio, dal nome del sarcofago di Isacio, ivi conservato, insieme Sinopia dell’abside di Sant’Apollinare in Classe
pigmento colorante su malta, dall’abside della basilica di Sant’Apollinare in Classe,
a bassorilievi appesi alle pareti che fiancheggiavano l’atrio, e ai resti della statua
prima metà VI secolo
dell’Ercole Orario, portati da Enrico Pazzi al Museo Nazionale. Dal protiro proveni-
vano, inoltre, le romaniche statue colonna (Fig. 14) oggi nel II chiostro del Museo
Nazionale. A ciò si aggiunge la risposta nel tempo alle attese degli ideatori e artefici
Collezioni d’arte
Stoffe copte (a rotazione, prevalentemente
del Museo, a partire dalla sua precoce istituzione post-unitaria, con Enrico Pazzi
nel 1884-85 nell’ex monastero di Classe in città, e a seguire: Corrado Ricci che nel di V-VII secolo)
1897 assunse la guida della istituenda Soprintendenza, la prima in Italia, e con Copertura di Evangeliario detta “Dittico
essa la direzione del Museo. Giuseppe Gerola (Soprintendente dal 1910 al 1919) ne di Murano” avorio, prima metà del VI
curò il trasferimento nel 1913-‘14 presso il complesso benedettino di San Vitale, secolo (Fig. 17)
l’ordinamento e l’allestimento della collezione lapidaria nei due chiostri. Ambro- Vergine Glycophilousa Scuola cretese-
gio Annoni dal 1920 al 1923 ne sistemò le sale al piano superiore inaugurando veneziana, tempera su tavola, inizio XVI
l’apertura al pubblico della nuova sede il 12 settembre del 1921, in concomitanza secolo (Fig. 15)
delle celebrazioni del VI centenario dantesco (Museo 1921). Giuseppe Bovini si Mensa circolare cuoio dorato con sostegno
occupò degli allestimenti, dopo i lavori post-bellici, riordinando la collezione lapi- in legno, Turchia, XVI secolo
daria nel primo chiostro, colpito da una bomba durante il conflitto mondiale, che Piatto con decorazione a foglie d’edera
danneggiò gravemente i portici sui lati nord e ovest e le sale al piano superiore. e motivo araldico
Dopo i lavori di ricostruzione e sistemazione compiuti nel 1949, il Museo venne Produzione ispano-moresca, fabbrica va-
riaperto il 7 maggio 1950 (Bovini 1951). lenzana, maiolica a lustro metallico, terzo Fig. 15 - Vergine Glycophilousa Scuola cre-
Alle collezioni storiche classensi e benedettine, dei conti Rasponi (acquisita nel quarto del XV secolo tese-veneziana, tempera su tavola, inizio
1893) e di altre famiglie si aggiunsero reperti e testimonianze che man mano Moneta con raffigurata Galla Placidia XVI secoloPer i bambini e le scuole
I Servizi educativi della Soprintendenza di Ravenna propongono un ricco calendario di percorsi
didattici e laboratori tematici ideati per le classi delle scuole, costantemente rinnovato e amplia-
to. Gli itinerari didattici, a partire dall’osservazione diretta delle opere del Museo, si pongono
l’obiettivo di avvicinare il pubblico scolare al patrimonio artistico-architettonico in una pro-
ficua interazione scuola-museo. Le attività, offerte gratuitamente, sono condotte da personale
specializzato. Specifici materiali didattici supportano la visita e consentono di approfondire in
classe gli argomenti affrontati durante il percorso.
2000 ragazzi delle scuole partecipano ogni anno all’attività didattica e alle iniziative ludiche a
tema che si svolgono regolarmente il martedì e il giovedì da ottobre a maggio. Per il nuovo
anno scolastico sono in programma i laboratori per i bambini e le scuole, una domenica
mattina al mese al Museo.
Per informazioni: sbap-ra.museonazionale@beniculturali.it - Prenotazioni per le scuole:
mercoledì dalle 9 alle 12 tel. 0544543710
Cicli di conferenze e concerti
Tra le diverse conferenze, incontri e presentazioni di libri:
2011 - ciclo di otto conferenze Ravenna. Otto monumenti patrimonio dell’U-
manità – partecipanti ca. 700 persone.
2012-13 – Vestire il sacro – in collaborazione con il Dipartimento di Conservazione
dei beni culturali (UniBO, a c. del prof. Luigi Canetti).
Ogni anno a settembre la domenica mattina i Concerti dell’Accademia bizantina.
Fig. 17 - Copertura di Evangelario cd Dittico di Murano, avorio, prima
metà del VI secolo
Fig. 18 - Rilievo con Ercole e la Cerva Fig. 19 - Particolare degli affreschi di Pietro Da Rimini (refettorio)
percorsi a tema La tradizione bizantina e gli episodi ravennati della pittura del Trecento di
Il ricco e vasto patrimonio del Museo offre la possibilità di fruire delle opere Pietro da Rimini ricuciono esperienze lontane, il cromatismo e un’attenzione
e degli ambienti in maniera diversificata, scegliendo uno dei tanti percorsi a soggetti ripresi dalle chiese bizantine della stessa città.
tematici che, organizzati in occasione di eventi e manifestazioni dal Servizio Nei percorsi tematici va ricordato l’ingente lascito classense delle icone bi-
Museo, spaziano su vari argomenti, dalla mitologia alla figura della donna zantine del Museo Nazionale, che testimonia il perdurare dei contatti sulle
nell’arte, dalla musica all’amore, dall’archeologia alle arti applicate, fino alle sponde dell’Adriatico, con i Balcani e con l’Oriente.
suggestioni musive e ai monumenti UNESCO. A partire da questi può essere A queste icone possono aver guardato i pittori riminesi del Trecento, e ancora
rintracciato un filo conduttore nell’esplorazione di oggetti rari e preziosi, più in là, i pittori della controriforma attivi in Romagna.
tra le cose d’arte espressione delle botteghe artistiche di autori ignoti la cui Nella sezione delle pitture, l’attenzione va agli affreschi staccati, provenienti
provenienza resta difficile da rintracciare, raccolte dai camaldolesi, doni o da San Giovanni Evangelista ed esposti nel Museo Nazionale, che rappresen-
acquisizioni e scambi tra i monasteri dello stesso ordine. Si ripercorre una tano il naufragio di Galla Placidia al suo ritorno a Ravenna da Costantinopoli.
micro-storia ravennate che si spiega nella lunga durata. Autore è Francesco Longhi e il committente è Teseo Aldrovandi, abate di San
Si intrecciano le storie di opere erratiche o dei loro simulacri, molte di esse Giovanni Evangelista dell’ordine di San Salvatore, fratello del più noto Ulisse
migrate dai luoghi di provenienza. Aldrovandi, collezionista e naturalista.
Guide del Museo Nazionale e bibliografie E. Tea, Guida del Museo Nazionale di Ravenna 1921, dattiloscrit- Soprintendente per i beni architettonici e paesaggisti
to, Ravenna 1921; S. Muratori, Il R. Museo Nazionale di Ravenna, per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ri-
A.M. Iannucci, Due abbazie, un museo, in “Corsi di cultura Roma, 1937; G. Bovini, Guida del Museo Nazionale di Ravenna, mini: arch. Antonella Ranaldi.
sull’arte ravennate e bizantina”, XXXV, 1988, pp. 271-293; L. Ravenna 1951; G. Bermond Monatanari, Museo Nazionale di Direttore del Museo Nazionale di Ravenna
Martini, Il Museo Nazionale di Ravenna in Ravenna patrimo- Ravenna. Itinerario e notizie, Ravenna 1969; A.M. Iannucci - L. Dott. Cetty Muscolino.
nio dell’umanità, Forlì 1997, pp. 111-119; L. Martini, Dal convento Martini, Museo Nazionale Ravenna, Roma 1993. Servizio Museo e Comunicazione:
benedettino alla nascita del Museo Nazionale, in La Basilica di CATALOGHI: Icone dalle collezioni del Museo Nazionale di Aurora Ancarani; Federica Cavani; Elisa Emaldi;
San Vitale a Ravenna, a cura di P. Angiolini Martinelli, Mode- Ravenna, a cura di G. Pavan, Santa Sofia 1979; Ceramiche dal- Emanuela Grimaldi, Ilaria Lugaresi; Paola Palmiotto.
na 1997, pp. 123-133; S. Pacassoni, Enrico Pazzi e il Museo Civico le collezioni del Museo Nazionale di Ravenna, a cura di F. Zurli, Segreteria d el Soprintendente:
Bizantino, in “Ravenna Studi e Ricerche”, IX, 2002, pp.123-133; A.M. Iannucci, Bologna 1982; P. Angiolini Martinelli, Le icone Carmen Morelli; Felicita Pistolesi.
L. Nista, Ravenna, il Museo Nazionale. Sistemazioni e nuovi al- della Collezione Classense di Ravenna, Bologna 1982; E. Cocchi Servizio manutenzioni: Maria Pia Viselli; Pasquale Barison.
lestimenti dagli inizi del Novecento agli anni Settanta, in “Acta Ercolani, Imperi romano e bizantino. Regni barbarici in Italia Architetti progettisti e direttori dei lavori delle sistemazioni e
Photographica”, 1, 2004, pp. 44-48; A. Ranaldi, Giuseppe Gero- attraverso le monete del Museo Nazionale di Ravenna, Ravenna allestimenti in corso:
la e il Museo Nazionale di Ravenna, in L’avventura archeologi- 1983; L. Martini, Piccoli bronzi e placchette del Museo Nazionale Antonella Ranaldi, Annalisa Conforti.
ca di Giuseppe Gerola dall’Egeo a Ravenna, a cura di I. Baldini, di Ravenna, Ravenna 1985; G. L. Boccia, L’Oploteca del Museo Laboratorio di Restauro:
mostra 29 ottobre 2011 - 28 gennaio 2012, Museo Nazionale di Nazionale di Ravenna. Tre secoli di armi antiche, Ravenna 1989; Elena Cristoferi, Alessandra Pocaterra, Aurora Ancarani.
Ravenna, Ravenna 2011, pp. 51-65; A. Ranaldi Gruppo di cinque L. Martini - C. Rizzardi, Avori bizantini e medievali nel Museo Laboratorio Fotografico: Paola Pilandri, Paolo Bernabini.
erme, in Restituzioni 2013. Tesori d’arte restaurati. Sedicesima Nazionale di Ravenna, Ravenna, 1990; Oggetti in avorio e osso Archivi e Biblioteca: Nicoletta Urbini, Paola Novara,
edizione, catalogo on line della mostra Napoli, Museo di Ca- nel Museo Nazionale di Ravenna sec. XV-XIX, a cura di L. Mar- Paola Palmiotto, Lorella Cimatti, Carmen Morelli.
podimonte, Venezia 2013, pp. 108-118. A. Ranaldi, Gruppo di tini, Ravenna 1993; C. Rizzardi, I tessuti copti del Museo Nazio- Servizi al Pubblico in concessione: Elisa Gazzetta.
cinque erme, in Restituzioni 2013. Tesori d’arte restaurati. Sedi- nale di Ravenna, Roma 1993; L. Martini, Cinquanta capolavori Servizio Personale: Maria Margherita.
cesima edizione, Venezia 2013, pp. 66-69. nel Museo Nazionale di Ravenna, Ravenna 1998; L. Martini, La Concessionario dei Servizi al Pubblico di biglietteria e bo-
GUIDE. C. Ricci, Raccolte artistiche di Ravenna, Bergamo, 1905; collezione degli oggetti in avorio e osso. Museo Nazionale di Ra- okshop:
A. Annoni, Regio Museo Nazionale in Ravenna, Ravenna 1921; venna, Roma 2004. ATI – Novamusa, Il Cigno GG, La Scala editore.Mostre temporanee in corso
Realizzazione grafica e impaginazione
a cura di publik image
Il Battistero Neoniano. Uno sguardo attraverso i disegni e i materiali della
Soprintendenza (fino all’autunno 2013)
I disegni e i materiali esposti costituiscono una eccezionale testimonianza degli studi intrapresi, delle pro-
gettazioni e dei lavori condotti fra la fine dell’Ottocento e gli anni Trenta del Novecento, per rimediare al
grave stato di abbandono dei monumenti “dell’età d’oro” ravennate, denunciato dai viaggiatori e da molti
studiosi italiani e stranieri, con esposti disegni raffinatissimi, cartoni pittorici di brani musivi, studi e pro-
gettazioni e ancora taccuini di lavoro e materiali provenienti dal cantiere di restauro.
Davide Rivalta “Terre Promesse” a cura di Pier Luigi Tazzi (fino al 28 ottobre 2013)
Negli spazi museali sono allestite le sculture di animali a grandezza naturale di Davide Rivalta: due bianchi
Cavalli nel II Chiostro, tre Lupi negli spazi del Dormitorio Grande, un’Asino nel protiro della Chiesa di San
Vitale, a cui si aggiungono le cinque Bufale nel prato antistante la Basilica di Sant’Apollinare in Classe.
Riccardo Licata e i maestri del mosaico (fino al 30 settembre 2013)
Organizzata da Il Cigno GG Edizioni – www.il cigno.org
La rassegna ricostruisce l’importante esperienza artistica di Riccardo Licata e la continuità della sua ricerca
nella cifra stilistica di un linguaggio fatto di segni, fino alle operi più recenti nel mosaico e nella pittura, nei
suoi rimandi ad artisti presenti in mostra, Afro, Vedova, Licini, fino a Paladino. I curatori Giovanni Granzot-
to e Antonella Ranaldi hanno voluto far dialogare la tradizione ravennate del mosaico e le testimonianze
conservate presso il Museo Nazionale di Ravenna con opere di artisti contemporanei in mosaico e in pittura.
Catalogo mostra: Riccardo Licata e i maestri del mosaico, a cura di Giovanni Granzotto e Antonella Ranaldi,
Il Cigno GG edizioni, Roma 2013. Mimmo Paladino, senza titolo
Le erme del Museo Nazionale in Restituzioni 2013 a Napoli, Museo di Capodimonte
Le cinque erme di Ippolito II d’Este, copie romane del II sec. d.c. di originali greci perduti, hanno partecipato al
progetto Restituzioni 203 di Intesa San Paolo, raccontando la loro affascinante storia di un viaggio interrotto
da Roma a Ferrara nel 1573, naufragate a Ravenna dove vennero ripescate in mare nel 1936 e negli anni seguen-
ti, erano state scelte dall’antiquario e architetto napoletano Pirro Ligorio per la Biblioteca di Alfonso II d’Este
nel Castello di Ferrara.
Intesa San Paolo ha finanziato il restauro, realizzato da Etra restauri di Michele Pagani e Lucia Rocchi, diretto
da Giuseppa Maria Fazio (ISCR), Cetty Muscolino (SBAP- Ra) con la partecipazione di Antonella Pomicetti e
Mauro Ricci (SBA-ER).
A. Ranaldi, Gruppo di cinque erme, in Restituzioni 2013. tesori d’arte restaurati. Sedicesima edizione, catalogo
on line della motra Napoli, Museo di Capodimonte, Venezia 2013, pp.108-118.
A. Ranaldi, Gruppo di cinque erme, in Restituzioni 2013. tesori d’arte restaurati. Sedicesima edizione, Venezia
2013, pp. 66-69.
Le erme del Museo Nazionale restaurate con il contributo di Intesa San Paolo, in mostra a Napoli Restituzioni 2013 Riccardo Licata, Nuvole e Sole, mosaico 2010
La Soprintendenza
ieri,
foto del 1907
durante i lavori La Soprintendenza oggi, foto di gruppo con la Soprintendente Antonella Ranaldi nel
in San Vitale portichetto veneziano d’ingresso al Museo e agli Uffici della Soprintendenza (dic. 2012)
La Fondazione Cassa di Risparmio per la cultura (a cura ufficio stampa P.I.)
Decisivo l’apporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna al settore dell’arte e della cultura nella nostra città. L’Istituzione, presieduta
da Lanfranco Gualtieri (foto), continua a destinare infatti la parte rilevante delle sue risorse, per mantenere alto il livello qualitativo dell’offerta
culturale e il livello di conservazione del patrimonio monumentale. Gli impegni più rilevanti sono rivolti al recupero, conservazione e valoriz-
zazione del patrimonio artistico e alle operazioni di sostegno per la produzione della cultura.
Anche per il 2013 la Fondazione ha destinato al settore “Arti, attività e Beni Culturali” la somma di 2.800.000 euro. Un elemento di indispensa-
bile rilievo per lo sviluppo di una efficace politica di promozione del territorio, finalizzato allo sviluppo culturale, ma più in generale volano di
sviluppo economico e sociale per la comunità ravennate.Puoi anche leggere