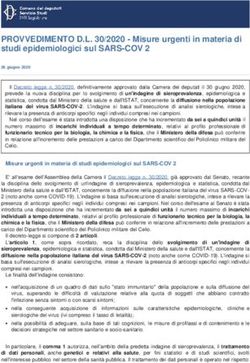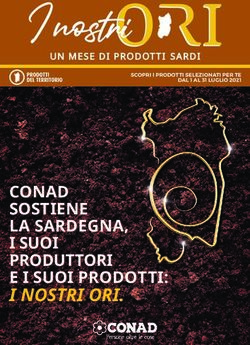Le migrazioni nel Salento
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
AAVV, H.O.S.T. Hospitality Otherness Society Theatre. Materiali di ricerca, Astragali Edizioni – Eufonia
Multimediale, Lecce, (pp. 213-224) [ISBN 978-88-903985-5-1]
Le migrazioni nel Salento
di Antonio Ciniero
Introduzione
I primi cittadini stranieri non comunitari arrivano nel Salento attorno agli anni ‘801, provengono dal vicino
Marocco, dal Senegal, dallo Sri Lanka e dalle Filippine. All’inizio si pensò a un fenomeno temporaneo, ma –
come nel resto del paese – la previsione fu smentita. Da allora a oggi, di fatti, il tasso migratorio ha registrato
una continua crescita, nella sola provincia di Lecce si è passati dai 469 residenti stranieri del 1989 ai 14.517
censiti dall’Istat nel 2011 (www.demo.istat).
La Puglia in generale e il Salento nello specifico, grazie alla loro posizione geografica, sono stati
fino alla seconda metà degli anni ’90 tra le aree del Paese che hanno registrato il maggior numero di ingressi,
in particolare per i flussi provenienti da est. Si sono configurate principalmente come aree di arrivo e transito
dei migranti diretti verso altre zone d’Italia e d’Europa, anche se, dalla fine degli anni Novanta, i flussi
migratori iniziano a stabilizzarsi sempre più sul territorio, come testimoniato da alcuni elementi indicativi del
fenomeno: l’aumento del numero delle coppie miste, dei figli dei migranti iscritti nelle scuole, dalle richieste
di cittadinanza e dai sempre più frequenti acquisti di abitazioni. A queste presenze “storiche” divenute stabili
sul territorio, continuano ad aggiungersi ogni anno nuovi arrivati, il saldo migratorio fino a oggi è sempre
stato positivo. Volendo schematizzare è possibile dividere la storia migratoria del territorio in almeno sette
fasi:
1. La prima, agli inizi degli anni ‘80, che registra la presenza pionieristica, come già visto,
soprattutto di uomini marocchini, senegalesi, srilankesi e filippini. Si tratta di migrazioni di
ripiego, poiché le tradizionali mete dei migranti (Francia, Regno Unito, Germania, Belgio,
Svizzera, Olanda) non possono più essere raggiunte per effetto delle Politiche di Stop.
2. La seconda, 1990-91, relativa al grande esodo dalla vicina Albania, dove si consumava
l’assalto alle ambasciate conseguenza della caduta dell’ultimo paese della cosiddetta cortina
di ferro. L’immigrazione albanese verso la Puglia è quella che più di altre ha modificato il
panorama migratorio locale e condizionato le scelte politiche non solo locali ma anche
nazionali2.
1
Come per il resto di Italia, gli arrivi sono conseguenza delle Politiche di stop, in questo lavoro Cfr. Le migrazioni in
Europa.
2
I cittadini albanesi arrivano in Italia attraverso il canale d’Otranto sin dal 1990, per lungo tempo si è parlato di costoro
come di eroi, considerati esuli in fuga dall’ultimo baluardo del socialismo reale sopravvissuto alla caduta del muro di
Berlino. È dal marzo del 1991, quando nel porto di Brindisi arriva la nave Lirja con a bordo numerose famiglie, che
l’immigrazione albanese in Italia assume però rilevanza nazionale e internazionale e, al contempo, cambia il registro
linguistico e simbolico con il quale ci si approccia al fenomeno (Perrone L., 1996). Questo primo arrivo di massa palesò
tutta l’incapacità del governo italiano a fronteggiare la situazione che allora era presentata come inaspettata ma che i
fatti hanno dimostrato non essere tale. L’Italia ebbe difficoltà a organizzare persino la primissima accoglienza (questi
cittadini dormirono per tre giorni sulle banchine del porto di Brindisi) che, di fatto, fu garantita solo dalla popolazione
locale. Furono le famiglie italiane che, sopperendo alle lacune istituzionali, accolsero migliaia di cittadini albanesi nelle
proprie case o portando conforto e viveri, e fu proprio il rischio di alienarsi il consenso elettorale che portò il governo
italiano a derogare alla legge 39/90 facendo rientrare tra coloro i quali potevano avvalersi della regolarizzazione della
legge emanata l’anno prima anche gli albanesi arrivati nel marzo del 1991. Se questo primo arrivo vide attivarsi una
forte catena di solidarietà tra la società civile, le cose andarono diversamente solo cinque mesi dopo. L'evento simbolo
che in Italia segna un punto di non ritorno verso politiche migratorie incentrate sullo Stato di Eccezione (Agamben G.,
2003) si avrà ad agosto, quando nel porto di Bari attraccò la nave Vlora con a bordo 20.000 cittadini albanesi. Questa
1AAVV, H.O.S.T. Hospitality Otherness Society Theatre. Materiali di ricerca, Astragali Edizioni – Eufonia
Multimediale, Lecce, (pp. 213-224) [ISBN 978-88-903985-5-1]
3. La terza, nel 1992, conseguente alla crisi del corno d’Africa, da dove arriva la comunità
somala ed eritrea.
4. La quarta, nel 1998, quando si constata la stabilizzazione sul territorio di alcune comunità
(albanese e marocchina in primo luogo, seguite da quella srilankese, senegalese e filippina) e
una significativa espansione della comunità cinese, che da allora in poi sarà in costante
espansione.
5. La quinta, nel 1999, quando, con la guerra in Kosovo, riprendo gli sbarchi sulle coste
salentine dei profughi in fuga dai bombardamenti, complessivamente transita dalla puglia
più di 150 mila profughi.
6. La sesta, nel 2002, con la “grande” regolarizzazione che accompagna la legge 189/2002, che
determina un’ulteriore modifica delle provenienze geografiche. Dal 2002 ci sarà una netta
prevalenza delle comunità dell’Europa dell’est incentivata, in primo luogo, alla sanatoria che
interessa principalmente cittadine romene, polacche, bulgare, ucraine, russe e moldave
impegnate in attività di assistenza e cura alle persone (Perrone L., 2007).
7. Dal 2002 a oggi, una fase che sostanzialmente ha visto accrescere ulteriormente il numero
delle presenze grazie soprattutto ai ricongiungimenti famigliari e al radicarsi dei gruppi
stranieri sul territorio. In questi ultimi anni, oltre ad aumentare i processi di stabilizzazione,
sono continuati gli arrivi via mare, non solo attraverso la rotta albanese (Valona - Otranto),
che anzi è diventata sempre meno seguita, ma anche attraverso la Grecia. Arriva via mare un
considerevole numero di richiedenti asilo provenienti per lo più dal medio oriente
(Afghanistan, Iran, Siria, Turchia, Iraq). Al gruppo dei richiedenti asilo di provenienza
mediorientale, si sono aggiunti dal 2010, a seguito della cosiddetta primavera araba prima, e
dell’emergenza nord Africa dopo, richiedenti asilo provenienti dal continente africano
(Tunisia, Libia, Eritrea, Sudan, Nigeria).
1. La situazione migratoria attuale
I cittadini stranieri soggiornanti in provincia di Lecce nel 2011 sono, secondo i dati dell’ultimo censimento
Istat, 14.517, il 17% di tutti gli stranieri che vivono in Puglia (83.633). Lecce è la terza provincia pugliese
per numero di stranieri (le prime due sono Bari con 28.879 e Foggia con 17.408). Più della metà dei residenti
non italiani (56,7%) sono soggiornanti di lungo periodo (Caritas/Migrantes, 2012). Il numero delle donne è
leggermente superiore a quello degli uomini, 8.198 (il 56,4%) contro 6.319 (43,5%). I nuovi permessi di
soggiorno rilasciati nel 2011 sono stati poco più di mille. La maggior parte sono permessi per motivi di
lavoro (50,4%). Le acquisizioni di cittadinanza sono state complessivamente 96.
seconda volta però l’accoglienza fu garantita dallo Stato italiano che internò i 20 mila profughi albanesi nello stadio
delle Vittorie di Bari per rimpatriarli poi con l’inganno.
2AAVV, H.O.S.T. Hospitality Otherness Society Theatre. Materiali di ricerca, Astragali Edizioni – Eufonia
Multimediale, Lecce, (pp. 213-224) [ISBN 978-88-903985-5-1]
Cittadini stranieri soggiornanti in Puglia nel 2011
ripartiti per provincia di residenza (v.a. e %)
Fonte: demo.istat.it 2011, ns elaborazione.
Rispetto alle provenienze geografiche, in provincia di Lecce, i primi cinque gruppi di cittadini
stranieri per numero di presenze sono quello romeno (gruppo divenuto maggioritario dopo il 2010), seguito
dagli albanesi (che dal 1991 al 2009 è stato il gruppo che registrava il maggior numero di presenze), dai
marocchini (comunità che è stata la più numerosa del Salento dagli anni ’80 fino agli anni ‘90), dai cinesi e
dai senegalesi.
Tra i gruppi provenienti dall’Europa dell’est prevalgono nettamente le donne (sono il 71% dei
romeni, l’84% dei polacchi, il 67% dei bulgari) così come pure tra chi proviene dalle Filippine (60%) e dal
Brasile (73%)3, gli uomini, invece, sono la maggioranza dei marocchini (59%), dei senegalesi (82%), dei
sirilankesi (62%) e degli indiani (82%). Tra gli albanesi, i cinesi e i montenegrini4 si registra un sostanziale
equilibrio di genere.
3
La maggior parte di queste donne sono impiegate nel settore domestico e/o nell’ambito dell’assistenza e cura delle
persone anziane.
4
La maggior parte dei montenegrini appartiene alla comunità Rom Xoraxane giunta nel Salento a partire dagli anni
Ottanta. Cfr. Perrone L., 2010.
3AAVV, H.O.S.T. Hospitality Otherness Society Theatre. Materiali di ricerca, Astragali Edizioni – Eufonia
Multimediale, Lecce, (pp. 213-224) [ISBN 978-88-903985-5-1]
Cittadini stranieri in provincia di Lecce al 31 dicembre 2010
ripartiti per Paese di Provenienza e sesso (v.a.)
Maschi Femmine Totale
Romania 918 2303 3221
Albania 1493 1469 2962
Marocco 1229 840 2069
Cina Rep. Popolare 585 521 1106
Senegal 722 160 882
Polonia 138 718 856
Bulgaria 263 537 800
Filippine 295 435 730
Sri Lanka 407 248 655
India 461 100 561
Brasile 113 303 416
Montenegro 191 198 389
Germania 102 268 370
Francia 63 103 166
Regno Unito 70 95 165
Altri Paesi 1040 1524 2564
Totale 8020 9727 17747
Fonte: demo.istat.it 2010, ns elaborazione.
La popolazione straniera residente in provincia di Lecce è giovane, la maggioranza assoluta, l’80%,
ha un’età compresa tra 18 e 65 anni, i minori sono il 17% del totale, mentre le fasce di età più anziane sono
scarsamente rappresentate, non superano il 3%.
Cittadini stranieri in provincia di Lecce al 31 dicembre 2010
ripartiti per età (v.a. %)
Fonte: demo.istat.it 2010, ns elaborazione.
4AAVV, H.O.S.T. Hospitality Otherness Society Theatre. Materiali di ricerca, Astragali Edizioni – Eufonia
Multimediale, Lecce, (pp. 213-224) [ISBN 978-88-903985-5-1]
2. L’inserimento nel mercato del lavoro locale
In riferimento all’inserimento lavorativo, i tradizionali settori di impiego dei cittadini stranieri nel Salento
sono, prevalentemente, quello agricolo, quello dei servizi (soprattutto domestici), quello turistico-
alberghiero, quello edile e quello del lavoro autonomo nell’ambito dell’ambulantato, specialmente per alcune
comunità (marocchini e senegalesi).
Rispetto al settore agricolo, il Salento, così come altre aree del meridione di Italia, richiama
periodicamente una consistente quota di braccianti da impiegare stagionalmente, durante periodo estivo,
nella zona neretina (Nardò, Collemento) per la raccolta delle angurie e dei pomodori (Perrone M., Lotteria
K., 2007; Perrotta M., Sacchetto D., 2012). A lavorare in questo settore, in condizioni di grave sfruttamento,
sono prevalentemente cittadini provenienti dal continente africano (magrebini, soprattutto tunisini, nella
raccolta dell’anguria, e cittadini sub sahariani nella raccolta del pomodoro). Altri lavoratori agricoli, questa
volta di nazionalità prevalentemente albanese, sono impiegati durante tutto l’anno nelle serre florovivaistiche
dell’agro del comune di Leverano (Ciniero A., 2007).
Nell’ambito del settore edile ritroviamo prevalentemente uomini albanesi, romeni e bulgari. Le
donne immigrate sono, nella maggioranza assoluta dei casi, concentrate nell’ambito del lavoro domestico,
settore questo che ha registrato una costante espansione nonostante la contrazione occupazionale registrata in
altri settori economici a seguito della crisi del 2008. A essere impiegate con la mansione di assistenti di
persone anziane o baby sitter, sono, per lo più, donne provenienti dalla Romania, Bulgaria, Ucraina e
Polonia. Nella maggior parte dei casi si tratta di lavoro che prevede la co-residenza con l’assistito e che
quindi implica una mole enorme di lavoro che può arrivare a occupare la lavoratrice anche per più di 20 ore
giornaliere (Ibid.).
Nel settore turistico alberghiero si concentrano lavoratori provenienti da diversi paesi, in particolare
si registra una forte presenza della comunità tamil, i cui membri sono impiegati come addetti nelle cucine dei
ristoranti della città di Lecce e della sua provincia con varie mansioni (lavapiatti, pizzaioli, aiuto cuoco e in
alcuni casi anche come cuochi).
Particolarmente significativi sono i dati relativi al lavoro autonomo. Negli ultimi anni il numero degli
imprenditori immigrati è stato in continuo aumento. Al tradizionale lavoro dell’ambulantato (una delle prime
occupazioni dei migranti giunti nel Salento sin degli anni ‘80) si sono aggiunte altre attività concentrate
nell’ambito del commercio. Secondo i dati Unioncamere 2012 diffusi dalla Camera di Commercio di Lecce,
sono 2.776 le imprese in provincia di Lecce il cui titolare è un cittadino straniero5, il 5,6% del totale delle
ditte individuali iscritte nel registro delle imprese. L’anno scorso erano 2.452, il 13% in meno.
L’imprenditoria immigrata a Lecce è, nonostante gli effetti della crisi economica, particolarmente attiva, nel
2012 il saldo delle imprese di proprietà straniera è stato positivo, 112 iscrizioni e solo 36 cancellazioni, con
un tasso di crescita pari a + 2,8%. Nello stesso periodo il tasso di crescita delle ditte individuali in generale è
stato solo dello 0,04%.
E’ il commercio al dettaglio il settore economico in cui si concentra la gran parte delle imprese
straniere, l’84% pari a 2.332 unità su un totale di 2.776, segue il comparto dell’edilizia con 98 imprese e i
servizi di alloggio e ristorazione con 74 aziende (delle quali 69 riconducibili alla sola ristorazione). Il settore
manifatturiero annovera 44 aziende (16 delle quali nel settore moda), mentre l’agricoltura ne conta 41.
Rispetto alla provenienza geografica, il Senegal, con 803 imprese, e il Marocco, con 742, sono i
gruppi che registrano il maggior numero di lavoratori autonomi (sono anche gli imprenditori inseritesi nel
tessuto economico salentino da più tempo), seguono gli imprenditori provenienti dai Paesi asiatici: Cina (240
imprese), India (164) e Pakistan (125) e i paesi al di là dell’Adriatico come l’Albania (105), la Serbia (68) e
5
In realtà, secondo i dati UNIONCAMERE, le ditte gestite da cittadini stranieri sarebbero 5.912, questa cifra però
comprende anche le 1.598 imprese gestite da cittadini nati in Svizzera, Germania, Belgio e Francia, imprese
riconducibili a imprenditori salentini figli degli emigranti pugliesi del secondo dopoguerra.
5AAVV, H.O.S.T. Hospitality Otherness Society Theatre. Materiali di ricerca, Astragali Edizioni – Eufonia
Multimediale, Lecce, (pp. 213-224) [ISBN 978-88-903985-5-1]
Montenegro (68). Gli incrementi più consistenti registratisi nel 2012 sono riconducibili, sia in termini
assoluti sia relativi, all’India, gli imprenditori indiani, infatti, sono passati da 95 unità del 2011 agli attuali
164, registrando un incremento del +72,6%.
Fonte: banca dati Stockview-Infocamere – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi UNIONCAMERE 2012.
La maggior parte delle imprese, il 46%, pari a 1.282, sono collocate sul territorio del comune
capoluogo e rappresentano oltre il 20% delle ditte individuali del comune di Lecce. Un’elevata incidenza
percentuale di imprenditori stranieri si registra anche nei comuni di Spongano (16,2%), Porto Cesareo
(14,9%) e San Cesario di Lecce (12,4%).
3. La condizione dei richiedenti asilo
La particolare configurazione geografica della provincia di Lecce - 218 km di costa e non più un’ora di
navigazione dalla prospiciente Albania, e la sua posizione - lungo la rotta mediterranea che collega l’Europa
ai Balcani e al Medioriente – hanno fatto di questo lembo di terra, per un certo periodo (fine anni ‘80 inizio
anni ’90), meta privilegiata per l’ingresso sul territorio italiano di uomini e donne in fuga da situazioni di
guerra e di crisi. Una volta approdati, molti di essi hanno stabilito la propria residenza in altre zone d’Italia o
hanno cercato di raggiungere (spesso in vano in virtù del principio di primo ingresso stabilito dal trattato di
Dublino) altri Stati europei. Non sono pochi però coloro che, ottenuto il riconoscimento dello status di
rifugiato o altra forma di protezione, hanno scelto la provincia di Lecce come luogo in cui costruire il proprio
futuro e quello delle proprie famiglie.
Nel Salento la principale comunità di rifugiati (o titolari di altre forme di protezione) sono i cittadini
tamil dello Sri Lanka, fuggiti dal genocidio attuato nei loro confronti dalla milizia governativa. Negli ultimi
anni si è stabilita anche una significativa comunità di giovani afghani. Sono presenti inoltre minori non
accompagnati provenienti dalla Colombia, Turchia, Somalia, Eritrea, Iran, Sudan, Nigeria e Ghana. La crisi
nei Paesi dell’Africa settentrionale ha poi, di recente, ridisegnato la composizione geografica dei richiedenti
6AAVV, H.O.S.T. Hospitality Otherness Society Theatre. Materiali di ricerca, Astragali Edizioni – Eufonia
Multimediale, Lecce, (pp. 213-224) [ISBN 978-88-903985-5-1]
asilo presenti sul territorio, si registra infatti un significativo incremento dei cittadini provenienti dalla
Nigeria, dal Ghana, dal Ciad, dal Mali, dal Togo e dalla Costa D’Avorio6.
Come messo in luce da diverse indagini (Scannavini K., 2012; Ciniero A., 2007a), sul territorio sono
diffuse forme di grave sfruttamento lavorativo dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione soprattutto nel
settore edile e in quello agricolo, dove la contrattualizzazione delle posizioni lavorative viene di sovente
trascurata o effettuata a condizioni differenti rispetto a quelle realmente praticate in termini di orario,
retribuzione e mansioni. Ciò è ancora più grave laddove la condizione giuridica dei richiedenti non sia
definita in termini di titolarità di permesso di soggiorno (irregolari o richiedenti diniegati in fase di ricorso)
ma non esclude altresì coloro i quali che, sebbene siano già titolari di una forma di protezione internazionale,
permangono in una condizione di subalternità e disagio in termini di integrazione socio-economica.
Altra criticità che il territorio provinciale condivide con il resto d’Italia riguarda la strutturale
mancanza di luoghi idonei a garantire la prima e la seconda. Il sistema italiano di accoglienza dei richiedenti
asilo, costituito dai Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA), i Centri di Accoglienza (CDA) e i
progetti territoriali all’interno del Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) è perennemente
stato di crisi. In tutto, il sistema è attrezzato per ospitare non più di 8.000 persone, vale a dire al massimo al
24% dei richiedenti del 20117 . Per far fronte a questa situazione nel 2011, a seguito dell’arrivo di circa 20
mila persone dal nord Africa, il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza, istituendo, da prima
territorio di Manduria8 una tendopoli denominata CAI (Centro di Accoglienza e Identificazione)9 nel quale
“accogliere” e “ospitare” i cittadini arrivati sulle coste italiane in attesa del rilascio di un eventuale titolo di
soggiorno; in seguito ha attivato e firmato protocolli di intesa con le regioni, le provincie autonome e gli enti
locali, in base ai quali le regioni hanno dato la disponibilità per accogliere fino a 50.000 persone secondo un
sistema di distribuzione basato su quote regionali, proporzionali alla popolazione residente10.
Bibliografia
Agamben G., 2003, Lo Stato di Eccezione, Bollati Boringhieri, Torino
Caritas/Migrantes, 2012, Immigrazione dossier statistico, Edizioni Idios, Roma.
Ciniero A., 2007 (a cura di), La discriminazione etnica nel lavoro pubblico e privato: monitoraggio del
fenomeno ed effettività delle tutele, OPI-Lecce - UNAR, Report di ricerca.
Ciniero A., 2007a, Settore lavoro in Perrone L. (a cura di), Indagine conoscitiva sul fenomeno migratorio,
accesso ai servizi e cittadinanza sociale nella Provincia di Brindisi, Osservatorio
6
Si tratta di soggetti presenti nei Paesi nord africani, la Libia in particolare, che a seguito dell’inizio dei bombardamenti
sul territorio libico hanno lasciato il paese cercando asilo in Europa.
7
I 9 CARA attualmente in funzione hanno una capienza massima di 2.000 unità. A volte i richiedenti sono ospitati
anche all’interno dei CDA, portando così la capacità della prima accoglienza a 5.000 unità. I richiedenti asilo che si
trovano in particolari condizioni, laddove per esempio siano già destinatari di un ordine di espulsione, possono essere
trattenuti all’interno dei CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione dove normalmente sono trattenuti i migranti primi
dei documenti di soggiorno). Lo SPRAR è una rete di comuni, provincie e organizzazioni no profit, coordinata dal
Servizio Centrale e gestita dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) messa su per accogliere e facilitare
lì inserimento sociale e urbano dei richiedenti asilo e delle loro famiglie. A livello nazionale sono attivi poco più di 150
progetti SPRAR che possono ospitare complessivamente circa 3000 persone.
8
Cittadina in provincia di Taranto.
9
La tendopoli sin dalla sua istituzione ha sollevato diversi dubbi di legittimità rispetto alla sua stessa esistenza, si tratta
infatti di un istituto non previsto dalla legislazione italiana, giustificato solo dalla dichiarazione dello stato di
emergenza, un non-luogo messo in piedi senza un riferimento normativo che ne definisca le finalità, né tanto meno la
sua gestione, un luogo in cui, per l’ennesima volta, si è riproposta la logica dello Stato di Eccezione, dei campi dove,
semplicemente, far aspettare l’umanità eccedente (Ciniero A., 2013).
10
Si tratta del piano di accoglienza denominato Emergenza Nord Africa.
7AAVV, H.O.S.T. Hospitality Otherness Society Theatre. Materiali di ricerca, Astragali Edizioni – Eufonia
Multimediale, Lecce, (pp. 213-224) [ISBN 978-88-903985-5-1]
Provinciale sull’Immigrazione, OPI-Brindisi, Univer-sità del Salento, Provincia di
Brindisi, Report di ricerca.
Ciniero A., 2013, Introduzione: Politiche migratorie europee e italiane tra approccio emergenziale e
contraddizioni in Ciniero A., Quarta E., Tritto M., (a cura di), Le pratiche locali
dell’accoglienza. Le politiche pubbliche locali e l'atteggiamento delle comunità locali
di fronte al fenomeno immigratorio in provincia di Brindisi: le possibili vie del
dialogo, Argo, Lecce (in corso di pubblicazione).
Perrone M., Lotteria K., 2007, Migranti e lavoro agricolo: la raccolta delle angurie nel Salento in Perrone
L., a cura di, Transiti e approdi. Studi e ricerche sull’universo migratorio nel Salento,
Franco Angeli, Milano.
Perrone L., 1996, a cura di, Naufragi albanesi. Studi, ricerche e riflessioni sull’Albania, Sensibili alle foglie
Tivoli.
Perrone L., 2007, Il Salento plurale e interculturale: immigrazione e mutamenti sociali in Perrone, a cura di,
Transiti e approdi. Studi e ricerche sull’universo migratorio nel Salento, Milano:
Franco Angeli.
Perrone L., 2010, a cura di, Condizioni, stili di vita e consumi culturali della comunità Rom residente nel
Campo sosta Panareo, Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione, OPI-Lecce,
Università del Salento, Provincia di Lecce, Report di Ricerca.
Perrotta M., Sacchetto D., 2012, Introduzione in AAVV Sulla pelle viva. Nardò: la lotta aut organizzata dei
braccianti immigrati, Derive e Approdi, Roma.
Scannavini K., 2012, Analisi dati quantitativi: Un universo per l’integrazione; Focus tematici: il lavoro
sommerso; Focus tematici: le reti informali in AAVV Le strade dell’integrazione.
Ricerca sperimentale quali-quantitativa sul livello di integrazione dei titolari di
protezione internazionale presenti in Italia da almeno tre anni in http://www.cir-
onlus.org/Ricerca%20Strade%20Integrazione%20definitivo%2019%20giugno.pdf.
8Puoi anche leggere