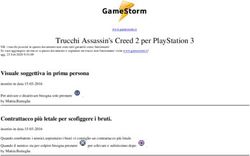Adolescenti e giovani nel mondo dell'immigrazione: alcune riflessioni
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Adolescenti e giovani nel mondo dell’immigrazione: alcune riflessioni
1) La complessità del fenomeno
Per affrontare il tema degli adolescenti e dei giovani nel mondo dell’immigrazione occorre chiarire
alcuni concetti basilari come, appunto, adolescente, identità, cultura; inoltre conviene anche
ricordare che se ogni storia di migrazione ha dei punti di contatto con le altre, ogni storia di
migrazione è una storia a sé. Bisogna anche sapere distinguere partendo dalle situazioni concrete:
esistono varie categorie di adolescenti e giovani immigrati o figli d’immigrati. Anche perché vi è
una differenza tra chi ha vissuto l’esperienza migratoria (e può essere definito immigrato) e chi no
(ed è figlio/a d’immigrati).
Le situazioni sono variegate; per esempio: 1) l’adolescente o il giovane immigrato cioè quello che
ha vissuto l’esperienza migratoria e che aveva già vissuto la propria infanzia nel paese di origine: la
partenza, lo sradicamento, il viaggio e le difficoltà dell’inserimento nel paese di accoglienza; 2)
l’adolescente o il giovane immigrato arrivato molto piccolo in Italia con i genitori e che
praticamente ha passato una parte consistente della propria infanzia qui; 3) quello che è nato in
Italia da genitori stranieri della stessa nazionalità; 4) quello che è nato in Italia da genitori stranieri
di diverse nazionalità; 5) quello che è nato in Italia da un padre straniero e una madre italiana; 6)
quello che è nato in Italia da un padre italiano e una madre straniera. A questo voglio aggiungere
altri elementi per la nostra riflessione e mostrare che, quando parliamo di immigrazione, abbiamo a
che fare con la complessità: il fatto di essere di sesso maschile o di sesso femminile cambia anche i
vissuti; se poi a questo si sommano i modelli di relazione familiare, uomo-donna, genitori e figli che
sono fortemente condizionati dai contesti storico-culturali di provenienza si comprende che
l’operatore sociale o pedagogico deve saper leggere la complessità di ogni storia concreta.
La storia di ogni migrante è una storia a sé che non può essere assimilata ad un’altra; ovviamente
questo discorso vale per i figli dei migranti. Nel caso dei bambini, degli adolescenti e dei giovani
c’è anche la storia migratoria della famiglia che determina spesso la loro traiettoria e il loro
sviluppo; la storia familiare prima, durante e dopo il viaggio, i mutamenti intervenuti con la
partenza, le motivazioni, le condizioni del viaggio e dell’arrivo. Sono tutti elementi che sono
importanti per la comprensione del loro vissuto e anche del modo come affrontano l’adattamento
alla situazione nuova. Per esempio è diverso se i genitori si spostano insieme e lo decidono insieme
da una situazione in cui decide solo il marito seguito, successivamente, dalla moglie che può vivere
tutto ciò con grande sofferenza. Altra cosa ancora se la storia parte da una donna che arriva sola in
Italia, incontra un suo connazionale e si sposa qui. Insomma per capire la condizione di sviluppo e il
vissuto dell’adolescente figlio o figlia d’immigrati occorre partire dalla complessità di ogni storia,
che al di là delle generalizzazione, rappresenta un percorso specifico. L’importante è che questo o
questa adolescente possa raccontare la propria storia, esprimere i propri vissuti e conferire senso a
tutto ciò. Anche la storia familiare precedente alla storia migratoria è importante; molti di questi
adolescenti hanno anche dei nonni nei propri paesi di origine e i nonni, soprattutto nelle situazioni
di lontananza, possono rappresentare un punto di riferimento importante. I nonni sono anche spesso
dei punti di riferimento nella costruzione dell’immagine di sé e nella strutturazione della sicurezza
interiore. I nonni svolgono anche spesso per gli adolescenti immigrati o figli di immigrati la
funzione di “oggetti transizionali” affettivi (per riprendere l’espressione di Winnicott) che facilita la
ricerca di un modello di sé accettabile.
Quindi non bisogna mai dimenticare il carattere complesso e molteplice dei processi psico-sociali e
storico-culturali nei quali sono inseriti gli adolescenti nel mondo dell’immigrazione. Complessità e
molteplicità che sono anche il prodotto di un modello del sé costruito attraverso un processo di
proiezione, identificazione ed interiorizzazione: proiezione delle proprie emozioni e dei vissuti su
alcune figure del sistema di relazione familiare e culturale di origine e non (abbiamo sopra fatto
accenno ai nonni ma si può anche pensare ad “oggetti relazionali” diversi come alcuni tratti della
1cultura di origine; vedi per esempio l’islam per molti giovani maghrebini in Europa);
identificazione con alcuni modelli rappresentati da figure o comportamenti e interiorizzazione di
questi modelli – spesso contraddittori o conflittuali come lo vedremo – per conferire senso al
proprio mondo interiore e al proprio esistere. Tutti questi ragionamenti ci portano tuttavia a fare uno
sforzo di chiarificazione di alcuni concetti chiave come identità, cultura, adolescenza, métissage per
capire meglio quello che succede a molti giovani nel mondo dell’immigrazione.
2) Alcuni concetti
Prima di proseguire conviene tuttavia chiarire alcuni concetti che vengono utilizzati regolarmente
quando si parla d’immigrazione; concetti che possono sembrare ovvi; ma non dimentichiamo mai
che i concetti sono le categorie che organizzano il nostro spazio mentale
e ci orientano nel monde delle relazioni. Ci facciamo una immagine di noi stessi e degli altri
attraverso la mediazione di concetti; i concetti sono la nostra rappresentazione del mondo, per dirla
con Kant la nostra comprensione dell’universo; sono le nostre categorie interpretative. Inoltre i
concetti svolgono sempre una funzione sociale a secondo il contesto e il loro utilizzo.
L’emigrato-immigrato: la traiettoria
Dall’inizio abbiamo parlato di immigrazione e di adolescenti; partendo da una considerazione fatta
da Abdelmalek Sayad nel suo libro “La doppia assenza: dall’illusione dell’emigrazione alla
sofferenza dell’immigrazione”; si può affermare che l’immigrato prima di essere un immigrato è un
emigrato cioè una persona che viveva in un altro paese, con una sua storia familiare, affettiva
sociale e culturale e che ad un cero punto decide di andarsene. In questa traiettoria è tutto il sistema
relazionale di riferimento del migrante che viene coinvolto: la famiglia, che in molti casi significa
una rete allargata, la coppia, i figli. Le conseguenze della partenza rappresentano un cambiamento
non solo per chi va via ma anche per chi resta; le aspettative e le speranze riguardano gli uni e gli
altri. Questi mutamenti producono anche una rappresentazione della propria terra di origine
attraverso la famiglia che può funzionare come meccanismo di difesa di fronte alle difficoltà e alle
disillusioni ma anche come ostacolo al cambiamento e alla ridefinizione di sé in un processo
complesso. L’adolescente vive questa situazione in termini ancora più drammatici e intensi visto il
periodo di transizione che vive comunque; il fatto di dover fare i conti con il punto di partenza, la
terra di origine, gli affetti familiari, il mondo degli amici, i sistemi di valori, le concezioni diverse
del mondo ecc; tutto ciò lo mette spesso in una situazione di sofferenza. Vogliamo anche
sottolineare il fatto che è necessario andare al di là dei luoghi comuni sul giovane immigrato diviso
tra due mondi; anche qui le cose sono talvolta molto più complicate. Il giovane immigrato o figlio
di migranti deve fare i conti con la propria famiglia di origine, il suo gruppo sociale, il suo gruppo
culturale, con il fatto che è marocchino ma di origine berbera, che parla l’arabo ma anche il
amazigh (che è la sua lingua materna), che magari ha fatto poi la scuola in francese, e che si ritrova
a vivere in Italia. La traiettoria non è poi solo spaziale ma soprattutto mentale e psico-sociale; il
trovarsi a sperimentare situazioni diverse, ad assimilare anche codici e linguaggi diversi senza
“perdersi” rappresenta una sfida continua per il giovane immigrato e /o figlio/a di migranti. Tutto
ciò non significa che le “radici” non esistono ma che si fa fatica a riconoscerle e a “connettersi a sé”
nella variegata esperienza della vita. La traiettoria vuol dire anche ritrovare le tracce di un percorso
che è il frutto di scelte e produttore di senso. Ecco questo giovane deve mediare dentro e fuori di sé
con una molteplicità di mondi che lo compongono e che l’interpellano continuamente nella
quotidianità: la famiglia, la scuola, il lavoro, il condominio e i rapporti con i vicini, il gruppo dei
pari, la vita sociale e culturale. Deve riuscire a non perdersi, a non estraniarsi da se stesso nel
passaggio da un contesto e da una situazione all’altra. In più deve fare i conti con lo sguardo della
2società sulla sua famiglia; l’essere marocchino o albanese non è un valore sociale positivo come
non lo era essere italiano in Belgio nel secondo dopo guerra. L’adolescente e il giovane si trova a
dovere confrontarsi con l’etichettamento sociale mediato dalla sua appartenenza ad un gruppo
culturale e familiare; altra traiettoria quella del conflitto e della tensione con i genitori che rischia di
diventare frattura e dove può scattare nel rapporto con loro la logica individuata da René Girard
della “vendetta mimetica”. I genitori vengono visti come responsabili di tutte le sofferenze e
colpevoli per la scelta fatta; poi c’è tutta la complessità dei rapporti con la figura paterna e quella
materna.
Il rischio del discorso sull’identità: le identità meticce
È Georges Devereux, il fondatore dell’etnopsichiatria moderna, che parlava del rischio dell’identità;
lui ne parlava come conoscitore di se stesso; nato in una famiglia magiara di origine ebraica,
secolarizzato prima in magiaro e successivamente in rumeno (perché la sua città natale passò nel
1918 alla Romania); si trasferisce a Parigi, va vivere e lavorare negli Stati Uniti, viaggia tra le
popolazioni del Sud Vietnam e gli indiani delle riserve dell’Arizona. Scriveva in due lingue diverse
dalla sua lingua materna cioè l’inglese e il francese. Ma cosa intendeva Devereux per rischio
dell’identità? Intendeva una concezione unidimensionale dell’identità cioè la tendenza ad
identificare se stesso o l’altro con una dimensione sola del suo essere storico e socio-culturale; è
quello che chiamava il “superinvestimento dell’identità etnico-culturale”. Questa tendenza a ridurre
l’identità con un aspetto solo; l’essere musulmano, l’essere sikh, l’essere nero, l’essere ebreo ecc…
è riduttiva della molteplicità che compone la storia della persona. Il rischio per Devereux è anche
quello di utilizzare dei concetti culturali per spiegare la storia e la traiettoria di una persona; e per
spiegarsi meglio usava la metafora dello spazio: nella relazione per me l’altro è fuori e io sono
dentro mentre per lui io sono fuori e lui è dentro; pensava anche che ognuno di noi è affetto di
“strabismo culturale” cioè si costruisce una immagine deformante di se stesso; questo perché non si
riesce a riconoscere se stesso in tutta la complessità e molteplicità di esperienze concrete e vissute.
Lo dice anche per l’adolescente di cui l’adulto in tutte le società e in tutte le culture si fa una certa
immagine; ed è questa immagine interiorizzata che determina il comportamento stesso e il modo di
essere dell’adolescente. Le cose si complicano nei processi di acculturazione nella misura in cui la
persona investita dal contatto con una altra cultura e un altro modo di vivere ne viene contaminata
(sarebbe meglio dire fecondata-espressione di Raimon Panikkar), a quel punto le vecchie mappe
mentali devono fare i conti con quelle nuove; per potersi orientare e ridefinire nel nuovo contesto il
migrante deve usare delle nuove mappe che non liquidano quelle vecchie ma che le aggiornano per
poter vivere ed adattarsi nelle nuova realtà. E proprio nelle situazioni di “dissonanza semantica e
cognitiva” che avviene la difficoltà della comprensione e quindi di costruire nuove relazioni senza
perdere se stesso (come dice Devereux rimanendo “connesso a sé”). L’adolescente immigrato o
figlio/a d’immigrati vive spesso una condizione di quel tipo.
Quel che importa forse non è tanto l’identità quanto la capacità di conferire senso e significato a se
stesso, alla propria traiettoria, alla propria esistenza e di poter raccontarsi e narrare a sé e agli altri la
propria storia.
I rischi di una identificazione unidimensionale non riguarda solo il giovane immigrato o figlio di
immigrati ma anche chi lo guarda anche con la pretesa di aiutarlo (operatore sociale, insegnante,
educatore, terapeuta ecc…); la lettura culturalista rischia di assolutizzare un aspetto solo della
personalità e anche di farlo in modo deformante. Il cosiddetto rispetto della diversità culturale è
spesso un alibi per non comprendere la storia concreta del singolo soggetto con la sua narrazione, il
suo vissuto e la sua capacità di raccontarsi quindi di fornire senso alla sua storia. La
categorizzazione culturale non permette di riconoscere le vere differenze che sono quelle
dell’esperienza di vita dell’adolescente in carne ed ossa.
3Invece di identità Devereux preferiva parlare di “modello di sé” che vedeva come una
configurazione psicologica, base di una personalità integrata a tre livelli: 1) il comprendere: il
comprendere il mondo vitale e sociale dove si è inserito; 2) il comprendersi: il comprendere se
stesso in relazione con il mondo e gli altri; 3) l’essere compreso: l’essere compreso nella propria
specifica storia. Tutto questo funziona come un processo dinamico e aperto; è quando avviene un
cortocircuito in questo processo che si crea un blocco e una sofferenza. È proprio nella sofferenza
psichica che emerge, secondo Devereux, la similitudine tra tutti gli esseri umani; i meccanismi
psichici del profondo sono identici per tutti a prescindere dall’appartenenza etnico-culturale; per
questa ragione si può parlare di “unità psichica del genere umano”.
È anche quello che affermava Lev Vygotsky quando parlava dell’identità storico-culturale: per lo
psicologo sovietico la cultura è il sociale cioè è l’insieme delle relazioni sociali e delle mediazioni
che permette agli uomini di vivere insieme e di riconoscersi; in questo sistema di mediazioni il
linguaggio ha una importanza decisiva in quanto non si tratta solo di uno strumento funzionale alla
comunicazione ma anche in quanto veicola dei codici e un modo di vedere le cose. La
comunicazione sociale precede la comunicazione interiore (l’interpsichico precede l’intrapsichico) e
fornisce gli strumenti per organizzare le proprie emozioni e dare un senso ai propri sentimenti. Qual
è il linguaggio sociale dell’adolescente o del giovane immigrato? Visto così ci si rende conto che il
problema è molto complesso e che ogni intervento educativo e sociale ne deve tener conto.
L’adolescenza e le adolescenze: il caso concreto di Kuribga (Marocco)
Anche qui ci sarebbe molto da dire; ricordiamo il titolo di un vecchio testo dello psicologo di
origine belga Gérard Lutte “Sopprimere l’adolescenza?”; era una domanda provocatoria che
nascondeva tuttavia un invito a riflettere sul concetto di adolescenza e sul suo significato sociale e
culturale. In effetti sappiamo ormai che il concetto di adolescenza non ha lo stesso significato in
tutti i contesti storico-culturali ma sappiamo anche che non ha avuto sempre lo stesso significato in
Europa. È con la rivoluzione industriale e Jean-Jacques Rousseau che l’adolescenza acquisisce un
senso e uno statuto diverso; il cittadino di Ginevra parla addirittura di “seconda nascita”. Non
dimentichiamo che l’adolescente e giovane dell’immigrazione si trova a fare i conti con una
percezione diversa dei genitori e del loro ruolo di genitori nel contesto nuovo; questo è importante
per i processi di identificazione. Cambiano l’immagine sia della figura paterna che della figura
materna; spesso i genitori vengono vissuti come inferiori socialmente e questo può produrre dei
conflitti sia interiori che interpersonali nel nucleo familiare. Per di più l’adolescente nato e cresciuto
in Italia usa un codice linguistico diverso da quello dei genitori, non sono rare le situazioni in cui il
figlio risponde in italiano al padre o alla madre che li parlano in arabo o in wolof. Qui i processi
sono complicati; se è vero quello che afferma Françoise Dolto quando parla di metafora del
gambero cioè di un adolescente che perde la vecchia pelle per produrne una nuova; nel caso
dell’adolescente dell’immigrazione le cose si complicano perché la pelle nuova è fatto di codici del
tutto nuovo non sempre compatibile con quelli del gruppo di origine. Ma occorre tener conto anche
di un altro aspetto importante; molti adolescenti e giovani immigrati o figli di migranti provengono
da paesi che conoscono cambiamenti profondi e che, come le nostre società, sono colpiti dai
cosiddetti processi di globalizzazione. Significa dei mutamenti anche nel contesto di partenza che
producono spesso situazioni di destrutturazione per i giovani e gli adolescenti, questo prima di
vivere l’avventura migratoria. I fattori socio-culturali dei paesi di origine che vivono le mutazioni
delle strutture tradizionali e degli stili di vita è interiorizzato dagli adolescenti quando arrivano in
Italia.
Prendiamo il caso concreto degli adolescenti marocchini di Bologna che provengono in gran parte
da Kuribga (una città a circa 200 km ad est di Casablanca); durante un viaggio di studio e di ricerca
sul campo per comprendere le cause e le motivazioni della migrazione da quella zona del Marocco
verso l’Italia ci siamo trovati di fronte ad una situazione inaspettata. In quanto ricercatore ci
4aspettavamo trovare una condizione drammatica sul piano economico e una zone depresse; invece
dal primo impatto con la città (circa 70.000 abitanti) abbiamo capito che le cose erano diverse dal
nostro immaginario sociale di partenza. La città è ordinata e respira anche un certo benessere; ci
sono non lontano le mine di fosfato (il Marocco è il 3° produttore mondiale) e si vedono in giro
tante macchine targate dall’Italia. È evidente che vi è una certa ricchezza dovuta alle miniere e alle
rimesse degli emigranti ma vi è anche una crisi occupazionale per i giovani e una assenza di
prospettiva (ma è qualcosa che incontriamo anche in Italia, in particolare in certe zone del
Mezzogiorno). Allora come spiegare la “fuga” dei giovani di Kuribga verso l’Italia (parlando al Bar
un ragazzo di 16 anni mi dice che il futuro è l’Italia)? Problemi complessi legati alla
globalizzazione e non riducibili alla povertà economica o ai fenomeni connessi alla religione.
Alain Goussot
5Puoi anche leggere