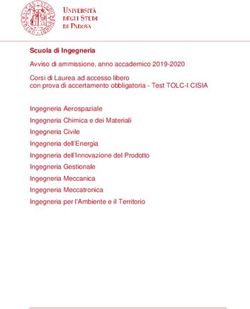SCENARI DI MAFIA Orizzonte criminologico e innovazioni normative - GIOVANNI FIANDACA e COSTANTINO VISCONTI
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
SCENARI DI MAFIA
Orizzonte criminologico e innovazioni normative
a cura di
GIOVANNI FIANDACA e COSTANTINO VISCONTI
G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO© Copyright 2010 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
http://www.giappichelli.it
ISBN/EAN 978-88-348-9788-1
Stampa: Officine Grafiche Riunite - Palermo
Chiuso in tipografia il 30 luglio 2010
Fotocopie per uso personale possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di pe-
riodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941,
n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI,
CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.
Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non supe-
riore al 15% del presente volume,solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Er-
be, n. 2, 20121 Milano, telefax 02-80.95.06, e-mail:aidro@iol.it
Pubblicato con il contributo dell’Università di Palermo (Fondi ex 60%)
I curatori ringraziano le dott.sse Silvia Lo Forte e Maria Giovanna Militello per aver curato le bozze del volume.
Foto di copertina: “Bewage and wine” di Matilde IncorporaINDICE
GIOVANNI FIANDACA e COSTANTINO VISCONTI, Nota introduttiva 9
PARTE I
PROFILI CRIMINOLOGICI, POLITICO-CRIMINALI E COMPARATISTICI
STEFANO BECUCCI, La criminalità organizzata di origine straniera in Italia. Una propo-
sta di analisi secondo la prospettiva transnazionalista 15
ERNESTO U. SAVONA, Le organizzazioni criminali in Europa viste dall’esperienza italiana 29
GIOVANNI MELILLO, Le mafie dell’area balcanica: profili criminologici e prassi giurispru-
denziali 38
SILVIO CIAPPI, Colombia: un laboratorio della post-modernità criminale 57
CARLA MONTELEONE, La criminalità organizzata come problema di sicurezza interna-
zionale nella nuova agenda transatlantica 72
SERGIO BONINI, Uno sguardo comparativo sulle sanzioni contro la criminalità organizza-
ta in alcuni sistemi-modello 91
PARTE II
CONCORSO ESTERNO NEL REATO ASSOCIATIVO: UN DIBATTITO CHE CONTINUA
GAETANO INSOLERA, Qualche risposta alle domande poste dal concorso esterno nell’associa-
zione mafiosa 123
GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, Concorso di persone, reati associativi, concorso nell’as-
sociazione: profili sistematici e linee di politica legislativa 128
ANTONIO CAVALIERE, I reati associativi tra teoria, prassi e prospettive di riforma 146
VINCENZO MAIELLO, Concorso di persone in associazione mafiosa: la parola passi alla legge 160
FRANCESCO VIGANÒ, Oltre l’art. 416-bis: qualche riflessione sull’associazione con finalità
di terrorismo 174
COSTANTINO VISCONTI, Sui modelli di incriminazione della contiguità alle organizzazio-
ni criminali nel panorama europeo: appunti per un’auspicabile (ma improbabile?) riforma
“possibile” 189
GIOVANNI FIANDACA, Il concorso “esterno” tra sociologia e diritto penale 203
PARTE III
INFILTRAZIONI MAFIOSE NELL’ECONOMIA E PREVENZIONE PATRIMONIALE
ANDREA DI NICOLA, La regolazione dei mercati e la riduzione della loro vulnerabilità al-
le infiltrazioni criminali: il crime proofing della legislazione 215
CARLO LONGOBARDO, Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di
esigenze preventive ed ineffettività della repressione penale 2284 Indice
ANGELO MANGIONE, Il volto attuale delle misure di prevenzione dopo i “pacchetti sicu-
rezza” 258
ANNAMARIA MAUGERI, Dall’ actio in rem alla responsabilità da reato delle persone giuri-
diche: un’unica strategia politico-criminale contro l’infiltrazione criminale nell’economia? 268
GIUSEPPE PIGNATONE, Le recenti modifiche alle misure di prevenzione patrimoniali e il
loro impatto applicativo 311
ANTONIO GIALANELLA, Un problematico punto di vista sui presupposti applicativi del se-
questro e della confisca di prevenzione dopo le ultime riforme legislative e alla luce della re-
cente giurisprudenza di legittimità 344
ANDREA AIELLO, I “terzi” nelle misure di prevenzione patrimoniali: una storia( in)finita? 392
FRANCESCO CASSANO, La tutela dei diritti nel sistema della prevenzione antimafia 414
NICOLA GULLO, La destinazione dei beni confiscati alla luce delle recenti riforme 455
ANTONIO MARUCCIA, Dal commissario straordinario del governo all’Agenzia per i beni se-
questrati e confiscati: realtà, azioni, prospettive 473
PARTE IV
ASPETTI PROCESSUALI E PROBLEMI PROBATORI
PAOLA MAGGIO, Prova e valutazione giudiziale dei comportamenti mafiosi: i risvolti proces-
suali 491
RAFFAELLO MAGI, Chiamata in correità e metodo di individuazione del riscontro nei pro-
cessi di criminalità organizzata 520
PIERGIORGIO MOROSINI, Prova e ideologia del giudice nei processi di criminalità organiz-
zata 533
PAOLA PIRACCINI, Gli standard probatori per l’applicazione del sequestro e della confisca
tra modelli di prevenzione e di repressione 556ELENCO DEGLI AUTORI ANDREA AIELLO - avvocato del Foro di Palermo STEFANO BECUCCI - docente di sociologia nell’Università di Firenze SERGIO BONINI - docente di diritto penale nell’Università di Trento FRANCO CASSANO - magistrato, componente del Consiglio superiore della magistratura ANTONIO CAVALIERE - docente di diritto penale nell’Università di Napoli Federico II SILVIO CIAPPI - docente di criminologia nell’Università di Verona GIOVANNANGELO DE FRANCESCO - docente di diritto penale nell’Università di Pisa ANDREA DI NICOLA - docente di sociologia della devianza nell’Università di Trento GIOVANNI FIANDACA - docente di diritto penale nell’Università di Palermo ANTONIO GIALANELLA - magistrato, Procura generale presso la Corte di cassazione NICOLA GULLO - docente di diritto amministrativo nell’Università di Palermo GAETANO INSOLERA - docente di diritto penale nell’Università di Bologna CARLO LONGOBARDO - docente di diritto penale nell’Università di Napoli Federico II PAOLA MAGGIO - docente di diritto processuale penale nell’Università di Palermo RAFFAELLO MAGI - magistrato, Tribunale di S.M. Capua Vetere VINCENZO MAIELLO - docente di diritto penale nell’Università di Napoli Federico II ANGELO MANGIONE - docente di diritto penale nell’Università Lumsa di Palermo ANTONIO MARUCCIA - magistrato, Procura generale presso la Corte di Appello di Roma ANNAMARIA MAUGERI - docente di diritto penale nell’Università di Catania GIOVANNI MELILLO - magistrato, Procuratore agg. della Procura della Repubblica di Napoli CARLA MONTELEONE - docente di scienze politiche nell’Università di Palermo PIERGIORGIO MOROSINI - magistrato, Tribunale di Palermo GIUSEPPE PIGNATONE - magistrato, Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria PAOLA PIRACCINI - magistrato, Corte di Cassazione ERNESTO UGO SAVONA - docente di sociologia della devianza nell’Università Cattolica di Milano FRANCESCO VIGANÒ - docente di diritto penale nell’Università di Milano COSTANTINO VISCONTI - docente di diritto penale nell’Università di Palermo
SCENARI DI MAFIA Orizzonte criminologico e innovazioni normative
Nota introduttiva
Giovanni Fiandaca e Costantino Visconti
I. I contributi qui raccolti – occasionati da più iniziative di studio promosse dal Di-
partimento DEMS dell’Università di Palermo1 – perseguono un comune obbiettivo: rivi-
sitare temi e nodi problematici relativi alla criminalità mafiosa, il cui rilievo perdura da
qualche tempo o è divenuto più avvertibile in tempi più recenti. Si tratta di temi e pro-
blemi che esibiscono quasi sempre (perlomeno) una doppia dimensione, cioè al tempo
stesso socio-criminologica e giuridica; senza contare gli ulteriori e complessi intrecci a ca-
rattere economico-patrimoniale connessi al perverso fenomeno delle infiltrazioni mafio-
se nel mondo dell’economia.
Anche per un’esigenza di ordine espositivo, i contributi dei diversi autori sono rag-
gruppati in quattro aree tematiche rispettivamente rispecchianti ambiti problematici che
– peraltro non soltanto a nostro avviso – richiedono approfondimenti in termini di ana-
lisi teorica, elaborazione politico-criminale e affinamento delle prassi applicative.
Più in particolare, la prima sezione del volume delinea un quadro ricognitivo delle
organizzazioni criminali di tipo mafioso presenti oggi sia in Italia sia nello scenario inter-
nazionale, con un approccio prevalente di tipo criminologico e, nella misura in cui il cri-
mine mafioso solleva problemi di sicurezza globale, anche di tipo politologico.
Considerato lo stretto intreccio tra la dimensione criminologica, le strategie politi-
co-criminali di intervento e le risposte ordinamentali a carattere repressivo/preventivo,
in questa prima parte sono anche inseriti approcci di tipo comparatistico volti a mette-
re a confronto i diversi modelli di risposta sanzionatoria sino a oggi approntati da paese
a paese.
Tanto l’analisi criminologica quanto l’indagine comparatistica confermano invero
l’esigenza di evitare una fallacia di generalizzazione sempre più alimentata da una sempli-
ficazione mediatica incline a rappresentare il fenomeno mafioso come una realtà unitaria
e indistinta, che dalla Sicilia e dal meridione d’Italia si estenderebbe uguale a se stessa in
altre parti del pianeta. In realtà lo scenario è molto più complesso, frammentato e varie-
gato: e la vera difficoltà oggi consiste nel tendere a forme di armonizzazione e omogeneiz-
zazione nelle risposte ordinamentali, senza però perdere di vista alcune persistenti speci-
ficità che, ad esempio, le mafie italiane classiche continuano a mantenere rispetto ad altre
forme di crimine organizzato meno profondamente radicate nei contesti socio-culturali e
politici di riferimento.
1 Per citare solo alcune tra le iniziative promosse negli ultimi anni, si segnalano il convegno dal titolo
Le mafie oggi in Europa: politiche penali ed extrapenali a confronto, tenutosi a Palermo il 29 e 30 novembre
2007, organizzato in collaborazione con le Università di Trento, Napoli Federico II, Milano Cattolica (Tran-
scrime), e la Commissione parlamentare antimafia; il seminario interdisciplinare su Le infiltrazioni mafiose
nell’economia: analisi e prospettive di intervento, tenutosi a Palermo il 28 e 29 novembre 2008, organizzato in
collaborazione con l’Università Cattolica di Milano (Transcrime); e l’incontro di studi dal titolo Confisca, ge-
stione e destinazione dei patrimoni mafiosi, tenutosi a Palermo il 5 giugno 2010, organizzato in collaborazione
con gli Ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti di Palermo e con le Fondazioni Pro-
getto legalità e F. Bianchini di Palermo.10 Nota introduttiva
II. Emblematica, da questo punto di vista, la problematica del c.d. concorso esterno
nel reato associativo, la cui virulenza e persistente attualità certo si spiegano soprattutto
con alcune note peculiarità del contesto italiano: connesse – prima ancora che alla con-
tingente conflittualità tra politica e magistratura – al fatto ormai assodato, sul versante
storico e sociologico, che la mafia di Cosa nostra e le altre mafie italiane devono non po-
co della loro specificità ai collegamenti di tipo sistemico che esse sono solite intrattenere
con le classi dirigenti. Anche a prescindere dall’andamento ciclico delle polemiche politi-
co-giornalistiche, il dilemma che continua a contrapporre i tecnici del diritto è a tutt’og-
gi così riassumibile: in vista di una soddisfacente precisazione dei presupposti della conti-
guità punibile, è più opportuno confidare in un progressivo affinamento dell’istituto del
concorso esterno ad opera della giurisprudenza e della dottrina? Oppure è preferibile che
del problema si responsabilizzi una buona volta il legislatore mediante l’introduzione di
una o più fattispecie ad hoc? I contributi sul tema contenuti nella seconda parte del volu-
me rivisitano criticamente sin dalle fondamenta le categorie dogmatiche finora utilizzate
in sede di gestione giurisprudenziale e dottrinale dell’istituto in questione, ponendo in
particolare in evidenza come continui a risultare problematico l’impiego della causalità.
Pur convergendo nella presa d’atto di tale difficoltà, mentre taluno propone la sostituzio-
ne del paradigma causale con un criterio funzionalistico di matrice sociologica, altri sug-
geriscono di abbandonare l’approccio basato su categorie o clausole generali per approda-
re a possibili modelli di disciplina di parte speciale. La complessità del tema e il plurali-
smo dei punti di vista rappresentati nei diversi saggi forniscono la riprova che la proble-
matica del concorso esterno esemplifica bene, oggi, una delle sfide più difficili e più av-
vincenti per la scienza della legislazione contemporanea.
III. La terza parte del volume presenta aspetti di particolare interesse e attualità, non
ultimo perché il settore della prevenzione patrimoniale è stato di recente quello più in-
vestito da innovazioni legislative introdotte dai cc.dd. Pacchetti sicurezza del 2008 e del
2009. Com’è noto, è stata inserita una novità molto significativa e potenzialmente di-
rompente, in termini sia di principio che di effetti applicativi: recependo sollecitazioni
di precedenti Commissioni ministeriali di studio e della stessa Commissione parlamen-
tare antimafia, è stato infatti affermato il principio della applicabilità autonoma e di-
sgiunta delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. È anche vero tuttavia che
l’espressa introduzione normativa del principio predetto non è stata accompagnata da
una contemporanea revisione in dettaglio della disciplina pregressa, in modo da rendere
chiari e definiti i presupposti che consentono l’applicabilità del sequestro e della confi-
sca a prescindere delle misure personali. Da qui l’emergere di un problema interpretati-
vo-ricostruttivo inevitabilmente gravante adesso sugli operatori e sugli studiosi: al cen-
tro del problema si pone in particolare il quesito se e in che misura al requisito della pe-
ricolosità sociale del prevenuto spetti ancora un ruolo tra i presupposti per l’applicabili-
tà delle stesse misure patrimoniali del sequestro e della confisca. Come dimostrano i sag-
gi contenuti nella corrispondente parte di questo volume, le risposte ermeneutico-rico-
struttive possono in proposito divergere a seconda che l’interprete privilegi una interpre-
tazione conservativa di tipo genealogico, ovvero sia culturalmente più disposto a valoriz-
zare al massimo la prospettiva innovativa di una prevenzione patrimoniale agganciata al-
l’idea di una pericolosità in rem.
Sempre in questa parte non mancano saggi che fanno il punto sull’elaborazione giu-
risprudenziale di un istituto dal volto polivalente e dalla disciplina in costante evoluzione
come la confisca, anche per input sovranazionali e per influenza della giurisprudenza del-
la Corte di Strasburgo.Nota introduttiva 11
Ancora, tra le questioni rimaste aperte e di grosso impatto sociale, merita di essere
menzionata quella della tutela dei terzi che vantano diritti sui beni confiscati. Se è vero
che la questione è riuscita molto di recente ad attingere la soglia dell’attenzione legislati-
va, non è meno vero che tale attenzione ha finito col produrre meno di un topolino. Co-
me emerge dai contributi specificamente dedicati al tema, l’embrione di disciplina abboz-
zato dal legislatore in proposito è ben lungi dal poter soddisfare le aspettative degli opera-
tori giuridici e dei cittadini.
Non ultima per importanza, tra le novità di maggiore rilievo vi è inoltre l’istituzio-
ne dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e con-
fiscati. Questo nuovo organismo, che ha avuto una genesi politica lunga e non incontra-
stata ma che alla fine ha visto la luce con l’approvazione di tutte le forze politiche, perse-
gue l’obbiettivo di razionalizzare e migliorare le procedure di assegnazione e destinazione
dei beni confiscati in vista di un loro impiego per fini pubblici o sociali. Il nuovo impian-
to di disciplina che affida all’Agenzia anche la funzione di amministrare i beni confiscati
sin dal primo grado di giudizio, pone inediti problemi di interazione e coordinamento tra
la funzione giurisdizionale e la funzione amministrativa. Soltanto la prassi futura – al di
là delle buone intenzioni del legislatore – potrà confermare o smentire la bontà della scel-
ta compiuta.
IV. L’ultima parte di questo volume contiene saggi incentrati sui problemi dell’ac-
certamento probatorio in sede processuale, con riferimento sia al processo penale sia al
processo di prevenzione. In proposito è di non secondario interesse l’esame critico delle
prassi giurisprudenziali, anche allo scopo di verificare se e fino a che punto nella realtà ap-
plicativa concreta continui oggi a trovare riscontro quella “teorica” differenziazione di stan-
dard probatori in astratto consentita dalle logiche normative che rispettivamente presie-
dono al processo penale e al procedimento di prevenzione. I contributi in questione, sem-
brano altresì confermare che il terreno della criminalità organizzata rappresenta un setto-
re emblematicamente sintomatico della esigenza, sempre più avvertita nel corso degli ul-
timi anni, di tener conto della stretta interazione tra connotati criminologici dei fenome-
ni penalmente rilevanti, categorie di diritto sostanziale e tecniche di accertamento proba-
torio.
È auspicabile che l’insieme dei saggi ripartiti nelle quattro sezioni contribuiscano in
qualche misura a una rivisitazione dei temi presi in considerazione che, oltre a soddisfare
esigenze di messa a punto teorica, risulti utile anche ai fini di un ulteriore affinamento del-
le strategie e delle prassi di contrasto alla criminalità mafiosa.Puoi anche leggere