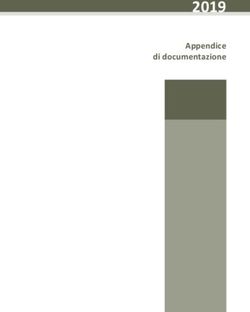L'INCLUSIONE UNA LETTURA ATTRAVERSO I DISABILITY STUDIES ITALY
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
L’INCLUSIONE
UNA LETTURA ATTRAVERSO I DISABILITY STUDIES ITALY
Roberto Medeghini
Il termine inclusione lo si ritrova nei convegni, nelle circolari ministeriali, nei progetti finalizzati
all’integrazione delle persone con disabilità all’interno del sociale e delle istituzioni educative:
sembra quindi che ci sia uno sfondo comune che ne accompagna l’utilizzo. Una riflessione più
attenta porta però a sottolineare come l’impiego dello stesso termine non corrisponda ad una
identità teorica e di prospettiva: infatti c’è chi la assimila all’integrazione, chi la definisce un
ampliamento delle possibilità integrative, chi la riduce ad un’esigenza lessicale per avvicinarsi al
linguaggio internazionale.
Allora, cos’è l’inclusione e quale paradigma assume soprattutto in riferimento alla disabilità?
Seguendo la prospettiva dei Disability Studies 1 e gli studi italiani di questi ultimi anni
(Medeghini, 2005; 2006 b; 2013; Medeghini e Valtellina 2006 a; D’Alessio, 2007; 2013; Marra,
2009; Vadalà, 2009; 2013) si potrebbe iniziare con questa breve sintesi introduttiva che delinea le
caratteristiche rilevanti dell’ Inclusione che qui viene proposta. L’inclusione,
1. si rivolge a tutte le differenze senza che queste siano definite da categorie e da criteri
deficitari, ma pensate come modi personali di porsi nelle diverse relazioni e interazioni
(sociali, scolastiche, educative, istituzionali, lavorative);
2. si riferisce a tutte le persone e non a gruppi particolari come nel caso dell’integrazione;
3. tende a superare ogni forma di discriminazione e di esclusione sociale, istituzionale ed
educativa;
4. richiede un cambiamento del sistema culturale e sociale esistente per permettere la
partecipazione attiva e piena di tutti;
5. contrasta i processi di omogeneizzazione, creando le condizioni per la libera scelta ed
espressione di tutti;
6. costruisce contesti inclusivi in grado di rispondere alle differenze di tutti, eliminando le
barriere sociali, culturali, economiche e istituzionali disabilitanti;
7. richiede inoltre di superare l’egemonia di un linguaggio «abilista» e «normativo», restituendo
la voce al pensiero delle persone con disabilità e alla loro azione;
8. colloca la sua riflessione e il suo processo all’interno dei giochi di potere e della
governamentalità (M. Foucault, 1999), togliendo i sistemi delle relazione dal rischio della
neutralità e della genericità;
9. richiede di esplicitare i riferimenti teorici delle enunciazioni dei Diritti per le Persone con
Disabilità per evitare ambiguità interpretative.
Da queste premesse consegue che l’Inclusione non assume il deficit come fattore interno alla
persona e come causa del non funzionamento, ma lo colloca all’interno dei processi disabilitanti
1
I Disability Studies si sono sviluppati negli ultimi trent’anni in ambito prevalentemente angloamericano e nord
europeo. I DS pur all’interno di un’ampia differenziazione condividono però una trama comune che comprende il rifiuto
del modello medico-individuale come fondamento delle concettualizzazione relative al deficit e alla disabilità, una
finalità di emancipazione e autoaffermazione sociali per le persone con disabilità, un approccio critico in relazione al
linguaggio e alle pratiche sociali ed educative dell’esclusione. La prospettiva dei D.S. è proposta dal Gruppo di Ricerca
Inclusione e Disability Italy (Grids Italy).prodotti da contesti, saperi disciplinari, organizzazioni e politiche incapaci a fornire una risposta
adeguata alle differenze delle persone.
Come si può osservare, l’Inclusione problematizza gli aspetti della vita sociale, delle istituzioni
e delle politiche: per questa sua complessità, si presenta come un processo dinamico, instabile, in
continua costruzione, in quanto l’essere inclusi non è vincolato a un ruolo prescrittivo, a una norma
o a una costrizione , ma implica una continua strutturazione e destrutturazione delle organizzazioni
e dei contesti istituzionali e sociali e un’attenzione che dà voce a chi li abita e li vive (Medeghini R.,
Simona D’Alessio, Giuseppe Vadalà, 2013, p.197).
Per rendere ulteriormente più chiara la complessità di questa prospettiva e dei processi che tende
ad attivare, risulta necessario evidenziare le differenze fra l’Inclusione e i paradigmi normativi;
approfondire il legame fra processi inclusivi e diritti; interrogarsi sul rapporto fra Inclusione e
pratiche governamentali ed evidenziarne la differenza dai processi integrativi.
I paradigmi normativi
La disabilità ha una storia comune alle definizioni che si producono in relazione alle sessualità,
al genere, alla razza: esempi, questi, che individuano le assiologie di un pensiero, proprio della
cultura occidentale, che tende a governare le pluralità attraverso un processo di classificazione
fondato su opposizioni concettuali. Nel nostro caso è la categoria dell’abilismo che, ispirandosi ad
una norma generale di funzionamento, governa la dicotomia abile/non abile assieme ai suoi
gradienti (più o meno abile). Il paradigma normativo qui accennato non è però neutro, ma assume
contorni diversi in virtù di sistemi sociali e culturali tanto che le forme di disabilità non sono
universalmente condivise: infatti, un deficit fisico produce una categorizzazione di inabilità in un
contesto sociale dove è preminente la forza fisica, mentre può non generarlo in contesti dove
l’elemento fisico non viene considerato significativo. In questo sfondo, la disabilità diventa relativa
(in quanto è in relazione a qualcosa) e prodotta da qualcosa o da qualcuno nel momento in cui la
rapportiamo ai macrocontesti sociali e culturali e ai microcontesti del quotidiano.
L’idea di disabilità ha quindi una natura essenzialmente sociale in quanto si definisce rispetto ad
una norma, ad un criterio di normalità che è anch’esso una nozione culturalmente costruita e
fortemente etnocentrica (Fougeyrollas P., 1987).
Il paradigma biomedico-individuale
Il paradigma normativo trova la sua legittimazione all’interno degli ambiti scientifici, nelle
discipline e nei discorsi che ne conseguono: infatti ogni società ha una sua politica generale di verità
(Foucault M., 2001) che consente di accogliere e di far funzionare come veri alcuni discorsi
piuttosto che altri; di sostenere tecniche e procedimenti considerati più idonei di altri; di definire il
ruolo di coloro che sono preposti a determinare ciò che funziona come vero. Nel caso della
disabilità, il paradigma normativo dominante è rappresentato dalla prospettiva biomedico-
individuale o altrimenti detto modello del deficit in quanto considera quest’ultimo come dato
interno alla persona e come fattore causale delle difficoltà. La disabilità viene qui concettualizzata
come elemento individuale basato sul legame causale fra la menomazione e l’essere disabile: ne
consegue una condizione di isolamento in quanto il problema non viene messo in relazione al
possibile ruolo causale dei contesti nella costruzione della disabilità. Questa sottolineatura, presente
nelle riflessioni dei Didsability Studies e in particolare del modello sociale (Medeghini R., op.cit.),
rappresenta lo spartiacque fra un’interpretazione deficitaria della disabilità avanzata dal paradigma
biomedico-individuale e l’attribuzione ai contesti sociali di un ruolo disabilitante, cioè di una
funzione causale nella produzione della disabilità in virtù di una struttura ed un’epistemologia
sociale abilista.
Il terreno sul quale le due prospettive si sono confrontate anche recentemente è quello delle
classificazioni della disabilità: per chiarire la natura del dibattito e la sua evoluzione è utile riferircialle modificazioni che l’ICIDH – International Classification of Impairments, Disabilities, and
Handicaps ha subito nel corso del tempo fino all’ultima stesura del 1999 che rinomina la
classificazione International Classification of Functioning, Disabilities and Health (ICF).
L’intenso dibattito fra la corrente biomediche e quella sociale, sostenuta dai movimenti dei
disabili, e la crescente richiesta per una revisione dell’ICIDH-1 hanno portato alla definizione di
una nuova classificazione, l’ICF, che nel 2001 viene adottata dall’OMS. Questa classificazione
pretende di integrare le due correnti di pensiero «in modo di fornire una prospettiva coerente delle
diverse dimensioni della salute a livello biologico, individuale e sociale» (OMS, 2002, p. 23).
Il carattere di mediazione che ha contraddistinto la costruzione della classificazione ha lasciato
però aperti diversi problemi, riguardanti soprattutto l’impianto concettuale generale. Imrie (2004),
pur aderendo allo sfondo concettuale del modello, afferma che l’ICF non riesce a specificare o
valutare in ogni dettaglio la natura e l’adeguatezza di alcuni dei suoi fondamenti teorici; ad
esempio, l’aspetto biopsicosociale non viene collegato ad alcuna origine concettuale, lasciando nel
vago l’interazione fra le tre componenti ed esponendola così a diverse interpretazioni. Infatti, come
sottolinea Amstrong (1987), vi potrebbero essere spiegazioni differenti e contrastanti di uno stesso
fenomeno in base alle gerarchie disciplinari che, influenzando il peso delle tre componenti,
orientano l’analisi.
Sullo stesso piano concettuale si colloca anche Barnes (2012), il quale amplia l’analisi,
individuando tre aspetti che rendono concettualmente e teoricamente problematico il modello ICF:
innanzitutto l’uso dei criteri normativi propri di un’impostazione medica, secondariamente uno
sguardo antropologico in cui la cultura occidentale è dominante e infine il peso causale attribuito
all’alterazione delle funzioni. Le critiche al modello ICF qui proposte evidenziano come, pur in
presenza di un cambiamento positivo rispetto alle classificazioni precedenti, non sia chiaro il ruolo
dell’ambiente e della strutturazione sociale. Per chiarire il problema potremmo chiederci se
l’ambiente sociale e i contesti siano solo variabili da mettersi in relazione alle condizioni della
persona o possano essere interpretati anche come agenti causali della disabilità.
L’interrogativo qui avanzato ha una valenza fondamentale in quanto richiama opzioni teorico-
concettuali e processi che si diversificano come è il caso dell’integrazione con i riferimenti ai
processi di normalizzazione e l’Inclusione nella sua dimensione critica alla norma, all’abilismo e
alla natura individuale del deficit.
L’ integrazione e i processi di normalizzazione
Nell’esperienza italiana le leggi 517/77 e 104/92 hanno come specifico riferimento l’area della
disabilità 2 e il concetto di «integrazione». Infatti con la 517 si sancisce la possibilità di ingresso nei
percorsi normali di istruzione per tutte quelle categorie di alunni che erano collocate in scuole
speciali e in classi differenziali; con la 104 si definisce invece il quadro di un’integrazione più
compiuta che, oltre ad individuare gli obiettivi della formazione scolastica prende in considerazione
anche le aree dell’inserimento sociale.
Questa legge ha avuto diversi riconoscimenti ma, pur mantenendosi come punto di riferimento
essenziale per il processo di integrazione, non è stata esente da critiche ( Breda & Santenera, 1995)
che hanno riguardato soprattutto la sua caratterizzazione assistenziale (già presente nel titolo),
l’assenza di una definizione innovativa dei diritti delle persone con disabilità e di precise
indicazioni relative al loro ruolo sociale e istituzionale.
Le critiche alla legge, pur positiva, coinvolgono l’epistemologia integrativa che non mette in
discussione la categoria dell’abilismo (nella sua dicotomia deficit/abilità), assumendo così i
processi di adattamento, compensazione e normalizzazione in un contesto dato (scuola e società)
come cardini concettuali.
2
Nei testi legislativi citati il termine di riferimento è «handicap». L’utilizzo dei termini «disabilità, con disabilità,
disabile» viene adottato dalla classificazione ICF (International classification of functioning, disability and health)
elaborata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2001.Tale caratterizzazione, nonostante il richiamo alla strutturazione del contesto in cui si attiva il
processo integrativo, trova nella teoria della normalizzazione e di ruoli sociali valorizzati uno dei
riferimenti principali. Questa prospettiva (Wolfensberger, 1972; Nirje, 1992) è stata assunta dalla
prospettiva integrativa italiana (Canevaro A. et al, 1996) mentre a livello internazionale ha
incontrato diverse critiche: da una prospettiva sociologica P. Fougeyrollas e K Roy (1996)
sostengono che i principi di normalizzazione veicolano un’idea generale condivisa di norme, di
regole, di comportamenti, una sorta di verità oggettiva nella quale si iscrivono dei ruoli sociali
definiti dalla società. Tentare di normalizzare le persone attraverso apparenze ordinarie come
possono essere i ruoli sociali valorizzati può assumere il senso di una violenza integrante, di una
standardizzazione limitativa alla cui base si trovano la negazione e l’espulsione delle differenze.
La relazione fra processo di normalizzazione, adattamento e compensazione sottostanti al
paradigma dell’integrazione italiana espressi dalla legge 104 non sono mai stati messi in
discussione, producendo nel tempo differenti forme integrative (Medeghini R., 2005). Infatti,
accanto all’idea di integrazione partecipata si sono consolidate altre forme concettuali e operative
(integrazione differenziata, integrazione progressiva, integrazione condizionale) prodotte da un
processo conservativo delle diverse istituzioni che può assumere diverse forme: la progressività,
cioè il legame fra ingresso e acquisizione di abilità sempre meno distanti dalla norma richiesta dall’
l’istituzione come la scuola o il lavoro ; la differenziazione, cioè la relazione fra accesso e livello di
gravità che pone non solo una divisione fra chi può e non può accedere ma dà anche l’indicazione di
percorsi differenziati fra chi non è in grado e chi può affrontare il processo di integrazione; le
condizioni, cioè la richiesta di risorse umane o finanziarie destinate alla persona in ingresso;
l’esclusione attraverso forme integrative che, ad esempio, hanno nell’aula di sostegno il luogo
privilegiato.
Come si può osservare, queste modalità rappresentano i meccanismi conservativi, ma soprattutto
immunizzanti, messi in atto dalle diverse istituzioni (ad esempio la scuola), per impedire, limitare o
tenere sotto governo le richieste di cambiamento. Qui le risorse vengono invocate come condizioni
di tutela dell’organizzazione e non come possibilità e mezzi per il cambiamento e l’innovazione in
grado di aprirsi alle differenze.
Si spiegano così i diversi fallimenti dell’integrazione pur in presenza di risorse adeguate: ne sono
un esempio gli studenti con disabilità che trovano poche opportunità di partecipazione
all’apprendimento in classe nonostante una copertura adeguata di ore; i progetti sociali per le
persone con disabilità che rimangono confinate ad un primo livello di inserimento come dimostrano
le piscine con corsie e orari riservati.
L’elenco potrebbe continuare, ma in questo passaggio la sottolineatura necessaria è che anche in
presenza di risorse per i processi di normalizzazione si produce un «handicap da conversione 3»,
cioè un’incapacità a tradurre in positivo i mezzi che vengono messi a disposizione. La causa di
questa inadeguatezza e il suo prodotto ,che potremmo definire un «doppio handicap» in quanto
svantaggia doppiamente la persona, vanno ricercati nella relazione deficit-bisogno-risorse e nella
sua attribuzione al singolo, all’individuale, eludendo così quei fattori ambientali e contestuali che
rappresentano davvero i fattori causali dell’esclusione.
Da queste considerazioni nasce la risposta non certo positiva all’interrogativo circa la capacità
del dispositivo dell’integrazione di essere ancora potenzialmente innovativo e, quindi, in grado di
trasformarsi. Infatti dall’analisi prodotta sin qui, l’integrazione appare prigioniera delle
stratificazioni e delle sedimentazioni dei diversi impliciti, che rimandano all’abilismo, alla
neutralità dei contesti, all’adattamento, alla normalizzazione, all’autonomia.
L’inclusione
3
Tale definizione è presa in prestito da A.Sen (Inserto domenicale Sole 24 Ore – 4 settembre 2005 – p.36) il quale
mette in relazione le risorse con la possibilità di convertirle in forme di vita adeguate.A differenza delle concezioni ora evidenziate, l’Inclusione nella prospettiva dei Disability
Studies Italy non assume la dicotomia norma/deficit, nè i conseguenti principi di
compensazione/adattamento/normalizzazione finalizzati all’integrazione in contesti definiti. Essa
supera la relazione norma-deficit-bisogno per assumere le «differenze», non come prodotto di
condizioni interne alla persona, ma come insieme di percorsi, modi e stili che ognuno mette in atto
per orientarsi e agire nei processi sociali, relazionali e di apprendimento. Nella prospettiva inclusiva
il problema non è nella o della persona ma nel possibile ruolo «disabilitante» dei contesti e delle
relazioni che in essi si attivano: da qui l’attenzione particolare che l’osservazione inclusiva dedica
alla presenza o meno di barriere alla partecipazione e all’apprendimento.
Ciò non significa però mettere in secondo piano le specificità dei singoli: anzi, le «differenze»
assumono un significato e una valenza maggiore nel momento in cui, superando la strutturazione
normativa viene messo in discussione il principio dell’oggettività, quel principio che mette sotto
silenzio l’esperienza individuale: infatti il vivente non vive in mezzo a leggi di norma, ma in mezzo
ad esseri, avvenimenti, contesti, giochi di potere che diversificano queste leggi e all’interno dei
quali le differenze acquisiscono senso e significato.
L’Inclusione vuole quindi fornire uno sfondo adeguato alle «differenze» in ambienti di forte
connotazione relazionale e sociale per cui, anziché essere un tema specifico relativo a come si possa
integrare qualcuno in un contesto dato (società, scuola, mondo lavorativo), essa si propone di
indicare una prospettiva per modificare le culture, le forme organizzative dei contesti, le modalità
relazionali, in modo da poter rispondere alle richieste di partecipazione.
Ma ciò è sufficiente? È sufficiente, cioè, richiamarsi all’ambiente ecologico per garantire un
processo inclusivo? Senza dubbio ciò rappresenta una condizione, ma risulta debole, generica e, per
certi versi, anche priva di una connotazione politica se si limita a richiamare i sistemi, le relazioni
in essi presenti, le interazioni senza ancorarla alla dimensione storica, spazio-temporale e alle
relazioni di potere che la attraversano. Le relazioni e le interazioni, infatti, si collocano in uno
spazio e in un tempo, sono situate storicamente; sono esse stesse frutto di relazioni inter-agite
all’interno di un sistema sociale (cultura, percezioni, rappresentazioni, ideologie, istituzioni, lotte
per l’egemonia…); sono iscritte in relazioni di potere (saperi disciplinari/produzione di servizi,
insegnanti/alunni, educatori/persone con disabilità…) intese come insieme di giochi strategici
tendenti a costituire la condotta degli altri 4. Da qui si desume che l’ecologia delle relazioni diventa
un esercizio retorico se non fa i conti con i dispostivi egemoni che si costruiscono in una data
cultura, in un dato spazio, in un dato tempo e che si esplicitano in politiche e pratiche (Medeghini
R., 2013).
Inclusione e diritti
Il tema dell’inclusione declinato nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
(2006) sembra non contenere elementi di problematicità sul versante dell’enunciazione: infatti
riconosce alle persone con disabilità un eguale diritto a vivere nella comunità con la stessa libertà di
scelta delle altre persone ed orienta le politiche a facilitare il godimento di tale diritto e della piena
inclusione e partecipazione alla comunità. Sfondo, questo, importante e decisivo per
un’emancipazione delle persone con disabilità, ma che apre però una serie di interrogativi che
riguardano non solo la presenza di un costrutto teorico comune in grado di condividere
l’interpretazione degli enunciati, ma anche la loro possibile e concreta applicazione.
Rispetto al primo problema, cioè al costrutto teorico, il lessico della Convezione appare ambiguo
in quanto utilizza indifferentemente inclusione ed integrazione come se fossero sinonimi e quindi
sovrapponibili. Certamente, ciò può derivare dal confronto con le diverse politiche, culture e sistemi
4
Foucault M. (1998). L’etica della cura di sé come pratica della libertà. In Archivio Foucault 3. Milano: Feltrinellieconomici che permettono o meno le condizioni di una loro elaborazione ed attuazione 5, ma ciò non è sufficiente per giustificare questa sovrapposizione come non lo è il riferimento al concetto di barriere: infatti l’utilizzo di questo costrutto può essere applicato ad entrambi i paradigmi ed interpretato allo stesso modo come impedimento alla partecipazione. Ciò che diventa sostanziale e che permette di uscire da questa ambiguità lessicale è invece il passaggio da una natura individuale della condizione ad una sociale: nel primo caso la barriera può essere la menomazione della persona oppure le condizioni ambientali ma sempre nella prospettiva di un contesto che non mette in discussione la sua natura, nel secondo caso la barriera è l’ambiente stesso con le relazioni di potere che lo contraddistinguono. In questa prospettiva può collocarsi anche la problematicità del costrutto delle “pari opportunità o uguaglianza delle opportunità”, presente in alcuni passaggi della Convenzione (punto f ed y del Preambolo), se esso viene interpretato come semplice possibilità di accesso alle esperienze (sociali, scolastiche, lavorative, culturali…). Infatti, anche in questo caso, l’attenzione è rivolta alle differenti condizioni in entrata dei singoli nei diversi contesti senza alcun riferimento ai processi presenti in essi (es. le modalità relazionali in un’azienda o quelle di insegnamento nella scuola). Si definisce qui il costrutto di risorsa come strumento compensativo che viene rivolto al singolo (si veda la figura dell’educatore, dell’assistente educatore, dell’insegnante di sostegno, dei vari contributi economici) teso a modificare la condizione individuale, ma non i diversi contesti. La stessa difficoltà sembra presente nell’approccio delle capacità 6 (Sen.A.,1994; Nussbaum M.C., 2002) che copre lo stesso terreno sia dei cosiddetti diritti di prima generazione (libertà civili e politiche) sia dei diritti di seconda generazione (diritti economici e sociali). Infatti, pur uscendo dal costrutto di risorsa per assumere quello di possibilità di attività da parte delle persone e pur definendo pericolosa una lista differenziata delle capacità per le persone con menomazione (Nussbaum M.C., 2007), non è chiaro come il costrutto delle capacità si articoli nel momento in cui incontra disabilità gravi. Infatti, in questo ambito, vengono introdotte le idee di compatibilità e di adeguatezza rispetto al tipo di coinvolgimento da adottare che, ad esempio, nel caso della disabilità intellettiva, deve realizzarsi ad un livello che sia adeguato alle abilità della persona. Cosa significa? Che non tutti i diritti sono esigibili allo stesso livello da tutte le persone? Posto il problema in questi termini, il rischio che ne consegue è che l’inabilità, esclusa dall’opposizione ad un elenco differenziato delle capacità, ritorni come dato di fatto, interno alla persona, senza essere messa in relazione al ruolo del sociale nella definizione dell’ «essere abili», prospettando in tal modo una prospettiva delle capacità su base individuale. Nella riflessione è senz’altro presente il riferimento al sociale come possibile ostacolo alle capacità e al funzionamento, ma con il limite che il livello del coinvolgimento e la possibilità di accedere alle abilità combinate vengono, in ultima istanza, rapportate alle capacità interne. La prospettiva delle capacità ora citata rappresenta senz’altro una visione culturale importante per l’interpretazione dei diritti (op.cit., 2002 p.85) per le persone con disabilità, ma sembra cedere all’influenza del paradigma abilista ed individualista nel momento in cui si tratta di mettere in relazione il costrutto di capacità con quello di gravità presente nella condizione di una persona. La centralità della strutturazione ambientale, delle relazioni che la contraddistinguono, dei conseguenti giochi di potere e del ruolo delle persone con disabilità risulta invece fondamentale per l’esercizio dei diritti e per la loro esigibilità: infatti, per garantire ad una persona una certa capacità, ad esempio l’accesso al tempo libero, non è sufficiente produrre stati interni di disponibilità, ma 5 Infatti ci troviamo di fronte a situazioni nazionali dove integrazione ed inclusione sono negate, altre che si dibattono nella difficoltà della loro attuazione e altre ancora che si interrogano sulla loro tenuta e su un possibile cambiamento di paradigma come è nel caso dell’integrazione italiana. 6 Il concetto di capacità qui utilizzato non ha alcuna relazione con quello di abilismo: infatti Nussbaum (2012, P.28) sottolinea come esse non siano «… semplicemente delle abilità insite nella persona, ma anche le libertà o opportunità create dalla combinazione di abilità personali e ambiente politico, sociale ed economico». Alcuni esempi: poter vivere con gli altri, poter partecipare a scelte politiche, poter amare e provare desiderio, aver diritto a cercare lavoro.
occorre modificare i contesti, sia istituzionali che specifici e, parallelamente, dare voce alle persone
con disabilità per sostanziarne la partecipazione.
La scuola nella prospettiva inclusiva
L’inclusione chiede alla politica scolastica e ai docenti un cambiamento concettuale ed
epistemologico, partendo dal superamento dei presupposti e dei conseguenti impliciti pedagogici
delle integrazioni:
la concezione abilista che ispira le visioni deficitarie e i loro supporti compensativi e
adattivi (rifer riflessioni precedenti);
la neutralità dei contesti nella costruzione della disabilità, dove le forme organizzative, i
processi di insegnamento-apprendimento, le relazioni educative e sociali sono
considerate come elementi «neutri» rispetto ad una condizione;
la neutralità degli attori che vi operano (dirigenti, docenti…) i quali faticano non solo ad
assumere la responsabilità degli esiti, ma tendono a delegare allo specialismo la gestione
dei percorsi ritenuti difficili. Nella scuola lo testimoniano i riferimenti alla figura
dell’insegnante di sostegno, alla certificazione o alla segnalazione che mettono le
differenze ritenute deficitarie in carico agli esperti ;
l’omogeneità formativa e di insegnamento che guida l’organizzazione, la valutazione e le
pratiche di insegnamento che si ispirano ad un «a priori», cioè ad un punto ideale
attraverso il quale leggere, interpretare e valutare l’individualità; un «a priori» produttore
della credenza che possa esistere e si possa proporre un unico modo di essere, un unico
modo di conoscere e un unico mondo di produrre significati. Da qui la necessità di
riferirsi ad un dato esterno, cioè al concetto di norma e di «distanza» che porta ad una
descrizione lineare di comportamenti, atti e situazioni. Tutto questo è indicativo di una
resistenza culturale della società e delle istituzioni formative verso le differenze alle quali
si risponde con il principio dell’ «uguaglianza delle opportunità» che risulta
contraddittorio in quanto utilizza un criterio di omogeneità per dare una risposta ad una
presenza plurale. Assumere le differenze come dato culturale implica invece, da parte dei
contesti educativi e fra questi dell’istituzione scolastica e degli insegnanti, un
decentramento rispetto all’omogeneizzazione formativa, ripensando l’organizzazione, i
tempi e le metodologie: da qui emerge il concetto di pluralizzazione nella formazione e
nella educazione ed è in questa direzione che le differenze non vengono collocate nella
eccezionalità, come incidenti, ma nella normalità e nelle relazioni di tutti i giorni;
l’autonomia e l’adattamento che hanno assunto nella nostra cultura uno spazio sempre
più rilevante tanto da essere utilizzati come parametri fondamentali per la definizione di
un corretto e adeguato funzionamento delle persone come prodotto conseguente ad
un’azione individuale. La ridefinizione dell’autonomia come superamento della sua
connotazione individuale diventa possibile se si collega al concetto di sistema (E. Morin
(1977) dove la centralità delle relazioni obbligano le persone a fare i conti con ciò che
potrebbe essere definito come un paradosso dell’autonomia; più si dichiara la propria
autonomia più si evoca la dipendenza dal proprio ambiente. Infatti dobbiamo imparare un
linguaggio, interagire in una cultura, assumere un sapere e bisogna che questa cultura sia
abbastanza varia da permetterci di fare la scelta nell’insieme delle idee esistenti e di
riflettere su di esse: dunque, questa autonomia si nutre di dipendenza tanto da venir
definita da Morin come un’«autonomia dipendente» fondata sulla relazionalità piuttosto
che sull’affermazione della propria autosufficienza e comporta la necessaria
consapevolezza delle dipendenze dal contesto e dagli altri. In questa dimensione
l’autonomia dell’apprendimento è possibile in un contesto ricco di aiuti e possibilità chesono destinate a moltiplicarsi in virtù del progressivo aumentare della complessità delle
richieste.
Il superamento degli impliciti integrativi permette l’apertura al nuovo paradigma dell’Inclusione
che, in sintesi e nelle sue componenti principali, potremmo così presentare:
1. Il focus dell’azione in campo scolastico, cioè i destinatari delle finalità.
Nel caso dell’integrazione questi sono gli alunni definiti con Bisogni Educativi Speciali che
comprendono alunni e studenti con disabilità e alunni e studenti che incontrano particolari difficoltà
nel percorso scolastico (es. Disturbo Specifico di Apprendimento): in quello inclusivo invece sono
tutti gli alunni che si trovano a vivere una esperienza scolastica impropriamente definita «della
normalità». La tipologia dei destinatari condiziona anche la qualità delle richieste: infatti se
l’integrazione con i bisogni educativi speciali chiedono agli insegnanti di rivolgere l’attenzione alle
possibilità di contatto tra il piano di studio normale e quello degli alunni con disabilità o in
difficoltà, l’inclusione fa riferimento a percorsi personalizzati per tutti gli studenti, richiedendo ai
piani di studio un ampio margine di flessibilità e di cambiamento.
2. I modelli di insegnamento, cioè i modi (pedagogico-didattici, socio-relazionali) di avvicinarsi
al tema delle differenze. Gli approcci dell’integrazione e dei bisogni educativi speciali tendono a
riferirsi ad un sostegno specifico che si deve coordinare con il percorso normale e con gli insegnanti
di classe. L’inclusione sottolinea invece che l’obiettivo centrale è il superamento culturale e
didattico del principio dell’omogeneizzazione formativa la quale tende a rispondere alla presenza di
«pluralità » con criteri di omogeneità. Tale cambiamento richiede a tutti gli insegnanti, ai loro
percorsi di insegnamento e all’organizzazione di avere in sé i presupposti e le condizioni per
rispondere alle differenze degli alunni in un’ottica di sostegni distribuiti. Questo non può però
ridursi ad operazioni di semplificazione e di riduzione, prestando attenzione solamente agli aspetti
di contenuto, ma deve prendere in considerazione il legame fra processi di insegnamento e di
apprendimento. Infatti l’approccio inclusivo richiama la caratteristica relazionale della didattica,
cioè quella dimensione co-costruttiva nella quale il conoscere viene visto come attività, cioè come
costruzione e organizzazione del sapere in una continua interazione e negoziazione di significati. E
ciò è tanto più necessario quanto più ci si rivolge a forme definite impropriamente deficitarie.
3. La formazione e la specializzazione. Il discorso inclusivo proprio perchè coinvolge le
concezioni, gli atteggiamenti e il fare scuola degli insegnanti, fa emergere anche il tema centrale
della formazione. L’approccio è quello di superare la figura dell’insegnante specializzato,
assumendo come fondamentale un percorso formativo (sia iniziale che in servizio) unitario per tutti
gli insegnanti nel quale sia centrale il tema delle differenze. Lo stesso discorso vale anche per la
costruzione di competenze che attualmente vengono gestite dai Master Universitari (sui DSA,
ADHD, Disabilità Intellettiva, Disturbo generalizzato dello Sviluppo…) dove può accedere solo
una minima parte degli insegnanti. Uscire dal dispositivo della «specializzazione» per una
«competenza» per tutti i docenti diventa uno degli obiettivi dell’Inclusione.
4. La certificazione di deficit o di difficoltà. Nella forma integrativa, la diagnosi e la conseguente
certificazione risultano le condizioni per avere diritto ad un insegnante specializzato. La stessa cosa
accade nel caso dei disturbi di apprendimento come la dislessia dove la diagnosi legittima la scuola
ad introdurre strumenti compensativi e dispensativi. Questa dipendenza fra diagnosi-certificazione e
azione di aiuto è una chiara contraddizione pedagogica che nella prospettiva inclusiva viene
superata attraverso l’abbandono della certificazione. Qui il valore di una diagnosi non è di tipo
strumentale, tendente cioè a legittimare aiuti e supporti, ma esplicativo ed orientativo in quanto può
offrire interpretazioni riguardo al problema evidenziato, permettendo agli insegnanti di progettare
l’azione: inoltre, la presenza di una diagnosi non è un elemento necessario in moltissimi casi. Il
problema, infatti, è l’organizzazione e la didattica alle quali si richiede il cambiamento e la
pluralizzazione nel loro guardare il contesto, nelle modalità con cui si avvicinano alle diverse
espressioni delle differenze (difficoltà di apprendimento, la lingua e la cultura, le varie forme di
svantaggio, la disabilità, i soggetti definiti dotati, gli stili di pensiero...). In questa dimensione, idiversi strumenti, gli aiuti diventano forme naturali della didattica e non un’eccezione conseguente
ad una diagnosi.
In questa prospettiva non vi può essere «discrezionalità» da parte dei docenti e dei Consigli di
Classe come traspare invece dalle ultime Circolari Ministeriali sui Bisogni Educativi Speciali: è
semplicemente la funzione docente che lo richiede.
I servizi nella prospettiva inclusiva
Il mondo dei servizi per la disabilità rappresenta una zona di frontiera con cui la prospettiva
inclusiva deve confrontarsi e misurarsi in quanto rappresenta contesto complesso, ricco di
esperienze e allo stesso tempo di contraddizioni, inserito fra processi immunizzanti di controllo e di
regolazione e la tensione educativa che resiste a tale visione.
La prospettiva inclusiva con il suo riferimento all’adultità si inserisce così in questa dinamica,
ponendo domande immediate alle politiche dei servizi, ma anche al pensiero e alle conseguenti
progettazioni che li guidano: qual è, ad esempio, il ruolo dei servizi nella costruzione
dell’appartenenza sociale? E di conseguenza, quale deve essere la loro natura e in quali forme deve
manifestarsi? E ancora, come possono collocarsi all’interno delle linee tracciate dalla Convenzione
ONU (2006) sui diritti per le persone con disabilità? Inoltre, è sufficiente istituire e incrementare i
servizi senza all’investimento sul territorio di appartenenza delle persone con disabilità?
Naturalmente, vi è qui un immediato rimando alla criticità delle attuali politiche sociali e del
welfare, inadeguate ad affrontare questo percorso in quanto ispirati da un’idea di disabilità
prigioniera del deficit che la proietta verso un’ineluttabile sospensione o, meglio, ad un ferma
immagine, dove la vita viene fissata in uno spazio dedicato (i servizi) e in un tempo bloccato (la
rappresentazione di eterno bambino).
La prospettiva inclusiva, assumendo una prospettiva emancipativa, sollecita il recupero
dell’identità biografica della persona con disabilità, affrancandola dalla categoria del bisogno e
dalla sua oggettivazione su base abilista. È in questa prospettiva che può delinearsi un progetto di
vita con una dimensione spazio-temporale ed evolutiva dell’esistenza e con una sua essenza sociale.
Naturalmente, tale visione richiede alle politiche e alla progettazione di modificare l’approccio
fino ad ora utilizzato, passando da proposte di razionalizzazione dei servizi ( ad esempio attraverso
la loro concentrazione territoriale) e di una loro sanitarizzazione a progetti che abbiano come
presupposto le relazioni di comunità. Tale riferimento ha un valore sostanziale in quanto richiede
alle politiche sociali e del Welfare e ai servizi un mutamento concettuale rispetto all’idea di bisogno
individuale e della sua fissità temporale, entrambi interpretati come esiti del deficit e della sua
gravità.
Ma, accanto a questo, ci sono altri ostacoli ai processi inclusivi devono essere tenuti in
considerazione. Si tratta dell’omogeneizzazione e dell’istituzionalizzazione dei percorsi di vita che
conseguono ai processi di categorizzazione delle persone in base allo stesso stato di bisogno e al suo
livello di intensità (ad esempio la disabilità o gli anziani): qui le persone vengono genericamente
assimilate, private di una propria specificità biografica con una conseguente organizzazione dei
servizi basata sulla tipologia del bisogno e sulla sua gravità.
Questi processi di omogeneizzazione e di segmentazione istituzionale 7 portano ad un
restringimento dei percorsi di vita delle persone con disabilità anche in virtù della irreversibilità
dell’appartenenza ad un servizio specifico. Questo diventa un fattore di rischio e di vulnerabilità
sociale in quanto limita le opzioni e introduce le persone con disabilità in percorsi senza uscita: in
questa prospettiva il progetto di vita assume un carattere burocratico che si riduce ad una semplice
definizione di sequenze temporali standardizzate.
Quali allora gli sfondi di analisi e di azione sui quali ci si deve confrontare per trovare una
risposta alla prospettiva inclusiva dei servizi e ad una loro valutazione?
7
Cioè la definizione di percorsi specifici basati sulle categorie dei bisogni: es. disabilità gravi1. Il servizio inclusivo
Se l’ostacolo più evidente ad una prospettiva inclusiva è la standardizzazione del corso di vita, la
via d’uscita può essere rintracciata in politiche sociali e in strutture dei servizi che assumono
politiche differenziate orientate agli eventi, alle transizioni e agli episodi significativi del corso della
vita delle persone (Saraceno C., 2001). In questa prospettiva, il riferimento culturale di un servizio
sta nelle possibilità di azione delle persone e nella promozione di condizioni e opportunità per il
superamento delle barriere alla partecipazione.
Il passaggio da un servizio standardizzato ad uno inclusivo richiede così di interrogarsi e di
esplicitare l’idea di disabilità e di persona con disabilità che ispira la sua natura:
Ciclo standardizzato di un servizio Ciclo inclusivo di un servizio
Analisi della situazione:« Cosa non funziona Analisi della situazione:« Cosa vuoi fare ?».
nella persona con disabilità?» Quali sono le potenzialità e le barriere presenti nei
contesti?
La capacità è basata sul livello del
danneggiamento e di cosa può o non può fare la La capacità è basata sul «rischio»
persona con disabilità. dell’indipendenza in relazione alla strutturazione dei
contesti e all’assenza di barriere alla partecipazione.
Assegnazione ai servizi. Riduzione delle
relazioni e delle convenzioni sociali Investimenti prioritari sui contesti sociali per una
loro costruzione inclusiva. Presenza di un sistema
misto di supporti sociali, di gruppo, familiari e
individuali.
Limitate opportunità di sviluppare nuove
competenze. Assenza di responsabilità sociali
L’obiettivo è il recupero della propria vita
(amicizie, affetti, interessi …) indipendentemente
dal danneggiamento. Inoltre investimento per
l’ampliamento di competenze inclusive dei diversi
contesti.
(Adattamento da GB Disability Training & Consultancy, 2007)
Le capacità e le possibilità di azione e di scelta delle persone rappresentano quindi il riferimento
culturale di un servizio e lo sfondo che guida il superamento delle barriere alla partecipazione sia
nel servizio che nel sociale. In questa prospettiva va considerata la centralità del “restituire voce”
(Vadalà G., 2012) alle persona con disabilità dove non c’è solo il riconoscere, ma l’affermare
un’identità non come dato, ma come processo di costruzione, come campo dinamico nel quale si
attivano traiettorie e significati.
2. Dentro/fuori: una dicotomia da superare
La prospettiva inclusiva, proprio per la sua caratterizzazione sociale, interroga il servizio sulla
sua natura: dove si colloca e a chi si rivolge? Nonostante diverse esperienze abbiano tentato di
uscire da vincoli legislativi attraverso progettazioni innovative, è ancora dominante la
rappresentazione «sostitutiva» e immunizzante del servizio derivante dalla delega che gli ha
attribuito il sociale. Si genera così l’idea di servizio come luogo funzionalmente dedicato per le
categorie a rischio, soprattutto per la disabilità ed è in questa rappresentazione che si costituisce la
sua autoreferenzialità: da qui, l’identità del servizio si mantiene distante dal sociale e non affondale sue radici nei sistemi quotidiani di vita per una partecipazione che lascia tracce e connessioni
nelle relazioni sociali.
L’uscita da questo vincolo epistemologico sta nel superamento concettuale e semantico della
dicotomia dentro/fuori, sempre pensando il servizio come territorio e parte di esso, sempre in
relazione ai luoghi in cui si trova e a quelli di provenienza delle persone con disabilità. È in queste
relazioni ed interazioni che si colloca una parte rilevante della mission di un servizio, attraverso le
quali si può tracciare il suo profilo qualitativo. È in questa dimensione che si produce una
modificazione delle prospettive educative e della progettazione, assieme ad un riposizionamento del
ruolo di educatore.
3. La dimensione spazio-temporale nella prospettiva evolutiva
Il riferimento al corso di vita ha una ricaduta importante sulla prospettiva inclusiva dei servizi in
quanto permette di togliere la disabilità da un indifferenziato temporale in cui si trova inserita.
Infatti, spesso è presente un concetto di sviluppo fissato su una certa fase, quella di eterno bambino,
che nega le transizioni che segnano la vita delle persone come ad esempio il lavoro e la vita di
coppia, i figli. L’assunzione della prospettiva evolutiva richiede ai servizi di interrogarsi sul
posizionamento e sullo scorrere del tempo nella persona (giovane, adulto, anziano) e sul
cambiamento che ciò comporta in termini di percezione di sé, di aspettative e di richieste. Ciò
richiama la necessità di superare le pratiche ispirate dalla fissità temporale come, ad esempio, i
criteri per la costituzione dei gruppi, la proposta delle attività e la scelta dei luoghi per le esperienze
sociali.
La riduzione della dimensione temporale si intreccia però anche con quella spaziale in virtù di
una prospettiva deficitaria che limita spazialmente l’esperienza delle persone con disabilità. In tal
modo gli spazi per la disabilità esistono in virtù della oggettivazione normativa dell’inabilità a
partecipare e vivere gli spazi che la società mette a disposizione delle persone che vivono in essa: si
produce così una frattura per differenziazione e specializzazione fra gli spazi della normalità e
quelli della disabilità che può essere colmata col superamento della dicotomia del dentro/fuori
proposta precedentemente.
4. La progettazione e l’azione fra ricerca ed innovazione
Le progettazioni e le azioni educative inclusive richiedono di collocarsi in una pluralità di
relazioni fra soggetti (es. educatori, famiglie, persone con disabilità, territorio, volontariato,
istituzioni, cittadinanza, luoghi di produzione…) i quali si trovano assieme ad indagare, mettere a
fuoco, gestire, problematizzare i processi e fare delle scelte. In questo modo diventa possibile
rileggere e problematizzare la progettazione, l’azione e la valutazione alla luce della prospettiva
evolutiva e sociale al fine di costruire percorsi in grado di sostenere la richiesta di un nuovo
protagonismo delle persone con disabilità che non sia limitato alle rivendicazioni, ma dia
concretezza ai Diritti oggetto della Convenzione ONU del 2006.
… per non concludere
La prospettiva inclusiva delineata in questo contributo non si riduce ad alcune categorie, ma
coinvolge le condizioni e la vita di tutte le persone nel loro essere differenti, ricomponendo così la
frattura fra i diversi sistemi (società, territorio, scuola, servizi, istituzioni, luoghi produttivi,
persone…) prodotta dalle categorie di abilismo, individuale, specialismo che sono state assunte
dalla logica integrativa. Infatti, l’esperienza individuale non può essere separata dalle condizioni in
cui essa si esprime, né dai vincoli che la società o le istituzioni pongono e che determinano tali
condizioni.
In questa prospettiva la connotazione inclusiva diventa fattore culturale di resistenza ad uno
sguardo sociale e disciplinare di un corpo e di una mente che da soggetto di vita diventa solamente
un oggetto di operazioni specifiche che hanno il tempo, lo spazio e il linguaggio delle istituzioni incui sono inseriti. È una resistenza verso uno sguardo che coglie nelle persone i ritardi, le assenze, la
memoria fallita; nello spazio l’inefficienza; nell’attività la scarsa abilità; nel comportamento il
disadattamento; nel corpo i gesti non corretti o la loro assenza o l’eccezionalità ( Galimberti U.,
2008).
È una resistenza al linguaggio, ai discorsi e alle sue pratiche (modi, espressioni, termini,
concetti, valutazioni, regole, prescrizioni amministrative, procedure d’osservazione) che
marginalizzano le persone, con disabilità e non, e occultano i loro discorsi perché la loro vita è detta
e scritta da altri. Si apre in questo modo la ricerca di un nuovo e diverso spazio per un linguaggio
che non riguarda solo la disabilità, ma la totalità delle persone.
E questo resistere non significa solo contrastare o «chiamarsi fuori», ma produrre nuove culture
e nuove pratiche che prendono le distanze dai processi immunizzanti di regolazione e di controllo
sociale, ma prefigurando percorsi emancipativi in grado di rendere concrete ed esigibili per tutti le
condizioni per essere pienamente in una vita.
Bibliografia
Armstrong D. (1987) Theoretical tensions in biopsychosocial medicine, «Social Science and
Medicine», vol. 25, pp. 1213-1218.
Barnes C. (2012), The social model of disability: Valuable or irrelevant? In N. Watson, A.
Roulstone e C. Thomas (a cura di), The Routledge Handbook of Disability Studies, London:
Routledge, pp. 12-29.
Breda M.G, Santanera F. (1995), Handicap: oltre la legge quadro, riflessioni e proposte,
Torino:Utet.
Canevaro A. et al. (1996), Pedagogia speciale dell’integrazione, Firenze: La Nuova Italia.
D’Alessio (2007), Prospettive di cambiamento, «L’integrazione Scolastica e Sociale», vol.6,
pp.342-365
Disability Training & Consultancy (2007), Applying the Social Model of Disability to Health and
Social Care Services, www.gbdtc.org.uk
Esposito R. (1998), Communitas. Torino, Einaudi.
Foucault M.(1999), Soggettività e verità. In Foucault M., I corsi al Collège de France. I Résumés.
Milano: Feltrinelli
Fougeyrollas P. e Roy K. (1996), Regard sut la notion de roles sociaux. Réflexion conceptuelle sur
les roles en lien avec la problématique du processus de production du handicap, Service
Social, vol.45, n°3, pp.31-54.
Galimberti U. (2008), Il corpo, Milano:Feltrinelli.
Imrie R. (2004), Demystifying disability: A review of the International Classification of
Functioning, Disability and Health, «Sociology of Health & Illness», vol. 26, n. 3, pp. 287-
305.
Leisering L. e Leibfried S. (1999), Time and Poverty in Western Welfare States, Cambridge
University Press, Cambridge in Saraceno C. (2001), Età e corso della vita, Bologna: il
Mulino.
Marra A. (2009), Diritto e Disability Stdies. Materiali per una ricerca miltidisciplinare, Reggio
calabria, Falzea Editore
Medeghini R. (2005), Problematizzare il concetto di inclusione. Dall’integrazione all’inclusione,
«Animazione Sociale», vol.10, pp. 48-58.
Medeghini R., Valtellina E (2006 ), Quale disabilità?. Milano:Angeli
Medeghini R. (2006 ), Le pratiche inclusive come presupposto di cittadinanza, «Animazione
Sociale», vol. 10, pp. 70-80.
Medeghini R. (2012), Quali servizi nella prospettiva inclusiva? In R. Medeghini et al. (a cura di)
L’adulto disabile è risorsa di una comunità inclusiva, «Animazione Sociale», n. 261 pp. 42-
51.Medeghini R. et al (2013), Disability Studies, Trento: Centro Studi Erickson.
Nirje B. (1992), The normalization principle papers, Uppsala: Uppsala University Press.
Nussbaum M. C. (2002). Giustizia sociale e dignità umana. Bologna: il Mulino.
Nussbaum M. C. (2007). Le nuove frontiere della giustizia. Bologna: il Mulino.
Oliver M. (1996), Education for all? A perspective on an inclusive society, in Under-standing
disability, from theory to practice, Houndmills: Palgrave.
Saraceno C. (2001), (a cura di), Età e corso della vita. Bologna: il Mulino.
Sen A. (1994). La diseguaglianza. Un riesame critico. Bologna: il Mulino.
United Nations. (2006), Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York:
Disponibile online: http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconve.pdf.
Vadalà G. 2009), Oltre la differenza semantica. Riflessioni e note a margine del Convegno
sull’Educazione Inclusiva, in CQIA scuole
http://wwwdata.unibg.it/dati/bacheca/682/36460.pdf
Vadalà G. (2012), La voce del disabile nel tratteggiare la vita sociale. I disabili come attori di
ricerca emancipativa per l’intera comunità. In R. Medeghini et al. (a cura di), L’adulto
disabile è risorsa di una comunità inclusiva, «Animazione Sociale», n. 261, pp. 42-51.
Wolfensberger W.(1972, The principle of Normalization in Human services, Toronto: NIMR OMS,
2002.Puoi anche leggere