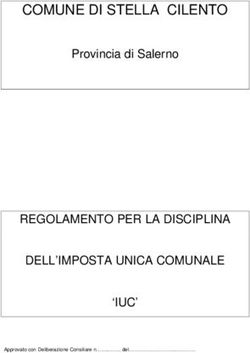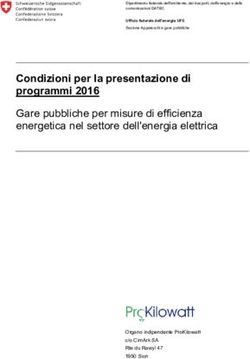Art. 47-ter - Filodiritto
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752
Direttore responsabile: Antonio Zama
Art. 47-ter
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio
Detenzione domiciliare (1)
01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo
III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall’articolo 51, comma 3-
bis, del codice di procedura penale e dall’articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella
propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona
che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i
settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia
stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale. (1-bis)
1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena,
nonché la pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata
dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell’ipotesi di cui alla lettera a),
in case famiglia protette, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; (2)
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia
deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi
sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
[1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’ articolo 99, quarto comma, del
codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se
costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni.] (3)
1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura
non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle
condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio
sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La
presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all’articolo 4-bis.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai
sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il
limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine
di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L’esecuzione della pena prosegue durante
la esecuzione della detenzione domiciliare. (4)
1-quater. L’istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio
l’esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei
casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza didetenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l’applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4. 1-quinquies. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall’articolo 41 -bis , il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell’esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1 - ter , o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis , anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il magistrato o il tribunale di sorveglianza procedono comunque anche in assenza dei pareri. (5) [2. La detenzione domiciliare non può essere concessa quando è accertata l’attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una scelta di criminalità.] (6) [3. Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la procedura di cui al comma 4 dell’articolo 47] (7) 4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare. [4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l’osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 275-bis del codice di procedura penale.] (8) 5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare. 6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure. 7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1, 1 bis e 1-ter. (9) 8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell’art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell’ultimo comma dello stesso articolo. (10) 9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio.
9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 414/1991, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che la reclusione militare sia espiata in detenzione domiciliare quando trattasi di persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali. (1-bis) La Corte costituzionale, con sentenza 56/2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, limitatamente alle parole "né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale". (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 177/2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della seconda parte della presente lettera. (3) Comma abrogato dal DL 78/2013, convertito con modifiche nella L. 94/2013. (4) La Corte costituzionale, con sentenza 99/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47- ter, comma 1-ter, nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter. (5) Questo comma è stato introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera b), del DL 28/2020. (6) Comma abrogato dal DL 152/1991, convertito con modifiche nella L. 203/1991. (7) Comma abrogato dalla L. 165/1998. (8) Comma abrogato dal DL 146/2013, convertito con modifiche nella L. 10/2014. (9) Il riferimento all'art. 1-ter è stato introdotto dall'art. 1 del DL 29/2020. (10) La Corte Costituzionale, con sentenza 177/2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell’art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall’art. 47-sexies, comma 2, della presente L. 354/1975, sul presupposto, di cui all’art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Rassegna di giurisprudenza Questioni di legittimità costituzionale L’art. 4-bis reca una disciplina speciale, a carattere restrittivo, per la concessione dei benefici penitenziari a determinate categorie di detenuti o di internati, che si presumono socialmente pericolosi in ragione del tipo di reato per il quale la detenzione o l’internamento sono stati disposti; disciplina la cui genesi risale alla “stagione emergenziale” in tema di lotta alla criminalità organizzata risalente al principio degli anni ’90 dello scorso secolo. Già nella versione di origine - introdotta dall’art. 1 DL 152/1991, convertito nella L. 203/1991 - l’art. 4-bis distingueva le figure criminose di riferimento in due “fasce”. Per i reati di “prima fascia”, a matrice o sfondo carattere associativo, l’accesso alle misure alternative era subordinato all’acquisizione di elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata; per i reati di “seconda fascia”, privi di tale connotazione ma comunque socialmente allarmanti, si richiedeva - in termini inversi, dal punto di vista probatorio - la mancata emersione di elementi tali da far ritenere attuali detti collegamenti. Erano parallelamente disposti aggravamenti istruttori, di natura obbligatoria, ancorché dall’esito non vincolante. In relazione, era previsto l’innalzamento dei “tetti” di pena stabiliti per i benefici penitenziari caratterizzati dall’accesso subordinato all’avvenuta espiazione di una predeterminata quota parte della pena stessa. A seguito della riforma operata dal DL 306/1992, convertito nella L. 356/1992, assunse un ruolo centrale, nell’economia
dell’istituto, la collaborazione con la giustizia. L’utile collaborazione, nei sensi indicati dall’art. 58-ter, divenne, infatti, condicio sine qua non per l’accesso ai benefici penitenziari, in rapporto ai delitti di “prima fascia”, salva - anche per effetto delle pronunce della Corte costituzionale e delle successive conformi modifiche legislative - l’equiparazione della collaborazione impossibile o «oggettivamente irrilevante», ove al condannato fossero state concesse talune attenuanti, sintomatiche di una minore pericolosità. Il meccanismo poggia sulla presunzione legislativa che la commissione di determinati delitti dimostri il collegamento dell’autore con la criminalità organizzata e costituisca, quindi, un indice di pericolosità sociale incompatibile con l’ammissione del condannato ai benefici penitenziari extra- murari. La scelta di collaborare con la giustizia viene assunta, in questa prospettiva, come una sorta di prova legale, la sola idonea ad esprimere con certezza la volontà di emenda del condannato e, dunque, a rimuovere l’ostacolo alla concessione delle misure, in ragione della sua valenza “rescissoria” di tale legame, ferma in ogni caso la necessità che risulti esclusa l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Pur a seguito del successivo incremento del relativo catalogo dei reati, l’assetto complessivo dell’istituto ha ripetutamente superato il vaglio di legittimità costituzionale, ancorché talune pronunce della Corte costituzionale, tra le quali vanno in particolare ricordate quelle in tema di rieducazione già raggiunta e di collaborazione impossibile e quelle relative ai minorenni, abbiano inciso su aspetti specifici (e limitati) della disciplina. Quanto ai reati di “seconda fascia”, il loro regime giuridico, nonostante la sempre più marcata eterogeneità dell’elencazione, via via aggiornata dal legislatore, non è sostanzialmente mutato dal 1991 ad oggi. Si tratta, in sostanza, di reati considerati espressivi - nella astratta valutazione, preventivamente operata dal legislatore - di accentuata pericolosità sociale del loro autore, la quale giustifica nel sistema legale la necessità di verificare, presso le competenti autorità di pubblica sicurezza, se sussistano collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, la cui emersione soltanto opera, “in negativo”, come fattore preclusivo del beneficio penitenziario. Il DL 11/2009, convertito nella L. 38/2009, nel ridisegnare l’intera impalcatura della disposizione, ha poi, tra l’altro, istituito una “terza fascia”, solo contrassegnata dal condizionamento dei benefici all’espletamento di un periodo minimo di osservazione in istituto di pena. Attualmente il sistema delineato dall’art. 4-bis istituisce, pertanto, un ventaglio di presunzioni di pericolosità ostative, vincibili: per i delitti di “prima fascia”, oggi individuati nel comma 1, solo in forza della esigibile e prestata collaborazione con la giustizia, ferma la necessità dell’accertamento della insussistenza di collegamenti con il crimine organizzato; per i delitti di “seconda fascia”, oggi identificati con quelli di cui al comma 1-ter, dall’assenza di elementi deponenti per tali collegamenti; per i delitti di “terza fascia”, delineati nel sue comma 1-quater, sulla scorta di una complessa valutazione sull’evoluzione della personalità del condannato. In tale tessuto ordinamentale si inserisce la disposizione del comma 1-bis dell’art. 47-ter, la cui introduzione risale alla L. 165/1998, che, secondo l’inevitabile interpretazione sopra ricordata, introduce una presunzione assoluta di inidoneità contenitiva della detenzione domiciliare di tipo ordinario, rispetto ai condannati per certuni titoli di reato, ritenuti di per sé espressivi di più accentuata pericolosità, in ragione del loro inserimento nel catalogo di cui all’art. 4-bis. Per costoro, la detenzione domiciliare di cui si discute è, per definizione e in assoluto, ritenuta inadeguata ad evitare il pericolo di recidiva. Siffatto assetto appare tuttavia non coerente con gli artt. 3, comma 1, e 27, commi 1 e 3, Cost., potendo dubitarsi della intrinseca ragionevolezza della preclusione assoluta così istituita, e della sua conformità ai principi di rieducazione e di personalità e proporzionalità che dovrebbero sorreggere la risposta punitiva in ogni momento della sua attuazione. La giurisprudenza costituzionale sembra, invero, orientata in linea di principio ad escludere, anche nella materia dei benefici penitenziari, la legittimità di rigidi automatismi, e a richiedere invece che vi sia sempre una valutazione individualizzata, così da
collegare la concessione o meno del beneficio a una prognosi ragionevole sulla sua utilità a far procedere il condannato sulla via dell’emenda e del reinserimento sociale (Corte costituzionale, sentenze 291/2010, 189/2010, 255/2006, 436/1999; da ultimo, sentenza 149/2018). Le presunzioni di pericolosità sono eccezionalmente ammesse, a patto che non siano arbitrarie né irrazionali, in quanto rispondenti a dati di esperienza generalizzati, non suscettibili di agevole smentita, e che non siano neppure ad altro titolo lesive di valori costituzionali. Incompatibili con tale opzione di fondo dovrebbero allora ritenersi previsioni, come quella oggetto di scrutinio, che precludano in modo assoluto l’accesso a un beneficio penitenziario in ragione soltanto della particolare gravità del titolo di reato commesso, riflessa dall’inclusione di quest’ultimo in un catalogo (quello ex art. 4-bis) cui si ricollegano, a vari livelli, indici presuntivi di pericolosità che - a prescindere da ogni considerazione circa l’estrema eterogeneità dei titoli inclusi - parrebbero potersi ritenere legittimi solo nella misura in cui gli stessi risultino, in concreto, agevolmente vincibili: così in radice impedendo, la disposizione in esame, l’accesso alla misura alternativa anche ai condannati per i quali, per l’avverarsi dei presupposti risolutivi indicati dalla legge - la prestata utile collaborazione con la giustizia (ove richiesta), la rescissione o mancata instaurazione dei collegamenti con il crimine organizzato e gli eventuali progressi nel percorso di rieducazione - la presunzione di perdurante pericolosità sociale sarebbe invece da escludere proprio ai sensi dell’art. 4-bis, in sintonia con l’impostazione di fondo del regime ivi delineato. Anche in questo caso, in realtà, il legislatore parrebbe mosso solo «dall’esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati» (Corte costituzionale, 149/2018), che però, come non può di per sé giustificare presunzioni assolute nella fase di verifica del grado e dell’adeguatezza delle misure cautelari durante il processo (Corte costituzionale, 331/2011), nemmeno parrebbe legittimare, nella fase di esecuzione della pena, operazioni «in chiave distonica rispetto all’imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena medesima, da intendersi come fondamentale orientamento di essa all’obiettivo ultimo del reinserimento del condannato nella società ( sentenza 450/1998), e da declinarsi nella fase esecutiva come necessità di costante valorizzazione, da parte del legislatore prima e del giudice poi, dei progressi compiuti dal singolo condannato durante l’intero arco dell’espiazione della pena (Corte costituzionale, 149/2018). Si coglie appieno allora, sotto gli aspetti considerati, l’irragionevolezza intrinseca della disposizione censurata, in relazione al valore della responsabilità penale personale e alla necessaria finalità rieducativa della pena. Irragionevolezza intrinseca non sfuggita, peraltro, in sede di attuazione della delega contenuta nella L. 103/2017, nella parte relativa alle modifiche all’ordinamento penitenziario, se è vero che, nello schema originario del conseguente decreto legislativo, era stata prevista la soppressione della disposizione censurata. E nonostante tale scelta non sia stata confermata nel testo definitivo, non può omettersi in questa sede di rilevare come opportunamente nella relazione illustrativa governativa (pag. 37) si rimarcasse che comunque - venuta meno l’esclusione dell’applicabilità della detenzione domiciliare “comune” ai condannati per reati di cui all’art. 4-bis, limite in grado di precludere l’accesso alla misura anche ai condannati che avessero collaborato con la giustizia - sarebbero rimaste ferme tutte le condizioni di accesso ordinariamente stabilite dalla normativa speciale a tutela della sicurezza pubblica. Tale irragionevolezza intrinseca si accentua, se si pone specifica attenzione al delitto di rapina aggravata, per il quale la ricorrente deve ancora scontare parte di pena, incluso in “seconda fascia”. Sicuramente estraneo, nella fattispecie strutturale e nelle più frequenti manifestazioni empiriche, a contesti di crimine organizzato - elemento che, in senso contrario, connota, di massima, i reati della fascia antecedente - la rapina aggravata si trova indiscriminatamente, e illogicamente, ai medesimi reati accomunata nell’effetto di comprimere in modo irrimediabile lo spazio applicativo di una misura alternativa alla detenzione. Con
il paradosso che - se, per i reati della prima categoria, il risultato che si produce è la mera esasperazione della innegabile sfiducia ordinamentale verso il buon esito di percorsi rieducativi estranei al sistema carcerario - per la rapina aggravata non vige alcuna generale presunzione di immeritevolezza del relativo condannato rispetto al beneficio penitenziario, la cui concessione è solo circondata da maggiori cautele, temporali e istruttorie. Per essa, dunque, la disposizione censurata rappresenta una “rottura” della filosofia cui si ispira il sotto-sistema costituito dall’art. 4-bis. La rapina aggravata, del resto, può assumere in concreto, e in base a dati di comune esperienza giudiziaria moltissime volte assume, una dimensione di ridotta offensività oggettiva e può non essere affatto sintomatica di una pericolosità contenibile solo con misure carcerarie: come è a dirsi con riferimento al caso di specie, ove con essa non concorsero delitti più gravi; le “armi” usate erano un coltello e una pistola giocattolo; la somma sottratta era esigua ed ebbe luogo il risarcimento del danno; la pena patteggiata è modesta ed è stata già in parte espiata in regime cautelare attenuato (arresti domiciliari); non è stato rilevato collegamento alcuno della condannata con la criminalità organizzata; risulta relazione dell’Ufficio di esecuzione penale esterna la possibilità di reinserimento familiare. Sicché la constatazione che la possibile ricorrenza di analoghi indicatori non è affatto inusuale, o eccezionale, “carica” la disposizione anzidetta di contraddizioni interne ulteriori. Non potrebbe neppure sostenersi che il divieto assoluto della detenzione domiciliare ordinaria, rispetto al condannato per uno dei delitti ex art. 4-bis, e comunque rispetto alla rapina aggravata, trovi la sua ragion d’essere nell’estraneità della detenzione domiciliare al circuito rieducativo e trattamentale. La detenzione domiciliare, inserita tra le misure alternative alla detenzione di cui al Titolo I, Capo VI dell’ordinamento penitenziario, realizza, come sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza 165/1996), una modalità meno afflittiva di esecuzione della pena. L’istituto, dopo l’ampia riforma realizzata con la L. 165/1998 (cui si deve, come già si ricordava, l’introduzione, nel corpo dell’art. 47-ter, del comma 1-bis), ha assunto aspetti più vicini e congrui alla ordinaria finalità rieducativa e di reinserimento sociale della pena, non essendo esso più limitato alla protezione dei “soggetti deboli” prima previsti come destinatari esclusivi della misura, ed essendo applicabile in tutti i casi di condanna a pena non superiore a due anni (anche se residuo di maggior pena), purché risulti in concreto idoneo ad evitare il pericolo di recidiva (Corte costituzionale, 422/1999, la quale ha ritenuto che la concessione d’ufficio del beneficio, al condannato che ne abbia titolo, non soltanto non è in contrasto, ma piuttosto realizza lo scopo rieducativo di cui all’art. 27 Cost.). E, secondo Corte costituzionale 239/2014, la detenzione domiciliare non solo non prescinde da contenuti trattamentali ma è partecipe a pieno titolo della finalità di reinserimento sociale del condannato, costituente l’obiettivo comune di tutte le misure alternative alla detenzione; il che è comprovato tanto dal requisito negativo di fruibilità, rappresentato dalla insussistenza del pericolo di commissione di ulteriori delitti, quanto dalla disciplina delle modalità di svolgimento della misura e delle ipotesi di revoca. D’altronde, in linea ancora più generale, già Corte costituzionale 173/1997 osservava che, se è vero che la misura alternativa della detenzione domiciliare «è indubbiamente caratterizzata da una finalità umanitaria ed assistenziale [...] non può negarsi che essa ha in comune con le altre misure alternative - come avverte anche la giurisprudenza di legittimità. E alla possibilità del raggiungimento di tale finalità, ben può - e perciò deve anche - guardarsi nel momento della concessione del beneficio. Né la misura è priva di prescrizioni a contenuto risocializzante, alla cui formulazione e al cui controllo concorrono gli UEPE previsti dall’art. 72. Considerazioni, queste, che paiono ulteriormente confortare il dubbio circa l’irragionevolezza intrinseca di una previsione che, nel precludere ai condannati per i reati di cui all’art. 4-bis (e, comunque, ai condannati per rapina aggravata) l’accesso alla particolare forma di detenzione domiciliare prevista per le pene detentive inferiori a due anni di reclusione, non riserva alcun rilievo alla
concreta pericolosità del soggetto, desumibile dalla sua condotta o dalla sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, così violando altresì i principi della personalità e finalità rieducativa della pena e il principio della progressività del trattamento, quali affermati dalla costante giurisprudenza costituzionale. Proprio in relazione a quest’ultimo principio, quello della progressività del trattamento, non può, d’altra parte, non evidenziarsi che il condannato per un delitto ricompreso tra quelli elencati dall’art. 4-bis potrebbe essere ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale, ove sussistano le condizioni previste in tale norma, mentre gli è inibito l’accesso alla detenzione domiciliare prevista dal comma 1-bis del successivo art. 47-ter, nonostante quest’ultima misura abbia carattere maggiormente contenitivo e sia perciò semmai maggiormente idonea a fronteggiarne la pericolosità sociale eventualmente residua. Vero è che la Corte costituzionale, giudicando di analoga denunciata contraddizione, ha rilevato (sentenza 338/2008) che l’affidamento in prova è misura non «omogenea» rispetto alle misure gradate, quanto a requisiti soggettivi di ammissione. Per la concessione dell’affidamento in prova è necessaria, infatti, una prognosi di rieducazione del reo, opportunamente assistito, e di ragionevole assenza del rischio di recidiva. Se questa è la valutazione effettuata sulla personalità del condannato, nel caso concreto ed alla luce di tutti i parametri indicati dalla legge, rispetto all’affidamento si giustifica - per il giudice delle leggi - la parificazione tra coloro che hanno commesso reati in astratto valutati con particolare severità, come quelli previsti dall’art. 4-bis, e tutti gli altri condannati, sempre che la pena da espiare non superi i tre (ora quattro) anni; parificazione che invece non sarebbe imposta allorché il rischio di recidiva esista e abbia bisogno di contenimento (come era, nel caso sottoposto allora a giudizio, per il condannato ritenuto meritevole della sola semilibertà, accessibile a condizioni più gravose). Lo schema di ragionamento potrebbe essere mutuato a proposito della detenzione domiciliare, concessa in via gradata rispetto al pur richiesto affidamento in prova. Anche qui il condannato non presenta le caratteristiche personali e comportamentali di piena affidabilità, sufficienti a far ritenere che sia del tutto assente il rischio di reiterazione. Il legislatore potrebbe dunque ritenersi legittimato a conformare, mediante più severe regole di accesso, una misura alternativa siffatta, che presuppone debba fronteggiarsi un certo grado di pericolosità. Tuttavia tale aggravamento di disciplina - se rende «non [...] manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di pretendere una congrua espiazione della pena inflitta, prima di far acquistare [al condannato] una condizione che, comunque, implica un atto di fiducia dello Stato nei confronti di chi si sia reso responsabile di reati di particolare gravità» (sentenza 338/2008) - non sembra invece altrettanto giustificabile allorché arriva ad escludere, in maniera categorica, l’accesso alla misura alternativa più contenitiva, e quindi anche alla forma di detenzione domiciliare “comune”, parte integrante, come sopra evidenziato, di un ordinamento penitenziario partecipe dei valori della risocializzazione. Una diversificazione dei requisiti di ammissione alle misure, congegnata in termini così estremi, parrebbe eccedere i margini della pur ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione degli istituti di diritto penitenziario nella pur sempre necessaria prospettiva della risocializzazione del condannato. Né sembra coerente con l’assunto che tale prospettiva, come «chiama in causa la responsabilità individuale del condannato nell’intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità, in linea con le esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda la convivenza civile», parimenti «non può non chiamare in causa - assieme - la correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato ad intraprendere tale cammino, anche attraverso la previsione da parte del legislatore - e la concreta concessione da parte del giudice - di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento del condannato nella
società» (Corte costituzionale, 149/2018). Appare dunque non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-bis, nella parte in cui prevede che tale disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all’art. 4-bis, avuto riguardo all’irragionevolezza intrinseca di tale disposizione, in relazione ai principi della personalizzazione e finalità rieducativa della pena, da cui consegue l’esigenza di trattamenti penitenziari non legati esclusivamente a catalogazioni per tipi d’autore e non sbarrati da presunzioni invincibili, ma misurati in base alla concreta gravità dei fatti-reato commessi e alla effettiva pericolosità del condannato, nonché l’esigenza di percorsi di responsabilizzazione ispirati al principio di progressione e gradualità. La questione appare, quindi, certamente rilevante nel presente giudizio. Soltanto il suo accoglimento consentirebbe infatti, in accoglimento del petitum sostanziale oggetto del terzo motivo di ricorso, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza perché valuti nel merito l’esistenza delle condizioni per l’accesso della condannata alla detenzione domiciliare da lei richiesta. Alla stregua di tutte le argomentazioni sin qui svolte, deve conclusivamente dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui prevede che tale disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all’art. 4-bis della medesima legge (Sez. 1, 9126/2019). Competenza per territorio La competenza per territorio del magistrato o del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente “all’atto della richiesta” (secondo la testuale indicazione dell’art. 677 c.p.p.) di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti: e, ciò, anche nelle ipotesi in cui subentri, dopo la presentazione della richiesta iniziale, la rimessione in libertà del soggetto. Tale principio non muta, naturalmente, anche nell’ipotesi in cui, essendo libero il condannato, sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione, con evenienza, ex art. 656 c.p.p., della competenza del TDS del luogo in cui ha sede l’ufficio del PM che ha promosso la sospensione (Sez. 1, 53177/2014). L’esito di questo rilievo non muta, per gli effetti che la notazione determina in questa sede, per il fatto che, dopo la presentazione da parte del condannato dell’istanza di accesso a una misura alternativa alla detenzione, sopraggiungano altre istanze volte a incidere sulla medesima misura o comunque siano alla stessa connesse o collegate, giacché anche in tal caso la competenza resta ferma, in virtù del richiamato principio della perpetuatio iurisdictionis, che esige di annettere rilevanza al momento della prima richiesta di misura alternativa (Sez. 1, 4098/2020). La competenza di tipo funzionale del magistrato di sorveglianza si appunta in capo all’organo che ha giurisdizione sull’istituto in cui il detenuto “si trova”. Si deve, tuttavia, chiarire che, ai sensi dell’art. 677, detto luogo e il relativo riferimento normativo si legano alla località in cui il detenuto è assegnato in via definitiva, salvo che costui non sia ancora destinatario di provvedimento siffatto, caso in cui di converso, indubbiamente avrebbe facoltà di adire e rivolgersi al magistrato di sorveglianza del luogo stesso. Per i casi, tuttavia, in cui il detenuto sia in transito e risulti solo temporaneamente ristretto, la competenza in generale resta attribuita al magistrato del locus custodiae definitivo e non sussistono le condizioni per provvedimenti legati a criterio di competenza itinerante nel senso che per il semplice accesso - anche di poche ore - all’istituto di pena si realizza una modifica della competenza dal magistrato di sorveglianza del luogo di assegnazione e detenzione definitiva a quella del magistrato di
sorveglianza del luogo di transito (Sez. 7, 35405/2018). Ricordato che, in caso di concorso di residenza anagrafica e di domicilio di fatto in Italia, la competenza territoriale va, comunque, radicata in base al criterio della residenza anagrafica, operando il criterio del domicilio solo in via residuale, va chiarito che, ai fini di cui all’art. 677, comma 2, la nozione di domicilio deve essere definita, ai sensi dell’art. 43 Cod. civ., come il luogo dove il soggetto ha il centro dei propri interessi, e tale non può, all’evidenza, essere considerato il luogo dove, solo ai fini del procedimento relativo alla istanza presentata, l’interessato ha eletto domicilio presso il quale ricevere comunicazioni e notificazioni del procedimento stesso. Siffatta nozione di domicilio si lascia preferire sia per ragioni di coerenza sistematica sia perché capace di assicurare la necessaria oggettività del criterio attributivo della competenza per territorio (funzionale al rispetto del principio costituzionale del giudice naturale), mentre il rilievo, a detti fini, dell’atto di elezione renderebbe la determinazione del giudice competente dipendente da una libera ed insindacabile scelta del soggetto che propone l’istanza (Sez. 1, 31346/2018). In tema di procedimento di sorveglianza, qualora dopo la presentazione da parte del condannato dell’istanza di accesso ad una misura alternativa alla detenzione, sopraggiungano altre istanze volte ad incidere sulla medesima misura o comunque siano ad essa connesse o collegate, rimane ferma, in virtù del principio della “perpetuatio iurisdictionis”, la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza radicatasi con riferimento alla situazione esistente al momento della prima richiesta di misura alternativa (Sez. 1, 51083/2013). Il ricorrente, al momento di presentazione dell’istanza ex art. 35-ter Ord. pen., era detenuto; ed era detenuto anche al momento della decisione del magistrato di Sorveglianza così come era detenuto al momento di proposizione del reclamo al tribunale di Sorveglianza. Nelle more del procedimento di impugnazione è stato scarcerato per termine della pena. Questa circostanza ha indotto il tribunale di sorveglianza a ritenere inammissibile il reclamo poiché la richiesta iniziale di riduzione della pena era stata trasformata in richiesta di liquidazione del ristoro economico previsto dalla norma citata: ha ritenuto il giudice che fosse stato irritualmente trasformato il petitum e che la competenza a provvedere fosse ormai del tribunale civile. Tuttavia, questa Corte ha più volte espresso il principio secondo il quale presupposto necessario per radicare la competenza della magistratura di sorveglianza è lo stato di restrizione del richiedente al momento della proposizione del reclamo ex art. 35-ter Ord. pen., a nulla rilevando l’eventuale scarcerazione nelle more della decisione, trattandosi di competenza di natura funzionale (Sez. 1, 41211/2018). La richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma 6, deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto. Né l’inosservanza delle formalità di cui all’art. 677, comma 2-bis, può essere superata dalla mera indicazione di residenza, che, non comportando l’inequivocabile volontà di riconoscere il proprio domicilio con la residenza dichiarata, non risulta rispettosa dei parametri di cui all’art. 677, comma 2-bis (SU, 18775/2010). La competenza in materia di concessione di misure alternative alla detenzione, in ipotesi di condannato per il quale è stata disposta la sospensione dell’esecuzione, appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l’ufficio del PM che ha decretato la sospensione, a norma dell’art. 656, commi 5 e 6, norme che debbono ritenersi speciali e prevalenti rispetto al disposto dell’art. 677, comma 2 (Sez. 1, 2182/2018). Nell’escludere l’applicabilità delle regole derogatorie di competenza, stabilite dall’art. 16-nonies DL 8/1991, convertito dalla L. 82/1991, alla liberazione anticipata - pur formalmente rientrante tra le misure
alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI Ord. pen. - richiesta dal detenuto collaboratore di giustizia, assoggettato a speciali misure di protezione, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, 43798/2015) ha da ultimo sottolineato la natura di stretta interpretazione delle regole derogatorie anzidette, correlata al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 comma 2 Cost.). Nelle materie attribuite alla magistratura di sorveglianza, la competenza a conoscere delle istanze presentate da soggetto ristretto in istituto penitenziario appartiene in via ordinaria al tribunale o al magistrato di sorveglianza avente giurisdizione sull’istituto medesimo (art. 677, comma 1). La deroga che a tale disposizione apporta, per i collaboratori di giustizia assoggettati a speciali misure di protezione, il citato art. 16-nonies - il quale riserva, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui il collaboratore stesso ha eletto domicilio ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, del decreto legge (ossia del luogo sede della Commissione centrale prevista dal precedente art. 10, comma 2, che è Roma), la cognizione in tema «di liberazione condizionale, di assegnazione al lavoro all’esterno, di concessione dei permessi premio e di ammissione a taluna delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, L. 354/1975, e successive modificazioni » - trova la sua ratio giustificativa nell’esigenza funzionale di assicurare uno stretto coordinamento tra l’operato della magistratura di sorveglianza, che decide sulla concessione delle misure alternative, prevista in misura più ampia rispetto alle generalità dei detenuti, e quello degli organi amministrativi centrali preposti all’attuazione delle misure predette nei confronti del collaboratore protetto (Sez. 1, 45282/2013) e capaci altresì di recare un preventivo contributo ai fini di una più pregnante valutazione sull’attualità e sulla serietà del percorso seguito dal collaboratore (Sez. 1, 43798/2015), che costituisce il presupposto per il più ampio accesso ai benefici (la riassunzione si deve a Sez. 1, 8131/2018). I provvedimenti in materia di rinvio dell’esecuzione della pena non sono testualmente compresi nell’ambito dell’art. 16-nonies DL 8/1991, convertito dalla L. 82/1991, e non partecipano della ratio ad esso sottesa; né sul piano funzionale, posto che, dopo la liberazione e per il tempo del differimento, nessuno specifico raccordo, di natura istituzionale ed organizzativo, è necessario mantenere tra organi della giurisdizione ed organi esecutivi; né sul piano logico-sistematico, perché i provvedimenti ex artt. 146 e 147 Cod. pen. postulano il riscontro di condizioni legittimanti (la presentazione della domanda di grazia, lo stato di gravidanza, di maternità, di salute) già in possesso dell’AG o ricavabili essenzialmente dalle relazioni degli operatori a diretto contatto con il detenuto in istituto, o dei sanitari di quest’ultimo; condizioni che comunque - così come affermato per la liberazione anticipata - non implicano previe valutazioni sul regime di collaborazione con la giustizia, e sulla sua valenza ed importanza, così da non giustificare lo spostamento di competenza ad un organo giudiziario diverso da quello altrimenti “naturale”. Né a diversa conclusione può indurre la circostanza che, nei casi di accoglimento dell’istanza di rinvio, il giudice competente possa disporre in sua vece la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47- ter Ord. pen. La misura in tal caso disposta, pur annoverabile tra le misure alternative in senso lato, ha una finalità eminentemente assistenziale, potendo essa essere applicata, anche d’ufficio, al fine di contemperare le necessità del condannato, in relazione alla tutela della salute (o delle altre esigenze contemplate dagli artt. 146 e 147 Cod. pen.) i e quelle della collettività, in relazione ai profili di sicurezza pubblica (Sez. 1, 12565//2015). Essa non richiede alcun apprezzamento, né in ordine all’importanza della collaborazione, né in ordine al ravvedimento (ed al riflesso presupposto dell’assenza di mantenuti collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva), che sono i requisiti cui, nel sistema delineato dall’art. 16-nonies citato, è ancorata la concessione delle misure, marcatamente premiali, viceversa prese in considerazione ai fini della deroga di competenza; requisiti, al tempo stesso, in
rapporto ai quali riveste importanza decisiva l’apporto di conoscenza degli organi centrali di protezione, e in questo quadro, trova senso l’istituito stretto collegamento tra la sede di tali organi e la competenza giudiziaria. Deve essere pertanto conclusivamente affermato il seguente principio di diritto: “ In tema di rinvio, necessario o facoltativo dell’esecuzione della pena, la competenza a provvedere sull’istanza del soggetto detenuto, collaboratore di giustizia, appartiene al magistrato o al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, quand’anche l’interessato richieda, o il giudice ritenga comunque di applicare, la detenzione domiciliare in luogo del differimento, non operando la regola di cui all’art. 16-nonies, comma 8, DL 8/1991, convertito dalla L. 82/1991, che prevede la competenza territoriale esclusiva del giudice di sorveglianza di Roma” (Sez. 1, 8131/2018). Competenza per le istanze presentate da collaboratori di giustizia Dispone l’art. 16-noníes, comma 8, DL 8/1991: «Quando i provvedimenti di liberazione condizionale, di assegnazione al lavoro all’esterno, di concessione dei permessi premio e di ammissione a taluna delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono adottati nei confronti di persona sottoposta a speciali misure di protezione, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha eletto il domicilio a norma dell’articolo 12, comma 3-bis, del presente decreto». In questa cornice, deve rilevarsi che l’indicato art. 16-nonies, nel richiamare espressamente l’applicazione delle «misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni [...]», ai fini dell’individuazione della competenza della magistratura di sorveglianza, non consente alcuna distinzione fondata sulla natura trattamentale del beneficio penitenziario invocato, introducendo una deroga alle regole generali stabilite dall’art. 677, comma 1, c.p.p. dalla quale deriva la competenza funzionale della magistratura di sorveglianza di Roma. 3 Sulla base di queste considerazioni, la competenza generale della magistratura di sorveglianza di Roma per i collaboratori di giustizia deve considerarsi come la conseguenza di un’attribuzione di natura funzionale, che costituisce un’eccezione alle regole generali stabilite dall’art. 677, comma 1, c.p.p. e non è derogabile (Sez. 1, 4930/2020). La detenzione domiciliare non è un diritto del detenuto Posto il tenore testuale dell’art. 47-ter, secondo cui, alle condizioni e nei limiti ivi previsti, le pene possono essere espiate in regime di detenzione domiciliare, è da escludere che l’applicazione di tale misura alternativa possa mai costituire oggetto di un diritto, essendo essa al contrario sempre subordinata ad una valutazione discrezionale affidata al giudice di merito. Quest’ultimo, quindi, è investito del potere-dovere di valutare non solo la effettiva ricorrenza o meno di una o più tra le condizioni dettate dal legislatore, ma anche la compatibilità o meno del beneficio con le esigenze di un’effettiva espiazione della pena inflitta. Per poter godere del beneficio della detenzione domiciliare non basta disporre di un determinato luogo di privata dimora, ma occorre pure che la personalità del condannato faccia ritenere positivamente che tale misura, alternativa alla detenzione in carcere, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (Sez. 7, 5849/2020). Osservazione della personalità Come dimostra la lettura dell’art. 47, l’osservazione e la valutazione della personalità e del comportamento del detenuto è il punto di riferimento principale per la decisione sull’applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale; analoga valutazione è richiesta per la semilibertà dall’art. 50, comma 4, che fa riferimento ai progressi compiuti nel corso del trattamento; implicitamente, anche la norma dell’art. 47-ter sulla detenzione domiciliare richiede tale valutazione. L’importanza di tale
osservazione e valutazione è ovvia: se la pena detentiva è finalizzata alla rieducazione del condannato, il giudizio di pericolosità attuale del soggetto e di utilità di una misura alternativa non può essere espresso soltanto sulla base delle informazioni relative al periodo anteriore alla detenzione (salvi i limiti disposti dal legislatore nella concessione delle misure alternative con riferimento a determinati reati), ma deve tenere conto degli esiti del trattamento penitenziario fino al momento della richiesta (Sez. 1, 831/2020). In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice - nell’esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato (in particolare, l’UEPE) - non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi. Il giudice è, invece, tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, 38219/2019). In questa direzione, di conseguenza, il TDS, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere (in questa prospettiva, sia pure in un contesto di verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, 5213/2020). Sanzioni disciplinari Nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione di una misura alternativa alla detenzione si devono utilizzare tutti gli elementi da cui desumere l’assenza di partecipazione all’opera di rieducazione del condannato, nel cui contesto i comportamenti intramurari oggetto di sanzioni disciplinari assumono un rilievo altamente sintomatico del percorso rieducativo intrapreso dal detenuto durante l’esecuzione della pena. Non v’è dubbio, infatti, che le trasgressioni comportamentali del detenuto - soprattutto se ripetute nel tempo, assumono una valenza negativa, risultando espressive della scarsa partecipazione all’opera di rieducazione del carcerato, in quanto sintomatiche dell’assenza di effetti positivi sul percorso intrapreso (Sez. 1, 4387/2019). Immunodeficienza, grave deficienza immunitaria e altre malattie particolarmente gravi
In tema di emergenza da Covid-19, fermo restando che l'incompatibilità tra le condizioni di salute del detenuto e il regime carcerario deve essere concreta ed effettiva, e non ipotetica e potenziale, sicché il rischio di contrarre l'infezione deve risultare da elementi specifici che rivelino fattori di effettivo e concreto pericolo, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi a valutazioni astratte sull'idoneità dei presidi sanitari all'interno del circuito penitenziario, ma deve tener conto delle patologie da cui risulta affetto il soggetto ristretto, tali da comportare, in caso di contagio, l'insorgere di gravi complicanze o la morte, e delle obiettive condizioni dell'istituto penitenziario, per la eventuale presenza di casi di contagio e la possibilità di adottare specifiche misure di prevenzione atte ad impedirne la diffusione, per esempio mantenendo la distanza di sicurezza tra detenuti "a rischio" (ha precisato la Corte che, nel caso de quo, il tribunale si è limitato a valutare l'esito negativo dei test di intolleranza riferiti soltanto a due farmaci (gentamicina e cirpofloxacina) senza spiegare la loro utilità nella cura dell' infezione da Covid 19 e, più a monte, senza indicare se, nella situazione concreta in cui versa il detenuto, per le patologie pregresse e per la condizione dell'istituto dove è ristretto, corra o meno un rischio serio di contrarre detta infezione e se, in caso di contagio, le cure risulterebbero o meno compromesse dall'impossibilità di somministrare i farmaci di elezione, come accertato dal consulente della difesa con argomentazioni scientifiche ritenute valide dal Tribunale del riesame ma nemmeno prese in esame dall'ordinanza impugnata anche al solo fine di disattenderle) (Sez. 1, 38103/2021). Il magistrato di sorveglianza, nel valutare la possibilità di ammettere il detenuto che debba espiare pena detentiva non superiore a diciotto mesi alla detenzione al domicilio ai sensi dell'art. 123 DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, può ravvisare un grave motivo ostativo al beneficio nel pericolo di reiterazione di reati, purché ne accerti la sussistenza e ne offra specifica giustificazione (nel caso specifico, osserva la Corte che la conforme decisione dei giudici di sorveglianza nei due gradi in cui si è articolato il procedimento è supportata da congrua motivazione che espone i dati informativi rilevanti e giustifica in termini logici, coerenti e privi di vizi giuridici il giudizio prognostico negativo espresso a carico del ricorrente. rilevando la attuale pericolosità sociale del richiedente, intesa quale valutazione prognostica circa l'elevata probabilità di ricaduta nel crimine, desunta dal contesto ambientale e familiare di maturazione delle condotte criminose, dalla natura e dalla pluralità dei delitti commessi, dalla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina in concorso, detenzione illegale di armi e dalla gravità di quelli ulteriori di concorso in tentato omicidio e violazione della disciplina sulle armi) (Sez. 1, 8885/2021). Ai fini del differimento obbligatorio della pena detentiva, di cui all’art. 146, comma 1, n. 3), c.p. - o della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, che ne mutua i presupposti - rileva l’esistenza della sindrome da immunodeficienza acquisita conclamata, o di grave deficienza immunitaria, o di altra malattia particolarmente grave, giunte in ogni caso ad una fase così avanzata da escludere la rispondenza del soggetto ai trattamenti disponibili o alle terapie curative (Sez. 1, 42276/2010) Rispetto al differimento cosiddetto. facoltativo, di cui all’art. 147, comma 1, n. 2), c.p. (e alla detenzione domiciliare sostitutiva, sopra citata), è viceversa richiesto uno stato .di «grave infermità fisica», ravvisabile quando la malattia da cui è affetto il condannato sia comunque tale da porre in pericolo la vita, o da provocare rilevanti conseguenze dannose, e comunque da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato, che trova fondamento nell’art. 32 Cost., e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, 789/2014). Al contempo, la giurisprudenza di legittimità rileva che, rispetto al differimento facoltativo, debbano considerarsi anche patologie ulteriori, che siano di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma
Puoi anche leggere