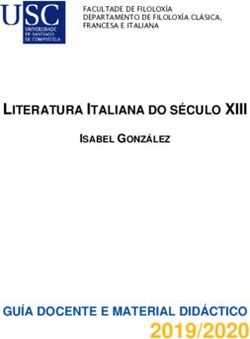2019/2020 GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO - LITERATURA ITALIANA DO SÉCULO XIV - Usc
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
FACULTADE DE FILOLOXÍA
DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA CLÁSICA,
FRANCESA E ITALIANA
LITERATURA ITALIANA DO SÉCULO XIV
ISABEL GONZÁLEZ
GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO
2019/2020FACULTADE DE FILOLOXÍA. DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA CLÁSICA, FRANCESA E ITALIANA AUTORES: Isabel González Edición electrónica. 2019 ADVERTENCIA LEGAL: Reservados todos os dereitos. Queda prohibida a duplicación total ou parcial desta obra, en calquera forma ou por calquera medio (electrónico, mecánico, gravación, fotocopia ou outros) sen consentimento expreso por escrito dos autores.
INDICE
1. DATI DESCRITTIVI DELLA MATERIA
2. SIGNIFICATO DELLA MATERIA ALL’INTERNO DEL PIANO DI STUDIO
3. OBBIETTIVI
4. COMPETENZE DA ACQUISIRE
5. CONTENUTI
6. BIBLIOGRAFIA
7. METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
8. VALUTAZIONE
1. DATI DESCRITTIVI DELLA MATERIA
1.1. Materia:
Denominazione della materia: LIteratura italiana do século XIV
Codice: G5081437
Tipo: Obbligatoria
Corso di Laurea (“grado”): Linguas e Literaturas Modernas: Italiano
Corso: 4º corso
Numero di crediti ECTS: 6
Periodo di svolgimento: Secondo quadrimestre
1.2. Docenza:
Docente del corso: Dott.ssa Isabel González
Lingua impiegata: Italiano. Le lezioni si svolgeranno, fondamentalmente, in
italiano; se necessario, per tradurre e/o chiarire eventuali dubbi, si userà anche il
gallego e lo spagnolo
Area: Filoloxía Italiana
Dipartamento: Filoloxía Clásica, Francesa e Italiana
Facoltà: Filoloxía
Ufficio: 440 (4º piano)
Telefono: 881811865
E-mail: isabel.gonzalez@usc.es
Orario del corso: L, Mt e Mc. 9.00-10.00
Orario di ricevimento: L, Mt e Mc: 11.00-13.00
31.3.Requisiti previ e condizioni ottimali:
È essenziale avere una competenza media dell’italiano orale e scritto.
Trattandosi di una materia obbligatoria dell’ultimo anno, cioè del 4º corso si
suppone, -affinchè si possa studiare con proffito la letteratura del s. XIV-, che lo
studente abbia un livello medio/alto di lingua italiana e che abbia superato le materie
letterarie dei primi corsi (Literatura italiana: Correntes e movimentos (1º), Xéneros
literarios italianos: lírica (2º), Xéneros literarios italianos: narrativa (2º), Xéneros
literarios italianos: teatro (2º), Literatura italiana do século XX (3º), Literatura italiana
do século XIX (3º), e anche la Literatura italiana dos séculos XVII e XVIII (4º primeiro
quadrimestre) e la Literatura italiana dos séculos XV e XVI (4º primeiro quadrimestre),
grazie alle qualli dovrebbe aver imparato a capire, annalizzare e commentare i testi.
2. SIGNIFICATO DELLA MATERIA ALL’INTERNO DEL PIANO DI STUDIO
2.1. Modulo di appartenenza
Nell’ambito del “grado en Linguas e Literaturas Modernas” questa
materia appartiene al Maior e più concretamente al blocco superiore delle letteratura
italiane. Con le altre letterature italiane del Maior, la letteratura italiana del s. XIV
forma un blocco che permette allo studente di acquisire i mecanismi, gli strumenti e i
metodi per l’analisi dei testi che sono fondamentali per lo studio di qualsiasi
letteratura ma molto di più nella letteratura italiana del Trecento.
2.2. Interesse della materia
Oltre all’importanza e alla necessità dello studio della letteratura italiana di
questo periodo in sé, l’interesse della materia è fondamentale per l’influsso
determinante esercitato sulla letteratura dei secoli successivi.
2.3. Raccomandazioni e osservazioni:
Si raccomanda vivamente l’assistenza regolare alle lezioni teoriche e pratiche e
si consiglia uno studio continuato della materia accompagnato dalla lettura critica e
approfondita dei testi letterari.
3. OBBIETTIVI
Il programma di Letteratura Italiana del secolo XIV intende fornire alcune chiavi
e strumenti per la lettura e l’interpretazione dei testi letterari del s. XIV; quindi,
l’obiettivo fondamentale di questa materia è far conoscere all’allievo la produzione
letteraria italiana del Trecento, particolarmente l’interpretazione dell’opera di Dante,
Petrarca e Boccaccio dentro della letteratura italiana e universale.
Dato che la letteratura italiana del Trecento è così ampia (si pensi soltanto alle
opere di Dante, Petrarca e Boccaccio) è impossibile analizzarla nella sua totalità in un
corso di 6 crediti. Perciò i nostri obiettivi saranno: offrire una panoramica generale
della letteratura italiana del s. XIV ed anche studiare in modo approfondito gli autori
più importanti del Trecento. Le ragioni di questa scelta sono le seguienti:
41. È necessario conoscere la letteratura del Trecento per l’influsso
determinante esercitato sulla letteratura dei secoli successivi, oltre, ovviamente,
all’importanza rivestita dallo studio di questo periodo in sé.
2. Occorre approfondire lo studio degli autori e delle opere del Trecento
perché forse questo è il secolo più prestigioso della letteratura italiana: l'influenza di
Dante, Petrarca e Boccaccio sulla letteratura posteriore, non soltanto su quella italiana
ma anche sulle letterature europee e mondiali fu così grande che è basilare analizzarla
nel dettaglio.
4. COMPETENZE DA ACQUISIRE
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di conoscere
l’importanza della letteratura italiana del Trecento, in particolare l’opera di Dante,
Petrarca e Boccaccio. Secondo questa prospettiva, alla fine del corso, il laureando
dovrebbe essere in grado di :
Secondo questa prospettiva, alla fine del corso, il laureando dovrebbe essere in
grado di :
• Leggere e interpretare correttamente un testo letterario del Trecento,
traducendolo, se è necessario, in italiano moderno.
• Individuare gli elementi caratteristici della lingua letteraria (in prosa e
poesia), dei principali autori italiani del s. XIV, soprattutto delle Tre Corone fiorentine
(Dante, Petrarca e Boccaccio).
• Avere una conoscenza approfondita dei tre grandi autori del XIV secolo,
in particolar modo di Dante.
• Alla fine del corso l’alunno dovrà essere in grado di condurre un’analisi
critica di un’opera di Dante, di fare anche un esame approfondito di un canto della
Divina Commedia, di annalizzare una poesia del Canzoniere di Petrarca o di
interpretare e commentare un racconto del Decameron.
5. CONTENUTI
Le lezioni teoriche saranno sempre accompagnate dalle letture pertinenti
seguendo le diverse impostazioni critiche esistenti e le personali ricerche della
professoressa, per arricchire il lavoro personale dello studente.
Lo studio dei testi e delle opere si farà in modo tale da comprendere le opere in
sé e anche all’interno del sistema letterario dello scrittore.
Di seguito viene dettagliato il programma del corso, con gli argomenti da
svolgere durante l’anno accademico. Di ogni tema si presenta un elenco degli
argomenti che verranno trattati.
Programma:
Tema 1: Il Trecento
5Caratteri generali. Situazione storica e culturale. La letteratura italiana nel s.
XIV. Dante, Petrarca e Boccaccio. Rimatori, prosatori minori e cronisti del Trecento.
Tema 2: Dante Alighieri
Dante esule e poeta. Firenze e l'ambiente intellettuale fiorentino nella seconda
metà del s. XIII. Vita di Dante. Profilo, passione e ideologia. La giovinezza e i primi studi.
Le Rime della giovinezza. La ricerca dell’amore e della saggezza. L’attività politica.
L’esilio. Le Rime della maturità e dell'esilio La questione del Fiore e del Detto d'Amore.
Il Convivio. La felicità degli uomini. La cultura filosofica di Dante. La ricerca della lingua
nuova. Riflessioni teoriche sulla questione della lingua. Il De Vulgari Eloquentia. La
riflessione politica. La Monarchia. Le Epistole, le Egloghe e la Questio. Dante
personaggio-poeta. Fortuna ed eco di Dante. Il latino e la prosa di Dante. Dante,
testimone di un'epoca.
Tema 3: La Divina Commedia
Progetto. Titolo. Date di composizione, di pubblicazione e di prima diffusione.
Tradizione manoscritta del testo. Motivi ispiratori. Fonti. Cronologia del viaggio,
topologia morale, il sistema tolemaico. La struttura del cosmo dantesco. L’uso
simbolico dei numeri e l’importanzia del tre. La geografia dei tre mondi. Struttura
dell'opera. La articolazione simmetrica. L’Inferno. Il Purgatorio. Il Paradiso. La missione
di Dante. L’utopia. Lo stile. Temi. Allegoria e poesia. Cultura e ideologia. Il
plurilinguismo dantesco. Ricerca, sperimentazione e invenzione. La Commedia non è
scritta in ‘volgare illustre’. La creazione di una nuova lingua poetica. Una costruzione
lessicale ricca e innovativa. La Divina Commedia, il viaggio di Dante come cammino per
la conoscenza interiore. Dante, pellegrino, Ulisse, esploratore: Il viaggio “folle”
Diffusione e divulgazione della Divina Commedia.
Tema 4: Francesco Petrarca
Petrarca intellettuale europeo. Profilo. Cronologia essenziale. Intreccio di vita e
letteratura. La formazione. Tra Medioevo e Umanesimo. L’amore per i classici e la
nascita dell’Umanesimo. Continua ricerca della perfezione formale. Umanista e
filologo. Il bilinguismo: La separazione tra latino e volgare. Il monolinguismo
petrarchesco. Poetica e poesia. Il Secretum: Il contrasto tra materia e spirito. L’io
diviso. L’altra opere in volgare: I Trionfi. Opera in latino. Petrarca e Dante. Eco e
fortuna del Petrarca. Il petrarchismo dentro e fuori d’Italia: lettori, imitatori e critici del
Petrarca.
Tema 5: Il Canzoniere
Liriche di una vita. Dalla raccolta al Canzoniere. Titolo, composizione,
elaborazione e correzione. Il perfetto equilibrio tra fondo e forma. Il vero protagonista
dell’opera: L’io del poeta. Interiorità e sofferenza. La redazione definitiva.
Organizzazione e struttura. Il senso dell’opera. L’analisi psicologica dell’io poetico.
Tematica. La figura poetica di Laura. Laura simbolo del desiderio. La descrizione di
Laura. Il paessaggio. Elementi e fonti dell'esperienza artistica del Petrarca. Lingua e
stile del Canzoniere.
Tema 6: Giovanni Boccaccio
6Profilo. Boccaccio umanista. Eredità cortese nella nuova società borghese.
Cronologia essenziale. La produzione letteraria tra autobiografia ed erudizione. Tra
realtà e mito. Ideologia e pratica della letteratura. Sperimentazione linguistica. Il
peridodo di formazione. L’esperienza napoletana. Le opere del periodo napoletano. Il
Filocolo. Il ritorno a Firenze. Le opere del periodo fiorentino. Elegia di madonna
Fiammetta. Il Corbaccio. L'amicizia con il Petrarca. Scritti d'argomento dantesco.
Opere latine. Il ritiro di Certaldo
Tema 7: Il Decameron
La poetica realistica di Boccaccio. Elaborazione, composizione, pubblicazione e
diffusione del Decameron. La coerenza della struttura. La cornice. Adozione del
“genere” novella. I personaggi. I temi delle novelle : L’amore, l’intelligenza e la fortuna.
Maturità artistica del Decameron. Le fonti. Gli interventi dell'autore. Lo stile della
narrazione. Il “realismo” di Boccaccio. Significato storico. Il Decameron, modello di
prosa volgare.
OPERE DI LETTURA OBBLIGATORIA:
Divina Commedia, Canzoniere e Decameron (particolarmente le edizioni
racomandate).
6. BIBLIOGRAFIA
6.1. Come libro di consultazione sarà ovviamente utile qualunque antologia
ampia e completa, qualunque opera di carattere generale o qualsiasi storia della
letteratura italiana come quelle delle case editrici Einaudi, Garzanti, Hoepli, Laterza, Le
Monnier, Mondadori, Marzorati, Mursia, Rizzoli, Vallardi, ecc., o quelle di F. De Sanctis,
G. Contini, F. Flora, N. Sapegno, Asor Rosa, Petronio, Oliveri-Saraso, Gianni- Balestieri-
Pasquali, Fubini-Bonora, A.Budriesi, ecc.
6.2. Per l’impostazione scientifica e didattica saranno particolarmente indicate
storie della letteratura italiana come le seguenti:
AA.VV., L'Italianistica. Introduzione allo studio della letteratura italiana, a cura
di G. Bárberi Squarotti e F. Bruni, Torino, Utet Libreria, 1992
Budriese, Aldo, Letteratura, forme e modelli, v. I: Dalle origini al Quattrocento,
Torino, SEI, 1994
Ferroni, G., Storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1991
Guglielmino, S - Grosser, H., Il sistema letterario. Guida alla storia letteraria e
all'analisi testuale, Milano, Principato, 1990
Nencioni, G. - Baldelli, I. - Sabatini, F., Strumenti per lo studio della letteratura
italiana, Firenze, Istituto Geografico De Agostini/Le Monnier, 1992
Pazzaglia, M., Letteratura italiana. Testi e critica con lineamenti di storia
letteraria, Bologna, Bologna, Zanichelli, 1986
Segre, Cesare- Martignoni, Clelia, Guida alla letteratura italiana: testi nella
storia, Milano, Mondadori, 1995-96, 3 vols
7Zaccaria, G.- Benussi, C., Per studiare la letteratura italiana. Strumenti e metodi,
Torino, Paravia Scriptorium, 1999
6.3. Sono più recenti, e perciò aggiornate le seguenti:
Brioschi, F. - Di Girolamo, C., Manuale di letteratura italiana. Storia per generi e
problemi, Torino, Boringhieri, 1995
Bruscagli, R. - Caretti, L. - Luti, G., Letteratura italiana, Milano, Mursia, 1995
Gioanola, E., Storia della letteratura italiana, Milano, Librex Scuola, 1995
Pullega, P., La forma letteraria in Italia, Bologna, Zanichelli, 1995
Baldi-Giusso-Razzetti-Zaccaria., Dal testo alla storia. Dalla storia al testo,
Torino, Paravia, 1996
Colombo, A., La letteratura per unità didattiche. Proposte e metodi per
l’educazione letteraria, Firenze, La Nuova Italia, 1996
Mandruzzo, E., Il piacere della letteratura italiana. Per scoprirla, leggerla e
amarla, Milano, Mondadori, 1996
Asor Rosa, A., Storia della letteratura italiana, Firenze, La Nuova Italia, 1997
Dotti, Ugo., Autori e testi della letteratura italiana, Milano, Laterza, 1997
Gibellini-Oliva-Tesio., Il valore letterario, Brescia, Ed. La Scuola, 1997
Giudici-Bruni: Problemi e scrittori della letteratura italiana, Torino, Paravia,
1997
Parenti-Vegezzi-Viola., Il tempo storico e le forma, Bologna, Zanichelli, 1997
Pasquini, E., Guida allo studio della letteratura italiana, Bologna, Il Mulino, 1997
Varanini-Marti-Viti-Boldrini., Letteratura italiana, Firenze, Le Monnier, 1997
Pozzi, Mario; Mattioda, Enrico, Introduzione alla letteratura italiana. Istituzioni,
periodizzazioni, strumenti, Torino, UTET, 2002
Luperini, Romano et alii, La scrittura e l'interpretazione. Storia e antologia della
letteratura italiana nel quadro della civiltà europea, Firenze, Palumbo, 2002
6.4. Diretta da C. Segre, e perciò molto approfondita e ben curata è l’opera:
Testi nella storia. La letteratura italiana dalle origini al Novecento, Milano,
Edizioni Scolastiche Mondadori, 1997
6.5. Strutturata in modo “tradizionale” ma con una articolazione interna della
materia diversa dalle altre letterature esistenti –questa studia i fatti letterari entro un
più ampio orizzonte-, considera la storia letteraria non solo in rapporto con la storia
della lingua, dell’arte, del pensiero, della cultura italiana, ma anche in rapporto con le
altre culture europee, è la Storia della letteratura italiana diretta da E. Malato per la
Salerno editrice, Roma, 1995, 20 vv.
6.6. Per la Teoria della letteratura, Critica letteraria e la Teoría della
letteratura comparata, si possono consultare:
8Brioschi, F. & Di Girolamo, C., Elementi di teoria letteraria, Milano, Principato,
1996
Garrido, M. A., Nueva introducción a la teoría de la literatura, con la colab. de
A. Garrido y A. García Galiano, Madrid, Síntesis, 2000
Gardini, N., Critica letteraria e letteratura italiana, Milano, Einaudi Scuola,
1999.
Roncaglia, A., Principi e applicazioni di critica testuale, Bulzoni, Roma, 1975
Segre, C., Due lezioni di Ecdotica, Scuola Normale Superiore, Pisa,1991
Gnisci, A., Introduzione alla letteratura comparata, Milano, Bruno Mondadori,
1999
Guillén, C., Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada,
Barcelona, Editorial Crítica, 1985
6.7. Bibliografia di consultazione e approfondimento relativa ai singoli temi:
Tema 1:
Malato, E., Il Trecento, Storia della letteratura italiana, Roma, Salerno editrice,
1995, v. II
Manni Paola., Il Trecento toscano, Bologna, Il Mulino, 2003
Tema 2:
Malato, E., Studi su Dante, Citadella Padova, Bertoncello Artigrafiche, 2005
Malato, E, Dante, Roma, Salerno editrice, 1999
González, Isabel., “La comparación en las Rime de Dante”, Scripta Philologica in
memoriam Manuel Taboada Cid, Servicio de Publicaciones, Universidade da Coruña,
1996, t. II. pp. 871-883.
Vallone, La prosa del Convivio, Firenze, 1967
Simonelli, M., Materiale per un’edizione critica del Convivio di Dante, Roma,
1972
Brambilla Ageno, F., Dante Alighieri, Convivio, Firenze, Le lettere, 1995
Mengaldo, P. V., Alighieri, Dante, De vulgari eloquentia, Opere minori, Milano-
Milano, Ricciardi, 1979, tomo II, pp. 26-237
Gutiérrez Carou, Javier, La visión alegórica de tres damas en la obra de Dante,
Villasandino y el marqués de Santillana, in Actas del VI Congreso Internacional de la
Asociación Hispánica de Literatura Medieval (ed. de José Manuel Lucía Megías), Alcalá
de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 1995, tomo I, pp.737-746.
Gutiérrez Carou, Javier, Referencias a Dante en el Cancionero de Baena, in Atti
del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza. Centro di studi
filologici e linguistici siciliani. Università di Palermo 18-24 settembre 1995 (a cura di G.
Ruffino), Tübingen, Max Niemeyer, 1998, vol. VI, pp. 639-650.
9Gutiérrez Carou, Javier, Dante en la poesía de Diego de Burgos, in Actes del VII
Congrés de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval. Castelló de la Plana, 22-26 de
setembre de 1997 (ed. de S. Fortuño Llorens - T. Martínez Romero), Castelló de la
Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 1999, vol. II, pp. 209-221
Tema 3:
Isabel González - J. Benavent., Guía a la lectura de la Divina Comedia,
(Introducción, Infierno y Purgatorio a c. de Isabel González; Paraíso, a c. de J.
Benavent), Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2008 (lettura obbligatoria).
Dante Alighieri. La Divina Commedia (Testo critico della Società Dantesca
Italiana. Riveduto col commento scartazziniano rifatto da Giuseppe Vandelli), Milano,
Ulrico Hoepli, 1985
Pasquini, E., Quaglio, A., La Divina Commedia, Milano, Garzanti, 1987
Dante Alighieri. La Divina Comedia. Estudio preliminar de Stefan Zweig,
Barcelona, Editorial Juventud, 1987
Jacomuzzi, V., Dante Alighieri, La Divina Comedia. Inferno (Guide allo Studio),
Torino, Società Editrice Internazionale 1990
Jacomuzzi, S., Dughera, A., Ioli, G., Jacomuzzi, V., Dante Alighieri. La Divina
Commedia (Antologia di canti), Torino, Società Editrice Internazionale, 1991
Bosco, U., Reggio, G., Dante Alighieri. La Divina Commedia: con pagine critiche a
cura di U. Bosco e G. Reggio, Firenze, Le Monnier, 1995
Jacomuzzi, S., Dughera, A., Ioli, G., Jacomuzzi, V., Dante Alighieri. La Divina
Commedia, Torino, Società Editrice Internazionale, 1996
Dante Alighieri. Comedia. Edición bilingüe. Traducción, prólogo y notas de
Ángel Crespo, Barcelona, Seix Barral Biblioteca Formentor, 2004
Corrado, M., Commento alla ‘Divina Commedia’. Con la continuazione di
Salvatore Frascíno, Roma, Salerno editrice, 2007
Gutiérrez Carou, Javier, La influencia de la Divina Commedia en la poesía
castellana del siglo XV, Santiago, Universidade de Santiago de Compostela, 1996 (Teses
en microfichas, nº 598).
Gutiérrez Carou, Javier, Sinestesia e símbolo na Divina Commedia, in «Boletín
galego de literatura», 18 (1997), pp. 5-17.
González, Isabel., “Comparacións de tema relixioso na Divina Commedia”,
Boletín Galego de Literatura, 6 (1991), pp. 51-60.
González, Isabel., “La comparación en el Inferno dantesco”, Estudios
Románicos, Homenaje al Prof. Luis Rubio, Universidad de Murcia, (1987-89), t. 4, pp.
461-499.
González, Isabel., “L'exemplum nell'Inferno dantesco”, Atti del XXI Congresso
Internazionale di Lingüistica e Filologia Romanza, Centro di studi filologici e linguistici
siciliani, Università di Palermo, a c. di G.Ruffino, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, vol
VI, 1998, pp. 203-213.
10González, Isabel., “La comparación en el Purgatorio dantesco”, Homenaje a
Alonso Zamora Vicente, Castalia, Madrid, 1991, t. III, pp. 31-47.
González, Isabel., “La comparazione nel Paradiso dantesco”, Homenaxe ó Prof.
Constantino García, Universidade de Santiago de Compostela, 1991, t.II, pp. 319-349.
González, Isabel., “'Significar per verba': Lessico e similitudini nel canto I del
Paradiso”, Letture Classensi, 20/21, Longo editore, Ravenna, 1992, pp. 175-183.
González, Isabel “Dos viajes “locos”: el ultraterreno de Dante y el osado de
Ulises”, Revista Medieval, 37 (2010), Editorial Toisón, pp. 32-41.
Merlante, R., Il Dizionario della Commedia, Bologna, Zanichelli, 1999
Tema 4:
Ariani, M., Petrarca, Roma, Salerno editrice, 1999
Santagata, M., La biblioteca volgare di Petrarca, Bologna, Il Mulino, 1990
González Isabel., “Sintomi ed effetti della “malattia d’amore” nel Triumphus
Cupidinis di Petrarca” Archivi del Nuovo, 20/21 (2007), Cesenatico, Legoprint-Lavis,
(TN), 2007. pp. 5-14.
Francesco Petrarca, Canzoniere, ed. commentata a c. di M. Santagata ed.
diretta
da M. Santagata, Milano, Mondadori, 2004
Santagata, M., I frammenti dell’anima. Storia e racconto nel Canzoniere di
Petrarca, Bologna, Il Mulino, 1992
Recio, R., Petrarca en la península Ibérica, Madrid, Universidad de Alcalá de
Henares, 1996
Tema 6:
Battaglia Ricci, L., Boccaccio, Roma, Salerno editrice, 2000
Boccaccio, Giovanni., Rime-Carmina-Epistole e lettere-Vite-De Canaria, Milano,
Mondadori, 1992
Boccaccio, Giovanni., Trattatello in laude di Dante, Introduzione, prefazione e
note di Luigi Sasso, Milano, Garzanti, 1995
González, Isabel., Fiammeta, una mujer boccacciana, en Boccaccio e le donne,
Roma, Aracne editrice, 2014, pp. 15-29. ISBN: 978-88-548-7039-0.
Fiammetta, una mujer boccacciana, en Boccaccio e le donne, Roma, Aracne editrice,
2014, pp. 15-29. ISBN: 978-88-548-7039-0.
Tema 7:
Decameron, di Giovanni Boccaccio, a cura di Vittore Branca, correzioni di
Natalino Sapegno, Torino, Utet, 1956, Firenze, Le Monnier, 1951 - 1952 ...
Branca, V., Boccaccio medievale e nuovi studi sul Decameron, Frenze, Sansoni,
1996
Segre, C., Le strutture e il tempo, Torino, Einaudi, 1979
117. METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Le lezioni, che si svolgeranno in lingua italiana, prevedono l'inquadramento
storico delle principali correnti, degli autori e delle opere della letteratura italiana del
Duecento, lo studio della poetica dei principali autori del s. XIV e la lettura, il
commento e l'analisi dei testi più significativi.
7.1. Le lezioni teoriche svolgeranno i seguenti argomenti:
Definizione del periodo: Sussidi e inquadramenti storici. Poetica e ideolgia
dell’autore: profilo e cronogia essenziale. Impostazione dell’opera: disegno generale,
antecedenti, le fonti principali e la cultura. La composizione e la struttura. Stile, temi e
argomenti. Pubblicazione, diffusione e divulgazione del testo. Eco e fortuna critica.
Bibliografia essenziale.
7.2. Le lezioni pratiche sviluperanno un approccio all’analisi testuale, saranno
“grosso modo” uno studio approfondito dei seguenti temi (senza dimenticarci però,
della specificità di ogni testo letterario): Premessa e breve sommario. Lettura attenta
del testo. La trama e la struttura. I contenuti. Le forme. I personaggi: la distanza, le
parole e i pensieri. La dimensione del tempo e dello spazio. Commento linguistico e
stilistico. Il problema del punto di vista e prospettive. L’autore e il lettore.
7.3. Qualche esempio :
Divina Commedia, canto I : L’importanza del canto I come introduzione alla
prima cantica e anche a tutta la Commedia: Inferno, luogo di pene etterne, ove udirai
le disperate strida, / vedrai li antichi spiriti dolenti, / ch’a la seconda morte ciascun
grida (vv. 115-117); Purgatorio, luogo di sofferenze e di penitenze ma con la speraza di
salire in Paradiso, e vederai color che son contenti / nel foco, perché speran di venire /
quando che sia a le beate genti (vv. 118-120), e Paradiso, luogo di etterna gioia e
felicità godendo della presenza beatifica di Dio. Il disegno generale, breve sommario
del canto I. Tempo, luogo e personaggi. Risposta alle cinque domande fondamentali:
chi, cosa, come, quando e dove. La trama e la struttura: la funzione del primo canto, la
struttura allegorica, le costanti strutturali. Le tre parti principali: Lo smarrimento e la
paura di Dante di fronte alle tre fiere; l’arrivo di Virgilio che incoraggia Dante e gli si
offre come guida; l’annunzio delle differenti fasi del viaggio oltremondano. Dante inizia
il suo cammino: Nel mezzo del cammin di nostra vita (v.1). L’incertezza e lo
smarrimento del poeta: sì che 'l piè fermo sempre era 'l più basso (v. 30). L’apparizione
delle tre fiere: una lonza, una lonza leggiera e presta molto (v. 32), un leone, ma non sì
che paura non mi desse / la vista che m’apparve d’un leone (v. 45) e una lupa, Ed una
lupa, che di tutte brame / sembiava carca ne la sua magrezza (vv. 49-50). La meta
finale: La speranza de l’altezza (v. 54). Il silenzio della ragione: chi per lungo silenzio
parea fioco (v.63). La figura di Virgilio (vv. 67-78). Presentazione del poeta latino: Or se’
tu quel Virgilio e quella fonte / che spandi di parlar sì largo fiume?(vv. 79-80); O de li
altri poeti onore e lume, / vagliami ‘l lungo studio e ‘l grande amore / che m’ha fatto
cercar lo tuo volume (vv. 82-84). La profezia del Veltro come restauratore della
giustizia: Di quella umile Italia fia salute (v. 106). Dante chiede aiuto a Virgilio (vv. 130-
135). Tutti e due cominciano il viaggio oltremondano: Allor si mosse, e io li tenni dietro
(v. 136). Similitudini, metafore e allegorie del canto.
128. VALUTAZIONE
Per accertare la maturità del candidato ed il possesso della conoscenza della
materia nella quale sarà esaminato, si realizzerà un esame scritto (10 punti). L’esame si
svolgerà in lingua italiana.
I criteri di valutazione saranno uguali sia nella prima che nella seconda
opportunità.
13Puoi anche leggere