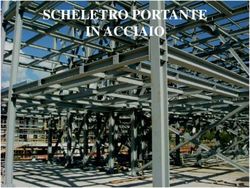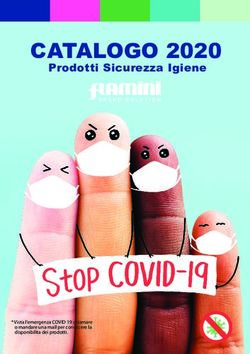Principi di cinetica chimica - supportodidattico.it
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Prof. Paolo Marchesi Chimica, Biologia, Astronomia, Scienze della terra Principi di cinetica chimica …..non divulgare questo materiale senza il consenso dell’autore, grazie….. Sommario Premessa introduttiva ................................................................................. 2 La misura del pH: le titolazioni .................................................................. 3 Formazione a distanza-marzo 2020 …..non divulgare questo materiale senza il consenso dell’autore, grazie….. Pagina 1 di 7
Prof. Paolo Marchesi Chimica, Biologia, Astronomia, Scienze della terra Premessa introduttiva Lo studio delle proprietà degli acidi e delle basi e di notevole importanza per l’apprendimento della chimica. Il seguente documento costituisce una guida allo studio, e si basa sul libro di testo “Chimica concetti e modelli” della casa editrice Zanichelli. Un primo percorso riguarda la comprensione di che cos’è un acido e cos’è una base. La definizione ha subito dei cambiamenti nel tempo. Le tre definizioni più utilizzate sono quella di Arrhenius (teoria molto semplice che sta alla base dei calcoli di carattere pratico normalmente utilizzati) quella di BrØnsted e Lowry e infine la teoria di Lewis (considerata la più complessa) proprietà generali degli acidi e delle basi (pag 511) Acidi e basi secondo Arrhenius (pag 512) Acidi e basi secondo Bronsted e Lowry (pag 513 fino a pag 515) Acidi e basi secondo Lewis (pag 515 e 516) La maggior parte delle soluzioni che incontriamo sono soluzioni acquose: per questo motivo la teoria di Arrhenius è nata proprio come applicazione in questo ambito. L’acqua infatti è un composto straordinario, e una delle sue proprietà è la ionizzazione di una piccolissima parte delle sue molecole. Le molecole ionizzate si comporteranno come ioni di un soluto. L’acqua pura quindi si comporta sia come solvente che come soluto Formazione a distanza-marzo 2020 …..non divulgare questo materiale senza il consenso dell’autore, grazie….. Pagina 2 di 7
Prof. Paolo Marchesi Chimica, Biologia, Astronomia, Scienze della terra Le soluzioni acquose e il pH Il prodotto ionico dell'acqua (pag 517 518) Il pH pag. 518-519 (con esempi di esercizi svolti) acidi forti e deboli (Pag. 520, 521, 522, 523,524 Calcolo del pH (Pag. 525, 526) Applicazioni pratiche della Indicatori di pH (pag 528,529) teoria acido/base L'idrolisi salina (pag 529, 530,531) Le soluzioni tampone (pag 531 fin o a pag 534) La misura del pH: le titolazioni (vedi paragrafo in questo stesso documento) La misura del pH: le titolazioni La misura del pH di una soluzione può essere fatta in laboratorio attraverso una metodica chiamata titolazione. Il principio su cui si basa è quello delle reazioni di neutralizzazione, Acido + Base = sale +H2O. Per avere quantitativi stechiometrici esatti di sale, senza eccesso di acido o di base, il numero di moli che reagiscono dell’una e dell’altra specie si deve eguagliare. Vediamo un esempio: Se abbiamo volume di 100 ml di soluzione HCl 1M quale quantitativo di in ml di soluzione 0,1M di NaOH sarà necessario ? Potremmo fare i seguenti ragionamenti: ➢ 1 molecola di HCl produce 1 Ione H+ e uno ione Cl- ➢ 1 molecola NaOH produce 1 Ione Na+è e uno ione OH- ➢ Quindi 1 molecola di HCl reagisce con 1 molecola di NaOH Formazione a distanza-marzo 2020 …..non divulgare questo materiale senza il consenso dell’autore, grazie….. Pagina 3 di 7
Prof. Paolo Marchesi Chimica, Biologia, Astronomia, Scienze della terra Nel nostro caso specifico avremo la neutralità perfetta quando i due volumi mescolati conterranno un ugual numero di moli. Nel caso di un rapporto di reazione 1:1 questo avverra quanto: MHCl * VHCl = MNaOH * VNaOH Nel caso di un acido poliprotico (o di una base poliossidrilica) occorrere moltiplicare la Molarità per il numero di cariche di ciascuna specie, ma poiché: Molarità X Cariche = Normalità potremmo riscrivere, più correttamente, l’equazione di neutralizzazione come segue NHCl * VHCl = NNaOH * VNaOH E più in generale: Nacido*Vacido = Nbase*Vbase Per procedere ad una titolazione occorre procedere con l’allestimento simile a quello mostrato nella figura 1. Figura 1: esempio di allestimento per titolazione Prima di procedere con la titolazione occorrerà fare alcune considerazioni di carattere teorico abbastanza importanti. Innanzi tutto se le sostanze, sia quella da titolare che quella titolante sono acidi/basi forti oppure deboli. Secondo questa classificazioni le titolazioni si suddividono in: ✓ Titolazione forte con forte ✓ Titolazione forte con debole ✓ Titolazione debole con debole (che non tratteremo in questa dispensa) Un secondo aspetto riguarda il punto in cui le due soluzioni sono perfettamente in equilibrio: tale punto è detto punto equivalente e nella soluzione quindi si avrà Nacido = Nbase . Vediamo ora alcuni aspetti teorico pratici relativi alle titolazioni. Titolazione forte con forte In questo tipo di titolazione, sia l’acido che la base sono entrambi forti. La reazione quindi sarà: Acido + base = sale + H2O e al punto di equivalenza si avranno solo i prodotti di questa reazione. Essendo il sale originato da 2 forti, si tratterà di un sale neutro, pertanto in questo caso, al punto di equivalenza il pH sarà esattamente 7. Un’altra considerazione importante riguarda l’andamento del pH durante la titolazione. Supponiamo di procedere a titolare un acido forte (a titolo incognito) con una base forte (a titolo noto), Inizialmente nella soluzione posta nella beuta avrà sempre un eccesso di acido, che essendo forte manterrà comunque il pH molto basso. All’approssimarsi dell’uguaglianza dei volumi normali, la curva presenterà una rapida variazione (gradino) che comprenderà anche il punto equivalente per poi assumere un Formazione a distanza-marzo 2020 …..non divulgare questo materiale senza il consenso dell’autore, grazie….. Pagina 4 di 7
Prof. Paolo Marchesi Chimica, Biologia, Astronomia, Scienze della terra andamento speculare (rispetto a una linea orizzontale passante per il punto equivalente). il suo andamento è mostrato nella figura 2. Figura 2A Figura 2B andamento del pH in funzione del liquido titolante aggiunto, acido titolato con base (2A) e base titolata con acido (2B), entrambi forti. Nelle titolazioni forte/forte il gradino ha un andamento quasi verticale, questo perché anche piccoli eccessi dell’una o dell’altra specie, possono spostare grandi valori di pH verso la specie in eccesso. Per la scelta dell’indicatore occorre prendere in considerazione la percezione dei colori da parte dell’operatore, perché la titolazione sarà tanto più accurata quanto più l’operatore sarà in grado di cogliere la prima comparsa del colore di viraggio. Altra cosa molto importante riguarda l’intervallo di viraggio dell’indicatore scelto (ovvero a quali valori di pH cambierà il colore) che deve rimanere dentro la parte a gradino della curva. Il punto centrale dell’intervallo di viraggio è detto punto di viraggio dell’indicatore. Nel caso di una titolazione forte con forte possono essere scelti indifferentemente diversi tipi di indicatori (vedi figura 3) non necessariamente con viraggio al punto equivalente: prendiamo in considerazione nel nostro esempio l’uso della fenolftaleina: il suo intervallo di viraggio e fra valori di pH compresi fra 8,0 e 9,8 per cui il punto di viraggio sarà a pH=(8,0+9,8)/2 ovvero 8,9. Poiché il punto di viraggio si trova sul gradino e il quantitativo di base da aggiungere passare da pH 7 a pH 8,9 risulta del tutto trascurabile, è una approssimazione più che accettabile quella di considerare che il valore sull’asse delle X del punto equivalente sia lo stesso del punto di viraggio. Altri indicatori potrebbero dare risultati meno precisi che però potrebbero comunque essere accettabili a seconda del contesto o essere riaggiustati con opportuni calcoli (vedi figura 3) Figura 3 andamento di una titolazione e misurazione del pH al punto di viraggio. Come si evince dalla figura la fenolftaleina è molto adatta perché la differenza sull’asse delle x fra il suo punto di viraggio e il punto equivalente è praticamente nulla, cosi come per il blu di Bromotimolo. Il metilarancio risulta un po’ meno adatto poiché la differenza fra il volume al punto equivalente e il volume al punto di viraggio è ml NaOH aggiunti maggiore. Formazione a distanza-marzo 2020 …..non divulgare questo materiale senza il consenso dell’autore, grazie….. Pagina 5 di 7
Prof. Paolo Marchesi Chimica, Biologia, Astronomia, Scienze della terra Nel caso in esempio si potrà poi procedere come segue: ✓ Si mette la sostanza da titolare (l’acido) nella beuta (o in un becher) dopo averne misurato accuratamente un volume di comodo. Con Vacido e Nacido indichiamo il volume e la normalità,ancora incognita, della sostanza acida. ✓ Sempre nella beuta occorrerà aggiungere qualche goccia di un indicatore in grado di cambiare colore (viraggio) nel passaggio da una soluzione acida a quella basica e viceversa. Ad esempio la qualche goccia di fenolftaleina ✓ Nella buretta invece va posta la sostanza titolante (nel nostro caso la base) che è stata preparata in modo da determinarne una ben precisa Normalità che chiameremo Nbase. L’operatore dovrà riempire la buretta in modo da portarla ad un volume iniziale di comodo (ad esempio zero ml) ✓ L’operatore comincerà quindi ad aprire la buretta facendo scendere la base nella beuta, poco alla volta, anche a gocce se si è vicini al viraggio. ✓ Quando l’operatore inizia a cogliere il viraggio deve chiudere il rubinetto della buretta e agitare la soluzione in modo da verificare se il viraggio riguarda tutta la soluzione o meno. Se il viraggio scompare, l’operatore riaprirà il rubinetto facendo scorrere poche gocce alla volta e aprendo e chiudendo il rubinetto più volte, fino al raggiungimento di un viraggio stabile. Una volta raggiunto il viraggio il rubinetto deve restare definitivamente chiuso. ✓ L’operatore leggerà sulla buretta il volume versato per raggiungere il viraggio, chiamiamo questo volume Vbase Poiché al punto equivalente vale la relazione Vacido*Nacido = Vbase*Nbase nel nostro caso la normalità incognita (quella dell’acido) sarà Nacido= (Vbase*Nbase)/ Vacido Poiché per gli acidi forti pH= -log(N) quindi pHsoluzione = -log(Nacido) Titolazione forte con debole In questo tipo di titolazione, uno dei due componenti è un elettrolita debole, solitamente la sostanza a titolo incognito dato che la sostanza titolante viene scelta dall’operatore. La reazione sarà: Acido + base = sale + H2O e punto di equivalenza si avranno solo i prodotti di questa reazione. Essendo il sale originato da un elettrolita forte e uno debole esso darà idrolisi salina e pertanto, al punto di equivalenza, il pH sarà diverso da 7. In secondo luogo la curva di titolazione presenterà un andamento meno netto e un gradino più corto, questo perché durante la titolazione, finché perdura l’eccesso della sostanza debole si formerà una soluzione tampone. Per questi motivi diventa di fondamentale importanza la scelta di un indicatore con in punto di viraggio adatto alla curva (vedi figura 4). Figura 4: raffronto fra le curve di titolazione forte/forte e forte/debole Formazione a distanza-marzo 2020 …..non divulgare questo materiale senza il consenso dell’autore, grazie….. Pagina 6 di 7
Prof. Paolo Marchesi Chimica, Biologia, Astronomia, Scienze della terra Nota la natura dell’acido debole è possibile individuare un insieme di indicatori idonei alla titolazione. L’individuazione può avvenire attraverso una metodica abbastanza complessa , che qui non trattiamo, oppure rifacendosi alle numerosi pubblicazioni e siti internet o all’esperienza dei docenti e dei tecnici che a seconda della sostanza suggeriscono quali indicatori siano più adatti. Una volta scelto l’indicatore giusto si potrà procedere come nella titolazione forte/forte. Definiti come in precedenza i valori Vacido , Nacido , Vbase , Nbase avremo le seguenti relazioni: Vacido*Nacido = Vbase*Nbase che permettono di trovare la normalità incognita (quella dell’acido) con la formula Nacido= (Vbase*Nbase)/ Vacido Se consideriamo però un elettrolita debole (nel nostro caso l’acido) osserveremo che se anche fosse poliprotico (o una base poliossidrilica) la seconda dissociazione sarebbe di entità trascurabile rispetto la prima (che sarebbe già molto bassa data la natura debole della sostanza) per cui, nel caso di elettroliti deboli si assume N=M. La formula pertanto diviene Macido= (Vbase*Nbase)/ Vacido Nota M potremo ricavare il pH usando la formula degli acidi deboli ovvero: = − √ ∗ Formazione a distanza-marzo 2020 …..non divulgare questo materiale senza il consenso dell’autore, grazie….. Pagina 7 di 7
Puoi anche leggere