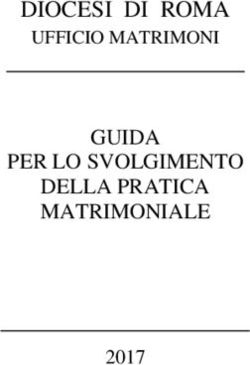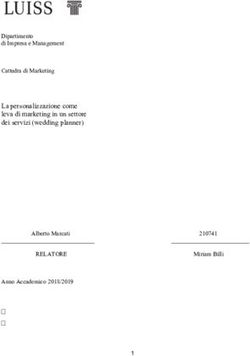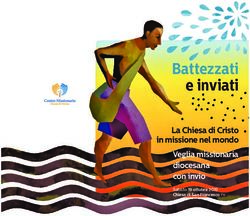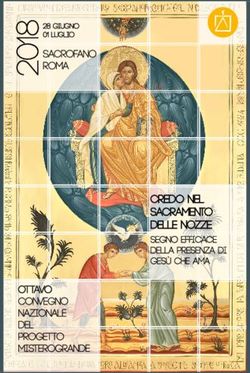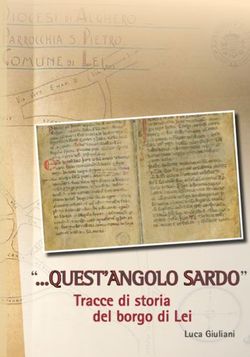La relazione tra battesimo, fede e matrimonio sacramentale
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Jus-online n. 2/2015
Héctor Franceschi
Professore ordinario di Diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce
La relazione tra battesimo, fede e matrimonio sacramentale
SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Il matrimonio come sacramento della Nuova Alleanza. -
- 3. Conclusione.
1. Introduzione
Nel n. 48 della Relatio Synodi, si afferma che “secondo altre proposte, andrebbe
poi considerata la possibilità di dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in ordine
alla validità del sacramento del matrimonio, tenendo fermo che tra battezzati tutti i
matrimoni validi sono sacramento”. Queste proposte mi spingono a ripensare il tema
del ruolo della fede nel matrimonio. Da una parte, uno dei principali problemi reali,
oltre a quello della preparazione al matrimonio e dell’ammissione ad esso delle persone
che non hanno fede, è quello del fallimento del matrimonio dei battezzati che avevano
celebrato il matrimonio fuori dalla Chiesa cattolica perché ad Essa non appartenenti,
com’è il caso dei protestanti o dei membri di altre confessioni che hanno un battesimo
riconosciuto come valido dalla Chiesa cattolica, o quello dei cattolici che quando
contrassero il matrimonio erano lontani dalla pratica religiosa.
Benedetto XVI, in un suo incontro con il clero della Valle d’Aosta, mette in
evidenza questi problemi, affermando: “Direi particolarmente dolorosa è la situazione
di quanti erano sposati in Chiesa, ma non erano veramente credenti e lo hanno fatto per
tradizione, e poi trovandosi in un nuovo matrimonio non valido si convertono, trovano
la fede e si sentono esclusi dal Sacramento [dell’Eucaristia]. Questa è realmente una
sofferenza grande e quando sono stato Prefetto della Congregazione per la Dottrina
della Fede ho invitato diverse Conferenze episcopali e specialisti a studiare questo
problema: un sacramento celebrato senza fede. Se realmente si possa trovare qui un
momento di invalidità perché al sacramento mancava una dimensione fondamentale
non oso dire. Io personalmente lo pensavo, ma dalle discussioni che abbiamo avuto ho
capito che il problema è molto difficile e deve essere ancora approfondito. Ma data la
situazione di sofferenza di queste persone, è da approfondire”1. In queste sue parole,
che sembrano essere quasi un pensare a voce alta, il Pontefice afferma che lui stesso si è
posto in profondità la domanda sul ruolo della fede nella celebrazione del sacramento
del matrimonio. E la sua domanda non è accademica, ma risponde ad una vera
1 BENEDETTO XVI, Al clero della Valle d’Aosta, 25 luglio 2005, in Supplemento a L’Osservatore Romano del 25
luglio 2005, Città del Vaticano 2005, p. 21.preoccupazione pastorale dinanzi a queste situazioni difficili, che lo portò ad
approfondire l’argomento, fino al punto di concludere che quello che in un primo
momento lui vedeva non tanto complicato ora si rende conto che è più difficile da
determinare. Cioè, si potrebbe affermare che la mancanza di fede può intaccare la
validità del matrimonio tra i battezzati, come hanno ipotizzato alcuni Padri Sinodali?
Questa domanda, a mio avviso, riguarda due aspetti diversi. Da una parte,
possiamo chiederci fino a che punto la mancanza di fede può impedire la comprensione
della stessa realtà naturale del matrimonio, vale a dire, se la mancanza di fede può
incidere indirettamente sulla validità del matrimonio, nella misura in cui rende difficile o
alle volte persino impossibile la comprensione di che cosa è il matrimonio e la volontà
di volere il vero matrimonio2. D’altra parte, ci si pone la domanda se la fede in quanto
virtù teologale sia requisito per la celebrazione del matrimonio sacramentale, quindi se la
mancanza di fede potrebbe avere un effetto diretto sulla validità del matrimonio.
Riguardo al primo punto, come più avanti spiegherò, mi pare che una risposta la
si trovi attraverso una rilettura del Magistero di Giovanni Paolo II sulla relazione tra
fede e sacramento del matrimonio. Ora, in questa introduzione voglio soltanto
richiamare la stretta relazione che esiste tra fede e ragione e, in concreto, tra Rivelazione
e comprensione ed accettazione della verità sul matrimonio. Lo stesso Benedetto XVI,
in un suo intervento quando era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede,
diceva al riguardo: “Nell’uomo annida un anelito inestinguibile verso l’infinito. Nessuna
delle risposte tentate è sufficiente; soltanto il Dio che si fece Lui stesso finito per aprire
la nostra finitezza e condurci all’ampiezza della sua infinità, risponde alle domande del
nostro essere. Perciò, anche oggi la fede cristiana troverà l’uomo”3. Per tanto, quando
manca la fede, si rende più difficile quella conoscenza di che cosa sia veramente l’uomo,
è più difficile il raggiungimento delle verità naturali, come sono anche quelle che
riguardano la comprensione stessa della natura umana, della concezione di una retta
antropologia sulla sessualità umana, sulla complementarità uomo-donna, sulla natura del
matrimonio. Tenendo conto di questa realtà e della relazione stretta tra fede e ragione,
2 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Enc. Fides et Ratio, n. 18: «Quando s’allontana da queste regole, l’uomo
s’espone al rischio del fallimento e finisce per trovarsi nella condizione dello “stolto”. Per la Bibbia, in questa
stoltezza è insita una minaccia per la vita. Lo stolto infatti si illude di conoscere molte cose, ma in realtà non è
capace di fissare lo sguardo su quelle essenziali. Ciò gli impedisce di porre ordine nella sua mente (cfr. Pro. 1, 7) e
di assumere un atteggiamento adeguato nei confronti di se stesso e dell’ambiente circostante. Quando poi giunge
ad affermare “Dio non esiste” (cfr. Sal. 14 [13], 1), rivela con definitiva chiarezza quanto la sua conoscenza sia
carente e quanto lontano egli sia dalla verità piena sulle cose, sulla loro origine e sul loro destino».
3 J. RATZINGER, Situación actual de la fe y la teología, in «Humanitas» 10 (2005), edición especial, p. 43 (La
traduzione è mia).
2possiamo pertanto affermare che il possesso della fede e della vita della grazia di fatto
influiscono molto sulla conoscenza e sull'adesione alla stessa dimensione naturale del
matrimonio4, per cui nei casi in cui quando si celebrò il matrimonio mancava la fede ciò
che succede è che vi è una maggiore possibilità che sia mancato anche il vero consenso
anzitutto sul piano naturale, che costituisce peraltro l’unica misura pratica in grado di
dirci se c’è stato o meno vero matrimonio. Esigere un determinato grado di fede,
scollegandolo dalle conseguenze della mancanza di fede sulla comprensione della natura
del matrimonio nel caso concreto, a mio avviso renderebbe pressoché impossibile il
raggiungimento della certezza sulla validità o meno del matrimonio. Non è possibile
stabilire a priori quale sia questo grado di fede necessario, se non lo si fa mettendo a
confronto la concezione di che cosa è il matrimonio come verità del principio con la
concezione o con la volontà positiva dei nubendi al momento della sua celebrazione. Se
si tentasse di stabilire un determinato grado di fede per la valida celebrazione del
matrimonio: quale sarebbe questo grado di fede? come lo si misura? quando può il
giudice dire che non vi era la fede necessaria?
Per quanto invece concerne il secondo punto, mi sembra che il ruolo della fede
nella confezione del sacramento del matrimonio non si possa chiarire tentando di
determinare quali siano la materia, la forma, i ministri e i soggetti del sacramento del
matrimonio così come si fa per gli altri sacramenti, o quale sia la fede necessaria per
celebrare il sacramento del matrimonio, perché esso è un sacramento che ha una sua
propria specificità, quella di essere, come ricorda Giovanni Paolo II nell’Esortazione
Apostolica Familiaris Consortio, n. 68, “il sacramento di una realtà già esistente
nell’ordine della creazione”.
Per tanto, per dare una risposta giusta e vera alle diverse problematiche
giuridiche e pastorali si deve determinare proprio che cosa significa che il matrimonio è
sacramento e quale è la sua specificità, nonché determinare le esigenze di giustizia e di
verità che ne scaturiscono.
Nel caso del sacramento del matrimonio, la realtà che per istituzione divina
diventa essa stessa sacramento della Nuova Alleanza, sono lo stesso patto coniugale e il
matrimonio inteso come la stessa unione coniugale, non come realtà estrinseca che
unisce, ma come l’unione stessa in quanto tale. Bisogna evitare una visione del
sacramento matrimoniale come realtà meramente transeunte (la cerimonia) che
4Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Enc. Fides et Ratio, n. 56: «È la fede che provoca la ragione a uscire da ogni
isolamento e a rischiare volentieri per tutto ciò che è bello, buono e vero. La fede si fa così avvocato convinto e
convincente della ragione».
3conferisce in quel momento la grazia per vivere fedelmente il matrimonio, perché il
matrimonio è sacramento in quanto unione permanente e indissolubile, dato che quello
che significa sacramentalmente è l’unione tra Cristo e la sua Chiesa, che è permanente e
indissolubile.
In questo mio contributo, che è un tentativo di approfondimento sul significato
della sacramentalità del matrimonio, come ci chiedeva Benedetto XVI nell’incontro
poc’anzi citato, e ci chiedono anche i Lineamenta per il Sinodo Ordinario; per spiegare il
significato dell’affermazione che il matrimonio dei battezzati è uno dei sacramenti della
Nuova Alleanza, terrò conto del Magistero del Concilio Vaticano II, dell’acuta analisi
presentata da Giovanni Paolo II nella Es. Ap. Familiaris Consortio, n. 68 (in avanti FC),
nonché dei suoi discorsi alla Rota Romana e di quello di Benedetto XVI dell’anno 2013.
2. Il matrimonio come sacramento della Nuova Alleanza
Dal secolo XII la Chiesa ha più volte esplicitato che il matrimonio costituisce
uno dei sette sacramenti della Nuova Alleanza. Tali esplicitazioni sono state dovute alla
necessità di affermare la sacramentalità del matrimonio di fronte a coloro che la
negavano. In questo cammino verso la comprensione della sacramentalità del
matrimonio dei battezzati, una pietra miliare è stato il Concilio di Trento. In questo
articolo, analizzerò quali siano la portata e le conseguenze di questa verità più volte
affermata dal Magistero della Chiesa, cioè che il matrimonio è uno dei sette sacramenti
istituiti da Cristo.
2.1. Il patto coniugale celebrato tra battezzati è stato elevato da Cristo
Signore alla dignità di sacramento (can. 1055 § 1 CIC 1983 - can. 776 § 2 CCEO
1990)
L’espressione usata dal legislatore nel canone 1055 § 1 CIC e nel canone 776 § 2
CCEO non va intesa nel senso che il matrimonio sia passato dalla categoria degli affari
umani, profani, intramondani, a quella dignità propria delle cose sacre, soprannaturali.
Non è questione di livelli, poiché il «matrimonio del principio» è sempre il «grande
mistero», ed appartiene all’ordine soprannaturale (cfr. FC, 68). È chiaro che il
matrimonio, in ogni tappa della storia della salvezza, appartiene innanzitutto all’ordine
naturale, benché si debba tener conto che l’ordine naturale è in sé stesso sacro e
trascendente e include la relazione con Dio, non essendo quindi profano e immanente.
Tuttavia, l’espressione codiciale ha una grande forza, poiché sottolinea il fatto che
Cristo abbia voluto annoverare il matrimonio tra quei sette sacramenti da Lui istituiti,
che sgorgano dalla sacramentalità della Chiesa: «Si può dire che la sacramentalità della
4Chiesa è costituita da tutti i sacramenti per mezzo dei quali essa compie la sua missione
santificatrice»5. Perciò, benché l’ordine soprannaturale accompagni l’uomo sin dal
principio, quando la Chiesa afferma che il matrimonio è un sacramento della Nuova
Alleanza, sta affermando la novità che implica la Redenzione e l’appartenenza alla
Chiesa mediante il battesimo, e il fatto che il matrimonio dei battezzati, come vedremo,
è in senso stretto sacramento della Nuova Alleanza.
Questa espressione usata dal Legislatore — che più che una determinazione del
diritto canonico è la dichiarazione di una realtà — è densa di contenuto. Al riguardo,
vorrei soffermarmi su tre idee:
2.1.1. Ciò che Cristo ha «elevato» è lo stesso matrimonio-mistero,
affidando alla Chiesa, nel caso del matrimonio dei battezzati, la precisazione di
alcuni elementi del segno, sempre nel rispetto della natura del patto coniugale
“Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi” (Mt 19, 6).
L’azione di Dio non si produce senza il concorso libero dei nubendi, ministri del
sacramento, poiché sono loro due mediante il consenso coniugale che conferiscono
vicendevolmente il sacramento. Il patto e il vincolo coniugali sono, quindi, ciò che
Cristo ha assunto. Tuttavia, la dichiarazione di ciò in cui consista il patto, gli elementi e i
requisiti per la sua validità giuridica sono affidati alla Chiesa, e questo è proprio lo scopo
del sistema matrimoniale canonico: riconoscere e tutelare il vero matrimonio, il cui
contenuto naturale non viene deciso dalla Chiesa ma dalla natura stessa del matrimonio.
Essa, a sua volta, può anche assumere alcuni degli elementi dei concreti ordinamenti
giuridici o delle culture sul matrimonio che siano compatibili con la natura stessa del
matrimonio, e può anche stabilire nuovi requisiti di diritto positivo, come sarebbe
quello dell’esigenza della forma canonica per la valida celebrazione, o dichiararne altri
come appartenenti al diritto naturale.
Per capire adeguatamente cosa significa che il matrimonio di due battezzati è
sacramento, una prima domanda che ci dobbiamo porre è chi confeziona il sacramento,
cioè, chi è il ministro del sacramento. Al riguardo, esiste un certo divario tra la
tradizione orientale e quella latina. La teologia sacramentale latina ha sempre sostenuto
che i ministri del matrimonio sono gli stessi coniugi. Invece, in alcune tradizioni
orientali non cattoliche, si è sostenuto che il ministro del sacramento è il sacerdote.
5GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò, catechesi sull’amore umano, Città Nuova Editrice, Libreria Editrice
Vaticana, Roma 1985, p. 365. Il Papa aggiunge, dopo aver sottolineato la centralità del battesimo e dell’eucaristia,
che «bisogna infine dire che la sacramentalità della Chiesa rimane in un particolare rapporto con il matrimonio: il
sacramento più antico» (Ibidem).
5Come dice Prader, “secondo la dottrina delle Chiese orientali non cattoliche il ministro
del matrimonio sacramento (...) è il sacerdote. Il sacramento come azione di Cristo e la
Chiesa può avverarsi soltanto attraverso il sacerdote (presbitero o vescovo) che compie
il rito nuziale”6. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ha voluto prendere in
considerazione questa tradizione orientale. Nella prima redazione del n. 1623 del
Catechismo si poteva pensare che si ammettesse che, per gli orientali cattolici, il
ministro fosse il sacerdote o il vescovo. Così diceva: “Nella Chiesa latina, si considera
abitualmente che sono gli sposi, come ministri della grazia di Cristo, a conferirsi
mutuamente il sacramento del matrimonio esprimendo davanti alla Chiesa il loro
consenso. Nelle liturgie orientali, il ministro del sacramento (chiamato “Incoronazione”)
è il presbitero o il vescovo che, dopo aver ricevuto il reciproco consenso degli sposi,
incorona successivamente lo sposo e la sposa in segno dell’alleanza matrimoniale» (n.
1623). Prader, dinanzi a questa affermazione, poco dopo la pubblicazione del
Catechismo, affermò che queste parole volevano far riferimento agli orientali non
cattolici, perché anche per i cattolici orientali il ministro sono gli stessi coniugi7. A
conferma di questa interpretazione, nella correzione introdotta a questo numero del
Catechismo si dice: «Secondo la tradizione latina sono gli sposi, come ministri della
grazia di Cristo, a conferirsi mutuamente il sacramento del Matrimonio esprimendo
davanti alla Chiesa il loro consenso. Nelle tradizioni delle Chiese orientali, i sacerdoti,
vescovi o presbiteri, sono testimoni del reciproco consenso scambiato tra gli sposi ma
anche la loro benedizione è necessaria per la validità del sacramento” (n. 1623 n.v.)8.
Il canone 828 § 2 CCEO (equivalente al canone 1108 CIC sulla forma canonica
ad validitatem) segnala che “si intende qui come rito sacro l’intervento del sacerdote
assistente e benedicente”. La benedizione del sacerdote, per i fedeli soggetti al CCEO, è
dunque un requisito di validità, integrante la forma ordinaria di celebrazione, ma ciò
non significa che sia la benedizione a far sì che il matrimonio diventi sacramento,
perché un conto è che nelle Chiese cattoliche orientali la benedizione sia requisito di
validità del matrimonio, e cosa diversa è che sia essa a costituire il sacramento. Questo
viene confermato dall'insieme del sistema matrimoniale del CCEO, nel quale si ammette
la forma straordinaria, la convalidazione senza rinnovazione del consenso in forma
pubblica, la sanazione nella radice, la dispensa dalla forma canonica. Inoltre, anche in
questi casi, non vi è nessun’eccezione al principio consacrato dal canone 776 § 2
6 J. PRADER, La forma di celebrazione del matrimonio, in AA.VV., Il matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese
Orientali, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994, p. 288.
7 Cfr. Ibid.
8 Comunque, la questione sul ministro deve essere risolta alla luce di ciò che è il matrimonio e, pertanto, la
soluzione dovrebbe essere comune a tutte le Chiese. Cosa diversa è che alcune di esse non l’accettino.
6CCEO, secondo il quale il matrimonio valido tra due battezzati sarà sempre sacramento,
anche nei casi eccezionali previsti dal legislatore che ho appena citato.
Comunque sia, il sacramento non è altro che lo stesso «segno sociale-ecclesiale»,
vale a dire, le nozze (o quei riti che in ogni momento storico sono vigenti nella società
in cui vivono i battezzati e che la Chiesa ammette come modi di manifestare il
consenso) e la relazione coniugale che nasce da questo consenso matrimoniale.
2.1.2. Che Cristo ha «elevato» il matrimonio tra battezzati alla dignità di
sacramento comporta che questo nuovo segno partecipa efficacemente delle
proprietà dell’unione di Cristo e la Chiesa ed è segno del dono di Cristo come
Sposo ai coniugi cristiani
Afferma Giovanni Paolo II: «Egli vuole e dona l’indissolubilità matrimoniale
come frutto, segno ed esigenza dell’amore assolutamente fedele che Dio ha per l’uomo
e che il Signore Gesù vive verso la sua Chiesa» (FC, 20). Cristo impegna se stesso non
soltanto con la Chiesa, sua Sposa, né tanto meno solo con ciascuno dei fedeli battezzati
(in ragione del battesimo) ma impegna se stesso con un nuovo titolo con ogni coppia
coniugata. Si capisce così la profondità dell’espressione “bonum sacramenti” usata da
Sant’Agostino come riferita ad ogni matrimonio, ma in modo tutto specifico al
matrimonio cristiano: Cristo promette la sua grazia ai fedeli cristiani affinché possano
essere fedeli alla loro vocazione il che, qui, implica l’essere fedeli alla loro nuova identità
di coniugi e di genitori. Ciò logicamente non significa che Cristo prometta la felicità
coniugale ai fedeli cristiani, ma la sua grazia per poter essere fedeli agli impegni
matrimoniali in ogni circostanza o peripezia, per assurda e difficile che possa sembrare
allo sguardo umano. Nella Familiaris Consortio, 20 si può leggere, infatti, una lode a «tutte
quelle numerose coppie che, pur incontrando non lievi difficoltà, conservano e
sviluppano il bene dell’indissolubilità: assolvono così, in modo umile e coraggioso, il
compito loro affidato di essere nel mondo un “segno” – un piccolo e prezioso segno,
talvolta sottoposto anche a tentazione, ma sempre rinnovato – dell’instancabile fedeltà
con cui Dio e Gesù Cristo amano tutti gli uomini ed ogni uomo. Ma è doveroso anche
riconoscere il valore della testimonianza di quei coniugi che, pur essendo stati
abbandonati dal partner, con la forza della fede e della speranza cristiana non sono
passati ad una nuova unione: anche questi coniugi danno un’autentica testimonianza di
fedeltà, di cui il mondo oggi ha grande bisogno. Per tali motivi devono essere
incoraggiati e aiutati dai pastori e dai fedeli della Chiesa”.
7Parte importante di questo impegno è la certezza con cui il sacramento opera,
poiché — presupposta la volontà veramente coniugale — il matrimonio è per virtù del
battesimo dei due coniugi ed ex opere operato sacramento della Nuova Alleanza. Come
afferma Miras, parlando delle difficoltà per capire il significato preciso dell’affermazione
che il matrimonio è esso stesso sacramento quando celebrato tra battezzati:
«Concretamente, potrebbero soggiacere delle difficoltà di questo tipo nel rifiuto, da
parte di alcuni autori, di quello che hanno qualificato come automatismo sacramentale nel
matrimonio. Per superarle, forse sarebbe utile notare che, a rigor di termini, l’economia
divina in quanto al matrimonio non è consistita nell’elevare un’istituzione giuridica ad una
categoria teologica; e tornare a considerare da questa prospettiva che il fatto che il
matrimonio di due persone battezzate, se è vero matrimonio, non può che essere
sacramentale, si deve all’indistruttibile cristificazione battesimale di ognuno dei
coniugi»9.
Affinché ci sia valido matrimonio tra due battezzati e, quindi, esso sia
sacramento, si richiede dunque:
a) che ci sia una volontà veramente matrimoniale. Come afferma la Familiaris Consortio:
«La decisione dunque dell’uomo e della donna di sposarsi secondo questo disegno
divino, la decisione cioè di impegnare nel loro irrevocabile consenso coniugale tutta la
loro vita in un amore indissolubile ed in una fedeltà incondizionata, implica realmente,
anche se non in modo pienamente consapevole, un atteggiamento di profonda
obbedienza alla volontà di Dio che non può darsi senza la sua grazia. Essi sono già,
pertanto, inseriti in un vero e proprio cammino di salvezza, che la celebrazione del
sacramento e l’immediata preparazione alla medesima possono completare e portare a
termine, data la rettitudine della loro intenzione» (FC 68). Questo è conseguenza del
fatto che proprio il «mistero» del matrimonio è ciò che è assunto da Cristo10. È,
comunque, chiaro che la vera volontà matrimoniale si presume, perché è nella natura di
essa che quando due persone decidono di sposarsi la loro volontà implica, benché alle
volte inconsapevolmente, gli elementi che identificano il patto coniugale, vale a dire, il
suo carattere di unione indissolubile, fedele e feconda (cfr. cann. 1096, 1099 e 1101
CIC).
b) che entrambi i contraenti siano stati validamente battezzati. Nella stessa Familiaris
Consortio si può infatti leggere: “Mediante il battesimo, l’uomo e la donna sono
9 J. MIRAS, Consentimiento y sacramentalidad. Reflejos de la sacramentalidad del matrimonio en la regulación jurídica del
consentimiento en el CIC y en el CCEO, in Fidelium Iura 14 (2004), p. 138 (la traduzione è mia).
10 IBIDEM, p. 143 (la traduzione è mia).
8definitivamente inseriti nella Nuova ed Eterna Alleanza, nell’Alleanza sponsale di Cristo
con la Chiesa. Ed è in ragione di questo indistruttibile inserimento che l’intima
comunità di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore, viene elevata e assunta alla
carità sponsale di Cristo, sostenuta ed arricchita dalla sua forza redentrice” (FC, 13).
Non si richiede, invece:
a) né uno speciale grado di fede nei nubendi. Occorre ribadire che per «volontà
matrimoniale» si deve intendere la retta intenzione per la quale ciascuno dei nubendi
«dona coniugalmente se stesso» e riceve l’altro. Questa volontà «implica realmente,
anche se non in modo pienamente consapevole, un atteggiamento di profonda
obbedienza alla volontà di Dio, che non può darsi senza la sua grazia» (FC, 68). Questa
obbedienza della quale parla la Familiaris Consortio non va confusa con la fede teologale,
benché non le risulti completamente estranea, tenuto conto che l’Esortazione parla di
essa come sufficiente affinché i nubendi cattolici non siano respinti e non si rifiuti loro
la celebrazione delle nozze11. “Non si deve dimenticare — continua a dire Familiaris
Consortio, 68 — che questi fidanzati, in forza del loro battesimo, sono realmente già
inseriti nell’Alleanza sponsale di Cristo con la Chiesa e che, per la loro retta intenzione,
hanno accolto il progetto di Dio sul matrimonio e, quindi, almeno implicitamente
acconsentono a ciò che la Chiesa intende fare quando celebra il matrimonio”12. Inoltre,
dice ancora la Familiaris Consortio, “voler stabilire ulteriori criteri di ammissione alla
celebrazione ecclesiale del matrimonio, che dovrebbero riguardare il grado di fede dei
nubendi, comporta oltre tutto gravi rischi. Quello, anzitutto, di pronunciare giudizi
infondati e discriminatori; il rischio, poi, di sollevare dubbi sulla validità di matrimoni
già celebrati, con grave danno per le comunità cristiane, e di nuove ingiustificate
inquietudini per la coscienza degli sposi; si cadrebbe nel pericolo di contestare o di
mettere in dubbio la sacramentalità di molti matrimoni di fratelli separati dalla piena
comunione con la Chiesa cattolica, contraddicendo così la tradizione ecclesiale” (n. 68).
11 Anche dal punto di vista oggettivo, segnala A. MIRALLES, Il matrimonio, cit., p. 154: «Inoltre, poiché
manifesta il reciproco dono di sé di due cristiani, esprime oggettivamente il mistero sponsale tra Cristo e la Chiesa al
quale appartengono, in quanto battezzati, e che assume in sé l’unione che stabiliscono. Costituisce perciò
espressione della fede della Chiesa, la quale è sempre fede viva».
12 GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apos. Familiaris Consortio, n. 68. La volontà dei nubendi deve intendere la
creazione del «segno» in cui consiste il sacramento, ma questo «segno» non va confuso con la forma liturgica,
come ha precisato M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, Eunsa, Pamplona 1995, pp. 33-34: «Occorre tener
presente, infatti, che l’intenzione sacramentale deve fare riferimento a ciò che la Chiesa intende come sacramento
del matrimonio: se intende che esso è ogni matrimonio valido tra battezzati, basterà allora l’intenzione di
celebrare un matrimonio valido. In questo senso, l’intenzione matrimoniale che tende ad unire due battezzati è
sempre specificamente sacramentale, se si tiene conto che il consenso matrimoniale costituisce il nocciolo
essenziale del segno sacramentale». Giovanni Paolo II, nel suo Discorso alla Rota Romana del 1º febbraio 2001,
ricordò ancora una volta quanto detto al n. 68 della Familiaris Consortio.
9In questo senso, non vedo come si possa stabilire, come prospettato da alcuni Padri
Sinodali (cfr. Relatio Synodi, 48), un criterio diverso per valutare il ruolo della fede nella
validità del matrimonio dei battezzati13.
b) né una volontà intenta verso la sacramentalità. Per contrarre il matrimonio non è
necessario un diverso atto di volontà che abbia come oggetto anche la sacramentalità,
diverso da quello che è proprio di ogni matrimonio. È sufficiente che i contraenti,
essendo battezzati, abbiano “volontà matrimoniale”, cioè, decidano di costituire la
relazione coniugale che fa loro diventare coniugi, marito e moglie, affinché il vincolo da
loro costituito sia necessariamente «segno dell’unione di Cristo e la Chiesa». Questo è
così anche perché, data l'identità tra matrimonio e sacramento, sarebbe sbagliato esigere
dai contraenti una speciale volontà, diversa da quella di volere veramente sposarsi, cioè
donarsi nella loro coniugalità con ciò che essenzialmente essa significa. Lo ha ribadito
Giovanni Paolo II con le seguenti parole nel suo discorso alla Rota del 2003:
«L’importanza della sacramentalità del matrimonio, e la necessità della fede per
conoscere e vivere pienamente tale dimensione, potrebbe anche dar luogo ad alcuni
equivoci, sia in sede di ammissione alle nozze che di giudizio sulla loro validità. La Chiesa
non rifiuta la celebrazione delle nozze a chi è bene dispositus, anche se imperfettamente
preparato dal punto di vista soprannaturale, purché abbia la retta intenzione di sposarsi
secondo la realtà naturale della coniugalità. Non si può infatti configurare, accanto al
matrimonio naturale, un altro modello di matrimonio cristiano con specifici requisiti
soprannaturali»14.
Siccome il segno del sacramento del matrimonio è lo stesso patto coniugale
come momento fondazionale e il vincolo coniugale15 — quale relazione familiare che
unisce l’uomo e la donna — c’è infatti una coincidenza radicale tra l’oggetto del
consenso e il segno sacramentale: ciò che vogliono i nubendi è costituire la coniugalità,
ed essa in quanto vincolo indissolubile (cioè in quanto parte della loro co-identità
personale) è il segno della mutua appartenenza (non solo significata ma anche efficace) e
della loro co-identità con Cristo-Sposo. Il segno sacramentale non è né la vita coniugale,
né la testimonianza cristiana dei coniugi, né la comunione di vita e di amore, ma la
13 Per un accurato studio del tema nella dottrina e nella Giurisprudenza rotale, cfr. A.P. TAVANI, Fede e
consenso matrimoniale, Torino 2013.
14 GIOVANNI PAOLO II, Allocutio ad Romanae Rotae Auditores, 30 gennaio 2003, n. 8. Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ,
La peculiaridad sacramental del matrimonio y sus consecuencias canónicas (Comentario a las Alocuciones del Papa a la Rota
Romana de 2001 y 2003), in «Ius Canonicum» 44 (2004), pp. 282-307.
15 La sacramentalità del vincolo coniugale è analizzata con grande chiarezza in J. HERVADA, Una Caro.
Escritos sobre el matrimonio, Pamplona 2000, pp. 117-146 e C.J. ERRÁZURIZ M., La rilevanza canonica della sacramentalità
del matrimonio e della sua dimensione familiare, in Ius Ecclesiae 7 (1995), pp. 561-572.
10relazione coniugale o coniugalità, che è alla base della comunione di persone e sulla
quale si costituisce la loro identità di sposi (assunta da Cristo, che diventa loro Sposo
per un nuovo titolo)16.
In questo senso, come dicevo nell’introduzione di questo articolo, il rapporto tra
fede e sacramento del matrimonio — tenuto conto della peculiarità di questo
sacramento — lo si dovrà cercare nella comprensione e accettazione della realtà naturale
dello stesso matrimonio. Quantunque non si possa stabilire un determinato grado di
fede per essere ammesso alla celebrazione del matrimonio, non vi sono dubbi che la
mancanza di fede, in determinati casi, potrà oscurare la realtà stessa di che cosa è la
persona umana e la coniugalità e, in questo senso, l’assenza di fede renderebbe più
possibile la formazione di una volontà che non sia confacente con la verità stessa del
matrimonio così come istituito da Dio per tutti gli uomini. È quello che si deduce da
quanto afferma Giovanni Paolo II nel suo Discorso alla Rota del 2003: “è decisivo tener
presente che un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione
soprannaturale nel matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul
piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale” (n. 8).
2.1.3. L'indissolubilità è caratteristica di ogni matrimonio, e nel caso del
matrimonio tra due battezzati, poiché significa sacramentalmente l'unione tra
Cristo e la sua Chiesa mediante l'Incarnazione, non ammette nessuna
eccezione, qualunque sia stata la forma in cui è stato celebrato, se è stato
celebrato validamente e consumato
Il principio dell’indissolubilità accolto dalla Chiesa è stato il grande motore del
Diritto matrimoniale canonico, la spinta che ha portato canonisti e teologi a determinare
cosa sono il patto e il vincolo coniugali, quando inizia il vincolo e quando esso è
assolutamente indissolubile, cosa significa l’indissolubilità, quale differenza c’è tra cause
di nullità (il matrimonio non c’è, perché è nullo il patto coniugale) e cause di
scioglimento del vincolo coniugale (il matrimonio c’è ma può essere sciolto in taluni
casi), ecc. Si tratta di monumenti culturali, contributi della Chiesa alla civiltà, che
derivano dalla fedeltà con cui la Chiesa Sposa riconosce lo stretto legame esistente tra il
sacramento del matrimonio ed Essa stessa come Sposa. Questo legame ispira tutta la
normativa della Chiesa riguardante la pastorale familiare nei casi difficili, in particolare
16 Per una critica puntuale alla dottrina che pone il segno sacramentale nella comunità di vita, quale realtà
dinamica ed esistenziale, si veda M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio, Eunsa, Pamplona 1995, pp. 34-35,
pp. 37-38.
11nelle cosiddette situazioni irregolari17. In concreto, nel caso dei divorziati risposati e
dopo aver esortato la comunità cristiana alla carità verso questi fedeli e al loro
riavvicinamento a la pratica religiosa18, la Familiaris Consortio afferma decisamente: “La
Chiesa, tuttavia, ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere
alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi a non poter esservi ammessi,
dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente
a quell’unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall’Eucaristia”19.
La Chiesa, con la sua fedeltà a questo impegno dinanzi al suo Sposo, evita che il
matrimonio cristiano perda la sua capacità di significare (manifestare, attuare e rivelare)
il grande mistero, l’unione cioè di Cristo e la sua Chiesa20. Tale consapevolezza è alla
base di decisioni pastorali che la Chiesa ha preso negli ultimi decenni per evitare la
crescente secolarizzazione del matrimonio nel mondo occidentale, come quella, ad
esempio, di mantenere in vigore la forma canonica di celebrazione del matrimonio
cristiano. Per quanto riguarda i divorziati e risposati civilmente, non si tratta di soluzioni
di comodo né di rigorismo — termine che, a mio avviso, andrebbe evitato così come
quello di aperturismo — ma di cercare la verità e renderla amabile, con la chiara
consapevolezza che solo nella verità e nella fedeltà alla parola di Cristo, ci sarà un vero
atteggiamento pastorale che aiuti queste persone con autentica carità e misericordia, che
non si oppongono alla giustizia fondata proprio sulla “verità di quello che si è”.
17 GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apos. Familiaris Consortio, nn. 80-85. La difesa dell’indissolubilità, lungi da
essere indifferenza pastorale, costituisce un dovere di tutti, a cominciare dai coniugi che hanno ricevuto il
sacramento, e di tutta la Chiesa-Sposa.
18 IBIDEM, n. 84: «Insieme col Sinodo, esorto caldamente i pastori e l’intera comunità di fedeli affinché
aiutino i divorziati procurando con sollecita carità che non si considerino separati della Chiesa, potendo e anzi
dovendo, in quanto battezzati, partecipare alla sua vita. Siano esortati ad ascoltare la Parola di Dio, a frequentare il
sacrificio della Messa, a perseverare nella preghiera, a dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della
comunità in favore della giustizia, a educare i figli nella fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di penitenza
per implorare così, di giorno in giorno, la grazia di Dio. La Chiesa preghi per loro, li incoraggi, si dimostri madre
misericordiosa e così li sostenga nella fede e nella speranza»
19 Ibidem. Su questo tema si possono vedere: H. FRANCESCHI, Divorziati risposati e nullità matrimoniali, in «Ius
Ecclesiae» 25 (2013), pp. 617-639, nel quale si espone il Magistero recente sul tema; M.A. ORTIZ, La pastorale dei
fedeli divorziati rispostati civilmente e la loro chiamata alla santità, in C.J. ERRÁZURIZ M. - M.A. ORTIZ (a cura di),
Misericordia e diritto nel matrimonio, Roma 2014, pp. 99-129, articolo che imposta la questione dalla prospettiva della
chiamata universale alla santità la quale non esclude nessuno, mostrandoci allo stesso tempo le esigenze della vita
cristiana; A. S. SÁNCHEZ-GIL, La pastorale dei fedeli in situazioni di manifesta indisposizione morale. La necessità di un nuovo
paradigma canonico-pastorale dopo l’Evangelii gaudium, in «Ius Ecclesiae» 26 (2014), in corso di stampa, nel quale l’autore
propone nuove vie per spiegare il Magistero della Chiesa sul questo problema e altri simili.
20 Sul fondamento antropologico dell’indissolubilità del matrimonio e sulla necessità di inculturare di nuovo
la verità del principio, cfr. H. FRANCESCHI, Valori fondamentali del matrimonio nella società di oggi: indissolubilità, in
Matrimonio canonico e realtà contemporanea, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005, pp. 213-236.
122.2. Il matrimonio cristiano, celebrazione del «grande mistero»
La celebrazione del matrimonio e, da un altro lato, il divieto di celebrare seconde
nozze in vita dell’altro coniuge, sono l’espressione più chiara della sacramentalità del
matrimonio cristiano: non solo viene celebrato il matrimonio (attraverso i riti liturgici e
sociali-festivi) ma inoltre risulta proibita una seconda o ulteriore celebrazione; vale a
dire, dal patto coniugale (in fieri) nasce il vincolo (in facto esse), che sussiste lungo la vita
degli sposi in modo tale che i fedeli cristiani, che hanno accolto il dono degli sposi quale
segno del grande mistero21, non possono celebrare un’unione che sarebbe in
contraddizione con ciò che era stato celebrato e festeggiato. Il vincolo coniugale diviene
così un obbligo di tutta la comunità cristiana, incominciando dagli sposi, di “non
celebrare” seconde nozze mentre sia vivo l’altro coniuge. Da questa prospettiva, il
vincolo comporta la sussistenza e attualità dell'unione coniugale che è stata fondata
mediante il patto nel cuore della comunità cristiana22.
La sacramentalità del matrimonio non dipende dal fatto che il matrimonio sia
stato celebrato “in Chiesa” e con la benedizione del sacerdote. In tutti quei casi in cui
esso viene celebrato validamente in forma “non ordinaria” — per esempio, perché si è
dispensato dell’osservare la forma canonica — il matrimonio è di pari passo
sacramento23. Questo vale anche, come ho già detto, per il matrimonio dei battezzati
appartenenti alle Chiese orientali e, logicamente, per il matrimonio dei validamente
battezzati nelle comunità che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica ma
hanno un battesimo valido.
Occorre non dimenticare che nella stessa festa nuziale c’è un’implicita e forse
inconsapevole accettazione della sacralità stessa del matrimonio-mistero. Ciò è
opportuno ricordarlo anche in ambito pastorale, per non escludere dalla celebrazione
21 È molto nota la splendida intuizione di R. BELLARMINO, De controversiis, III, De Matrimonio, controversia
III, c. 6: «Il sacramento del matrimonio si può considerare in due modi: il primo mentre si celebra; il secondo
mentre perdura dopo che è stato celebrato. Giacché è un sacramento simile all’eucaristia, la quale è sacramento
non solo mentre si fa, ma anche mentre perdura: perché, fin quando vivono i coniugi, la loro unione è sempre il
sacramento di Cristo e della Chiesa» (la traduzione è mia).
22 Da ciò deriva l’obbligo di cui al can. 1069: «Prima della celebrazione di un matrimonio, tutti i fedeli sono
tenuti all’obbligo di rivelare al parroco o all’Ordinario del luogo, gli impedimenti di cui fossero a conoscenza». Cfr.
T. RINCÓN-PÉREZ, Comentario al canon 1069, in Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, vol. III, (opera
coordinata da A. Marzoa, J. Miras e R. Rodríguez-Ocaña), Eunsa, Pamplona 1996, pp. 1121-1122.
23 L’azione di Cristo è esercitata anche al di fuori dei concreti riti previsti: in questo senso, la liturgia
matrimoniale può anche essere celebrata (con l’opportuna dispensa) dinanzi a un’autorità civile: i ministri sono gli
stessi coniugi. Uso l’espressione «celebrato» nel senso largo con cui viene usata nei nn. 1136 e ss. del Catechismo
della Chiesa Cattolica.
13nuziale i nubendi cristiani che sembrano mossi più da motivi sociali che religiosi24. La
continuità tra l’ordine della creazione e quello dalla redenzione è vista qui da una
prospettiva sociale: la dimensione sacra è implicita in quella sociale, in modo simile a
come l’accettazione del disegno originario di Dio da parte dei nubendi implica
l’esistenza della retta intenzione, sufficiente agli effetti della validità del sacramento del
matrimonio.
Nell’affermare che le nozze costituiscono il segno (sacramentum tantum) del
matrimonio cristiano, non dobbiamo però dimenticare che all’interno di esse — che si
possono definire come quell’atto sociale e liturgico in cui viene celebrata l’unione
dell’uomo e della donna, i quali mediante il patto coniugale diventano coniugi e
costituiscono la prima relazione familiare — è contenuta una pluralità di elementi
significanti: gli anelli (o fedi nuziali), la “dexterarum coniunctio”, la manifestazione del
consenso, l’inserimento nell'Eucaristia, la benedizione del sacerdote sugli sposi, ecc.
2.3. Tra battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale,
che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055 § 2 CIC e can. 776 § 2 CCEO)
Il § 2 del canone 1055 CIC afferma: «Pertanto, tra battezzati non può sussistere
un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento»25.
Il CCEO non raccoglie, invece, questa affermazione, ma ciò non significa che tra
gli orientali possa esistere un matrimonio valido tra due battezzati che non sia
sacramento. Il can. 776 § 2 CCEO dice: “Ex Christi institutione matrimonium validum
inter baptizatos eo ipso est sacramentum, quo coniuges ad imaginem indefectibilis
unionis Christi cum Ecclesia a Deo uniuntur gratiaque sacramentali veluti consecrantur
24Nella Familiaris Consortio, n. 68 si può, infatti, leggere: «È vero, d’altra parte, che, in alcuni territori motivi
di carattere più sociale che non autenticamente religioso spingono i fidanzati a chiedere di sposarsi in Chiesa. La
cosa non desta meraviglia. Il matrimonio, infatti, non è un avvenimento che riguarda solo chi si sposa. Esso è per
sua stessa natura un fatto anche sociale, che impegna gli sposi davanti alla società. E da sempre la sua celebrazione
è stata una festa, che unisce famiglie ed amici. Va da sé, dunque, che motivi sociali entrino, assieme a quelli
personali, nella richiesta di sposarsi in chiesa. Tuttavia, non si deve dimenticare che questi fidanzati in forza del
loro battesimo, sono realmente inseriti nell’Alleanza sponsale di Cristo con la Chiesa e che, per la loro retta
intenzione, hanno accolto il progetto di Dio sul matrimonio e, quindi, almeno implicitamente, acconsentono a ciò
che la Chiesa intende fare quando celebra il matrimonio. E, dunque, il solo fatto che in questa richiesta entrino
anche motivi di carattere sociale non giustifica un eventuale rifiuto da parte dei pastori».
25 La formulazione di questo principio è alle volte poco fortunata, poiché viene presentato come
l’inseparabilità del contratto e del sacramento. Non si tratta tanto di «inseparabilità» quanto di «identità», perché
inseparabilità è una parola che implicitamente fa riferimento a due «elementi» o «realtà» diverse che «devono
essere insieme» e non conviene che siano separate. Nel matrimonio sacramento confluiscono la dimensione
sociale e quella ecclesiale, di identico modo che nel fedele cristiano convivono inscindibilmente la condizione di
cittadino e quella di fedele. La formulazione del principio affermato nel canone 1055 § 2 ha una concreta origine
storica, proprio all’inizio della secolarizzazione contemporanea del matrimonio.
14et roborantur”. Da questo canone si evince con chiarezza l’inseparabilità tra matrimonio
e sacramento tra i battezzati, e si sottolinea persino, con una chiara ragione teologica,
questa inseparabilità — o forse meglio identità — quando si dice che per istituzione di
Cristo (quindi non per una volontà che vuole positivamente il sacramento) il
matrimonio tra i battezzati è esso stesso sacramento. Poi, nel § 3 dello stesso canone, si
dà per certo che il matrimonio tra battezzati è sempre sacramento, quando si dice che le
proprietà essenziali del matrimonio acquisiscono una speciale forza in ragione del
sacramento.
2.3.1. Il matrimonio valido26 celebrato tra un coniuge battezzato e un altro
non battezzato, secondo la dottrina comune, non è sacramento.
Così come non può essere valido il matrimonio per un solo coniuge e nullo per
l’altro — matrimonium non potest claudicare —, esso non può neanche essere sacramento
per uno e non per l’altro. Il sacramento è il vincolo coniugale, è l’unione stessa: perciò
occorre che tutti e due i termini soggettivi del vincolo siano battezzati affinché esso
possa essere «segno» sacramentale dell’unione di Cristo con la Chiesa. Le possibili
perplessità dinanzi al carattere non sacramentale del matrimonio celebrato da un
cristiano con un non battezzato possono superarsi se si pensa che tale unione coniugale
è non solo valida — presupposta la dispensa dall’impedimento di disparità di culto —
ma essa può anche partecipare in qualche modo del mistero cristiano attraverso il
coniuge battezzato. Il fedele cristiano non si vedrà privato della grazia di Cristo e dovrà
essere cammino di santificazione del suo coniuge, come ricorda San Paolo nella Prima
Lettera ai Corinzi: «Perché il marito non credente viene reso santo dalla moglie credente
e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente» (I Cor. 7, 14).
2.3.2. Nel momento stesso in cui il coniuge non battezzato diviene
cristiano attraverso il battesimo, il vincolo diventa specificamente sacramentale.
Siccome il fondamento della sacramentalità del matrimonio è radicato nel
battesimo dei coniugi, mediante il quale essi vengono inseriti nell’ordine della
Redenzione, proprio nel momento in cui entrambi i coniugi sono battezzati il vincolo
diventa ipso facto sacramento della Nuova Alleanza, senza necessità di ripetere il rito. Ciò
che è il segno del sacramento, infatti, è lo stesso vincolo coniugale.
26 Si presuppone la dispensa dell’impedimento dirimente di disparità di culto (can. 1086), nel caso il
battezzato sia cattolico e tenuto ad osservare questa legge ecclesiastica.
152.3.3. Due battezzati non possono celebrare un matrimonio non
sacramentale27.
Dopo le considerazioni fin qui fatte non ci dovrebbero essere problemi per
capire perché due battezzati non possono contrarre un matrimonio non sacramentale.
La ragione principale è che non esiste in realtà questo tipo di matrimonio. Perciò, non si
tratta tanto che sia loro vietata la celebrazione di un matrimonio non sacramentale, ma
piuttosto dell’impossibilità ontologica di farlo, poiché ogni matrimonio valido tra due
battezzati, proprio perché tali, è esso stesso sacramento.
Un altro problema è la possibilità che due cattolici possano celebrare il
matrimonio senza rispettare il requisito della forma canonica, poiché tale matrimonio o
sarà nullo per difetto di forma o sarà valido, sia perché i soggetti non sono tenuti alla
forma canonica28, sia perché essa è stata dispensata dall’autorità competente29. In ogni
caso si rispetta il principio: se il matrimonio tra due battezzati è valido, esso è anche
sacramento.
Se i nubendi volessero ad ogni modo un’unione coniugale sprovvista della sua
dimensione sacramentale sarebbe necessario discernere con maggiore precisione il
processo di formazione della volontà matrimoniale. In linea di principio si deve
presumere che in questi casi si tratta di ipotesi che non intaccano la validità del
matrimonio; tuttavia, se si dimostrasse che in uno o in entrambi i nubendi ci fosse un
rifiuto del sacramento, dovremmo dire che la volontà contraria alla sacramentalità non
può far sì che il matrimonio diventi una realtà diversa da quella che ha disegnato il
Creatore (e che la Chiesa intende fare quando celebra il sacramento); se tale volontà
contraria alla sacramentalità fosse molto radicata, il risultato non sarebbe una situazione
matrimoniale non sacramentale, ma un matrimonio nullo per difetto di consenso se,
come dice Giovanni Paolo II, nel suo Discorso alla Rota Romana dell’anno 2003,
questa volontà intacca la validità sul piano naturale sul quale è posto lo stesso segno
sacramentale: «Questa verità non deve essere dimenticata al momento di delimitare
l'esclusione della sacramentalità (cfr. can. 1101 § 2) e l'errore determinante circa la
dignità sacramentale (cfr. can. 1099) come eventuali capi di nullità. Per le due figure è
27 Per maggiori approfondimenti sull’argomento si veda M.A. Ortiz, Il principio formale e la forma canonica, in
Ius Canonicum vol speciale 1999, 725-738; ID., La forma canonica quale garanzia della verità del matrimonio, in Ius Ecclesiae
15 (2003), pp. 371-406; ID., La forma, in Diritto matrimoniale canonico, III, Città del Vaticano 2005, pp. 25-56.
28 Il canone 1117 CIC, infatti, segnala che sono tenuti alla forma canonica solo i battezzati nella Chiesa
cattolica o in essa accolti successivamente.
29La dispensa della forma canonica è, in linea di massima, riservata alla Santa Sede salvo alcuni casi speciali
(pericolo di morte, matrimoni misti o con disparità di culto). Cfr. Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica del
16decisivo tener presente che un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della
dimensione soprannaturale nel matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la
validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale. La Chiesa
cattolica ha sempre riconosciuto i matrimoni tra i non battezzati, che diventano
sacramento cristiano mediante il Battesimo dei coniugi, e non ha dubbi sulla validità del
matrimonio di un cattolico con una persona non battezzata se si celebra con la dovuta
dispensa»30.
3. Conclusione
Per le ragioni spiegate, ritengo che qualunque prassi riguardo al matrimonio dei
non appartenenti alla Chiesa cattolica, ma validamente battezzati, non può non tener
conto del dato certo della sacramentalità del matrimonio dei battezzati, la quale non
dipende da una non ben precisata volontà di celebrare il sacramento, ma è conseguenza
della volontà salvifica di Cristo, il quale ha voluto elevare alla dignità sacramentale ogni
vero matrimonio celebrato tra due battezzati. Lo stesso, in ambito diverso, vale, come
ho detto, per la attenzione pastorale dei divorziati e risposati civilmente.
Perciò, nelle discussioni sulla necessità o meno di una volontà che accetti la
sacramentalità del matrimonio, ci dobbiamo necessariamente confrontare con quanto ha
detto Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio e ha ribadito nel suo Discorso alla Rota
del 2003: “la sacramentalità del matrimonio costituisce una via feconda per penetrare
nel mistero dei rapporti tra la natura umana e la grazia” (n. 5). Quindi, sono da evitare
tutte quelle prassi e soluzioni pastorali che, poggiando proprio sulla distinzione tra
matrimonio naturale e matrimonio sacramentale, più che aiutare a penetrare nel mistero dei
rapporti tra natura e grazia, finiscono per oscurare un’esigenza della natura, perfezionata
dal sacramento del matrimonio nel caso dei battezzati, quale è la proprietà essenziale
dell'indissolubilità del vincolo coniugale31.
Anche Benedetto XVI, nel suo discorso alla Rota Romana del 2013, pur
mantenendo fermo, sul piano teologico, l’importanza della relazione tra fede e
matrimonio, ha chiarito che, ai fini della sacramentalità del matrimonio dei battezzati,
non è richiesta la fede personale dei nubendi, quanto l’intenzione di fare ciò che fa la
CIC, in AAS 77 (1985), p. 771.
30 GIOVANNI PAOLO II, Allocutio ad Romanae Rotae Auditores, 30 gennaio 2003, n. 8.
31 Sulla continuità del pensiero di Giovanni Paolo II e sui diversi momenti nell’approfondimento del
magistero circa la relazione tra fede e sacramento del matrimonio, cfr. M. RIVELLA, Gli sviluppi magisteriali e
dottrinali sull’esclusione della dignità sacramentale del matrimonio, in H. FRANCESCHI, J. LLOBELL, M.A. ORTIZ (a cura di),
La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii», Roma 2005, pp. 299-315.
17Puoi anche leggere