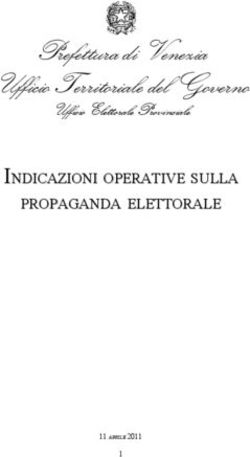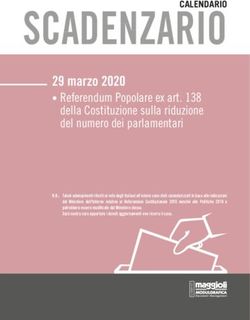LA MOBLLLTA ELETLORALE DEGLL ANNI OTLANTA DI ROBERTO BIORCIO E PAOLO NATALE - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
LA MOBlllTA ElETlORAlE DEGll ANNI OTlANTA
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
di Roberto Biorcio e Paolo Natale
Premessa
Lo studio della mobilita elettorale si ricollega per diversi
aspetti al dibattito sulle tendenze generali del mercato elettorale in
Italia e alia problematica legata ai tipi di voto. Lo studio delle
forme che pUG assumere la mobilita elettorale costituisce perc, a
nostro avviso, un tema dotato comunque di una sua autonoma
specificita, Le forme che assume il passaggio da una scelta di voto
ad un' altra dipendono sia dalle modifiche di posizionamento dei
partiti nell'ambito della competizione elettorale, sia dalle modalita
secondo cui i cittadini-elettori si rapportano ad essi e, pili in
generale, vivono il proprio rapporto con la sfera politica e le
istituzioni.
Si possono individuare nella scelta dell'elettore diverse com-
ponenti analitiche (cfr. Parisi e Pasquino 1977; Pizzorno 1983 e
1986, Mannheimer e Sani 1987), riconducibili, a nostro avviso, ad
alcune peculiari logiche motivazionali. Si pUG cogliere anzitutto
una logica dell 'identification e, secondo cui l' elettore esprime
adesione e solidarieta rispetto a qualche tipo di identita collettiva
che ritiene rappresentata in una delle proposte di voto in competi-
zione. Le identita collettive che costituiscono il referente necessa-
rio per questa tipo di logica motivazionale possono essere gia
presenti nella societa - e semplicemente trascritte 0 trascrivibili
in una delle possibili opzioni di voto - oppure essere costituite
dal «discorso identificante» dei politici (Pizzorno 1983). Oppure
Questo studio fa parte di un progetto di ncerca piu generale sui caratten della mobilita
elettorale in Italia ed e frutto, sia nell'impostazione teorica che nelle analisi empiricbe, di un
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
effettiuo lauoro comune. Per quanta nguarda la stesurafinale il secondo e il quinto paragrafo
sono da attribuirsi a Paolo Natale) il paragrafo terzo e il quarto a Roberto Biorcio, collegiali
sono inoece la premessa e la conclusione. Gli autori nngraziano l'Istituto Superiore di
Sociologia di Milano e la Doxa per aver loro concesso l'.utilizzo dei dati qui analizzati.
RIVISTA ITALIANA 01 SCIENZA POLITICA / a. XIX, n. 3, dicembre 1989386 Roberto Biorcio, Paolo Natale
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
ancora essere una combinazione di entrambe queste possibilita, Si
puo poi riconoscere nell'elettore l'esistenza di una logica dell'utili-
ta (o della razionalita strumentale rispetto allo scopo), quando il
voto appare finalizzato a favorire (oppure ad ostacolare) tendenze
politiche e/o provvedimenti specifici, in base ad un proprio
calcolo degli interessi. Insieme a queste due, si puo considerare
una terza componente analitica nel comportamento elettorale -
definibile come logica della protesta - che esprime motivazioni
prevalentemente «in negativo» rispetto al voto 0 rispetto al
tradizionale sistema dei partiti; questa logica emerge quando i
partiti esistenti non riescono a suscitare sufficiente identificazione
nell'elettore, ne a rappresentarne Ie domande sociali. La logica
della protesta si puo esprimere non solo con l' astensionismo
(attivo 0 passivo), rna anche con il voto per alcuni dei «nuovi
partiti» formatisi negli anni settanta e ottanta come espressione di
diverse forme di protesta politica 0 sociale.
E evidente che queste diverse logiche motivazionali possono
coesistere nello stesso atto di scelta, con un peso che puo variare in
base alle caratteristiche dell' elettore, alIa congiuntura politico-
sociale e al tipo di elezione. Quello che interessa al nostro studio e
la relazione fra queste logiche di voto ed i processi di rnobilita
elettorale: come il peso specifico delle diverse logiche motivazio-
nali puo fare variare sia le probabilita di mutamento delle prece-
denti scelte di voto, sia le forme ed il senso che questo mutamento
puo assumere.
La logica della identificazione - declinata nelle forme piu
diverse - costituisce ovviamente la base della fedelta elettorale di
partito 0, almeno, di «area politica». Per gli elettori che nel voto
esprimono soprattutto una esigenza di identificazione, la probabi-
lita di mutamenti e ridotta, e l'abbandono delle precedenti scelte
assume un carattere «traumatico», che si puo leggere come segno
di un generale processo di ri-orientamento politico-esistenziale. n
passaggio diretto ed immediato da una identificazione ad un' altra
e un evento che si verifica raramente. Gli elettori che scelgono di
non votare piu per un partito in cui si erano identificati sperimen-
tano una fase di relativa incertezza, nella quale possono acquistare
maggior peso, almeno transitoriamente, le logiche della protesta 0
quelle del calcolo delle utilita,
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
La logica della utilita si esprime in un «calcolo dei vantaggi»
che si puo riferire tanto a interessi individuali e particolaristici
(voto clientelare), quanto a quelli di gruppo 0 di categoria, fino ad
assumere come riferimento interessi piu generali (voto di opinio-La moblllta elettorale degli anni ottanta 387
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
ne). n calcolo dei vantaggi di ogni scelta di voto e funzione delle
caratteristiche specifiche e congiunturali delle diverse scadenze
elettorali, Ci si puo aspettare che quanto piu pesa, nella scelta del
singolo elettore, la logica della utilita, tanto piu sono probabili,
almeno in linea di principio, i cambiamenti delle opzioni di voto.
Anche la logica della protesta, se non e accompagnata da forte
identificazione in un partito vissuto come rappresentante signifi-
cativo della protesta sociale, fornisce un notevole contributo alla
instabilita elettorale: in questo caso e I'atto stesso di abbandono
delle precedenti scelte partitiche che diviene il veicolo piu impor-
tante per l'espressione del risentimento dell'elettore.
Si e rivolta l'attenzione a diversi tipi di mutamento nel com-
portamento elettorale, analizzando in particolare:
1) i cambiamenti di voto all'interno del gruppo dei 7-8 partiti
tradizionalmente presenti - nel dopoguerra - nelle competizio-
ni elettorali: la mobilita in questo caso puo essere interpretata
come I'esito di un giudizio razionale sugli effetti dell' opzione
elettorale suI quadro politico, 0 su una serie di politiche specifi-
che;
2) i cambiamenti di voto da uno dei partiti tradizionali alla
esplorazione di nuove possibilita di espressione elettorale - nella
scelta di votare, ad esempio, per uno dei partiti emersi negli anni
settanta ed ottanta, 0 per qualcuna delle liste che si caratterizzano
su specifiche issues (pensioni, ecologia, identita regionali, ecc.);
3) il cambiamento dal voto al non voto, che puo essere letto
come diminuzione del livello di identificazione (visto dal lato
dell' elettore) 0 nella capacita di mobilitazione (visto dal lato del
partito) di una determinata opzione partitica;
4) il ritorno dal non voto (non partecipazione alla votazione 0
non espressione di voto valido) al voto per una delle liste presenti
nella competizione elettorale, che puo dipendere dalla accresciuta
capacita di suscitare mobilitazione ed identificazione da parte di
una delle forze politiche presenti, oppure dalla particolare rilevan-
za soggettivamente attribuita ad una specifica tornata elettorale.
Lo studio empirico delle forme di mobilita elettorale presenta
- come e nota - particolari difficolta, sia perche ciascuna di esse
coinvolge quote limitate del corpo elettorale sia, piu in generale,
per I'ovvio motivo che non sono disponibili registrazioni - a
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
livello individuale - delle scelte di voto e delle loro variazioni fra
una elezione e l' altra. A causa di tali difficolta e per ovviare ai
problemi specifici di ciascuna delle tecniche di analisi, nel nostro
studio sulla mobilita elettorale 1983-87 abbiamo fatto riferimento388 Roberto Biorcio, Paolo Natale
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
a risultati di ricerche realizzate con diversi metodi: analisi di dati
raccolti tramite survey, analisi di dati elettorali aggregati a vari
livelli, stime dei flussi elettorali in alcune citta e stime di flussi a
livello nazionale basate sui dati rilevati in un insieme di sezioni-
campione 1. E nostra opinione che sia legittimo e necessario
utilizzare nella ricerca i diversi metodi a disposizione, con la
consapevolezza dei vantaggi e dei problemi metodologici che
ciascuno di essi pone: soltanto l'attenta comparazione dei risultati
ottenuti da diverse fonti puo convalidare 0, nel caso, porre seri
interrogativi sulle ipotesi sostantive via via formulate. In questa
sede il nostro interesse e rivolto ai risultati ottenuti con le diverse
metodologie, pili che alIa discussione delle metodologie stesse, per
la quale rimandiamo ad altre sedi-,
Le trasformazioni del mercato elettorale negli anni ottanta
Le elezioni politiche del giugno 1987 hanno puntualizzato una
tendenza costante di tutto il periodo qui considerato: una configu-
razione del sistema politico italiano sempre pili lontana sia da una
situazione ritenuta stabile fino ai primi anni settanta sia dalle
dinamiche elettorali emerse a meta del decennio scorso. n biparti-
tismo imperfetto, infatti, e la conseguente apparente «imrnobilita»
di fondo dell'elettorato del nostro Paese appaiono oggi tesi
nettamente superate, di fronte a movimenti di voto che hanno
ridimensionato il seguito elettorale complessivo dei due maggiori
partiti italiani.
E possibile cogliere alcuni aspetti fondamentali dell'evoluzio-
ne del sistema dei partiti sulla base di due tradizionali indicatori
sintetici: l'indice di bipolarismo e l'indice di instabilita (figg. 1 e 2).
n primo (calcolato con la semplice somma delle percentuali di
voto dei due maggiori partiti) fornisce un'indicazione della ten-
denza alIa frammentazione 0 alIa concentrazione del sistema
partitico. L'indice di instabilita (calcolato come semisomma, in
valore assoluto, delle differenze percentuali tra i risultati dei
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
1 Abbiamo utilizzato nelle nostre analisi tre sondaggi realizzati dalla Doxa nel 1985,
1986 e 1987 e i risultati elettorali dei due campioni nazionali di sezioni che sono serviti, nel
1987, per Ie proiezioni elettorali della Doxa e del Pci.
2 Per una discussione sui problemi metodologici relativi aIle diverse tecniche di stima
della rnobilita elettorale, si puc vedere 10 studio comparato basato su dati di survey e dati
aggregati realizzato da chi scrive (Biorcio e Natale 1987).90
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
80
/\ ' /r-,
/I,,' , \ '",
70
- /
~ r-----....
~--
60
,, r------
50
1946 1948 1953 1958 1963 1968 1972 1976 1979 1983 1987
FIG. 1. Indice di bipolarismo dal 1946 al 1987
10
-.\ / /
~
J\ - - --7
/ \
8
---
/
6
4
I
\ / /
2
o
1958 1963 1968 1972 1976 1979 1983 1987
FIG. 2. Indice di instabilita dal 1946 al 1987
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649390 Roberto Biorcio, Paolo Natale
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
singoli partiti tra una elezione e la precedente) 3 PUO essere invece
inteso quale misura della variazione complessiva dei rapporti di
forza elettorali registratasi nelle tornate elettorali considerate.
Nelle elezioni del 1987 l'indice di bipolarismo ha raggiunto il
livello piu basso in assoluto dalle elezioni del 1946, confermando
una tendenza al declino che si e mantenuta costante dal 1976 in
avanti. Questa tendenza e stata particolarmente accentuata nelle
maggiori citta: nel 1987 l'indice di bipolarismo e risultato infatti
del 54°1f> nel complesso delle citta con piu di 200 mila abitanti. Dc
e Pci detenevano ne11976, immediatamente prima del periodo qui
considerato, quasi tre quarti dei voti validi e piu di due terzi
dell'intero corpo elettorale. AI termine di quest'ultimo decennio i
due partiti maggiori fanno propri poco piu del 60% dei voti validi
e la meta circa di voti teoricamente disponibili: il livello minimo
nella storia elettorale repubblicana. Nel 1983 il principale respon-
sabile per tale caduta era stato il partito democristiano, che aveva
perduto oltre il 5°1f> degli elettori (tab. 1). N el 1987 il recupero
della Dc e risultato significativo soltanto in 26 provincie, collocate
in buona parte nell'Italia meridionale: va inoltre rilevato che in 22
province si e verificata per la Dc una ulteriore riduzione dei
consensi rispetto al 1983 (fig. 3). Nel 1987 e stato il Pci a fornire il
maggior contribuito all'ulteriore declino dell'indice di bipolari-
smo: le sue perdite (oltre il3% dei consensi) sono state significati-
ve in tutte le aree geo-politiche della penisola.
Questa tendenza mette in evidenza una diminuzione delle
capacita aggregatrici dei due maggiori partiti italiani e una paralle-
la potenziale diminuzione delle logiche di voto basate sulla appar-
tenenza subculturale. Dalla lettura della tabella 1 risulta chiaro
come nessun altro raggruppamento politico sembri potersi chiara-
mente proporre quale tendenziale sostituto: gli incrementi degli
altri partiti e, come vedremo piu oltre, i loro interscambi di voti
con Pci e De, non presentano infatti (a parte Forse il Psi) dimensio-
ni e valori numerici particolarmente elevati. n fenomeno sembra
suggerire, a questo livello generale di analisi, la presenza di
atteggiamenti «in negativo», di perdita di identificazione, piu che
di nuove forme di appartenenza.
L'indice di instabilita, al contrario di quello di bipolarismo,
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
3 Si sono presi in considerazione tutti i partiti che hanno ottenuto deputati 0 che
hanno conseguito almeno 50.000 voti; solo le liste al di sotto di tale soglia sono state
aggregate in un unico gruppo denominato «altri».TAB. 1. Percentuali di voto e uariazioni nelle elezioni politiche 1979-1987 (percentuali su
elettori)
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
1979 1983 1987 79-83 83-87 79-87
DC 33,3 27,6 29,0 -5,8 1,4 -4,4
PCI 26,4 25,1 22,5 -1,4 -2,5 -3,9
PSI 8,5 9,6 12,1 1,1 2,4 3,5
MSI 5,1 5,7 5,0 0,6 -0,8 -0,2
PRI 2,6 4,3 3,1 1,6 -1,1 0,5
PSDI 3,3 3,4 2,5 0,1 -1,0 -0,9
PLI 1,7 2,4 1,8 0,7 -0,6 0,1
PR 3,0 1,8 2,2 -0,8 0,4 -0,4
ES 1,9 1,2 1,4 -0,7 0,2 -0,5
Verdi 2,1 2,1 2,1
Altri 1,0 2,7 2,9 1,8 0,3 2)
Ast. 13,1 16,2 15,4 3,0 -0,8 2,2
Incremento Dc 1983-1987
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
FIG. 3. Ammontare deli'incremento della percentuale di uoti democnsttant nel 1987 nspetto
til 198J392 Roberto Biorcio, Paolo Natale
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
tende a crescere significativamente nel corso delle successive
tornate elettorali. La fig. 2 mostra come I'instabilita del 1983 e del
1987 sia superiore perfino al valore (anomalo) di 7,6 registratosi
ne11976. Quest'ultimo risultato, come e noto, fu significativamen-
te influenzato dalla prima partecipazione al voto di sette classi di
giovani neo-elettori, in seguito all'abbassamento della maggiore
eta a 18 anni, che contribui al balzo in avanti del Pci e all'arretra-
mento di {quasi} tutti gli altri partiti, modificando il quadro
politico italiano {Sani 1976}.
Dopo le elezioni del 1979 gli studiosi di sociologia elettorale
ebbero buon gioco nell' affermare l'anomalia di quel precedente
dato, in seguito alIa caduta dell'indice di instabilita ad un livello
inferiore perfino al1972 {4,7}. D'altra parte, in assenza di adegua-
te stime dei flussi elettorali a livello nazionale, si pose gia allora
l' accento sulla presenza di una nuova mobilita all'interno degli
schieramenti che «aumenta certo il suo peso relativo suI totale dei
movimenti di voto» {Parisi 1979, 24-25}, e che suggeriva una
continuita di comportamento elettorale soltanto accidentalmente
interrotta dalla «paura del sorpasso».
Le elezioni del 1979 misero fine alIa costante crescita dell'elet-
torato comunista. Mentre alcuni analisti politici sostenevano che il
risultato elettorale conseguito dal partito nel 1976 Fosse soltanto
una «gonfiatura» contingente di un trend favorevole che continua-
va' nel 1979 {Corbetta e Parisi 1979}, la diminuzione di consensi
per il Pci che si e realizzata nel 1979 ha rappresentato I'inizio di
una crisi politico-elettorale solo parzialmente smentita dai risultati
delle Europee del 1989 5 •
Dall'elettorato il risuItato del 1979 fu interpretato come un
segnale della effettiva incapacita 0 impossibilita del Pci di divenire
il primo partito italiano>; venuta rneno la «paura del sorpasso», un
4 «Eliminando» infatti l'elezione del 1976, i suffragi per il Pci nel1979 rappresentano
comunque un incremento rispetto a quelli del 1972: da qui l'ipotesi che 10 straordinario
successo di meta decennio fosse originato dalla compresenza di diversi fattori (nuovo voto
giovanile, aumento contingente dell'elettorato di opinione e di scambio, ecc.) che non si
ripresentarono (ne si potevano ripresentare) in egual misura nelle successive consultazioni.
5 In realta, come viene argomentato in un nostro studio sui flussi elettorali 1987-1989
di prossima pubblicazione, anche in questo caso la tendenza all'emorragia di voti del Pci e
stata confermata: il grosso calo di partecipazione al voto ha infatti favorito la tenuta del
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
partito comunista, che ha contribuito in misura minore degli altri partiti all'incremento
dell'area del non-voto, ed e risultato vincente nel computo dei voti validi.
Gli unici veri vincitori di questa tornata elettorale sono stati invece i «nuovi partiti», in
particolare le liste verdi.
6 L'unica eccezione a questa regola si registro in occasione delle elezioni Europee del
1984, dove il sorpasso (sia pur «in discesa») del Pci venne favorito dalle manifestazioni di
affettuoso ricordo e memoria dello scomparso Enrico Berlinguer.La mobllita elettorale degli anni ottanta 393
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
buon numero di elettori di centro ha abbandonato, nelle elezioni
uccessive, il partito democristiano. Il dato anomalo sembra
quindi essere non gia quello del 1976, bensi quello (relativamente
basso) del 1979.
La tendenza al progressivo incremento della instabilita eletto-
rale, insieme alla diminuita rilevanza elettorale di Pci e De, ha COS!
avuto l'effetto di aumentare la frammentazione del sistema dei
partiti, con una diminuzione relativa della concentrazione del
consenso elettorale.
Il senso generale delle trasformazioni del quadro politico puo
essere meglio inteso attraverso un breve confronto tra la situazione
esistente alla fine degli anni settanta e quella attuale, dopo le
politiche del 1987, presentato nella tab. 1. Risultano nettamente
premiati soltanto il Psi e i piccoli raggruppamenti (tra i quali in
particolare la lista verde), che crescono negli anni ottanta di circa il
4% (tra 3,6% e 3,9% sugli iscritti e tra 4,5% e 4,7% sui voti
validi); decisamente ridimensionati Dc e Pci, che perdono ciascu-
no il 4% dell' elettorato; sostanzialmente invariati i risultati per i
laici (tra i quali il Psdi perde la preponderanza elettorale a favore
del Pri), per i missini, per l'estrema sinistra e per i radicali. Il
fenomeno dell' astensionismo risulta in crescita non particolar-
mente sensibile ma uniforme su tutto il territorio nazionale.
I mutamenti dei suffragi elettorali hanno coinvolto, come dato
minimo e prescindendo daltasso di turn-over demografico dell'e-
lettorato, piu del dieci per cento degli iscritti, nel corso degli anni
ottanta, il che corrisponde ad un numero di elettori di almeno 5
milioni; i valori degli indici precedentemente esaminati e quest'ul-
timo dato (analogo ad un indice di instabilita calcolato sull'intero
decennio) inducono a pensare che i cambiamenti non siano
attribuibili al fenomeno del «pendolarismo» del voto, piu volte
riscontrato negli anni precedenti", ma ad un mutamento piu
generale nel comportamento elettorale dei cittadini.
Come si tenter a di verificare piu avanti, il cambiamento di voto
operato dall' elettorato sembra suggerire l'esistenza di nuove for-
me di mobilita, che emergono dalla progressiva erosione delle
7 Se ne ha un riscontro indiretto calcolando gli indici eli instabilita sui soli voti validi
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
per due elezioni non consecutive (in pratica, «saltando» quella intermedia tra tre consecuti-
ve), con un procedimento analogo a quello effettuato per l'ultimo decennio. L'inelice di
instabilita 79-87 risulta pari a 10,1%, quello 76-83 a 9,3°k, quello 72-79 a 6,8% e quello 68-
76 a 6,4°k (aggregando il Psiup al Pci, dove e confluito nel 1976): il trend crescente, dal
1968 al 1987, darebbe quineli una prova indiretta della progressiva caduta del fenomeno del
pendolarismo nelle scelte elivoto, confermato peraltro dai piu recenti sondaggi eliopinione.394 Roberto Biorcio, Paolo Natale
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
tradizionali subculture (De e Pci), con una sensibile riduzione del
voto d' appartenenza a favore di quello di scambio (Psi) e di
opinione (ancora Psi e «nuovi partiti») oppure con l'uscita dalla
competizione elettorale. Nell'area dei cosiddetti «nuovi partiti»
(verdi, Lega lombarda, pensionati, Liga veneta, ecc., rna anche i
piu radicati raggruppamenti regionali) va incluso 10 stesso partito
radicale, che gia negli anni settanta si era situato su posizioni
alternative rispetto all'area politica tradizionale e che, sia pur in
lieve flessione da allora, ha sostanzialmente mantenuto durante
l'ultimo decennio il precedente risultato elettorale e la propria
linea politic a (tra partito e movimento), talora affiancandosi allo
stesso movimento ecologista.
Se identifichiamo nel sistema dei partiti due sottosistemi,
distinguendo i partiti che sono (stati) al governo nel corso degli
anni ottanta da quelli che non ne fanno (0 non ne hanno fatto)
parte, rileviamo tendenze di tipo diverso. Tra i primi si e verificato
un ridimensionamento dello scarto tra i due partiti maggiori (De e
Psi) compreso tra gli 8 e i 9 punti percentuali (dal 29% di
differenza aI20%) ed un sostanziale equilibrio fra i tre minori, con
il parziale fallimento, da parte del Pri, del tentativo di inserirsi
quale terzo interlocutore privilegiato nell'area di governo. Tra i
partiti all'esterno dell' area governativa, di fronte alIa stasi missina
e al gia ricordato crollo comunista, nessun altro partito sembra
aver la forza di proporsi come reale alternativa politica.
Nel complesso tre sono stati gli elementi nuovi del panorama
politico italiano, COS! come si e presentato negli anni ottanta: la
crescita, non dovunque omogenea rna di proporzioni consistenti,
del Psi; la comparsa, 0 talvolta la riconferma, di nuovi partiti che si
sono caratterizzati per modalita non convenzionali di «ingresso»
nella competizione politic a e la tendenziale crisi dei partiti di
mass a (De e Pci). Il Psi e stato protagonista e artefice di un
processo di ridefinizione degli schieramenti tradizionali, costrin-
gendo a rimettere in discussione gli abituali modi di intendere il
gioco politico e di leggere i risultati elettorali. I nuovi partiti hanno
d' altra parte fornito la possibilita ad elettori estranei allo logica dei
partiti tradizionali, 0 con questi in aperta critica, di esprimere
opzioni piu consone aIle proprie reali esigenze e ai propri bisogni,
in netto contrasto comunque con gli schemi politici tradizionali. A
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
ben vedere, sono stati proprio i partiti che hanno introdotto
sostanziali novita nella loro azione politic a a risultare gli unici
vincenti nell'ultimo decennio.La rnobilita elettorale degli anni ottanta 395
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
La crescita della mobilita elettorale
L'indice di instabilita non fornisce una precisa misura della
effettiva mobilita elettorale. Questo indice infatti puo essere
ritenuto solo una stima approssimata 8 della «percentuale minima
di elettori che deve avere cambiato voto dato il mutamento
aggregato osservato» (Przeworski 1975,53). E stato pero dimo-
strato - con la tecnica delle simulazioni (Bartolini 1986) - che
sussiste una correlazione positiva sufficientemente elevata fra
1'indice di instabilita e la mobilita elettorale individuale. La
costante crescita dell'indice di instabilita nelle ultime elezioni
politiche (cfr. fig. 2) puo cosi essere assunta come un valido
indicatore di una crescita continua della mobilita elettorale in
Italia dalla fine degli anni settanta.
Questa ipotesi e convalidata dalle stime della rnobilita indivi-
duale ricavate sia da rilevazioni mediante survey che da dati
aggregati. Esistono diverse fonti di distorsione delle stime basate
sui sondaggi (Mannheimer 1986; Bartolini 1986; Corbetta et al.
1988), dovute 'non solo aIle possibili reticenze e dimenticanze degli
intervistati, ma anche alIa tendenza ad omologare il proprio
passatp comportamento elettorale aIle presenti preferenze partiti-
che". E pero ragionevole ipotizzare che l'entita di queste distorsio-
ni si mantenga relativamente costante, in particolare se i sondaggi
sono effettuati dallo stesso istituto demoscopico, in un arco di
tempo non troppo ampio.
In un campione di italiani intervistati dalla Doxa nel1984 (cfr.
Mannheimer 1986), la quota di coloro che hanno dichiarato
mutamenti di scelte di voto in almeno una delle tre elezioni
politiche tenutesi nel 1976, nel 1979 e nel 1983 e risultata pari al
18,8% 10. In tre sondaggi successivi effettuati dallo stesso istituto
demoscopico fra il 1985 e il 1987, circa un quinto (20,2%) degli
intervistati ha espresso l'intenzione di votare per un partito
diverso da quello votato nel 1983. A questa quota di elettori che
8 L' approssimazione e dovuta al fatto che Ie percentuali di voto dei singoli partiti fra
una elezione e l' altra possono - anche in assenza di rnobilita elettorale - variare per il solo
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
effetto del ricambio elettorale (Bartolini 1986).
9 E opinione comune degli studiosi che i dati tratti dai sondaggi individuali portino a
sottostimare la rnobilita individuale, per la tendenza di molti intervistati a esibire una
coerenza di comportamento nel tempo.
10 Questa quota si basa, per ragioni evidenti, su coloro che avevano I'eta per votare
nelle tre elezioni 1976, 1979 e 1983.396 Roberto Biorcio, Paolo Natale
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
aveva gia deciso di mutare scelta di voto, si deve aggiungere
almeno un parte di quegli intervistati che, pur non avendo ancora
deciso per chi votare, aveva espresso I'intenzione di non riconfer-
mare la opzione di voto del 1983. Nella sola transizione 1983-1987
le dichiarazioni di rnobilita elettorale sono state quindi percentual-
mente superiori a quelle registratesi nel complesso delle due
precedenti transizioni (1976-1979 e 1979-1983). Poiche la mobi-
lita dichiarata dagli intervistati nelle suruey e generalmente
sottostimata, si puo ritenere che la quota di coloro che, tra il1983 e
il 1987, ha cambiato opzione di voto sia senz' altro superiore ad un
quinto dell' elettorato italiano. La stima della mobilita ricavata
dalI'analisi effettuata sui due campioni nazionali di sezioni eletto-
rali presenta un valore pari a 25,4%, che conferma l'ipotesi
formulata. Corbetta, Parisi e Schadee (1988, 448), d' altra parte,
studiando i flussi di voto in cinque citta del centro-nord, hanno
riscontrato un livello medio di rnobilita elettorale del 31,2°ib: si
tratta sicuramente - per i motivi che vedremo tra poco -,di una
sovrastima dei livelli medi di mobilita elettorale italiani. E pero
significativo che, limitatamente aIle cinque citta, la mobilita 1983-
87 risulti la pill elevata dal 1968 ad oggi. Anche 10 studio dei flussi
di voto nella citta di Milano ha confermato come nel 1987 si sia
registrato il livello pill alto (43,4°ib) tra tutte Ie elezioni politiche
degli ultimi dieci annie
La tendenza di fondo alla crescita della rnobilita elettorale
negli anni ottanta risulta cosi confermata da tutti gli indicatori oggi
disponibili (indice di instabilita, suruey e stime dei flussi di voto a
livello nazionale ed in diverse citta). Si possono avanzare diverse
spiegazioni (in certa misura complementari) di questo fenomeno:
1) e possibile ipotizzare l' esistenza di una tendenza di lungo
periodo alIa secolarizzazione del comportamento dell' elettore, che
si manifesta con il progressive indebolimento delle identificazioni
partitiche e/o subculturali, contestualmente alIa crescita dei livelli
medi di informazione e di risorse culturali disponibili;
2) si puo poi enfatizzare un effetto congiunturale di rnobilita
crescente provocato da momenti di accelerazione della crisi della
Dc (nel 1983) e del Pci (neI1987).
Le due spiegazioni possono ovviamente coesistere, e rafforzar-
si reciprocamente. La secolarizzazione del rapporto fra elettori e
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
partiti permette, in particolari congiunture, pill rapidi e rilevanti
spostamenti di voti tra i partiti. D'altra parte i momenti - anche
congiunturali - di crisi elettorale delle principali forze politiche
italiane (nel 1983 per la Dc e nel 1987 per il Pci) possono creareLa mobilita elettarale degli anni ottanta 397
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
TAB. 2. Mobilita elettorale in diversi gruppi di interoistati
Ok> mobili N.
Sesso:
- maschi 19,6 1.444
- femmine 21,0 1.335
Eta:
- 18-24 anni 24,3 256
- 25-34 anni 24,6 584
- 35-44 anni 20,9 1.044
- 55 anni e oltre 15,4 895
Istruzione:
- laureati e freq. universita 26,0 145
- diplomati 25,9 743
- licenza media inf. 23,1 643
- licenza e1ementare 16,6 895
- nessun titolo 10,4 359
Condizione professionale:
- imprenditori, dirigenti,
liberi profess. 20,6 104
- impiegati insegnanti 24,0 490
- artigiani-cornmercianti 17,8 267
- lavoratori manuali 17,7 618
- agricoltori 9,1 98
- pensionati 18,9 393
- casalinghe 21,6 560
- disoccupati - in cerca della
prima occup. 19,2 116
- studenti 32,5 119
Tutto il campione 20,4 2.779
Fonti: ricerca «4 Nazioni» 1985;
. rilevazioni «Osservatorio politico italiano» 1986, 1987 e 1988.
temporanee crescite dei livelli di mobilita rna anche indurre gli
elettori «defezionisti» a rivedere definitivamente il proprio rap-
porto con i rispettivi partiti.
E opportuno a questo punto evidenziare le differenze nei
livelli di mobilita secondo le condizioni socio-demografiche degli
elettori. Si puo ipotizzare che nel corso della «carriera elettorale»
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
di ogni attore individuale esista una fase iniziale di apprendimen-
to, con una maggiore disponibilita alla sperimentazione e alia
esplorazione di diverse opzioni di voto; a questa succede una
successiva fase di relativa stabilizzazione delle scelte elettorali398 Roberto Biorcio, Paolo Natale
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
durante la quale, in relazione ai diversi livelli di identificazione
partitica, si creano maggiori resistenze al cambiamento. Diverse
indagini basate su sondaggi (Mannheimer 1986) hanno verificato
come nel corso del ciclo di vita individuale la rnobilita elettorale
diminuisca significativamente do po i 35-40 anni, L'influenza del
cicIo di vita sulla mobilita elettorale e pienamente confermata dai
nostri dati (cfr. tab. 2). Tuttavia questa relazione non spiega
l' aumento della rnobilita: poiche la composizione demografica
della popolazione cambia a ritmi relativamente lenti, non si
possono attribuire alIa diversa distribuzione delle classi di eta
effetti significativi sui livelli medi di mobilita elettorale.
La crescita di quest'ultima deve essere quindi ricondotta ad
altre caratteristiche dell'elettorato che registrano una evoluzione
piu rapida dei mutamenti demografici.
Una serie di studi sul comportamento elettorale negli anni
sessanta metteva in evidenza come la disponibilita a gestire in
modo piu «libero» l' opzione di voto Fosse in generale piu elevata
fra gli elettori di sesso maschile, di status professionale elevato e di
piu alto livello di istruzione (Ardigo 1963; Sivini 1966). L'analisi
sulle intenzioni di mutamento delle scelte elettorali, effettuata
sulla base delle tre survey gia citate, ha pienamente confermato, in
generale, la importanza del titolo di studio nel favorire la disponi-
bilita al mutamento delle opzioni di voto (cfr. tab. 2). La crescita
generale dei livelli di scolarizzazione, verificatasi in Italia negli
ultimi 20 anni, e percio una delle componenti fondamentali che ha
favorito, al di la delle oscillazioni congiunturali, un generale
aumento della rnobilita elettorale.
La tab. 2 indica come Ie probabilita di mutamento delle scelte
elettorali fra il 1983 e il 1987 risultino molto differenziate in
relazione aIle diverse condizioni sociali degli intervistati. Nelle due
condizioni sociali che presentano rispettivamente i livelli piu
elevati (gli studenti) e quelli meno elevati (gli agricoltori) di
mobilita elettorale, si «cumulano» gli effetti di componenti causali
gia richiamate. Per gli studenti, la fase del cicIo di vita e la
disponibilita di risorse culturali medio-superiori favoriscono una
disponibilita al mutamento delle scelte di voto tre volte superiori a
quelle degli agricoltori, che risultano mediamente di eta elevata,
con un limitato bagaglio di istruzione e residenti in contesti sociali
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
poco dinamici. Se non cambiano nel corso del tempo le relazioni
Era condizioni sociali e probabilita di mobilita elettorale, l' espan-
sione delle categorie sociali elettoralmente piu mobili (i ceti medi
impiegatizi e gli studenti) e la relativa contrazione di quelle cheLa rnobilita elettorale degli anni ottanta 399
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
presentano un grado maggiore di fedelta elettorale (agricoltori ed
operai), possono essere la base di una tendenza ad una maggiore
Iluidita elettorale.
Possiamo poi ipotizzare che la crescita della fluidita elettorale
sia dovuta anche alIa caduta del differenziale nei livelli di mobilita
fra i sessi. Gia per Ie elezioni del 1976, 1979 e 1983 e stato possibile
rilevare come la mobilita maschile Fosse solo poco superiore a
quella femminile, tanto da non essere statisticamente significativa
(Mannheimer 1986,54). Tra il1983 e il1987 si e registrata invece
una disponibilita al cambiamento di voto lievemente superiore fra
Ie elettrici (21,OOib) rispetto agli elettori maschi (19,6°ib).
n comportamento elettorale risulta pill mobile, e quindi pill
libero dalle appartenenze tradizionali, nelle citta rispetto ai piccoli
centri (tab. 3). Questo fenomeno appare particolarmente signifi-
cativo nelle tre citta con pill di un milione di abitanti (cfr. tab. 4),
per Ie quali si sono stimati i flussi di voto ", La mobilita raggiunge
in particolare i livelli pill elevati a Milano (43,4°ib) e a Torino
(39,6°ib). L'importanza del. contesto sociale metropolitano nel
favorire la crescita della mobilita elettorale era stata verificata nelle
elezioni region ali del 1985, sulla base dei risultati di un campione
nazionale di sezioni (Biorcio e Natale 1987). La diffusione anche
nei centri minori delle forme di vita e delle rappresentazioni della
politica particolarmente pre senti nelle citta puo essere un fattore
importante per la erosione delle scelte di voto tradizionali delle
aree periferiche.
I livelli di mobilita elettorale si presentano poi significativa-
mente differenziati fra Ie diverse regioni italiane (tab. 4): i cambia-
menti pill numerosi nella opzione di voto si sono verificati nelle
regioni del triangolo industriale, dove quasi un terzo dell'elettora-
to ha infatti mutato la propria scelta (29,9°ib). Le variazioni nei
livelli di mobilita elettorale pero dipendono pill dai diversi orien-
tamenti politico-culturali pre senti nel corpo elettorale, e dalle
11 E interessante notare come Ie stime di rnobilita presentate nelle tabelle 4 e 6
risultino significativamente coerenti, tenuto conto della specificita delle fonti utilizzate (cfr.
nota seguente), Le stime di mobilita basate sulle survey appaiono, in tutte Ie aree
geopolitiche, sottostimate rispetto a quelle ottenute dai dati aggregati delle sezioni
campione. D'altra parte, come previsto, le stime di mobilita nelle singole citra tendono in
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
genere ad essere superiori a quelle basate su campioni nazionali di sezioni, e molto superiori
a quelle desumibili dalle survey, Sembra pertanto plausibile ritenere che, analizzando la
mobilita elettorale in Italia a partire dalle sole survey, 0 a partire dai soli flussi di voto di
singole (grandi) citta, emerga una tendenza sistematica rispettivamente a sottostimare 0,
viceversa, a sovrastimare il livello degli effettivi movimenti di voto. Meno soggette a tali
distorsioni appaiono Ie stime basate su un campione nazionale di sezioni.400 Roberto Biorcio, Paolo Natale
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
TAB. 3. Valore della mobilita elettorale in rapporto alia dimensione dei comuni
Comuni con meno di 10.000 abo 18,2
Comuni con 10-100.000 abo 19,9
Comuni con piu di 100.000 abo 22,8
ltalia 20,8
Fonti: cfr. Tab. 2.
TAB. 4. Valore della mobilita elettorale 1983-87 (e della instabilita) in diverse zone regionali
e citta
da survey da dati aggregati
Zona industriale 23,9 29,9 (10,6)
- Torino 39,6
- Milano 43,4
- Genova 25,8
Zona bianca 18,0 25,5 ( 8,4)
- Verona 33,4
- Padova 34,9
Zona rossa 15,5 20,0 ( 6,2)
- Perugia 22,1
Zona meridionale 20,6 25,4 ( 5,4)
- Roma 33,8
totale Italia 25,4 ( 6,8)
appartenenze subculturali, che dalle specifiche caratteristiche
sociali e demografiche degli elettori.
La spiegazione della stabilita del voto, in particolare in quell a
parte dell' elettorato che fa riferimento alIa Dc e al Pci, e stata in
gran parte ricondotta alIa persistenza delle aree di appartenenza
sub-culturale. Queste sono state considerate come Ie basi di un
voto senza una effettiva scelta dell'attore individuale: «Il voto di
appartenenza e percio caratterizzato nell' elettore da una forte
determinazione, scarsa esposizione alla congiuntura politica, con-
tinuita nel tempo, assenza di specificita e scarsa considerazione del
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
tipo di consultazione» (Parisi e Pasquino 1977, 224).
Abbiamo anzitutto cercato di verificare se la quota di mobili
rilevata nelle zone in cui e tradizionalmente pili forte il fenomeno
dell' appartenenza sub-culturale sia, come in precedenti elezioni,La rnobllita elettorale degli anni ottanta 401
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
TAB. 5. Mobilita elettorale e onentamenti politici e culturali
01402 Roberto Biorcio, Paolo Natale
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
principali tradizioni politiche italiane. Mannheimer e Sani (1987)
hanno verificato che ai diversi gradi di «appartenenza subcultura-
Ie» individuale sono direttamente correlati i livelli di probabilita di
voto per la De e per il Pci. Nelle nostre analisi, abbiamo verificato
come l'adesione aIle due principali subculture politiche (misurata
sulla base dei giudizi espressi sulla Chiesa, la Cgil e I'Drss) risulta
correlata con una riduzione dei livelli di rnobilita individuale (tab.
5). Dunque anche nel19871'appartenenza sub-culturale - dipen-
dente sia da particolari contesti territoriali, sia da disposizioni
individuali - mantiene un ruolo importante nel garantire la
stabilita elettorale.
Assumendo il posizionamento sul tradizionale asse destra/si-
nistra come indicatore della personale posizione ideologica, ab-
biamo verificato che gli intervistati pill mobili tra il1983 e il 1987 si
sono autocollocati in un' area intermedia fra il centro e la sinistra e
fra il centro e la destra (fig. 4). Coloro che hanno invece definito la
propria posizione politica in termini pill netti, facendo riferimento
alle tradizionali definizioni di «campo» (sinistra, destra e centro),
hanno mostrato una minore disponibilita al cambiamento di voto.
A partire da questi primi indizi, si puo dunque avanzare
un'ipotesi, che verra discussa nel quinto paragrafo: la crescita
della mobilita degli anni ottanta, e la relativa novita delle sue
forme, emerge non solo dalla erosione delle tradizionali aree di
appartenenza subculturale, ma anche dalla minore rilevanza delle
tradizionali connotazioni ideologiche destra, sinistra e centro.
Le diverse forme di mobilita elettorale
Dopo avere esplorato Ie caratteristiche generali degli elettori
mobili, possiamo approfondire l' analisi delle forme di mobilita in
riferimento allo specifico elettorato dei singoli partiti.
In base alle indicazioni fornite dalle suruey e dalle stime dei
flussi di voto, possiamo osservare come i livelli di mobilita eletto-
rale 1983-87 siano risultati notevolmente differenziati nell'ambito
dell'elettorato dei diversi partiti (tab. 6). Gli elettori della Dc e del
Pci mantengono un' altissima continuita di comportamento eletto-
rale, in particolare nelle rispettive zone di tradizionale insedia-
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
mento subculturale (tab. 7). Nel complesso dell'elettorato e la Dc
a presentare la pill elevata fedelta elettorale 12. Sembra delinearsi,
12 Notiamo per inciso che Ie stime della mobilita elettorale ricavate dalle survey sonoLa moblllta elettorale degli anni ottanta 403
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
300fTAB. 6. Percentuali di elettoriehe non conjermano nel 1987 la scelta elettorale del 1983} per
partito
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
da stime dei flussi da survey
camp. naz. 5 citra
DC 12,8 11,3 16,3
PCI 17,1 20,7 10,7
PSI 24,1 29,3 19,2
MSI 45,3 42,3 23,1
PRJ 51,3 61,8 46,5
PSDI 56,0 82,2 28,3
PLI 60,0 59,8 51,1
PR 64,8 68,0 54,3
DP 63,1 66,6 50,0
Ast. 22,5 30,4 51,2
Media 25,4 31,2 20,4
Nota. Le stime delle 5 citta riguardano Torino, Genova, Verona, Padova e Perugia, e
sono tratte da Corbetta, Parisi, Schadee (1988).
TAB. 7. Pereentuali di elettori ehe confermano nel 1987 la seelta elettorale del 1983} per
partite e per area geopolitica
Italia zona zona zona zona
indust. bianca rossa meridion.
DC 87,2 86,8 96,4 87,4 85,1
PCI 82,9 79,0 80,6 91,6 78,4
PSI 75,9 81,6 78,7 68,4 75,2
MSI 54,7 45,9 54,1 67,5 53,1
PRJ 48,7 42,5 39,3 67,9 47,5
PSDI 44,0 54,3 25,6 37,6 46,0
PLI 40,0 41,6 39,2 32,5 38,9
PR 35,2 36,1 23,3 29,8 33,2
DP 36,9 43,4 26,7 22,6 37,9
Ast. 77,5 66,3 70,6 79,5 82,2
TAB. 8. Valore della mobilita elettorale 1983-87 in rapporto ai partiti votati nel 1983 e al
grado di istruzione
elettori DC e PCI elettori di altri
nel 1983 partiti nel 1983
0A> mobili N.
Istruzione:
- laureati e diplomati 18,0 449 34,1 437
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
- licenza media info 17,0 385 31,9 260
- licenza elementare 0 ness. titolo 10,1 858 24,5 412
Tutti 13,8 1.692 30,0 1.109
Fonti: cfr. tab. 2.La mobilita elettarale degli anni attanta 405
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
Prendendo in esame separatamente ogni singolo partito, si
possono avanzare due tipi di ipotesi: si puo innanzitutto pensare
che esistano differenze sostanziali e continue nel tempo fra gli
elettori «fedeli» e quelli «mobili» che fluttuano intorno al nucleo
stabile (il cosiddetto zoccolo duro) dell' elettorato di ogni partito.
Se non esistono differenze significative fra coloro che «escono» e
coloro che «entrano» a far parte dell' elettorato di un determinato
partito, la mobilita elettorale puo essere attribuita in grande
misura aile fluttuazioni congiunturali di un settore dell' elettorato
che si colloca al di fuori delle aree di elettori «fedeli» dei diversi
partiti. Se esistono pero rilevanti differenze sociali e culturali fra
gli elettori che abbandonano un determinato partito e quelli che
entrano a fare parte del suo elettorato, si puo cogliere l'esistenza di
un tipo di rnobilita che incide sulla composizione della sua base
elettorale tradizionale.
Per la esiguita del numero di intervistati che nelle suruey
dichiarano un mutamento di scelta elettorale, abbiamo potuto
affrontare questo problema soltanto per i tre principali partiti
italiani, cui si aggiungeranno alcune considerazioni sulle caratteri-
stiche degli elettori che hanno votato le Liste Verdi, e su quelli che
hanno scelto di astenersi dal voto. Nella tab. 9 sono analizzate le
composizioni sociodemografiche degli elettori fedeli e di quelli
mobili «in entrata» e «in uscita» per i partiti considerati. Nella tab.
10 sono riportate le differenze interne in riferimento agli orienta-
menti politico-culturali. Gli elettori che hanno confermato Ie loro
scelte di voto fra il 1983 e il 1987 presentano caratteristiche sociali
e culturali sostanzialmente analoghe a quelle evidenziate da diversi
studi nel corso degli ultimi venti anni (Barnes 1974; Sani 1978).
Gli elettori «fedeli» nel voto per Pci e Dc dispongono di un basso
livello di istruzione e si caratterizzano rispettivamente per una
prevalenza maschile e femminile. n nucleo sociale piu esteso e
costituito per il Pci dagli operai e per la Dc dalle casalinghe.
L'elettorato «stabile» del Psi presenta invece un livello mediamen-
te superiore di istruzione, e comprende quote di operai e di
impiegati superiori alIa media del campione.
Facendo riferimento ai livelli di consenso per la Chiesa, la Cgil
e l'Urss come indicatori di appartenenza subculturale, e possibile
verificare come la grande maggioranza degli elettori stabili della
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
De e del Pci nel 1987 mantengano i tradizionali riferimenti
ideologici (cfr, tab. 10). Questi riferimenti sono inoltre confermati
dalla autocollocazione prevalente degli elettori «fedeli» sull' asse
sinistra-destra. Se prendiamo in considerazione il complesso degliDownloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
TAB. 9. Composizione sociale degli eletton fedeli, mobili in uscita e mobili in entrata di DC} PCI e PSI
Tutto DC PCI PSI
il camp. Fed. Usc. Entr. Fed. Usc. Entr. Fed. Usc. Entr.
- Sesso:
maseru 52,1 43,7 48,1 37,1 57,0 52,5 44,8 59,1 55,9 57,6
femmine 47,9 56,3 51,9 62,9 43,0 47,5 57,1 40,9 44,1 42,4
- Eta:
< 35 anni 35,6 22,5 29,2 25,7 32,0 43,8 37,9 30,2 20,6 37,1
35-55 anni 34,7 35,5 42,2 39,2 38,0 38,8 40,2 36,7 48,0 37,1
> 55 anni 29,7 42,1 28,6 35,1 30,0 17,5 21,8 33,3 31,4 25,8
- Istruzione:
laureati
e universit. 4,8 3,8 4,5 5,2 3,3 5,0 3,4 5,4 3,9 6,8
diplornati 27,8 21,6 33,1 23,7 21,8 23,8 28,7 25,5 27,5 34,1
lie. media 25,5 21,0 27,3 17,5 23,0 30,0 26,4 24,6 27,3 17,5
senza lie. media 42,0 53,6 35,0 53,6 51,8 40,1 41,3 44,5 41,2 34,3
- Condizione professionale:
impr. dirigenti,
lib. prof. 3,5 3,1 1,9 2,1 1,7 2,5 1,1 3,7 4,0 7,6
impiegati e insegn. 16,8 16,6 19,5 14,6 14,1 20,0 21,8 18,7 19,8 18,2
artigiani-comrnerc. 9,2 8,9 8,4 8,3 9,8 6,3 5,7 10,8 11,9 9,1
operai 21,8 16,2 14,9 20,8 34,2 36,3 19,5 25,1 18,8 22,0
agricoltori 3,3 7,8 2,6 3,1 1,8 0,0 3,4 0,9 1,0 0,8
pensionati 13,1 17,7 15,6 14,6 12,8 7,5 11,5 14,8 18,8 12,9
casalinghe 18,9 22,7 25,3 29,2 17,9 21,3 26,4 18,7 19,8 18,9
disoccupati 5,4 3,7 4,5 5,2 4,7 2,5 3,4 3,7 1,0 3,0
studenti 7,9 3,3 7,1 2,1 3,2 3,8 6,9 3,5 5,0 7,6
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fonti: cfr. Tab. 2.Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
TAB. 10. Onentamenti politici degli eletton fedeli mobili in uscita e mobili in entrata di DC, PCI e PSI
Tutto DC PCI PSI
il camp. Fed. Usc. Entr. Fed. Usc. Entr. Fed. Usc. Entr.
Consenso per la CG IL:
- basso 36,9 51,2 44,9 38,8 16,2 19,7 28,9 32,7 37,8 35,4
- medio 31,8 31,5 32,4 37,6 22,7 27,6 31,6 24,0 32,3 40,2
- alto 31,3 17,2 22,8 23,5 61,1 52,6 39,5 33,2 30,0 24,4
Consenso per la Chiesa:
- basso 25,2 5,4 13,9 9,3 45,4 35,5 51,9 22,8 26,0 24,0
- medio 22,4 12,4 21,2 34,0 24,6 19,7 24,7 25,2 32,3 27,9
- alto 52,4 82,3 64,9 56,7 30,0 44,7 23,4 52,0 41,7 48,1
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fonte: cfr. Tab. 2.408 Roberto Biorcio, Paolo Natale
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
elettori mobili che entrano ed escono da questi partiti, ritroviamo
molte delle caratteristiche individuate in generale per questo tipo
di elettori (maggiore istruzione, minore eta, minore coinvolgimen-
to a livello subculturale). Come previsto, anche il grado di appar-
tenenza subculturale e Ie collocazioni sull' asse sinistra-destra del
complesso degli elettori mobili dei diversi partiti risultano poi
significativamente differenziati rispetto a quelli tipici degli elettori
fedeli.
Pero sono in atto importanti trasformazioni sociali della base
elettorale dei tre principali partiti, che si riferiscono al voto degli
operai e a quello delle donne. Possiamo notare che la quota degli
operai fra gli elettori che abbandonano il Pci nel 1987 e decisa-
mente superiore a quella che si ritrova fra gli elettori di altri partiti
che vi confluiscono. Se si considera, inoltre, che la dimensione dei
flussi elettorali «in uscita» dal Pci e stata nettamente superiore a
quella dei flussi «in entrata», la mobilita elettorale emergente
nell'elettorato comunista sembra caratterizzata dalla capacita di
erosione della componente operaia tradizionale. La quota di
operai tra gli elettori che sono confluiti nella Dc appare invece
nettamente superiore a quella registrata tra gli elettori che hanno
abbandonato questo partito (tab. 9). Nello stesso senso - anche
se in misura minore - sembra evolvere la componente operaia
nell' elettorato socialista. Se queste tendenze avranno uno svilup-
po, si puo ipotizzare nel prossimo futuro un saIto di qualita
importante nel processo di omologazione della composizione
sociale dei principali partiti italiani.
In termini di composizione per sesso, la base elettorale del Pci
sembra conoscere importanti trasformazioni alla meta degli anni
ottanta, con una tendenziale correzione della tradizionale prevalenza
maschile, che comunque ancora si registra nel nucleo dei «fedeli»,
Nella prevalenza delle donne tra gli elettori «in entrata» nell'area del
Pci si puo cogliere uno degli effetti della valorizzazione della compo-
nente femminile nell'ambito delle liste di questo partito.
Rappresentando su un piano cartesiano il posizionamento
degli elettori fedeli e di quelli mobili, che entrano ed escono dai
partiti citati, rispetto al continuum destra-sinistra e al consenso nei
riguardi della Chiesa (fig. 5), si puo cogliere il diverso grado di
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
eterogeneita ideologica che caratterizza Ie fluttuazioni di voto dei
principali partiti. AI contrario di Psi e De, l'interscambio elettorale
del Pci sembra toccare aree relativamente lontane, situate media-
mente molto piu a destra del posizionamento degli elettori stabili
di questo partito.La mobiltta elettorale degli anni ottanta 409
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.9.8.24, on 14 Sep 2020 at 20:03:58, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
8,5
DC-Fedeli
8-
7,S -
DC-Usciti
7- DC-Entrati
~
v:
v
:au 6,5 -
~
PSI-Fedeli
PSI-Entrati
[ 6- PCI-Entrati
o PCI-Usciti PSI-Usciti
v:
~ 5,5-
c
o
u 5-
PCI-Fedeli Verdi
4-t------.......------.------....--------....---------I
I I I
2 6
Posizionamento medio sinistra-destra
FIG. 5. Collocazione di diuersi gruppi di elettori secondo la posizione sui continuum sinistra-
destra e il consenso nei confronti della chiesa cattolica
La difficolta a raccogliere e a conservare consensi elettorali in
aree ideologicamente lontane da quelle della propria tradizione
puo essere quindi una delle ragioni pili rilevanti delle difficolta del
Pci a conservare la forza elettorale raggiunta negli anni settanta.
Queste difficolta sono accentuate dal fatto che l'interscambio
elettorale di questo partito avviene in un' area in cui esiste una forte
concorrenzialita del Psi e dei verdi.
L'esordio elettorale alle elezioni politiche delle Liste Verdi ha
provocato importanti trasformazioni nelle logiche della mobilita
elettorale, sia direttamente - raccogliendo una quota non trascu-
rabile del totale degli elettori mobili - sia soprattutto indiretta-
mente, investendo le tradizionali linee di divisione politica e
ideologica che hanno strutturato il mercato elettorale italiano. Le
Liste Verdi hanno raccolto voti soprattutto nei settori sociali
precedentemente individuati come i pili mobili (tab. 11). Le
https://doi.org/10.1017/S0048840200008649
condizioni sociali pili favorevoli per il voto verde sono risultate
infatti que lIe dei giovani appartenenti al ceto: medio istruito, in
particolare se impegnati in attivita che non hanno un diretto
riferimento alla produzione e circolazione delle merci (in specialPuoi anche leggere