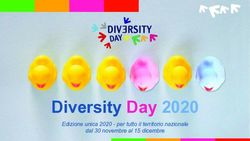L'allievo con disturbi dello spettro autistico: percorsi per l'inclusione
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
UNIVERSITÀ
DEGLI
STUDI
DI
UDINE
L’allievo con disturbi dello spettro autistico:
percorsi per l’inclusione
Lucio
Co(ni
Ordinario
di
Dida(ca
e
Pedagogia
Speciale
(Università
di
Udine)
Presidente
Società
Italiana
d
i
Pedagogia
Speciale
(SIPeS)
Cos’è
l’inclusione
Il
deficit
è
(anche)
Il
deficit
è
una
il
risultato
cara/eris1ca
dell’’interazione
tra
l’individuo
e
il
individuale
contesto
Come
interpretare
la
diversità:
i
modelli
Individuale
(Medico)
Capacità
ICF
(Capability
Approach)
Sociale
(Disability
Studies)
Piano
organizza@vo
Organizzare contesti inclusivi: questione di
alleanze, competenze diffuse, formazione, risorse
Non esiste un programma per l’allievo medio, ma
neanche un programma per allievoSezione 2
Il
“dentro”
e
il
“fuori”
COMPETENZE E METODOLOGIE
Come già visto, u
Tabella 3.3 – Situazioni di apprendimento dell’alunno con autismo all’interno della classe.
di un’articolazion
rimento alla pos
Situazione Descrizione Suggerimenti nizzazione (strut
di apprendimento
prevedendo spaz
ambiti di lavoro comune?
Ci sono
1) Fa le stesse cose dei compagni Nella programmazione curricolare e in In generale gli obiettivi condivisi quale si possano
quella individualizzata sono presenti possono fare riferimento all’area Agendo in quest
obiettivi comuni, individuati dagli dell’autonomia, alla coordinazione solitamente veng
insegnanti in maniera congiunta oculo -manuale necessar ia per munitario, alla p
durante la programmazione. effettuare giochi di incastro e di
Molti obiettivi possono essere costruzione, ad alcune competenze
menti significativ
condivisi, non solo nella scuola grafiche, lessicali e logico-matematiche, che, per il solo fa
dell’infanzia e primaria o con allievi all’ascolto, all’orientamento spaziale droneggiare com
ad alto livello di funzionalità, anche n e l l ’a m b i e n t e, a l l ’ u t i l i z zo del livello di program
se in queste condizioni sono più computer, allo sviluppo dei prerequisiti
agevoli da realizzare, ma uno sguardo funzionali del movimento, al gioco e
Alla luce di quan
non superficiale porta a individuare all’interazione sociale, a specifici ambiti
margini di operatività congiunta anche disciplinari. ne didattica all’in
per le classi superiori e per allievi autismo: molto d
I contenuti possono essere avvicinati?
carenti dal punto di vista cognitivo e ganizzazione e fle
comportamentale. Ciò non toglie, p
tempo scolastico
2) Lavora con obiettivi semplificati, ma Quando il livello di funzionalità è Oltre all’uso di materiale con ampia
vedere moment
con contenuti simili ai compagni basso oppure quando gli obiettivi presenza di figure, l’insegnante può
diventano complessi per l’aumentare anche decidere di agire sui libri di all’esterno della
del livello scolastico, individuare delle testo per renderli più semplici e sire competenze
sovrapposizioni può diventare arduo e, comprensibili per il suo allievo. attività di gruppo
comunque, riguardare solo una parte Può predisporre dei quadernoni ad L’organizzazion
marginale del tempo scolastico. anelli che affianchino o sostituiscano enfatizza questo
Anche in queste situazioni, comunque, completamente il libro di testo della
vengano effettu
la presenza in gruppo dell’allievo può classe o prevedere degli specifici
essere facilitata attraverso un’azione adattamenti degli stessi, realizzando l’intera classe, p
sui contenuti didattici, che possono degli strumenti personalizzati. Questa renderlo possib
essere modificati, ridotti o illustrati per procedura è sicuramente da preferire Bisogna inoltre r
Gli obiettivi individualizzati possono essere
adattarli alle sue esigenze. alla prassi frequentemente adottata di teristiche poco co
In concreto, si tratta di perseguire degli utilizzare libri riferiti a classi inferiori,
esempio, la sovr
obiettivi personalizzati con attività i quali enfatizzano in negativo le
che abbiano qualche somiglianza con differenze e non favoriscono la didattiche può gi
quelle dei compagni.
perseguiti nella classe? creazione di un senso di appartenenza
al gruppo.
gere i propri com
Anche lo spazio
strutturato e in
3) È impegnato in attività personali Svo l g e at t i v i t à p e r s o n a l i z z ate Molti spunti per la realizzazione di “come” e “fino a
supportato dall’insegnante, da uno o queste attività possono essere ricavate grafi precedenti.
più compagni o in maniera autonoma. dai workbook allegati, in relazione agli
In sintesi, quindi
In questo caso i compiti didattici ambiti di lavoro e alle caratteristiche
risultano del tutto diversi da quelli dei degli allievi. sibile e l’abbando
compagni, ma vengono sviluppati nel Le attività didatti
contesto integrato. necessarie in mo
Le attività didattiche svolte all’esterno della prevedere sulla b
re le condizioni p
significativa all’in
classe sono pericolose per l’integrazione?modalità comunicative: si può andare da una comunicazione attraverso oggetti,
per bambini non verbali con gravi carenze, a forme più simboliche e astratte che
Schemi
visivi
a
scuola
prevedono l’uso di fotografie, disegni, numeri, parole.
Con il passare del tempo, le caratteristiche dello schema generalmente cambia-
no, in quanto con l’esperienza l’allievo si abitua all’uso e sviluppa maggiore ca-
pacità di gestione, riuscendo anche a farne a meno (Cottini, 2011) (Figura 3.2). Fig. 3.2 – Esempi di schemi
della giornata: con oggetti
L’individualizzazione è fondamentale per creare uno strumento facilmente
(a sinistra), con immagini (al
comprensibile per ogni allievo, in modo che possa muoversi con autonomia
centro), con immagini e parole
da un’attività all’altra, anche nei momenti in cui è più nervoso e agitato. (a destra) (Workbook 1 pp. 30-
33).
Le quattro parole chiave
per l’integrazione
e l’inclusione
• 2.
Organizzazione
(stru/urazione)
Ambiente
AKvità
Compi1
Organizzazione
dell'ambiente
fisico:
la
classe
di
Filippo
L’aula per l’apprendimento individualizzato di Roberta
Schemi visivi
Schemi visivi
(per esempio: un puzzle completato, non sono adeguatamente predisposte a livello di organizzazione dell’ambiente e (Tortello, 1999).
colorato ecc.), a forme di strutturazio- di tipologia dei compiti previsti.
estra della postazione di lavoro, come Tutto questo rimanda alla questione relativa alla strutturazione (di cui abbia-
migliorare con grafic
Quando
finiscono
i
compi1?
te all’interno del programma
Sezione 2 TEACCH mo parlato nei due paragrafi precedenti), che rappresenta sicuramente uno degli
e nel workbook 1 (Figura 3.3). elementi di maggiore riferimento metodologico per favorire l’apprendimento e
della domanda/fumet
COMPETENZE E METODOLOGIE
l’adattamento al contesto sociale dei bambini con autismo.
do caso si possono utilizzare strumenti
il tempo necessario al completamento Schematizzando al massimo (Tabella 3.3 a pagina seguente), per quando l’allie-
prevedere ATTENZIONE!
dei suoni (ad esempio quel- L’ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO vo si trova in classe possiamo prevedere tre situazioni di apprendimento: IL DENTRO E IL FUOR
mpanella) o degli indicatori luminosi t fa le stesse cose dei compagni;
dono quandoNon saper aspettareil periodo
si conclude t lavora con obiettivi semplificati, ma con contenuti simili ai compagni;
“Adesso si colora, poi potrai giocare con le bolle!”. Questa informazione, anche quan-
ilizzarepuò derivare dal non t è impegnato in attività personali.
dre cheavere idea di quanto
do viene veicolata attraverso il sostegno di uno schema visivo che illustra la suc-
Il bambino deve semp
so puòsi dovrà aspettare, così cessione delle attività, non Va risulta
messo per il bambino
in evidenza consoprattutto
come, autismo ben definita
nella primapersituazione proposta, l’adat- che stia nell’aula del s
come rifiutarsi di effet-
Indicazione
verbale
, 2011) quanto concerne la duratatamentodel compito
degli di colorare.
obiettivi nonLa possa
sua percezione del tempo
essere inteso a senso unico, cioè come sem-
tuare un’attività può es- è estremamente deficitariaplice e, anche in questo della
caso, necessita di essere individualizzata
supportata
adeguamento programmazione per farla avvicinare
sere dovuto al non capi- con opportune operazionia di strutturazione.
quella della classe. In alcune occasioni ci possono essere anche delle attività
re quanto durerà. La peggiore risposta possibile a q
nza che “Quando finiscono i compiti? Ma quando finisce
appositamente l’adesso
pensate e comincia
a favore il dopo?”.
dell’allievo con autismo, alle quali partecipano
ettua a Non avere accesso a questo anche
tipo idicompagni
conoscenze a sviluppo
significa tipico. E questo
sperimentare unnon
mondorappresenta un semplice antepone
ral- un atteggiamento astratt
e figure, Capitolo 4, p. 80 lentamento
imprevedibile, in cui un’attesa per la
può essere classe,
lunga in quanto
minuti comeigiorni
compagni ne possono
e in cui non pragmatico.
trarre dei consistenti
odo da vantaggi, sia di tipo cognitivo e metacognitivo (per esempio Affermazioni del tipo: “Deve stare s
con la ripetizione
Campanella
si sa mai quello che sta per succedere.
omenti
Spesso gli allievi con autismodi alcune parti del programma, con la scomposizione di compiti complessi
non sanno aspettare; per esempio, se vedono le integrazione!”;
in oppure, al contrario,
sequenze, con la riflessione sui processi di apprendimento messi in atto daività com-adatte al suo livello, altrimenti co
bolle vogliono subito prenderle e questo comportamento, comune a molti bam-
pagni nelle esperienze di tutoring ecc.), sia di tipo sociale (Peck e Donaldson, primo orientamento. Queste idee n
bini piccoli, si mantiene anche quando crescono.
a attività.-
1992). L’adozione di un approccio pragma
Fig. 3.3 – Strutturazione della Esistono sostanzialmente due modalità per ricercare una strutturazione
postazione individuale con due temporale nel contesto scolastico: il quesito in modo diverso: “Quand
scaffali/contenitori al lato del a) rendere palese che l’attività è completata; fuori dalla classe quali obiettivi può pe
75
tavolo di lavoro (Workbook 1,
p. 11). Orologi
ada/a1
b) indicare che il tempo di lavoro è concluso.
a) Nel primo caso si può spaziare da immagini
Nella prima parte di questa guida
autismo manifesti dei deficit cons
che illustrano all’allievo come deve presentarsi il
lavoro finito (per esempio: un puzzle completato,
un disegno colorato ecc.), a forme di strutturazio-
possibile pensare che possa appren
non sono adeguatamente predispo
di tipologia dei compiti previsti.
Clessidra
ne sinistra-destra della postazione di lavoro, come Tutto questo rimanda alla questio
quelle previste all’interno del programma TEACCH mo parlato nei due paragrafi preced
, o presentate nel workbook 1 (Figura 3.3). elementi di maggiore riferimento m
l’adattamento al contesto sociale d
b) Nel secondo caso si possono utilizzare strumenti
per misurare il tempo necessario al completamento Schematizzando al massimo (Tabel
Organizzazione
sinistra-‐destra
dell’attività: prevedere dei suoni (ad esempio quel- vo si trova in classe possiamo pr
lo della campanella) o degli indicatori luminosi t fa le stesse cose dei compagni;
che si accendono quando si conclude il periodo t lavora con obiettivi semplifica
di lavoro; utilizzare t è impegnato in attività person
delle clessidre cheL’organizzazione sinistra-destra
L’adaPiano
Metodologico-‐
dida(co
La didattica inclusiva: per tutti e per ciascunoStrategie
di
didaKca
inclusiva
Strategie
riferite
ai
bisogni
speciali
degli
allievi
Asser1vità
e
Approccio
prosocialità
coopera1vo
Autodeter-‐
minazione
Metaco-‐
gnizione
Educazione
delle
emozioni
Clima
DIDATTICA
della
classe
Talen1
e
INCLUSIVA s1li
Ges1one
della
classe
Conoscenza
delle
Individualiz-‐ diversità
Ada/amento
Organizza-‐ zazione/
curricoli
zione
personaliz-‐
zazione
Piano
dell’evidenza
empirica
L’educazione inclusiva funziona?Le domande della ricerca
Quali
risulta@
Come
si
sta
sono
sta@
operando?
oLenu@?
Cosa
dà
i
migliori
risulta@?
Le
scuole
più
inclusive
sono
anche
più
efficaci?
Le strategie efficaci
• Approccio
comportamentale
e
cogniJvo-‐
comportamentale,
autoregolazione,
metacognizione
(HaKe,
2009,
2012;
Slavin
et
al.
2010;
Parsons
et
al.
2011;
Flynn
e
Healy
2012;
Mitchell,
2008,
2014).
• Collaborazione
fra
docenJ,
Leadership
(Mitchell,
2008,
2014).
• Coinvolgimento
delle
famiglie
(Hornby,
2000;
Turnbull
e
Turnbull,
2010;
Durst,
2012).
• Clima
della
classe
(Dorman,
2001;
Anderson,
Hamilton
e
HaKe,
2004;
Thapa
et
al.,
2013).
Cosa dà i
• Educazione
socio-‐emozionale
(Payton
et
al.,
migliori
2008;
Durlak
et
al.,
2011).
risultati?
• Peer
tutoring
e
CooperaJve
Learning
(Murphy
et
al.,2005;
HaKe,
2009;
Bowman-‐Perrot
et
al.,
2013;
Mitchell,
2008,
2014).
Le meta-‐analisi
Le strategie efficaci: disturbi spettro autistico
Fonte: Vivanet, 2014Le scuole più inclusive sono anche più efficaci?
UNIVERSITÀ
DEGLI
STUDI
DI
UDINE
DiparJmento
di
Scienze
Umane
Come
valutare
l’inclusività
delle
nostre
scuole
ScalaApprendimenti a confronto:
scuole ad alta inclusività vs scuole a bassa inclusività
I primi dati
Prove:
Campione:
Comprensione orale (CO-TT, 2013)
13 classi
Calcolo (AC-MT, 2012)
271 studenti
Soluzione problemi (SPM, 2003)
1 classe a bassa inclusività (n. 3)
Abilità emotive e prosociali (Prove
10 classi ad alta inclusività
PATHS, 2004)
2 classi livello soglia (n. 1, 4)Apprendimenti a confronto: scuole ad alta inclusività vs scuole a bassa inclusività
Apprendimenti a confronto: scuole ad alta inclusività vs scuole a bassa inclusività
Apprendimenti a confronto: scuole ad alta inclusività vs scuole a bassa inclusività
Un portale per l’inclusione: http://includere.uniud.it
La qualità dell’inclusione è la
qualità della scuola!Puoi anche leggere