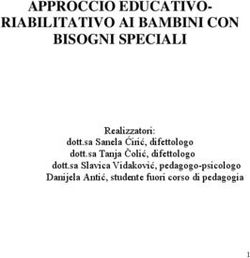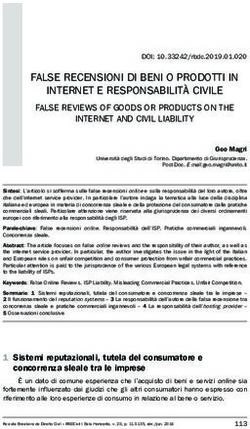Il linguaggio giuridico-istituzionale sul web e la disinformazione pubblica online - di Marina Pietrangelo - Sipotra
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
ISSN 1826-3534
LA DISINFORMAZIONE ONLINE
24 APRILE 2020
Il linguaggio giuridico-istituzionale sul
web e la disinformazione pubblica
online
di Marina Pietrangelo
Ricercatrice del Consiglio nazionale delle ricercheIl linguaggio giuridico-istituzionale sul web e la
disinformazione pubblica online *
di Marina Pietrangelo
Ricercatrice del Consiglio nazionale delle ricerche
Abstract [It]: Il saggio analizza il linguaggio istituzionale sul web alla luce delle norme di legge che prescrivono da
decenni la chiarezza e la precisione linguistica (trasversalmente) per tutti i tipi testuali.
Obiettivo del lavoro è verificare se un linguaggio istituzionale nelle attività di informazione e comunicazione
pubbliche online possa contribuire ad arginare alcuni fenomeni disinformativi, specie nei settori oggi più esposti
statisticamente ai rischi di disinformazione online (economia, ricerca scientifica e tecnologica, salute, ambiente
ecc.).
Abstract [En]: The essay analyses the online institutional language from a legislative perspective, considering that
clarity and linguistic precision of institutional texts has been required by Italian law.
The paper seeks to explore if a "plain" language in public digital information and communication can help to limit
internet disinformation, especially in sectors at greater risk of disinformation
Sommario. 1. Premessa. Comprensibilità linguistica e disinformazione pubblica online. 2. Informazione di fonte
pubblica e comunicazione istituzionale: cenni sul quadro normativo. 3. Il linguaggio giuridico-istituzionale “sul”
web. 3.1. In particolare, atti giuridici e testi comunicativi pubblicati online. 4. Regole e prassi sulla scrittura
giuridico-istituzionale “per” il web. 5. Per concludere.
Conosco l'obiezione che potrebbe muoversi a questo
"Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche":
perché il Dipartimento della funzione pubblica si interessa a questo problema,
quando ve ne sono altri ben altri più urgenti (...)?
(S. Cassese, 1993)**
1. Premessa. Comprensibilità linguistica e disinformazione pubblica online
La disinformazione presente in Rete è oggi ampiamente osservata sotto il profilo sostanziale1. Come noto,
le distorsioni informative diffuse sul web sono censite e classificate a grandi linee anzitutto a seconda del
* Articolo sottoposto a referaggio.
**
S. CASSESE, Prefazione al Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche, in Quaderni del
Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, n. 8/1994, p. 9.
1 La letteratura italiana e straniera in materia è davvero estesa; impossibile darne conto. Per trarre le fila di alcune
questioni giuridiche ricorrenti che ruotano attorno alla libertà di informazione e al pluralismo informativo dopo Internet,
tra i molti v. alcuni scritti più recenti e non occasionali: M. MONTI, Le 8, il discorso pubblico e la democrazia, in Quaderni
costituzionali, n. 4/2019, pp. 811 ss.; G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell'era di Internet, in MediaLaws, n.
1/2018; O. POLLICINO, La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet, in MediaLaws, n. 1/2018;
C. MAGNANI, Libertà di espressione e "fake news", il difficile rapporto tra verità e diritto. Una prospettiva teorica, in
Costituzionalismo.it, n. 3/2018; G.L. CONTI, Manifestazione del pensiero attraverso la Rete e trasformazione della libertà di espressione:
c'è ancora da ballare per strada?, in Rivista AIC, n. 4/2018; M. CUNIBERTI, Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del
mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo, in MediaLaws, n. 1/2017.
350 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 11/2020grado di manipolazione del contenuto informativo e del livello di intenzionalità che essa esprime2. In taluni casi, queste distorsioni - alimentate in gran parte dall'uso di applicazioni digitali che facilitano la produzione e la diffusione di grandi quantità di dati - possono essere ricondotte anche ad usi linguistici non controllati, inadeguati tanto al mezzo quanto al messaggio trasmesso. Fintanto cioè che i contenuti informativi sono racchiusi in testi scritti – oltre che in immagini o suoni - le devianze informative potranno essere considerate anche sotto il profilo della chiarezza intesa come comprensibilità linguistico- lessicale. In ipotesi, dunque, le ambiguità del linguaggio possono generare o favorire devianze informative “a cascata”, al pari di altre forme di manipolazione dei contenuti. A ciò si aggiunga che la contrazione dei tempi di elaborazione dei testi imposta dai nuovi modelli di produzione delle informazioni, la rapidità e la volatilità delle pubblicazioni stesse sono di per sé foriere di imprecisione e vaghezza; con conseguenze sotto il profilo sia sostanziale della verifica e attendibilità delle fonti, sia formale, per l'appunto, della chiarezza del messaggio mediante cui il contenuto è trasmesso. Ciò che qui s'intende osservare è allora l'adeguatezza del registro linguistico di alcuni testi informativi pubblicati sul web, suscettibili di essere "rilanciati" e quindi esposti al rischio di manipolazione. Saranno considerati, in particolare, i soli testi che compongono il patrimonio informativo condiviso online dai soggetti pubblici nell'ambito delle proprie attività di informazione e di comunicazione3. Si tratta di un patrimonio di conoscenze esteso non più mirato al solo perseguimento di interessi istituzionali; esso, infatti, assolve oramai ad una diversa e più ampia funzione di stimolo socio-economico, tanto che l'apertura e la valorizzazione - anche a fini commerciali - di dati e informazioni prodotti o detenuti da soggetti pubblici sono da tempo un obiettivo primario delle politiche europee e nazionali4. Inoltre, le 2 Cfr., per esempio, Council of Europe, Report DGI(2017)09 by Claire Wardle and Hossein Derakhshan, Information Disorder. Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking, 2018 (2nd revised edition), che distingue tre macro aree di distorsione informativa: «Mis-information is when false information is shared, but no harm is meant. Dis- information is when false information is knowingly shared to cause harm. Mal-information is when genuine information is shared to cause harm, often by moving information designed to stay private into the public sphere». V. in questo numero speciale M. CAVINO, Il triceratopo di Spielberg. Fake news, diritto e politica, in questo fascicolo. 3 Anche le informazioni e i dati di fonte pubblica finiscono nel complicato processo di disaggregazione, autoproduzione e disintermediazione dell'offerta informativa tradizionale. Cfr. AGCOM, Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali (Delibera n. 423/17/CONS), Rapporto tecnico le strategie di disinformazione online e la filiera dei contenuti fake. 4 Da ultimo, v. la Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione). Il settore pubblico degli Stati membri «raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, per esempio informazioni di tipo sociale, politico, economico, giuridico, geografico, ambientale, meteorologico, sismico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. I documenti prodotti dagli enti pubblici di natura esecutiva, legislativa o giudiziaria costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire la società. La fornitura di tali informazioni, che comprendono dati dinamici, in un formato elettronico di uso comune consente ai cittadini e alle persone giuridiche di individuare nuovi modi di utilizzarle e di creare prodotti e servizi nuovi e innovativi» (considerando 8). In linea con gli indirizzi Ue, a livello nazionale v. AGID – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, 2017. 351 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 11/2020
conoscenze “possedute” dai soggetti pubblici riguardano molti settori sensibili sotto il profilo disinformativo, più esposti cioè statisticamente ai rischi di disinformazione online; tra gli argomenti connessi ai dati di fonte pubblica più manipolati spiccano, per esempio, quelli relativi a governo ed economia, ricerca scientifica e tecnologica, salute, migrazioni ecc5. In tutti i casi in cui i soggetti istituzionali pubblicano online testi informativi sulle proprie attività (nuove norme, servizi erogati ecc.) si servono di parole. Essi utilizzano “anche” sul web un linguaggio scritto, ancora prevalente rispetto alle immagini, che non dovrebbe sfuggire agli stessi requisiti di chiarezza e comprensibilità richiesti per la redazione degli atti giuridici; con le debite differenze che qui si proveranno ad esaminare. Anzi, nel caso dei testi istituzionali pubblicati online, l'oscurità - storicamente radicata negli atti – può farsi quasi più ostile, perché rischia di ampliare la distanza tra regolatore e regolato, tra amministrazione e amministrato, proprio nell'ambito di un'attività comunicativa cui la legge assegna il compito specifico di accorciarla6. Si tratta di attività finalizzate, infatti, ad illustrare le disposizioni normative o le attività delle istituzioni e il loro funzionamento o più ancora i servizi7. Ecco perché oggetto di questa riflessione è il linguaggio istituzionale utilizzato sul web, cui può essere assegnata una funzione di “controllo preventivo” o di argine alla disinformazione online, opponendo ad essa una vera e propria "controinformazione primaria", almeno per quella porzione significativa di disinformazione secondaria che si fonda su dati di fonte pubblica8. Come più avanti si dirà, pur trattandosi 5 Cfr. i dati contenuti nei Rapporti dell'Osservatorio sulla disinformazione online promosso dall'AGCOM (). Gli argomenti oggetto di disinformazione online sono elaborati secondo il modello statistico del c.d. topic modeling: i contenuti disinformativi sono classificati per argomenti mediante un'analisi testuale condotta da un «algoritmo di apprendimento automatico non supervisionato che tiene conto della frequenza e della co-occorrenza dei termini utilizzati nella raccolta di documenti» (così AGCOM, Servizio economico statistico, News vs. fake nel sistema dell'informazione - Interim report nell'ambito dell'Indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 309/16/CONS, novembre 2018, pp. 34 ss.). 6 Sulla funzione e sulle potenzialità inattuate della comunicazione istituzionale, v. le considerazioni recenti di S. ROLANDO, Comunicazione istituzionale e identità nazionale. Relazione al Convegno “L’amministrazione questa sconosciuta. Chiavi di lettura della storia unitaria a proposito del libro 'Storia dell’amministrazione italiana' di Stefano Sepe, in ARCHIVIO STORICO DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, 16 aprile 2019, Roma, pubblicato online su . L'A. tenta un bilancio dei percorsi comunicativi condotti dalle amministrazioni italiane, segnalando alcuni dei limiti e dei ritardi che ne hanno ridotto le potenzialità democratiche: resistenze culturali legate al retaggio di epoca fascista sui caratteri dell'informazione di Stato e alla propensione degli apparati amministrativi per la segretezza; supplenza nelle attività comunicative «di accompagnamento» da parte del privato sociale; inefficacia nella comunicazione «di spiegazione», che ha lasciato vuoto un contenitore informativo utile specialmente «per il segmento giovanile, che ha cultura digitale e che potrebbe tentare di accedere a più fonti» nel contesto «di un incremento vistoso di incapacità di distinguere il vero dal falso». 7 Così l'art. 1, co. 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, su cui più avanti v. il par. 2. 8Si pensi, per esempio, al già vivace dibattito sui rischi di una disinformazione scientifica online e al ruolo della cosiddetta comunicazione generalista, esterna cioè alla comunità scientifica, in cui la precisione terminologica è considerata strategica per contrastare proprio le distorsioni informative e talvolta sensazionalistiche alimentate dai media o dai singoli. Gli usi linguistici ambigui nelle note informative destinate alla collettività, riguardanti i risultati di ricerche finanziate con denaro pubblico, sono ritenuti una delle prime cause di rottura del rapporto fiduciario delle istituzioni 352 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 11/2020
di una varietà del linguaggio giuridico-istituzionale relativamente nuova, è possibile rintracciare già nel nostro ordinamento regole e indirizzi che impongono il rispetto dei requisiti della chiarezza e della precisione linguistica, da tempo riconosciute come trasversali a tutti i tipi testuali9. Si tratta di regole che s'innestano in un solido quadro normativo che da oltre un decennio disciplina le attività comunicative dei soggetti istituzionali come attuative dei principi di buon andamento e trasparenza dell'agire amministrativo10. 2. Informazione di fonte pubblica e comunicazione istituzionale: cenni sul quadro normativo La scrittura di testi destinati al sito web istituzionale di un'amministrazione pubblica assolve ad una funzione pubblica e rientra a tutti gli effetti nelle attività amministrative di informazione e di comunicazione, disciplinate anzitutto con la legge n. 150 del 2000 in attuazione dei «princìpi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa» (art.r 1, co.1)11. Si tratta di attività che certamente ricomprendono, tra gli altri, tutti gli adempimenti necessari a progettare, realizzare e manutenere tecnicamente il sito web; selezionare, raccogliere e organizzare gli atti e i provvedimenti da pubblicare online a vario titolo; ma anche redigere e aggiornare i testi informativi destinati esclusivamente alle pagine web12. La legge n. 150 ha avuto il grande merito di riordinare e valorizzare le attività informative dei soggetti pubblici, affiancando alla tradizionale attività degli uffici stampa per i mezzi d'informazione anche una nuova comunicazione destinata in via diretta alla cittadinanza, condotta mediante «ogni mezzo di della ricerca con la collettività stessa. In tal senso, tra i tanti, v. E. TASKER - J. TAN - K. HENG. et al., The language of exoplanet ranking metrics needs to change, in Nat Astron 1, n. 42/2017. 9 Così M.E. PIEMONTESE - M.T. TIRABOSCHI, Leggibilità dei testi della pubblica amministrazione. Strumenti e metodologie di ricerca al servizio del diritto a capire testi di rilievo pubblico, in E. ZUANELLI (a cura di), Il diritto all’informazione in Italia, Roma, 1990, pp. 225 ss. 10Per altri aspetti della comunicazione istituzionale e del ruolo delle istituzioni v. in questo numero speciale i contributi di L. CONTE, Questioni costituzionali in tema di opinione pubblica e M. MALVICINI, Parlamento e fake-news: spunti per un dibattito, entrambi in questo fascicolo. 11 Avendo però sempre a mente che nel nostro ordinamento nazionale la trasparenza amministrativa ha preso le mosse al principio degli anni Novanta dalla lungimirante legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Su informazione e comunicazione pubbliche, v. P. MARSOCCI, Poteri e pubblicità. Per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale, Padova, 2002; F. MERLONI (a cura di), L'informazione delle pubbliche amministrazioni, Rimini, 2002. Per i primi commenti alla legge n. 150, tra gli altri, v. P. MARSOCCI, Informazione e comunicazione istituzionale: la legge n. 150 del 2000 come nuovo passo per la riforma amministrativa, in Giurisprudenza di merito, nn. 4-5/2000, pp. 1133 ss.; P. COSTANZO, Informazione e comunicazione pubblica nella Società dell'informazione (osservazioni sparse a margine della legge 7 giugno 2000, n. 150), in DRT - Il Diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni, 2001, n. 1/2001, pp. 11 ss.; A. VIGNUDELLI, Genesi e fenomenologia della comunicazione pubblica dallo Stato autoritario “secretante” alla “trasparenza” dello Stato democratico, in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, n. 2/2005, pp. 237 ss. 12 Sulla comunicazione istituzionale osservata sotto il profilo linguistico, v. M.E. PIEMONTESE, La comunicazione pubblica e istituzionale. Il punto di vista linguistico, in S. GENSINI (a cura di), Manuale di comunicazione. Modelli semiotici, linguaggi, pratiche testuali, Roma, 1999, pp. 315 ss.; R. BOMBI (a cura di), Quale comunicazione tra Stato e cittadino oggi? Per un nuovo manuale di comunicazione istituzionale e internazionale, Roma, 2015. 353 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 11/2020
trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi»13. La formula ampia scelta dal legislatore tendeva a racchiudere tutti i mezzi comunicativi all'epoca conosciuti, comprese quindi le prime applicazioni della telematica, indicate nella legge genericamente come «sistemi telematici multimediali». Qualche anno più avanti, il d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) eleggeva i siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni a canali esclusivi dell'informazione e della comunicazione di fonte pubblica (artt. 53-54)14. Sulla medesima materia, interveniva un decennio più tardi il d.lgs. n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)15, da intendersi come integrativo e complementare di quella prima importante legge del Duemila, benché non raccordato ad essa formalmente. Il decreto legislativo del 2013, infatti, compiva un passo ulteriore, figlio dei tempi, sia prevedendo obblighi di pubblicazione a carico delle amministrazioni adempibili solo online, sia anche confermando il nesso tra queste attività informative e comunicative e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento. Tutte le attività funzionali alla pubblicazione di dati, documenti, atti e testi informativi sui siti web istituzionali, infatti, venivano espressamente finalizzate alla tutela dei diritti dei cittadini e alla promozione della partecipazione all'attività amministrativa, ma anche all'esercizio di un controllo diffuso sulle attività istituzionali; e ricondotte alla competenza statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni 13 Art. 2, co. 2, legge n. 150/2000: «Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico- editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali». 14 Sul d.lgs. n. 82 del 2005 (da ultimo con il d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217), la letteratura è ampia; tra i primi commenti, v. I. D'ELIA - M. PIETRANGELO (a cura di), Il Codice dell'amministrazione digitale. Relazioni e contributi al Convegno DAE 2005, n. spec. di Informatica e diritto, 2005; E. CARLONI (a cura di), Codice dell’Amministrazione Digitale. Commento al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Rimini, 2005; G. CASSANO - C. GIURDANELLA (a cura di) Il codice della pubblica amministrazione digitale. Commentario al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Milano, 2005; P. COSTANZO - G. DE MINICO - R. ZACCARIA (a cura di), I tre codici della società dell'informazione: amministrazione digitale, comunicazioni elettroniche, contenuti audiovisivi, Torino, 2006. Sulle modificazioni successive apportate al d.lgs. n. 82/2005, v. B. CAROTTI, L'amministrazione digitale: le sfide culturali e politiche del nuovo Codice. Commento a d.lg. 26 agosto 2016, n. 179, in Giornale di diritto amministrativo, n. 1/2017, pp. 7 ss.; ID., Il correttivo al Codice dell'amministrazione digitale: una meta-riforma. Commento a d.lg. 13 dicembre 2017, n. 217, in Giornale di diritto amministrativo, n. 2/2018, pp. 131 ss.; E. DE GIOVANNI, Il codice dell'Amministrazione digitale: genesi, evoluzione, principi costituzionali e linee generali. in Rassegna dell'avvocatura dello stato, n. 3/2018, pp. 155 ss. 15 Il d. lgs n. 33 è stato modificato e integrato, titolo compreso, dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). Sulla trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. n. 13/2013, tra i molti, R. CANTONE - E. CARLONI, Corruzione e anticorruzione. Dieci lezioni, Roma, 2018; A. NATALINI - G. VESPERINI, (a cura), Il big bang della trasparenza, Napoli, 2015; B. PONTI (a cura di), Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni, seconda ed., Rimini, 2016; C. COLAPIETRO (a cura di), La terza generazione della trasparenza amministrativa: dall'accesso documentale all'accesso generalizzato, passando per l'accesso civico, Napoli, 2016. Per una ricognizione delle posizioni dottrinarie in tema di trasparenza, con uno sguardo anche comparato, v. A. SIMONATI, La ricerca in materia di trasparenza amministrativa: stato dell'arte e prospettive future, in Diritto amministrativo, n. 2/2018, pp. 311 ss. 354 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 11/2020
concernenti i diritti civili e sociali (le norme del d.lgs. n. 33 integrano il «livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»16). Considerate all'interno di questo perimetro normativo, dunque, anche le pratiche scrittorie finalizzate alla pubblicazione online di informazioni di fonte pubblica devono ritenersi funzionali a garantire tutta una costellazione di vecchi o nuovi diritti, tra loro intimamente legati: all'accesso e alla conoscibilità delle fonti normative e delle altre informazioni pubbliche, alla trasparenza su organizzazione e funzionamento delle istituzioni e, in senso ampio, alla partecipazione democratica17. Il contenuto dei numerosi obblighi informativi introdotti dal decreto n. 33 per molta parte è relativo ad «atti già formati» (per esempio, sull'organizzazione, su alcune specifiche attività autorizzatorie o concessorie), che le amministrazioni devono rendere disponibili a chiunque sui propri siti web. Non mancano, tuttavia, obblighi di pubblicare informazioni “native” sull'accesso alle raccolte di atti, sull'offerta di servizi (come le carte dei servizi e degli standard di qualità), sui tempi medi per il pagamento nel caso di acquisti di beni o forniture, ecc. Se, come detto, l'obiettivo ultimo della norma è rendere azionabili ed effettivi i diritti sopra richiamati, a queste informazioni tutte – e forse ai nuovi testi informativi più ancora che agli atti - sono richieste anche precisione e “chiarezza di linguaggio”, perché i destinatari delle comunicazioni possano almeno avere una chance di comprensione linguistica dinanzi alla mole di dati liberati; e perché le informazioni di fonte pubblica possano meglio “resistere” ai fenomeni di disaggregazione e distorsione dei contenuti nel canale informativo globale che è oggi il web. Vedremo più avanti allora - ed è esattamente ciò che qui s'intende approfondire - se vi siano norme più specifiche che vincolano le amministrazioni alla scelta di registri linguistici adatti a tal fine. 3. Il linguaggio giuridico-istituzionale “sul” web Gli usi linguistici variano di norma in corrispondenza di modificazioni nelle forme di convivenza e nelle relazioni sociali. Questo tratto ricorrente parrebbe confermato anche nel tempo attuale, in cui le nuove forme della socialità digitale sembra abbiano favorito la nascita di linguaggi di gruppo nuovi o solo 16 Cfr. l'art. 1, d.lgs. n. 33/2013. 17 Nella prospettiva della costruzione di una cittadinanza che è anche partecipazione delle comunità, e prima ancora relazione comunicativa tra Stato e cittadini, volendo v. M. PIETRANGELO, La lingua delle istituzioni pubbliche nell'attività di comunicazione sul web, in P. CARETTI - G. MOBILIO (a cura di), La lingua come fattore di integrazione sociale e politica, Torino, 2016, pp. 183 ss.; e A. VALASTRO, Dalla comunicazione pubblica all'«integrazione partecipe»: quali politiche in favore dei migranti e quale ruolo per le ICT, in M. PIETRANGELO (a cura di), La lingua della comunicazione pubblica al tempo di Internet. Profili giuridici, Napoli, 2016, pp. 181 ss. 355 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 11/2020
rivisitati, a seconda delle relazioni cui l'uso è destinato.18 Secondo i linguisti, la comunicazione successiva alla comparsa del computer «ha profondamente modificato le modalità di costruzione e di fruizione del testo e ha complicato il quadro dei canali di diffusione del messaggio verbale»19. I testi delle comunicazioni via web presenterebbero, dunque, tratti sia della lingua parlata che della lingua scritta, e sarebbero riconducibili alla categoria del «trasmesso», che il linguista Sabatini codificò dopo la comparsa dei "primi" mezzi di comunicazione di massa (telefono, radio e televisione)20. I mutamenti del linguaggio legati alla diffusione delle applicazioni digitali hanno interessato anche il linguaggio giuridico-istituzionale, utilizzato nella speciale e multiforme relazione tra istituzioni pubbliche e cittadinanza21. Un linguaggio già ricco di sfumature, sempre più complesse a seconda degli usi, nelle sue molte varianti storicamente connotato da un fisiologico velo di incomprensione reciproca. Come se ci fosse «una incompatibilità di fondo tra la lingua delle istituzioni e i suoi principali fruitori, i cittadini, o 18 Osserva G. ANTONELLI, Parlare, scrivere, digitare, saggio introduttivo a L. SERIANNI, L'italiano. Parlare, scrivere, digitare, Torino, 2019: «la lingua nazionale ha finalmente conquistato anche l'uso scritto di massa (a scapito del non uso). (…) Il fenomeno è evidente: grazie ai cosiddetti “nuovi media”, moltissime persone che fino a vent'anni fa non avrebbero scritto un rigo oggi producono e consumano quotidianamente una mole impressionante – sia pure frammentaria e quasi atomizzata – di testi digitati», pp. 9-10. 19 P. D'ACHILLE, I social network e la lingua italiana, tra neologismi e anglicismi, in , § 2. In particolare, secondo l'A, il web avrebbe indotto la nostra lingua scritta all'abbandono dell'ipotassi, tipica della tradizione scrittoria italiana, in favore della paratassi, più adatta alla produzione di testi brevi e rapidi, come sono i testi destinati a certe applicazioni del web. Un salto che altre lingue come l'inglese o il francese avrebbero meglio assorbito rispetto all'italiano, avendo da tempo accolto nell'uso la preferenza per la paratassi e per periodi più lineari. In generale, sull'“italiano telematico” (o “italiano digitato” o “e-italiano”, a seconda delle diverse formule suggerite dai linguisti), tra i tanti, v. S. SPINA, Fiumi di parole. Discorso e grammatica delle conversazioni scritte in Twitter, Roma, 2019; S. LUBELLO (a cura di), L'e-italiano. Scriventi e scritture nell'era digitale, Firenze, 2018; M. PALERMO, Italiano scritto 2.0. Testi e ipertesti, Roma, 2017; V. GHENO, Social-linguistica. Italiano e italiani dei social network, Firenze, 2017; G. ANTONELLI, L'italiano nella società della comunicazione 2.0, Bologna, 2016; M. PRADA, Lingua e Internet, in I. BONOMI - S. MORGANA (a cura di), La lingua italiana e i mass media, Roma, 2016, pp. 249 ss.; ID. (a cura di), L'Italiano in rete. Usi e generi della comunicazione mediata tecnicamente, Milano, 2015. 20 Così P. D'ACHILLE, cit. 21 Sul linguaggio giuridico la letteratura è davvero estesa, impossibile darne conto, se non per salti. Tra i molti lavori apparsi nel tempo, v. almeno U. SCARPELLI, Diritto e analisi del linguaggio, Milano, 1976; A. ROSS, Critica del diritto e analisi del linguaggio (a cura di A. Febbrajo, R. Guastini), Bologna, 1982; T. DE MAURO - M.E. PIEMONTESE - M. VEDOVELLI (a cura di), Leggibilità e comprensione. Atti dell’incontro di studio, Roma, Istituto di Filosofia, Villa Mirafiori, 26-27 giugno 1986, n. spec di Linguaggi, n. 3/1986; A. BELVEDERE, Linguaggio giuridico, in Digesto delle discipline privatistiche, sez. civile, X, Torino, 1994, pp. 21 ss.; M. CORTELAZZO, Lingua e diritto in Italia: il punto di vista dei linguisti, in L. SCHENA (a cura di), La lingua del diritto: difficoltà traduttive, applicazioni didattiche. Atti del primo convegno internazionale, Milano 5-6 ottobre 1995, Roma, 1997, pp. 35 ss.; U. SCARPELLI - P. DI LUCIA, Il linguaggio del diritto, Milano, 1994; B. MORTARA GARAVELLI, Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani, Torino, 2001; R. GUASTINI, Il diritto come linguaggio. Lezioni, Bologna, 2006; P. FIORELLI, Intorno alle parole del diritto, Milano, 2008; G. GARZONE - F. SANTULLI (a cura di), Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari, Milano, 2008; B. POZZO - F. BAMBI (a cura di), L'italiano giuridico che cambia. Atti del Convegno di studi, Firenze, 1° ottobre 2010, Firenze, 2010; F. GALGANO, Le insidie del linguaggio giuridico, Bologna, 2010; N. MARASCHIO, Lingua e diritto: qualche questione di metodo, in R. ZACCARIA (a cura di), La buona scrittura delle leggi, Roma, 2011, pp. 29 ss. 356 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 11/2020
per lo meno un rapporto difficile, non lineare, un rapporto di incomprensibilità quasi che i due interlocutori appartengano a mondi distinti»22. Come noto, il linguaggio delle istituzioni che più di altri ha capacità ordinante è quello della legge, che mira alla certezza del diritto anche attraverso la chiarezza e l'univocità del discorso normativo e la rigidità testuale, a garanzia di margini interpretativi minimi23; ma che tuttavia sconta una incomprensibilità atavica, se possibile oggi gravata ulteriormente dalla complessità del sistema regolatorio24. Dinanzi alle oscurità dei linguaggi del diritto, dovute a resistenze culturali e a oggettive carenze comunicative, si potrebbe allora considerare come meritoria - reattiva e supplente al contempo - la previsione di una specifica attività comunicativa dedicata proprio a riannodare le fila della relazione tra governanti e governati. Una comunicazione, cui la legge assegna una rilevante funzione sociale, che oggi può giovarsi di mezzi comunicativi più potenti, ma che richiede anche un registro linguistico adeguato, in ipotesi rinnovato e più cristallino. Nonostante i presupposti e i vincoli di legge, non pare però che le cose siano andate come “previsto” (e prescritto) dal legislatore. Dal canto loro, i linguisti addirittura ci ricordano che la scrittura delle amministrazioni in Rete ha solo amplificato gli antichi e irrisolti vizi presenti negli atti, sommando ad essi la mancata adeguatezza al mezzo e al contesto comunicativo25. Le comunicazioni digitali dei soggetti 22 Così J-L. EGGER, A Norma di (chi) legge. Peculiarità dell'italiano federale, Milano, 2019, p. 2, che scrive di una “identità oscillante” del testo normativo, la quale cioè oscilla tra due esigenze opposte, quella di essere compresa dall'intera comunità da essa regolata e quella di mantenere la propria specialità e tecnicità (ivi, pp. 13-14). Secondo l'A., questa ambivalenza inciderebbe inevitabilmente sulla redazione del testo normativo e sulla sua comprensione da parte dei destinatari sin dal principio. Riflette sulla comunicazione “del” e “nel” diritto come pratica condotta “in buona fede” e che mira alla comprensione, senza tuttavia poterla garantire G.U. RESCIGNO, Comunicare, comprendere, interpretare nel diritto, in Diritto pubblico, n. 3/2009, pp. 687 ss.: «Sono sempre singoli individui che hanno compreso o non hanno compreso (che dicono e pensano, magari senza porsi la questione, ma mediante atti concludenti, di aver compreso), in tutto o in parte» (p. 696). 23 V.F. SABATINI, I tipi di testo e la ‘rigidità’ del testo normativo giuridico, in S. COVINO (a cura di), La scrittura professionale. Ricerca, prassi, insegnamento, Firenze, 2001, pp. 97 ss. 24 Sul punto, v. le interessanti considerazioni di G. SEVERINI, La sicurezza giuridica e le nuove implicazioni della nomofilachia, in Federalismi, n. 19/2018. Sulla rinuncia all'uso di un lessico tecnico-specialistico in favore di parole di uso comune, con conseguente perdita di certezza e autorevolezza della fonte normativa, volendo, v. la Sintesi dell'audizione di Marina Pietrangelo presso il Comitato della legislazione della Camera dei deputati del 18 dicembre 2018, in CAMERA DEI DEPUTATI (XVIII LEG.), Rapporto sull'attività svolta dal Comitato per la legislazione. Primo turno di Presidenza, Presidente On. Fabiana Dadone (10 luglio 2018 – 05 maggio 2019), pp. 158 ss. 25 Cfr. A. FRATI - S. IANNIZZOTTO, Osservazioni sulla lingua delle pubbliche amministrazione nelle comunicazioni sui siti web istituzionali e sui social network, in M. PIETRANGELO (a cura di), La lingua della comunicazione, cit., pp. 123 ss., secondo cui «Il nuovo mezzo infatti richiede nuovi modelli comunicativi più agili e basati su regole precise che sono diverse da quelle a cui bisognava attenersi quando si scriveva solo “sulla carta” (basti per esempio pensare a come la lettura su schermo richieda testi e periodi più brevi). La comunicazione attraverso il sito web impone dunque un cambiamento nel modus scribendi dei redattori: essi devono essere capaci cioè di gestire lo stesso contenuto su canali diversi e con modalità comunicative diverse. Questo vuol dire certamente imparare una nuova tecnica di scrittura, ma implica anche una disponibilità a cambiare il modo di confrontarsi con una prassi ormai consolidata» (p. 124). 357 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 11/2020
pubblici paiono cioè ancora affidate a vecchi registri scrittori 26. Inoltre, dopo il web i testi informativi sono cresciuti a dismisura - anche a causa della comparsa di nuovi spazi informativi da riempire -, se possibile opacizzando ulteriormente per quantità i contenuti di fonte pubblica27. A ciò si aggiunga che occorrerebbe pure differenziare i nuovi registri linguistici a seconda dei canali digitali utilizzati. Anche se gli obblighi informativi di legge riguardano le pubblicazioni sui soli siti web, i più diffusi social media (facebook, twitter, instagram, youtube) sono già da tempo utilizzati dalle amministrazioni, benché in modo del tutto disomogeneo28. Non stupisce, infatti, che siano state proprio queste più recenti applicazioni a incidere maggiormente e negativamente sui primi modelli di comunicazione istituzionale, contribuendo - insieme a tutta una serie di fattori concomitanti – a ridurre queste pratiche a una replica delle attività degli uffici stampa, contrariamente a quanto previsto dalla legge, affidate in modo diffuso e occasionale a tutti gli uffici29. Una frammentazione che di fatto avrebbe così marginalizzato e reso opache le finalità normative di trasparenza e inclusione, sostituendo la comunicazione dell'ente pubblico, che costruisce relazioni con la cittadinanza, con una comunicazione politica propagandistica gestita dal vertice dell'ente30. 26 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Scuola superiore della pubblica amministrazione, Report di ricerca “Gli stili della comunicazione istituzionale”, aprile 2004, pp. 247 ss. 27 Sul fenomeno della “opacità per confusione”, v. Corte cost. n. 20/2019 relativa al bilanciamento fra trasparenza amministrativa e riservatezza dei dati personali. Tra le pieghe della decisione, la Corte ha evidenziato un profilo sinora trascurato: l'eccesso di dati sui canali digitali può risultare limitante per l'esercizio di alcuni diritti riconosciuti (alla conoscibilità dei dati pubblici, alla partecipazione ai processi decisori, al riutilizzo del dato pubblico anche per finalità economiche ecc.). Per un commento generale, v. A. CORRADO, Gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti, in questa Rivista, n. 5/2019; O. POLLICINO - F. RESTA, Visibilità del potere, riservatezza individuale e tecnologia digitale. Il bilanciamento delineato dalla Corte. Nota a sent. C. Cost. 21 febbraio 2019 n. 20, in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica, n. 1/2019, pp. 110 ss. 28 Per la scrittura delle amministrazioni sui social media, v. FORMEZ (a cura di), Vademecum Pubblica Amministrazione e social media, 2011, su cui si legge testualmente: «Sul sito web dell’Amministrazione il cittadino deve recarsi volontariamente e, per farlo, deve essere spinto dal bisogno di cercare qualcosa. Nei social network il cittadino è presente quasi tutti i giorni, per cui è proprio lì che il bisogno va creato e comunicato. Ciò naturalmente non implica la possibilità di trascurare il sito web istituzionale, che, anzi, acquisisce un ruolo centrale nel momento in cui diviene il punto di riferimento verso il quale indirizzare gli utenti per le informazioni ufficiali. Tuttavia presidiare i social network implica acquisirne il linguaggio, che deve essere adeguato al contesto e specifico per lo strumento, garantire tempi di risposta sufficientemente rapidi, definire internamente i livelli di responsabilità necessari per parlare in nome e per conto del proprio Ente». Preme però sottolineare qui ancora una volta che le pagine social e i siti web istituzionali sono due oggetti molto diversi nel nostro sistema giuridico - come chiaramente emerge anche da queste poche righe -, ma lo sono sotto il profilo giuridico, prima che tecnico. 29 F. FACCIOLI, Comunicazione pubblica e media digitali: la prospettiva del public engagement, in Problemi dell'informazione, n. 1/2016, pp. 13 ss., secondo cui le nuove piattaforme digitali hanno travolto il «processo di cambiamento e di apertura verso l'esterno di istituzioni che per anni erano state immobili, lontane e chiuse in sé stesse» (p. 15). 30 Ibidem. 358 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 11/2020
3.1. In particolare, atti giuridici e testi comunicativi pubblicati online In questo quadro poliedrico, nel quale - come detto - iniziano prepotentemente a farsi spazio le immagini, scavalcando i testi comunicativi prima ancora che essi abbiano potuto esprimere gli effetti positivi attesi, occorre allora ripartire proprio dai tipi testuali che a norma di legge compaiono (devono comparire) sul sito web pubblico. Esemplificativamente, questi testi possono essere distinti in due categorie di carattere più generale. Alla prima possono essere ricondotti gli atti tipici, cioè testi ai quali il sistema giuridico assegna anche una struttura formalizzata (procedimento di formazione vincolato, denominazione, partizione interna ecc.), pure se tra loro davvero molto eterogenei: atti giuridici in senso proprio e stretto o atti tipici (leggi, provvedimenti amministrativi, sentenze ecc.). La seconda classe è residuale e raccoglie invece propri i testi che a vario titolo compaiono sulle pagine web per accompagnare gli atti (glosse, sintesi ufficiali ecc.) o per informare sulle attività dell'ente. Appartengono a questa seconda categoria testi scritti, pensati e formati per essere pubblicati sulle pagine web31. Come già ricordato, della scrittura degli atti molto ci si è occupati, a livello scientifico e istituzionale, e non è questa la sede per ripercorre il lungo e ancora difficoltoso percorso della qualità formale della regolazione32. Questi atti, se viziati da oscurità originaria, restano ostili alla collettività anche se pubblicati negli archivi online dei soggetti che li producono o detengono. Benché – ad avviso di chi scrive – gli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali potrebbero avere un qualche effetto positivo di lungo periodo, sottoponendo gli atti stessi ad un controllo diffuso che potrebbe indurre i nostri decisori a produrre meno diritto e di migliore qualità. Nel caso degli atti già formati, la trasparenza è intesa quindi come apertura dei dataset del patrimonio informativo pubblico, senza però alcuna garanzia in ordine all'accessibilità effettiva al contenuto dei dati liberati. Anche di questo percorso, lungo e impervio, non si può dar conto in questa sede33. 31 Nel 2015 il Consiglio di Stato si è espresso a proposito del valore giuridico di un testo comunicativo diffuso attraverso un social network, precisando che esso va tenuto distinto dall'atto in ragione dell'assenza di tipicità dell'atto prodotto dall'amministrazione e del legittimo affidamento del cittadino nella cui sfera giuridica si producono gli effetti dell'attività amministrativa. Seconda questa pronuncia dal giudice amministrativo, le attività comunicative dovrebbero restare distinte dalla funzione amministrativa vera e propria, come assicurato dal principio di tipicità degli atti. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 febbraio 2015, n. 769, su cui v. G. SGUEO, La comunicazione di un Ministro attraverso un social network integra gli estremi di un atto amministrativo?, in Giornale di diritto amministrativo, n. 4/2015, pp. 523 ss. 32 Impossibile dar conto qui dei numerosi lavori sulla qualità della regolazione. Una bibliografia esaustiva è online sul sito Tecniche normative (a cura di P. COSTANZO). Tra i molti, v. G. U. RESCIGNO, Tecnica legislativa, voce, in Enciclopedia giuridica, vol. XXX, Roma, 1993; ID., Dal rapporto di Giannini alla proposta di manuale unificato per la redazione di testi normativi, adottata dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, in Informatica e diritto, n. 1/1993, pp. 1 ss.; R. PAGANO, Introduzione alla legistica: l'arte di preparare le leggi, Milano, 2004; P. COSTANZO, La qualità della normazione nella dialettica Governo-Parlamento. Strumenti e tecniche della XVI legislatura, n. spec. della Rassegna parlamentare, Napoli, 2011. 33 Per avvicinarsi agli sviluppi più recenti dell'apertura online dei dataset pubblici, occorre certamente conoscere i primi scritti d'avanguardia, tra cui, E. LAPORTA. - R. BORRUSO - A. FALCONE - V. NOVELLI, Sistema di ricerca elettronica della giurisprudenza. Descrizione ed esperimenti, Roma, 1969; e, a seguire, almeno R. BORRUSO, Civiltà del computer. La ricerca automatica delle informazioni e dei giudizi, Milano, 1978; R. BORRUSO - C. TIBERI, L'informatica per il giurista, Milano 1990; fino a AA.VV., Progetto NIR - Accesso alle Norme in Rete, 2 voll, Napoli, 2000-2001. Sul tema della conoscibilità delle fonti dopo Internet, G. TRIVISONNO, Prime note sul problema della conoscibilità del diritto e sulle nuove prospettive offerte dall'informatica 359 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 11/2020
Sono, invece, qui d'interesse i testi del secondo tipo, comunque riferibili all'ambito del diritto sotto il profilo oggettivo, avendo ad oggetto la conoscenza di norme o attività istituzionali, o soggettivo, essendo imputabili a soggetti pubblici. Benché non tipizzati e privi di un effetto giuridico diretto, è esattamente ad essi che si affida oggi in modo prevalente la collettività, alla ricerca di informazioni rese mediante un linguaggio preciso e chiaro, oltre che agevolmente raggiungibili via web34. Come detto, questa nuova varietà di linguaggio istituzionale però stenta a farsi strada, affidandosi troppo spesso le amministrazioni a vecchi registri stilistici che sconfinano - anche online - nello stereotipo del burocratese, e che scavano così un solco ulteriore tra governanti e governati, nonostante tutte le ricordate norme e i principi sulla trasparenza. Ciò conferma che la questione ha radici antiche di ordine culturale e non può certo trovare risposte in vincoli di legge. Tuttavia, pare comunque opportuno, e forse necessario, esaminare le fonti, alla ricerca di regole più stringenti che possano comunque presidiare questa potente attività scrittoria, capace forse – come annotato in premessa - di prevenire parte delle distorsioni informative di derivazione pubblica. 4. Regole e prassi sulla scrittura giuridico-istituzionale “per” il web Tracciato il perimetro giuridico generale entro cui si colloca l'attività di composizione e redazione dei testi informativi pubblicati online dalle amministrazioni pubbliche, proviamo ora a rintracciare eventuali regole specifiche sulla loro qualità scrittoria. Nonostante qualche indicazione sulla comprensibilità dei contenuti pubblicati online dalle amministrazioni sia presente in alcune disposizioni recenti, di cui ora di dirà, senza dubbio la sola e unica prescrizione normativa espressa sulla “chiarezza del linguaggio” da utilizzare sui siti web pubblici resta quella contenuta nell'articolo 53 del già ricordato d.lgs. n. 82/2005: «1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità»35. A partire dal 2005, dunque, la chiarezza del linguaggio può essere considerata “per legge” requisito comune e unificante dei diversi testi prodotti dalle nostre istituzioni, dagli atti normativi ai provvedimenti giuridica, in Informatica e diritto, n. 1/1976, pp. 113 ss.; P. COSTANZO, La pubblicazione normativa al tempo di internet, in AA.VV., Le fonti del diritto, oggi. Giornate di studio in onore di Alessandro Pizzorusso, Pisa, 2006, pp. 203 ss.; volendo v. M. PIETRANGELO, La conoscibilità della legge per via informatica e telematica, in Informatica e diritto, 2, 2006, pp. 245 ss. 34 Su una trasparenza amministrativa “totale”, per cui gli istituti della comunicazione pubblica e della pubblicità legale appaiono molto ravvicinati, v. P. MARSOCCI, Gli obblighi di diffusione delle informazioni e il d.lgs. 33/2013 nell'interpretazione del modello costituzionale di amministrazione, in Istituzioni del federalismo, nn. 3-4/2013, pp. 38 ss.; E. CARLONI, La “casa di vetro” e le riforme. Modelli e paradossi della trasparenza amministrativa, in Diritto pubblico, n. 3/2009, pp. 779 ss.; ID., La trasparenza (totale) delle pubbliche amministrazioni come servizio, in Munus, n. 1/2012, pp. 179 ss. 35 Cfr. d. lgs. n. 82/2005, art. 53 (Caratteristiche dei siti). 360 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 11/2020
amministrativi fino ai testi destinati ai siti web. Una linea già presente sottotraccia in una direttiva PCM del 2002 sull'attività di comunicazione delle amministrazioni, che per l'appunto indicava la chiarezza dei testi comunicativi come requisito trasversale di qualunque tipo testuale redatto dalle amministrazioni, contro un burocratese sempre pervasivo36; e più ancora nella successiva direttiva PCM del 2005 sul linguaggio dei testi amministrativi, che assumeva come valide per la scrittura sulle pagine web tutte le indicazioni generali già formulate in merito alla leggibilità e alla comprensibilità degli atti amministrativi37. Come anticipato, qualche ulteriore indicazione sulla comprensibilità delle informazioni di fonte pubblica si rintraccia anche in norme più recenti, le quali tuttavia non pare abbiano aggiunto molto alla più esplicita prescrizione contenuta nel Codice del 2005. Il d.lgs. n. 33/2013 effettivamente si è preoccupato di garantire la qualità delle informazioni pubblicate online sotto il profilo della comprensibilità, disponendo all'art. 6 che ne siano assicurate «l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità», oltre che - per il caso della pubblicazione di atti e provvedimenti - «la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità». Lo stesso decreto ha previsto, inoltre, un'attività “interna” di controllo del rispetto degli obblighi informativi, affidata al responsabile della trasparenza, che deve monitorare periodicamente i dati pubblicati per verificare anche «la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate»38. La normativa del 2013 in sostanza non ha fatto che ribadire o confermare la prescrizione generale del 2005 su chiarezza e comprensibilità delle informazioni liberate sui siti web, senza tuttavia un riferimento puntuale anche al profilo linguistico. Sulla comprensibilità è tornato nel 2018 anche il d.lgs. n. 106, attuativo della direttiva (UE) 2016/2102 sull'accessibilità dei siti web, che ha ridefinito i «principi generali sull'accessibilità» e previsto - se possibile – il requisito della comprensibilità anche per le applicazioni: i siti web devono essere «percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi»39. Un lessico di derivazione eurounionale, che parrebbe mostrare almeno - e solo - nella ratio una qualche attenzione per il profilo della comprensibilità nell'ambito della più generale garanzia di accesso tecnico ai dati pubblicati online.40 Lo stesso decreto n. 106 ha prescritto, inoltre, che 36 Dir. PCM 7 febbraio 2002 sull'attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Nella premessa della direttiva si legge: «L'opinione pubblica, ma anche le amministrazioni, si aspettano ulteriori sforzi per combattere e rendere il cosiddetto “burocratese” più chiaro ed accessibile e la comunicazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione più snella ed efficace». 37 Dir. PCM 24 ottobre 2005 sulla semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni, p. 5. V. anche la precedente dir. PCM 8 maggio 2002 sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi. 38 Cfr. art. 43, d.lgs. n. 33/2013. 39 Cfr. il comma 4 dell'art.1, d.lgs. n. 106/2018, che introduce l'art. 3-bis nella legge n. 4/2004. 40 Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Il considerando n. 36 della direttiva precisa: «Le prescrizioni in materia 361 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 11/2020
i servizi online soddisfino i requisiti necessari della «accessibilità del contenuto» e della «fruibilità delle informazioni offerte»41,, declinata come «facilità e semplicità d'uso» o «soddisfazione nell'uso da parte del destinatario» del servizio. Concetti non nuovi, piuttosto vaghi, di cui tuttavia - come detto - si può apprezzare la ratio. Ciò che però occorre senz'altro denunciare è il limite dell'intero impianto normativo del decreto del 2018, che condiziona l'attuazione delle disposizioni citate, e dunque il rispetto dei parametri di comprensibilità, alla garanzia che non ne derivi agli enti pubblici un onere sproporzionato42. Una clausola di salvaguardia che mostra, tra le maglie della legge, tutta la fragilità e i ritardi che connotano l'attività comunicativa, alla quale risulta di fatto ancora assegnato un ruolo marginale. Senza poi considerare che queste norme più recenti insistono specificamente sull'accessibilità tecnica (e quindi sulla trasparenza come accessibilità formale al patrimonio informativo pubblico), la quale solo in parte "si tira dietro" la comprensibilità sotto il profilo linguistico, che resta invece dirimente per la comprensione dei contenuti pubblicati online43. 5. Per concludere Se il redattore di una testata informativa o chiunque altro vorrà forzare l'informazione di fonte pubblica, plasmandola della propria opinione, avrà margini interpretativi o distorsivi minori, se i contenuti informativi di fonte pubblica saranno precisi nel lessico e il più possibile univoci. Ma tirando le fila di di accessibilità definite nella presente direttiva sono intese in modo da essere neutre sul piano delle tecnologie. Descrivono cosa occorre garantire affinché l'utente sia in grado di percepire, utilizzare, interpretare o comprendere un sito web, un'applicazione mobile e i relativi contenuti. Non è specificata la tecnologia da scegliere per un determinato sito web, informazione online o applicazione mobile. Per queste loro caratteristiche, le prescrizioni non ostacolano l'innovazione»; e il considerando 37 si limita tautologicamente a precisare che i siti web sono comprensibili nel senso che «le informazioni e il funzionamento dell'interfaccia utente devono essere comprensibili». 41 Cfr. il comma 3-bis dell'art. 1 della legge n. 4/2004, introdotto dal d.lgs. n. 106/2018. 42 Ci si limita qui a riportare il “faticoso” secondo comma dell'art. 3-ter (Individuazione dell'onere sproporzionato per l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili) della legge n. 1/2004: «2. Per onere sproporzionato si intende un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacità degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilità. Non possono costituire, di per sé, un onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed applicazioni mobili ovvero la necessità di acquisire le informazioni occorrenti per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle linee guida». 43 L'attenzione per l'accessibilità di tipo tecnico risulta già da tutta una serie di fonti attuative delle prime norme sulla pubblicazione online di contenuti di fonte pubblica, che risalgono a un decennio fa. Gli atti sono davvero numerosi, e si sono sovrapposti nel tempo. Tra gli altri, cfr. la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 26 novembre 2009, n. 8, Disposizioni in materia di riconoscibilità, aggiornamento, usabilità, accessibilità e registrazione al dominio ".gov.it" dei siti web delle P.A.; la delibera CIVIT n. 105/2010, Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che ha fissato, tra l’altro, il contenuto minimo dei dati da pubblicare sui siti istituzionali sul sito istituzionale e le modalità di pubblicazione per finalità di trasparenza; il DPCM 26 aprile 2011, Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69; la delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 88/2011 recante le Linee guida del Garante Privacy in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web. 362 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 11/2020
Puoi anche leggere