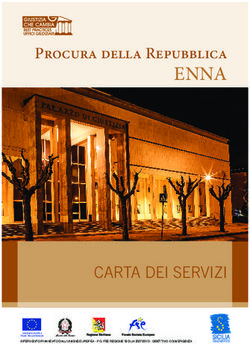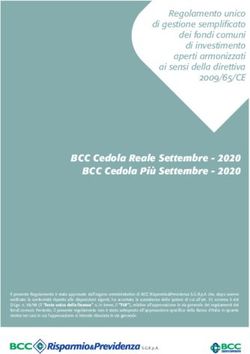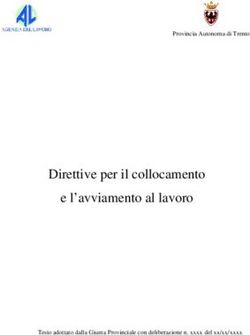Associazione Italiana di Psicologia Giuridica - AIPG
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Associazione Italiana di Psicologia Giuridica
Corso di Formazione in
Psicologia Giuridica e Psicopatologia Forense
Teoria e Tecnica della Perizia e della Consulenza Tecnica
in ambito Civile e Penale, adulti e minorile
“Il ruolo dello psicologo nelle S.I.T. alla luce
della Legge n. 172 del 1ottobre 2012”
Candidata
Antonella Postorino
CORSO 2020INDICE
Introduzione……………………………………………………......... 3
I. Riferimenti normativi e linee di indirizzo sulla raccolta delle
dichiarazioni/testimonianze di vittime vulnerabili 4
II. La legge 172/2012 e il principio generale di protezione dei
diritti del minore testimone o vittima di reato: il ruolo dello 8
psicologo
III. Legge 172/2012 e la scarsa definizione del ruolo degli
psicologi e della modalità operativa e procedurale nella
raccolta delle dichiarazioni 12
IV. Sussistenza dell'obbligo di avvalersi dell'esperto per ascoltare
il minore nella S.I.T. 15
V. Conclusioni 19
Bibliografia……………………………………………………………… 21
2Introduzione
La legge 1ottobre 2012, n. 172, che ratifica la della Convenzione di Lanzarote, è ispirata ad un
principio generale di protezione dei diritti del minore, sia nel ruolo di vittima che di testimone, e
introduce gli artt. 351, comma 1-ter, e 362, comma 1-bis, codice di procedura penale. Tali disposizioni
prevedono, fin dalla fase delle indagini preliminari, l’ausilio di un esperto in psicologia o in
psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero, durante l’assunzione di sommarie informazioni
testimoniali (S.I.T.) del minore nei procedimenti per reati di natura sessuale e riguardanti la tratta e
lo sfruttamento.
La legge 172/2012 rappresenta quindi un traguardo diretto a rinforzare le azioni di prevenzione
e contrasto dei reati di abuso e sfruttamento infantile e adolescenziale, e allo stesso tempo aumenta
le garanzie a tutela delle vittime e dei testimoni minorenni.
Un “buon ascolto” deve infatti poter garantire la protezione psicologica necessaria al
bambino/adolescente (valenza “clinica”) e, parallelamente, rispondere all’esigenza investigativa di
acquisire delle fonti di prova utili alla ricostruzione del fatto e all’eventuale individuazione del
colpevole (valenza “criminologica”).
Ma di fronte a questo nuovo quadro normativo rimangono poco definiti il ruolo dello psicologo
nominato dal pubblico ministero, la modalità operativa, procedurale nella raccolta delle dichiarazioni
e l’obbligatorietà della presenza dell’esperto in sede di audizione di minori coinvolti in procedimenti
per reati a sfondo sessuale.
Tale lavoro, pertanto, si propone di tracciare un percorso che, dai riferimenti normativi internazionali
alla Legge 172/2012, dalla giurisprudenza alle linee guida e alla pratica professionale, conduca a
prendere consapevolezza del ruolo che assume lo psicologo, nominato dall’autorità giudiziaria per
l’ascolto della persona minorenne in fase d’indagine preliminare.
3I. Riferimenti normativi e linee di indirizzo sulla raccolta delle
dichiarazioni/testimonianza di vittime vulnerabili o in condizioni di particolare
vulnerabilità
Il ruolo dello psicologo nella raccolta delle dichiarazioni delle “vittime vulnerabili”
nell’ambito dei procedimenti penali, soprattutto in riferimento ad alcune tipologie di reato, negli
ultimi anni è stato sancito su indicazioni di linee di indirizzo internazionali e nuove leggi nazionali a
tutela di un miglioramento del sistema di protezione della vittima e a garanzia di una corretta modalità
di assunzione della testimonianza stessa in sede di S.I.T.
A livello internazionale, la protezione della vittima di un reato si fonda oggi su linee di
indirizzo e normative che definiscono il sistema di interventi erogati a livello europeo e nazionale. Si
evidenziano in tal senso le disposizioni volte a garantire1:
a) le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime dei reati
(Direttiva 2012/29/UE, che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI);
b) il reciproco riconoscimento di misure di protezione adottate a tutela delle vittime (Direttiva
2011/99/UE; Reg. 2013/606);
c) la cooperazione tra gli Stati Membri, volto a facilitare, nei casi transfrontalieri, l’accesso
delle vittime di reato a un indennizzo (Direttiva 2004/80/CE).
A questo hanno contribuito anche:
- la convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l’11 maggio 2011 (e
ratificata dall’Italia con Legge 27 giugno 2013, n.77);
- la convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento
e gli abusi sessuali firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 (e ratificata dall’Italia con legge 1°
ottobre 2012, n. 172);
- la convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione nei confronti della donna, adottata dall’assemblea generale delle Nazioni
Unite il 18 dicembre 1979 (e ratificata in Italia con la legge del 14 marzo 1985, n. 132).
Rispetto allo specifico sistema di protezione da attuare nella raccolta della prova dichiarativa,
1
“Le buone prassi” Raccolta delle dichiarazioni/testimonianza di vittime vulnerabili o in condizioni di particolare
vulnerabilità, a cura di Vera Cuzzocrea e Melania Scali – Ordine Psicologi Lazio, 2019
4ovvero nella fase di ascolto giudiziario della vittima a partire dall’acquisizione della notizia di reato
(direttamente dall’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria), erano già presenti importanti
sollecitazioni europee grazie alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini
contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale, la “Convenzione di Lanzarote”.
Nello specifico, l’art. 35 della Convenzione di Lanzarote (“colloqui con il minore”), nel
comma 1 definisce che:
1. Ciascuna parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché:
a. I colloqui con il bambino abbiano luogo senza alcun ritardo ingiustificato dopo che i fatti
siano stati segnalati alle autorità competenti;
b. I colloqui con il bambino abbiano luogo, ove opportuno, presso locali concepiti o adattati
a tale scopo;
c. I colloqui con il bambino vengano condotti da professionisti addestrati a questo scopo;
d. Nel limite del possibile e, ove opportuno, il bambino sia sempre sentito dalle stesse persone;
e. Il numero dei colloqui sia limitato al minimo strettamente necessario al corso del
procedimento penale;
f. Il bambino possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale, o, in caso, da
maggiorenne di sua scelta, salvo decisione contraria, motivata e assunta nei riguardi di tale
persona.
Il legislatore italiano, in riferimento all’art. 35 comma 1c, individua gli esperti in psicologia
o psichiatria infantile quali professionisti con le competenze necessarie a condurre il colloquio con i
minori.
Sarà infatti la legge 1 ottobre 2012, n. 172, riguardante la “Ratifica ed esecuzione della
convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso
sessuale, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento
interno” (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 8 ottobre 2012 n. 235), a stabilire quanto siano
determinanti la presenza e il ruolo di esperti in psicologia o psichiatria infantile nei colloqui S.I.T.
Il provvedimento detta alcune norme di adeguamento dell'ordinamento interno volte a
modificare il codice penale -introducendo i nuovi reati di adescamento di minorenni, anche attraverso
Internet, di istigazione e apologia di pratiche di pedofilia e di pedopornografia - e il codice di
procedura penale, introducendo la figura dell’esperto in psicologia/psichiatria infantile in ausilio della
polizia giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni delle persone minorenni vittime di abuso e
5sfruttamento sessuale.
In particolare, le lettere c), d) ed f) dell’articolo 5 della legge 172/2012 modificano gli articoli
351, 362 e 391-bis del codice di procedura penale, in tema di informazioni assunte nel corso delle
indagini preliminari rispettivamente dalla polizia giudiziaria, dal pm e dal difensore.
Le novelle inseriscono nelle tre disposizioni del codice di rito un ulteriore comma volto a
prevedere che nei procedimenti per delitti di sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1 e 600-quinquies), di tratta di persone (artt. 600, 601 e 602), di violenza
sessuale (artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies) e di adescamento di minori (art. 609-
undecies), la polizia giudiziaria o il pubblico ministero o il difensore, se devono assumere
informazioni da minorenni, si avvalgano dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria
infantile.
La direttiva 29/2012 mira ad ampliare le strategie di protezione ponendo al centro la
vulnerabilità delle vittime, le condizioni in cui possano trovarsi e quindi estendendo la prospettiva di
analisi e considerazione dei diversi scenari di problematicità presenti, nella vittima e nel sistema di
appartenenza, prima dell’ingresso nell’iter giudiziario e durante la sua permanenza.
Con il decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212 si dà attuazione alla già citata direttiva
2012/29/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Le integrazioni normative
modificano le disposizioni dell’articolo 351 c.p.p. (e dell’art. 362 c.p.p.) estendendo le modalità
protette nell’assunzione delle sommarie informazioni con l’ausilio di un professionista dalla persona
minorenne a quella maggiorenne “in condizione di particolare vulnerabilità”; infatti, nel testo vigente
si legge: «Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies
e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da
persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato
dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da
una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso
assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie
informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte
a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini».
Un altro aspetto innovativo, introdotto dal legislatore con il D.lgs n. 212/2015, è la definizione
di “particolare vulnerabilità della persona offesa” «[…] desunta, oltre che dall'età e dallo stato di
6infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si
procede» e precisando anche che, a tale fine: «[…] si tiene conto se il fatto risulta commesso con
violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o
di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di
discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente
dipendente dall'autore del reato» (articolo 90-quater c.p.p.).
La maggiore attenzione del legislatore, rispetto alle vittime dei reati di violenza di genere,
nasce dalla ratifica della Convenzione di Istanbul con la legge n. 77/2013. Bisogna attendere la legge
69/2019, denominata “codice rosso”, per un percorso prioritario per la trattazione dei procedimenti
in materia di violenza di genere, che rende più efficace la tutela delle vittime. La principale e più nota
innovazione in ambito procedurale, infatti, è rappresentata dalla previsione che siano attivate le
iniziative a tutela della vittima entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato. Ciò significa che
la polizia giudiziaria deve riferire immediatamente, anche in forma orale, la notizia di reato al
pubblico ministero, che avrà un termine di 3 giorni dall’iscrizione della stessa per assumere
informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (S.I.T.).
Nasce così l’esigenza delle procure della Repubblica della disponibilità di un elenco di
psicologi appositamente formati nell’ascolto dei minori e delle vittime vulnerabili, anche se
maggiorenni, da utilizzare per la nomina prevista ex art. 351 c.1 ter c.p.p. ovvero ex art. 362 co. 1bis
c.p.p., prontamente reperibili nei casi di urgenza.
Ma di fronte a questo nuovo quadro normativo che prevede la presenza dello psicologo in
ausilio alla polizia giudiziaria e alla magistratura fin dalle primissime fasi dell’acquisizione della
notizia di reato, rimangono poco chiari il ruolo degli psicologi e la modalità operativa e procedurale
nella raccolta delle dichiarazioni che verranno approfonditi nei prossimi capitoli.
7II. La legge 172/2012 e il principio generale di protezione dei diritti del minore testimone
o vittima di reato: il ruolo dello psicologo
In attuazione della Convenzione di Lanzarote, nell'ottobre del 2012 il legislatore italiano ha
provveduto ad adeguare l'ordinamento interno al fine di assicurare ai minorenni, coinvolti come fonti
di prova nei procedimenti per reati a sfondo sessuale, protezione psicologica e tutela da manipolazioni
volte a compromettere l'attendibilità, prevedendo la presenza dello psicologo in ausilio alla polizia
giudiziaria e alla magistratura fin dalle primissime fasi dell’acquisizione della notizia di reato.
La legge 1° ottobre 2012, n. 172 rappresenta quindi un traguardo diretto a rinforzare le azioni
di prevenzione e contrasto dei reati di abuso e sfruttamento infantile e adolescenziale, ma anche a
garantire la tutela delle vittime e dei testimoni minorenni. Lo scopo dell’intervento legislativo, infatti,
è quello di conformare la disciplina interna del diritto penale, del processo penale e dell’ordinamento
penitenziario alle indicazioni della Convenzione di Lanzarote. Dal punto di vista del sistema
processuale penale, la ratio delle nuove norme è improntata ad un principio generale di protezione
dell’offeso: si vuole assicurare un’adeguata tutela dei diritti del minore, sia come vittima che come
testimone, garantendo a costui anche un’assistenza psicologica durante i colloqui.
La presenza di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico
ministero, durante l’assunzione di sommarie informazioni del minore, è dunque finalizzata alla
prevenzione dei rischi connessi alla “vittimizzazione secondaria”, ovvero all’ulteriore trauma che
potrebbe scaturire dalle dinamiche processuali. In altri termini, la vittima non solo subisce un danno
diretto dal reato (vittimizzazione primaria), ma anche le conseguenze che possono derivare da2:
- essere ascoltati diverse volte e da persone diverse
Ciò implica rivivere ripetutamente le esperienze, spesso traumatiche, subite dalla vittima o
dal testimone con amplificazione degli stati d’animo connessi. Inoltre, moltiplica l’esperienza
con il contesto penale di cui il soggetto spesso non comprende le regole, i ruoli, le finalità,
con conseguente sentimento di estraneazione.
- la modalità di conduzione dell’escussione della vittima e del testimone
Spesso viene messo in dubbio ciò che ha visto o vissuto, e, a seconda del tipo di reato per il
quale si sta procedendo (per esempio i reati sessuali), vengono anche indagati aspetti della
2
“Le buone prassi” Raccolta delle dichiarazioni/testimonianza di vittime vulnerabili o in condizioni di particolare
vulnerabilità, a cura di Vera Cuzzocrea e Melania Scali – Ordine Psicologi Lazio, 2019
8vita privata della vittima stessa, come, per es. quelli relativi alla sua reputazione, allo stile di
vita, fino anche alla moralità, ecc.
- incontrare il presunto autore di reati
i contesti giudiziari ancora oggi, malgrado le diverse accortezze tecniche previste anche
normativamente, non sono organizzati per assicurare una adeguata tutela della vittima (per
esempio non vi sono entrate o percorsi differenziati nelle sedi giudiziarie), se non in casi
isolati. Questo provoca conseguenze tali sulle vittime e sui testimoni che possono arrivare a
ritrattazioni di quanto affermato in precedenza, o addirittura che possono portare alla
negazione di quanto accaduto.
- la durata del procedimento penale
i tempi che intercorrono tra la denuncia, le indagini e il processo vero e proprio, senza poi
contare i diversi successivi gradi di giudizio per cui un processo può durare anni, con le
ovvie conseguenze negative per la vittima o per il testimone.
- la pubblicità delle udienze
In qualche caso il nominativo della vittima o del testimone è facilmente ricostruibile se non
addirittura reso pubblico dai media; ma non solo, spesso, la vittima o il testimone deve
riferire di particolari della propria vita davanti ad estranei con il rischio concreto che
possono, in alcuni casi, divenire di dominio pubblico.
Lo psicologo costituisce una figura di mediazione tra le parti impegnate nel processo
processuali e il soggetto debole da tutelare in quanto vittima o testimone del reato, volta ad incidere
sulla corretta formazione del contributo dichiarativo del minore e ad evitare una narrazione
inattendibile, scaturente dalla non completa comprensione delle domande formulate da parte
dell’esaminatore.3
I molteplici ascolti a cui le vittime sono sottoposte costituisce uno dei nodi problematici più
dibattuti, in ordine ai rischi di mancata tutela dei minori, legati al fatto di rivivere ripetutamente tali
esperienze traumatiche e di farlo all’interno di un contesto di indagine non “a misura di bambino” (e
quindi potenzialmente non protettivo). Oltre allo stress che chiunque, anche una persona adulta,
vivrebbe in un contesto di ascolto giudiziario, molti studi hanno dimostrato come per le vittime
3
Persona offesa e modalità di audizione protetta: verso lo statuto del testimone vulnerabile di Ada Famiglietti
In Processo penale e giustizia n. 2 | 2016
9minorenni tale stato di disagio possa aumentare in concomitanza di altri aspetti, come ad esempio la
difficoltà nel comprendere il linguaggio utilizzato o la modalità in cui viene condotto l’ascolto4.
Un “buon ascolto” deve infatti poter garantire la protezione psicologica necessaria al
bambino/adolescente (valenza “clinica”) e, parallelamente, rispondere all’esigenza investigativa di
acquisire delle fonti di prova utili alla ricostruzione del fatto e all’eventuale individuazione del
colpevole (valenza “criminologica”). La duplice finalità dell’ascolto, informazioni da raccogliere
minimizzando le possibili fonti di stress al bambino e le possibili contaminazioni nel recupero del
ricordo, impone pertanto a chi conduce il colloquio di possedere non solo delle conoscenze
approfondite in ordine alla psicologia giudiziaria, alla psicologia della testimonianza e alla psicologia
dell’età evolutiva ma anche di avere una preparazione consolidata nell’utilizzo di specifici protocolli
di intervista investigativa5. Tra questi: la Step wise interview6; l’Intervista cognitiva7, l’Intervista
strutturata8; il NICHD investigative interview protocol9. Questi protocolli si articolano in diverse fasi
orientate alla creazione di un clima di familiarizzazione funzionale a far sentire il bambino o
l’adolescente a proprio agio e anche a favorire una narrazione libera dei fatti presumibilmente
accaduti, utilizzando un linguaggio consono all’età e alle sue competenze (psicologiche, sociali e
relazionali).
È infatti necessario «neutralizzare il rischio che la prova testimoniale risulti oltreché traumatica
anche insoddisfacente per gli esiti del processo e, perciò, occorre rendere più confortevole il contesto»
in cui avviene la narrazione del fatto/reato. D’altra parte, la ratio che guida le regole da seguire durante
4
Scali-Calabrese, La conduzione dell’audizione protetta: analisi dell’interazione comunicativa tra esperto e minore
presunta vittima di abuso sessuale, Maltrattamento e abuso all’infanzia, 5, 3, 2003; Scali- Calabrese-Biscione, La tutela
del bambino o adolescente: le tecniche di ascolto, Roma, 2003; AACAP, Practice parameters for the forensic valuation,
cit. in V. Cuzzocrea, L’ascolto protetto delle persone minorenni prima e dopo la ratifica della Convenzione di
Lanzarote, in Proc. pen. giust., 2013, n. 2, p. 111.
5
V. Cuzzocrea, L’ascolto protetto delle persone minorenni prima e dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote, in
Proc. pen. giust., 2013, n. 2, p. 111
6
Yuille-Hunter-Joffe-Zaparniuk, Interviewing children in sexual abuse cases, Goodman-Bottoms, Child Victims, Child
Witnesses, New York/London, 1993; Dèttore, La conduzione dell’intervista, cit.
7
Per un approfondimento si veda Caffo-Camerini-Florit, Criteri di valutazione, cit., 269; Geiselman-Padilla, Interviewing
child witnesses with cognitive interview, Journal of Police Science and Administration, 16, 1988; Geiselman-Fisher,
Memoryenhancing techniques for investigative interviewing: The cognitive interview, Springfield, III, 1992; Goodman-
Bottomns, Child victims, child witnesses, Guilford, New York, 1993; Mestitz (a cura di), Chiedere, rispondere e
ricordare. Interviste con minorenni vittime e/o testimoni in ambito giudiziario, Roma, 2003.
8
L’intervista strutturata è una forma di intervista cognitiva utilizzata con bambini al di sotto dei sette anni. Per un
approfondimento si veda: Caffo-Camerini-Florit, Criteri di valutazione, cit.; Koehnken-Thurer-Zorberbier, The cognitive
interview: are the interviews’ memories enchanced too?, Applied cognitive psychologies, 8, 1994.
9
Si tratta di un protocollo investigativo strutturato costruito dai ricercatori del National Institute of Child Health and
Human Development (NICHD). Per un approfondimento si veda: Lamb-Orbach-Hershkowitz-Esplin-Horowitz,
Structured forensic interview protocols improve the quality and informativeness of investigative interviews with children:
A review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol, Child Abuse & Neglect, 31, 2007; Lamb-
Hershkovitz-Orbach-Esplin, Tell Me What Happened Structured Investigative Interviews of Child Victims and Witnesses,
University of Leicester (UK), 2008; Mestitz (a cura di), Chiedere, rispondere e ricordare, cit.
10l’esame testimoniale è della medesima natura: l’art. 499 («Regole per l’esame testimoniale»)
prescrive che l’esame testimoniale debba svolgersi «mediante domande su fatti specifici» (comma
1), evitando «le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte» (comma 2) vietando
quelle che «che tendono a suggerire le risposte» (comma 3) e ponendo attenzione a non «ledere il
rispetto della persona» (comma 4).10
Ne deriva quindi che la legge 172/2012 individua nello psicologo o nello psichiatra infantile
la figura competente professionalmente a condurre un “buon ascolto” giudiziario di bambini e
adolescenti, rispondendo a diverse finalità, tra cui:
a) diminuire il possibile effetto traumatico dell’attività di raccolta di dichiarazioni;
b) garantire alle persone minorenni coinvolte nei procedimenti giudiziari il diritto di essere
informate;
c) ottenere il massimo di informazioni in merito all’evento;
d) ridurre gli effetti di contaminazione dell’ascolto sul ricordo dell’evento e salvaguardare la
genuinità della testimonianza;
e) mantenere l’integrità del processo investigativo;
f) diminuire la quantità di ascolti;
g) garantire il contraddittorio (in caso di incidente probatorio).
Un colloquio ben condotto permette anche di avere una funzione psicologicamente
“trasformativa” ovvero di rendere possibile che i “vincoli” dell’impatto con la giustizia si
trasformino in occasioni di riduzione della vulnerabilità e di sviluppo di fattori protettivi come la
resiliency e l’empowerment11.
Affinché tutti questi obiettivi vengano raggiunti, è necessario che venga adottata una
metodologia scientificamente fondata e una competenza professionale specifica «centrata su
alcuni fondamentali principi teorici e metodologici che orientano la scelta degli strumenti di
indagine, le modalità operative, le finalità stesse dell’intervento».12
10
V. Cuzzocrea, L’ascolto protetto delle persone minorenni prima e dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote, in
Proc. pen. giust., 2013, n. 2, p. 111
11
De Leo, Vulnerabilità e risorse, cit., 21 ss.
12
De Leo-Patrizi, Psicologia Giuridica, cit., 104
11III. Legge 172/2012 e la poca chiarezza del ruolo degli psicologi e della modalità
operativa e procedurale nella raccolta delle dichiarazioni
Studiosi in psicologia giuridica e in criminologia hanno da tempo fissato numerose direttive
circa i ruoli e le modalità operative degli esperti13: dalla famosa Carta di Noto del 1996 (poi
aggiornata nel luglio 2002) alle linee guida S.I.N.P.I.A. (Soietà Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, del 15 febbraio 2007) e alle linee guida nazionali per l’ascolto
del minore testimone (Roma, 6 novembre 2010). Il problema è che queste “carte” non hanno
efficacia vincolante e sono spesso disattese nell’esperienza pratica14. Viene ad esempio
sovrapposto il ruolo di perito o consulente nella valutazione della idoneità a rendere testimonianza
a quello dello psicologo in sede di assunzione delle dichiarazioni15; ed ancora, viene confuso il
compito dell’esperto incaricato a svolgere attività psicoterapeutica o di sostegno psicologico al
minore abusato con il ruolo dell’esperto ausiliario del giudice in ambito penale16.
La nuova legge pertanto non chiarisce l’effettivo ruolo dell’esperto in psicologia o in
psichiatria infantile nel contesto dell’audizione del minore in sede di S.I.T. Alcuni spunti
interpretativi si possono peraltro desumere da quanto è stato osservato con riguardo ad un’analoga
previsione contenuta nell’art. 498 comma 4 c.p.p. In proposito, si è rilevato che le modalità
attraverso le quali il giudice può avvalersi dell’ausilio dell’esperto si ricollegano alla tecnica di
formulazione delle domande: il professionista “traduce” le domande del giudice in un linguaggio
comprensibile al minore17, anche allo scopo di evitare la suggestionabilità del minore stesso18. Le
funzioni dell’esperto psicologo dovrebbero comunque rimanere circoscritte al momento
dell’assunzione delle informazioni, non potendo sconfinare nella valutazione dell’attendibilità
delle dichiarazioni rese dal minore, che spetta esclusivamente al giudice19.
Interessanti sono le considerazioni critiche in riferimento al ruolo processuale da riconoscersi
13
V., per tutti, DE CATALDO NEUBURGER, L’esame del minore, in Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli
e responsabilità, a cura di de Cataldo Neuburger, Padova, 1997, p. 119 ss.
14
Capitta, A.M. (2012). Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al codice di procedura penale e
alla legge sull'ordinamento penitenziario. In DIRITTO PENALE CONTEMPORA NEO, 1-15.
15
Cass. pen., sez. III, 16 dicembre 2010, F. e altro, in C.E.D. Cass., n. 249898. Cfr. art. 12, Carta di Noto.
16
Cass. pen., sez. IV, 18 ottobre 2011, F., in C.E.D. Cass., n. 251663. Cfr. artt. 10 e 11, Carta di Noto
17
Per questo, l’esperto svolgerebbe una funzione simile a quella dell’interprete, pur non essendo qualificabile come tale:
v. CAMALDO, La testimonianza dei minori nel processo penale: nuove modalità di assunzione e criteri giurisprudenziali
di valutazione, in Ind. pen., 2000, p. 193.
18
Cass. pen., sez. II, 30 agosto 1995, in Dir. pen. proc., 1995, n. 10, p. 1144; v. anche Cass. pen., sez. III, 15 febbraio
2008, G., in C.E.D. Cass., n. 239003, ove si afferma che l’esperto indica «le modalità con cui devono essere
preferibilmente poste le domande».
19
Cfr., Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2007, Tranchida e altro, in C.E.D. Cass., n. 237539.
12all’esperto che deve presenziare all’esame del minore20. In proposito, le disposizioni affermano
semplicemente che quando occorre assumere sommarie informazioni da persone minori, ci “si avvale
dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile”, nominato dal pubblico ministero o
scelto dal difensore, senza precisare a quale titolo tale soggetto debba partecipare, quale debba essere
la sua funzione e quale contributo possa e ci si debba aspettare dallo stesso.
L’esperto diventa davvero “un personaggio in cerca d’autore o un protagonista muto della
vicenda”. Da un lato, il suo ruolo non è certo quello di riferire sulla credibilità del minore; dall’altro,
le domande al teste non devono essere necessariamente formulate da lui e la sua presenza
all’assunzione dell’atto non è affatto indispensabile. Lo psicologo potrà essere chiamato a coadiuvare
la parte nello svolgimento dell’esame, suggerendo quale approccio assumere con il minore, quali
domande evitare, quali aspetti della vicenda approfondire ecc.. Attribuendo all’esperto un tale
compito, però, lo si spinge verso una progressiva ed innegabile irrilevanza nella scena processuale.
Potrebbe capitare che i suggerimenti e le indicazioni dello psicologo facciano riferimento a prassi e
protocolli che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria già conoscono, o che il pubblico ministero
non tenga in considerazione i suggerimenti del consulente dal momento che seguire tali avvertenze
non è certo indispensabile per lo svolgimento dell’atto. Non si comprende inoltre quali siano le
possibilità e i poteri dell’esperto nel caso in cui dissenta sulle modalità di conduzione dell’ascolto di
vittime vulnerabili della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.
Abbandonare quindi l’interrogatorio, allontanandosi dall’esame e rendendosi così
inottemperante agli obblighi di nomina del magistrato, o assistere in silenzio all’esame del minore
pur condotto in maniera difforme rispetto alle sue indicazioni, per poi riferire delle sue perplessità e
delle sue critiche in sede di redazione dell’elaborato finale? Ma appare poco plausibile che colui che
proceda ad investigazioni nomini un proprio consulente tecnico non per farsi coadiuvare in tali
indagini, ma per sottoporre a valutazione la propria attività inquirente.
In alternativa il consulente, preso atto della censurabile metodologia con cui è assunta la
testimonianza, potrebbe dismettere l’incarico e non assistere, scomparendo dalla scena del processo,
ma ciò consentirebbe agli inquirenti di continuare a procedere secondo le modalità da loro scelte.
Tale ipotesi, quindi, andrebbe ad avvalorare la tesi che la sua presenza sia irrilevante all’assunzione
dell’atto.
E se comunque il suo compito fosse quello di riferire, a mezzo di un suo elaborato, sulle
20
Santoriello C., La presenza dell’esperto nell’esame testimoniale del minore: dalla Convenzione di Lanzarote alla
confusione del legislatore italiano, in Arch. pen., rivista on-line, 2013, n. 2.
13modalità con cui l’audizione del minore è stata condotta, evidenziando in particolare se nell’esame
testimoniale sono state poste domande suggestive, se il ragazzo è stato influenzato nell’elaborazione
delle proprie affermazioni ecc.. non sarebbe necessario la sua partecipazione all’esame, né tanto meno
prevederne come obbligatoria la presenza, ma sarebbe sufficiente che questo consulente possa
verificare ciò anche in un momento successivo tramite videoregistrazione.
A proposito di videoregistrazione, nella sentenza di Cassazione penale sez. IV - 12/03/2013,
n. 16981, la Corte osserva che ad essere davvero cruciale in sede di audizione di minori coinvolti in
procedimenti per reati a sfondo sessuale non è la presenza di un esperto, ma piuttosto, stando alla
stessa normativa sovranazionale, l'impiego di affidabili tecniche di documentazione, come la
videoregistrazione. La Corte, infatti, sottolinea che, piuttosto, ad essere centrale in questa prospettiva
sia la tecnica di documentazione impiegata, che dovrebbe essere la videoregistrazione, cui si assegna
espressamente rilievo sia nelle linee guida degli specialisti, ad esempio, la Carta di Noto, sia nella
stessa Convenzione di Lanzarote. Si tratta di una considerazione condivisibile, lato sensu, ma che
non si vede come possa depotenziare la portata delle altre garanzie che il legislatore si è premurato
di introdurre con la l. n. 172 del 2012.21
Tale questione si collega alla sussistenza dell’obbligo di avvalersi dell’esperto psicologo o
psichiatra in sede di audizione di minori coinvolti in procedimenti per reati a sfondo sessuale, trattato
nel successivo capito.
21
Nota a: Cassazione penale , 12 marzo 2013, n.16981, sez. IV di Claudia Cesari, Sull'audizione dei minori, le novità
legislative vengono tradite dalla suprema corte, in Cassazione Penale, fasc.4, 2014, pag. 1178
14IV. Sussistenza dell'obbligo di avvalersi dell'esperto per ascoltare il minore nella S.I.T.
Secondo la legge 172/2012, art.351, comma 1-ter C.p.p.: “Nei procedimenti per i delitti
previsti dagli art.572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater 1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-
quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria,
quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto
in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero”.
Il dato normativo ha un assetto apparentemente nitido: la clausola afferma perentoriamente
che il contatto a fini informativi con un minorenne che abbia subito o sia stato testimone di una serie
di fatti violenti e scabrosi deve avvenire con la partecipazione di un soggetto professionalmente
qualificato, ragionevolmente a presidio sia dell'equilibrio psicofisico del minore coinvolto in vicende
tanto gravose, sia della genuinità del suo apporto conoscitivo, che gestioni maldestre potrebbero
ineluttabilmente compromettere, vista la fragilità della fonte22.
Nonostante la formulazione letterale deponga per l’obbligatorietà, in considerazione
dell’indicativo «si avvale», è stata ridotta la portata applicativa dell’art. 362, comma 1-bis, c.p.p.
Così la presenza dell’esperto, nell’audizione del minore effettuata dal pubblico ministero, è
stata ritenuta meramente facoltativa, a causa della mancata sanzione di inutilizzabilità del relativo
materiale probatorio dalla sentenza di Cassazione penale sez. IV - 12/03/2013, n. 1698123:
[..]Va considerato che la previsione normativa non introduce alcun obbligo di
escussione del minore alla presenza dell'esperto sanzionato, per il caso di
inosservanza, a pena di inutilizzabilità.
Tale sanzione, infatti, non è stata espressamente prevista. La presenza
dell'esperto è piuttosto cautela, rimessa alla valutazione del pubblico ministero,
ai fini del giudizio di attendibilità e genuinità della deposizione del minore. Solo
per completezza, va piuttosto evidenziato che l'indicazione che viene dalle
diverse Carte internazionali che sono intervenute in materia (Carta di Noto e
Convenzione di Lanzarote) è non tanto quella di garantire la presenza
dell'esperto, quanto quella di procedere alla videoregistrazione dell'esame, che,
di norma, è necessaria e sufficiente per soddisfare le esigenze di riscontro
22
nota di C. CESARI, Sull’audizione dei minori, le novità legislative vengono tradite dalla Suprema Corte in Banca
Dati DeJure
23
Cass., sez. IV, 12 aprile 2013, n. 16981 in Banca Dati DeJure
15dell'attendibilità e genuinità della deposizione. In questa prospettiva, allora, alla
individuazione della nomina dell'esperto in psicologia o psichiatria infantile, per
consentire una duttilità nell'agire della polizia giudiziaria e dello stesso pubblico
ministero, si potrà procedere solo nei casi in cui tale nomina risultasse, a seguito
di apprezzamento congiunto della polizia giudiziaria e del pubblico ministero,
realmente necessaria, rappresentando un quid pluris in punto di attendibilità.
Apprezzamento discrezionale consentito dal fatto che l'istituto, come detto, non
è accompagnato dalla previsione di eventuali sanzioni in caso di mancanza della
nomina, vertendosi in una materia in cui ciò che conta è acquisire una
dichiarazione genuina e successivamente verificabile nel contraddittorio.
La questione qui, comunque, neppure si pone trattandosi di procedimento in cui
motivatamente (e la Corte di cassazione nella sentenza che già è stata pronunciata
nella vicenda ha già condiviso tale impostazione) il minore non è stata escusso
per evitarne pregiudizi di ordine psichico. Nè, va soggiunto, la mancata
escussione della vittima rappresenta alcuna lesione dei principi di difesa (in
primo luogo, quelli espressi dall'art. 6 della CEDU), come anche di recente
affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 19 febbraio 2013,
resa nel caso Gani c. Spagna - n. 61800/08), allorquando siano adottate misure
alternative al fine di garantire i diritti della difesa, tra cui, qui, la valutazione
approfondita da parte del giudice degli (altri) elementi probatori acquisiti
(circostanza già apprezzata dalla citata sentenza della 3 Sezione). […]
La Cassazione, nel suo primo intervento interpretativo sulla nuova disposizione, ha quindi
giustificato la tesi della discrezionalità di polizia giudiziaria e pubblico ministero, sulla base della
semplice considerazione secondo cui la sanzione non è prevista e le convenzioni internazionali in
materia pongono la loro attenzione non tanto sulla presenza dello psicologo, quanto sulla
videoregistrazione. Sostiene inoltre che il minore non è stato ascoltato “per evitarne pregiudizi di
ordine psichico”, venendo mano alla ratio stessa della legge improntata ad un principio generale di
protezione dell’offeso che garantisce al minore anche un’assistenza psicologica durante i colloqui che
si svolgono qualora venga chiamato a rendere dichiarazioni
16Un più approfondito pronunciamento giurisprudenziale, invece, è orientato a ritenere
obbligatoria la presenza dell’esperto, sebbene la sua violazione non comporti un’invalidità, ma sia
sanzionabile solamente ex art. 124.
[…]Merita solo segnalare che la inosservanza della disposizione di cui all'art.
351 c.p.p., comma 1 ter, (disposizione introdotta dall'art. 5, comma 1, lett. c)
della L. 1 ottobre 2013, n. 172, secondo cui nei procedimenti per i delitti indicati
nella lista del richiamato comma 1 ter, tra cui è compreso quello di cui all'art.
600 bis c.p., la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni
da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in
psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero) non produce alcuna
nullità delle dichiarazioni assunte in violazione della richiamata disposizione,
non essendo la nullità espressamente prevista dalla legge, ma con la necessaria
sottolineatura - a dimostrazione dell'importanza che un tale adempimento riveste
nell'economia delle dichiarazioni rese nel procedimento da persone minorenni -
che l'inosservanza, da un lato, può assumere rilevanza ai fini di una
responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 124 c.p.p.,
(disposizione espressamente applicabile anche agli ufficiali ed agli agenti di
polizia giudiziaria) e, dall'altro, determinare negative ricadute in tema di
valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni assunte senza le precauzioni
richieste dalla norma.[…]
Quest’ultima sentenza, quindi, presenta l'indiscutibile merito di riconoscere il carattere
vincolante delle disposizioni che prevedono la nomina di uno psicologo o psichiatra infantile da parte
di polizia giudiziaria e pubblico ministero, spostando perciò l'attenzione sul tipo di conseguenze
ricollegate ad un'eventuale trasgressione, ma nega comunque la sussistenza di una nullità, in ragione
del fatto che il legislatore non l'ha espressamente prevista.
Apparentemente, quindi, si assiste a un passo avanti rispetto alla sussistenza dell'obbligo di
avvalersi dell'esperto ma indica espressamente che l'assenza dell'esperto nella conduzione di
sommarie informazioni di polizia da minorenni nei procedimenti “sensibili” non ha conseguenze
17processuali poiché una verbalizzazione effettuata con modalità meno rigorose lascerebbe intatta la
validità dell'atto di indagine.24
L'art. 391-bis, comma 6, c.p.p., invece, colpisce con l'inutilizzabilità le dichiarazioni assunte
dai difensori in violazione delle disposizioni di cui ai commi che lo precedono, fra cui appunto quello
che impone la presenza dell'esperto. Nella ricostruzione disegnata dalla Corte, dunque, quando
assumano sommarie informazioni da minori nei procedimenti indicati dalla legge, gli inquirenti
possono non avvalersi dell'esperto senza ripercussioni, mentre i difensori debbono farlo a pena di
inutilizzabilità. Per gli uni, insomma, è facoltativo un adempimento che per gli altri è obbligatorio,
con una disparità di trattamento evidente e ingiustificabile25
24
Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 2013, n. 3651, in Cass. pen., 2014, p. 2976 e ss., con nota di N. PASCUCCI, La
Cassazione ci ripensa è obbligatorio l'ausilio dell'esperto in psicologia o psichiatria infantile per sentire la “persona
informata” in Banca Dati DeJure
25
nota di C. CESARI, Sull’audizione dei minori, le novità legislative vengono tradite dalla Suprema Corte in Banca
Dati DeJure
18V. Conclusioni
In attuazione della Convenzione di Lanzarote, finalmente nell'ottobre del 2012 il legislatore
italiano ha provveduto ad adeguare parzialmente l'ordinamento interno con nuovi strumenti e
metodologie volti ad assicurare protezione psicologica e tutela da manipolazioni idonee a
corromperne l'attendibilità ai minorenni coinvolti come vittime o come testimoni nei procedimenti
per reati a sfondo sessuale.
Purtroppo, la normativa 172/2012 non lo ha fatto completamente e soprattutto non lo ha fatto con
sufficiente determinazione, utilizzando soltanto l'input proveniente dalla normazione internazionale
per uno sforzo di modernizzazione del sistema su un tema delicato e attuale come l'assunzione di
informazioni da minorenni coinvolti come vittime o testimoni in vicende di violenza, sfruttamento o
abuso, soprattutto a sfondo sessuale.26
L’analisi approfondita della normativa a tutela dei minori vittime o testimoni di reati in sede di S.I.T.,
infatti, fa emergere la mancanza di riferimenti e limiti operativi della norma, che se da un lato
chiarisce l’intento di protezione del soggetto debole, dall’altro non fornisce gli strumenti operativi
alle parti in causa per poter efficacemente proteggere il minore. Una lacuna che di fatto rende persino
superflua la ratio del provvedimento, ovvero la presenza di un esperto psicologo o di uno psichiatra
infantile durante l’ascolto del minore.
Le prescrizioni contenute nell’art. 35 della Convenzione di Lanzarote sono ovviamente
vincolanti per gli Stati aderenti ed il legislatore italiano, nelle norme di adeguamento alla medesima
convenzione, avrebbe dovuto inserire qualche disposizione in più con riguardo alle modalità di
colloquio con il minore. Data l’importanza del ruolo assunto dall’esperto, occorre che vi siano regole
precise per lo svolgimento del colloquio con il minore. Sarebbe sufficiente riprodurre, negli artt.
351, 362 e 391-bis c.p.p. appena novellati, con i dovuti adattamenti, il testo dell’art. 398 comma 5-
bis, primo, secondo e terzo periodo, c.p.p., relativo all’incidente probatorio, che consente al giudice
di stabilire luogo, tempo e modalità particolari dell’audizione, anche avvalendosi di strutture
specializzate di assistenza, e che, inoltre, prescrive l’obbligo di documentazione delle dichiarazioni
con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, come indica fra l’altro l’art. 4 della Carta di
Noto.
È necessario inoltre garantire effettivamente la tutela dei minori prevedendo
26
Capitta, A.M. (2012). Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al codice di procedura penale e
alla legge sull'ordinamento penitenziario. DIRITTO PENALE CONTEMPORA NEO, 1-15
19l’obbligatorietà della presenza dello psicologo nell’escussione della vittima/testimone vulnerabile
durante le S.I.T. L’unico modo è prevedere che in assenza dell'esperto le audizioni unilaterali per
reati di natura sessuale nei confronti di persona informata minorenne, condotte da polizia giudiziaria
e pubblico ministero, devono essere considerate inutilizzabili. Non si può conferire agli organi
inquirenti un potere meramente discrezionale, del quale far uso solo quando ne avvertano la necessità.
Così come previsto dall'art. 391-bis, comma 6, c.p.p., che invece, colpisce con l'inutilizzabilità le
dichiarazioni assunte dai difensori in violazione delle disposizioni di cui ai commi che lo precedono,
fra cui appunto quello che impone la presenza dell'esperto. Nella trama normativa introdotta dalla l.
n. 172 del 2012, nell'intento di assicurare una metodologia omogenea di approccio alle dichiarazioni
rese dal minore in corso di indagine, l'assetto degli artt. 351, comma 1-ter, 362, comma 1-bis, e 391-
bis, comma 5-bis, c.p.p., è stato disegnato come un sistema unitario: per garantire che tali
dichiarazioni vengano sempre raccolte con la mediazione di un professionista qualificato.
Senza un perimetro d’azione chiaro e definito che preveda sanzioni per chi viola la normativa, il
rischio è quello di restare agganciati alla sensibilità e alle scelte soggettive dell’autorità giudiziaria.
Senza un atto di coraggio da parte del legislatore che imponga severe sanzioni per il mancato utilizzo
del professionista psicologo, che prevedano anche l’eventuale nullità della S.I.T., il sistema
difficilmente si sgancerà dalle consolidate metodologie di intervento.
20Bibliografia
CAPITTA, A.M. (2012). Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al
codice di procedura penale e alla legge sull'ordinamento penitenziario. In DIRITTO PENALE
CONTEMPORA NEO, 1-15
CESARI, C. Sull’audizione dei minori, le novità legislative vengono tradite dalla Suprema
Corte; in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 374 e ss.
CUZZOCREA, V., L’ascolto protetto delle persone minorenni prima e dopo la ratifica della
Convenzione di Lanzarote, in Proc. pen. giust., 2013, n. 2, p. 111 e ss.
CUZZOCREA, V., SCALI, M., Le buone prassi” Raccolta delle dichiarazioni/testimonianza
di vittime vulnerabili o in condizioni di particolare vulnerabilità, – Ordine Psicologi Lazio, 2019
DE LEO, G. & PATRIZI, P. (2002) Psicologia giuridica. Bologna: Il Mulino
FAMIGLIETTI, A., Persona offesa e modalità di audizione protetta: verso lo statuto del
testimone vulnerabile, in Proc. pen. giust., rivista on-line, 2016, n. 2, p. 142 e ss.
N. PASCUCCI, La Cassazione ci ripensa: obbligatorio l’ausilio dell’esperto in psicologia o
psichiatria infantile per sentire la persona informata minorenne, in Cass. pen., 2014, p. 2985
SANTORIELLO, C., La presenza dell’esperto nell’esame testimoniale del minore: dalla
Convenzione di Lanzarote alla confusione del legislatore italiano, in Arch. pen., rivista on-line, 2013
SCALI-CALABRESE, La conduzione dell’audizione protetta: analisi dell’interazione
comunicativa tra esperto e minore presunta vittima di abuso sessuale, Maltrattamento e abuso
all’infanzia, 5, 3, 2003; Scali- Calabrese-Biscione, La tutela del bambino o adolescente: le tecniche
di ascolto, Roma, 2003; AACAP, Practice parameters for the forensic valuation, cit. in V.
Cuzzocrea, L’ascolto protetto delle persone minorenni prima e dopo la ratifica della Convenzione di
Lanzarote, in Proc. pen. giust., 2013, n. 2, p. 111
21Puoi anche leggere