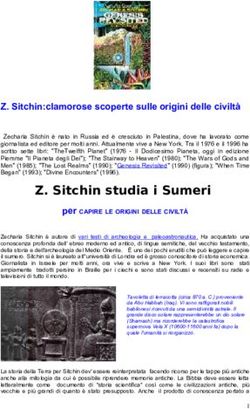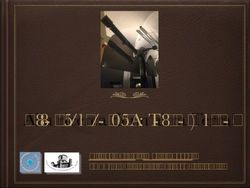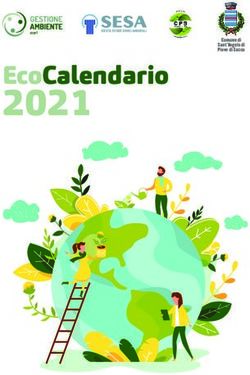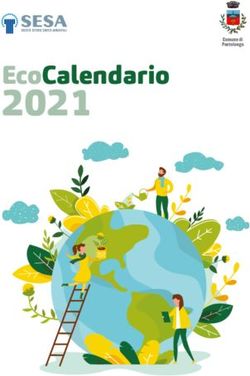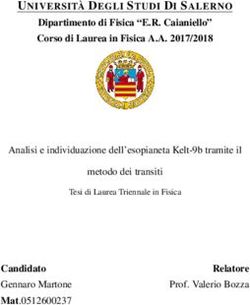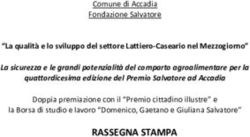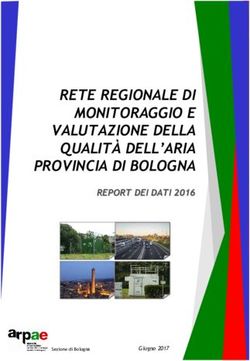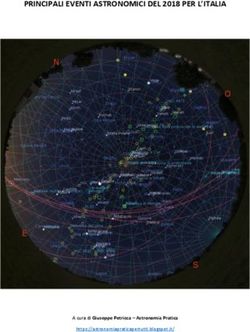Corso di astrologica - Genetliaca - III lezione - Massimiliano Gaetano - Laboratorio astrologico Astrolabs
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
*** Corso di astrologica ***
Genetliaca – III lezione
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento* * * Argomenti * * *
Ciclo sinodico dei pianeti
Teoria epiciclica dei pianeti
Epiciclo dei pianeti superiori
Epiciclo dei pianeti inferiori
Esempio pratico
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoCICLO SINODICO DEI PIANETI
Il ciclo sinodico planetario è il percorso di un corpo celeste (pianeta o stella fissa) a partire
dalla congiunzione precedente fino alla congiunzione successiva al Sole.
Il termine sinodo [lat. tardo: synŏdus (f.), gr.: σύνοδος (f.)] significa, in generale, «adunanza,
convegno»; e, in particolare in astronomia, «congiunzione di astri».
Tutti i corpi celesti compiono sinodo, ovvero congiunzione, con il Sole.
I pianeti (dalla Luna a Saturno, per quelli visibili e antichi, ma anche Urano, Nettuno e Plutone,
per quelli invisibili e moderni) realizzano congiunzione con il Sole e il periodo intercorrente fra
due congiunzioni successive viene definito sinodico. Questo periodo varia da pianeta a pianeta
sulla base del moto orbitale dei pianeti e della Terra stessa, che costituisce il nostro luogo di
osservazione.
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento In generale, il periodo sinodico dei pianeti è il seguente:
Fig. 1
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento Il rapporto dei vari pianeti con il Sole, l’astro principale e più importante, acquista notevole
rilevanza per valutare la forza e l’efficacia di ciascun pianeta.
“Rispetto alle loro configurazioni con il Sole, la Luna e i tre astri erranti (le stelle di Saturno, di Giove e
di Marte) assumono un'intensità ed un allentamento delle loro proprie virtù. La Luna infatti dal suo
primo sorgere fino al primo quarto produce soprattutto un aumento dell'umidità; indi, dal primo quarto
al plenilunio, del calore; dal plenilunio all'ultimo quarto della secchezza; e dall'ultimo quarto fino alla
sua occultazione del freddo” [Claudio Tolomeo, Tetrabiblos, libro I, Cap. VIII “Della virtù delle
configurazioni con il Sole”].
Secondo la fisica aristotelica, tutto quanto appartenga al mondo corporeo è composto da
diverse combinazioni di quattro qualità primarie: il caldo, il freddo, il secco e l'umido.
Queste quattro qualità primarie si distinguono in:
• attive, che sono il caldo e il freddo, le quali sono composte di poca materia, ne richiedono poca e
hanno la caratteristica di agire sui corpi dotati di materia;
• passive, che sono il secco e l'umido, le quali sono composte di molta materia, ne richiedono
molta e hanno la caratteristica di far subire ai corpi dotati di materia l'effetto delle qualità
primarie attive (il caldo e il freddo).
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento Il caldo ha la virtù di unire solo cose della medesima natura; il freddo quella di unire cose non
solo di natura uguale ma anche contraria.
Il secco ha la virtù di limitare, perché ha limiti propri ben definiti, ma è difficile a limitarsi;
l’umido quella di espandersi, perché non ha limiti ben definiti, ma è facile a limitarsi.
Nella materia ogni qualità primaria è presente sotto forma di combinazione con un'altra
qualità primaria.
L’interazione e la mescolanza fra di loro delle quattro qualità primarie danno origine ai quattro
elementi: il fuoco, l’aria, l’acqua e la terra .
Fig. 2
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoTutti i corpi terreni sono misti e il rapporto di mescolanza è il loro temperamento, o crasis, poiché
risultano composti dalla mescolanza secondo differenti quantità e proporzioni dei quattro
elementi (fuoco, aria, acqua e terra) i quali, a loro volta, sono il prodotto della miscelazione delle
quattro qualità primarie.
[Esempio: se domina l'elemento fuoco il temperamento è detto caldo-secco; se domina
l'elemento aria, caldo-umido; se domina l’elemento acqua, freddo-umido; e infine se domina
l’elemento terra, freddo-secco].
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento Il ciclo sinodico di ogni pianeta, a partire dalla Luna fino a Saturno, viene associato alle
quattro qualità e, di conseguenza, ai quattro quadranti stagionali.
Incominciando dalla Luna, Aristotele sostiene: “La Luna è quasi un altro piccolo Sole e per questo
contribuisce a tutti i processi di riproduzione e di compimento [...] sono i movimenti di questi astri che
determinano (nei corpi) il limite dell'inizio e della fine”.
In quanto piccolo Sole, la Luna ne imita gli effetti.
“La Luna, che tra tutti gli astri è quella più vicina alla Terra […] come una regina […] è stata modellata
in relazione al Sole regolandosi come le stagioni, in modo simile alle quattro settimane del mese. Infatti,
mentre il Sole percorre lo Zodiaco in un intero anno, la Luna […] da sinodo a sinodo impiega
approssimativamente ventinove giorni e mezzo, e mostra una strettissima connessione con le quattro
stagioni dell’anno. Infatti, dal sorgere fino al primo quarto è come la primavera, da qui in poi fino al
plenilunio è come l’estate, e dal plenilunio fino al secondo quarto è come l’autunno, e infine da qui fino
all’occultazione, è come l’inverno” [Porfirio, Introduzione al Trattato sugli effetti prodotti dalle stelle di
Tolomeo, cap. II “Sui cambiamenti meteorologici prodotti dal Sole, dalla Luna e dalle stelle nei
transiti”].
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento Le fasi della Luna sono assimilate alle quattro stagioni dell'anno, poiché nella primavera
prevale l’umido, nell'estate il caldo, nell'autunno il secco e nell’inverno il freddo.
Si tratta di un'analogia stabilita per convenzione, in virtù della quale i modi di illuminazione
del Sole nei quattro quadranti stagionali dell'anno sono assimilati omogeneamente alle quattro
fasi di illuminazione della Luna nel mese e nessuna distinzione viene posta tra la qualità della
luce solare e quella della luce lunare.
Fig. 3 Fig. 4
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento Il ciclo sinodico di ogni pianeta, a partire dalla Luna fino a Saturno, viene associato alle
quattro qualità e, di conseguenza, ai quattro quadranti stagionali.
Il Sole nasce al solstizio invernale, quando inizia a crescere la quantità del giorno pur
continuando a essere inferiore alla quantità della notte; in questo quadrante prende avvio la
qualità dell’umido, che si estende per dilatazione successiva della sua luce, da un minimo ad
un massimo, lungo l'intero emiciclo ascendente fino al solstizio estivo nel quale la quantità
del giorno, giunta alla sua massima dilatazione, inizia a decrescere; qui ha inizio il secco, che
si estende per restringimento successivo della luce, da un massimo ad un minimo, lungo
tutto l’emiciclo discendente fino al solstizio invernale.
Umido e secco hanno origine da due circoli tra loro opposti, il tropico del Capricorno e il
tropico del Cancro. Diversamente si comportano i principi del calore e del freddo: se l'umido
e il secco si propagano per dilatazione e per restringimento, il caldo e il freddo si propagano
entro punti delimitati dalla quantità degli archi diurni e notturni del Sole ed operano per
intensità dell'uno sull'altro. Essi hanno origine dal medesimo circolo, il cerchio equinoziale,
linea mediana delle diverse quantità luminose nel corso dell'anno e, raggiunto il loro
massimo nei punti opposti, ritornano al medesimo circolo. In inverno nasce la qualità
dell’umido, perdurando il freddo originato nell'autunno; in primavera nasce la qualità del
caldo, perdurando l'umido; in estate nasce la qualità del secco, perdurando il caldo; in
autunno nasce la qualità del freddo, perdurando il secco.
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento Le quattro qualità primarie sono ripartite in modo tale da caratterizzare le quattro età
dell’essere umano (infanzia, giovinezza, maturità e vecchiaia).
La prima età dell’essere umano, quella della nascita e dell’infanzia, è caratterizzata dalla
prevalenza dell’umido, qualità tipica della stagione della primavera.
La seconda età dell’essere umano, quella dell’adolescenza e della giovinezza, è caratterizzata
dal caldo, qualità tipica della stagione dell’estate.
La terza età dell’essere umano, quella della maturità, è caratterizzata dal secco, qualità tipica
della stagione dell’autunno.
La quarta età dell’essere umano, quella della vecchiaia, è caratterizzata dal freddo, qualità
tipica della stagione dell’inverno.
Fig. 5
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento Il ciclo sinodico della Luna è scandito da quattro fasi fondamentali: il novilunio e il
plenilunio (che corrispondono a gradi estremi delle sue qualità); il primo quarto e l’ultimo
quarto (che corrispondono a gradi di equilibrio delle sue qualità).
Il novilunio è caratterizzato dal freddo, a causa
dell’assenza della luce lunare nella totalità del suo
disco; e viene assimilato al solstizio d’Inverno,
istante nel quale vi è la minore illuminazione
dell’anno.
Il primo quarto è caratterizzato dall’umido, a
causa della presenza della luce lunare nella metà
del suo disco nell’emiciclo crescente; e viene
assimilato all’equinozio di Primavera, istante
mediano rispetto ai solstizi, quello d’Inverno e
quello d’Estate.
Il plenilunio è caratterizzato dal caldo, a causa
della presenza della luce lunare nella totalità del
suo disco; e viene assimilato al solstizio d’Estate,
istante nel quale vi è la maggiore illuminazione
dell’anno. Fig. 6
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento L’ultimo quarto è caratterizzato dal secco, a causa della presenza della luce lunare nella metà
del suo disco nell’emiciclo decrescente; e viene assimilato all’equinozio d’Autunno, istante
mediano rispetto ai solstizi, quello d’Estate e quello d’Inverno.
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoTEORIA EPICICLICA DEI PIANETI
L’Epiciclo è un artifizio geometrico
(escogitato dal matematico Apollonio di
Perga intorno al 200 a.C. e ripreso da
Claudio Tolomeo) per rappresentare
movimenti periodici composti.
Osservati dalla Terra, i pianeti sorgono,
avanzano nel cielo, si arrestano e tornano
indietro per poi riprendere il cammino.
Per conciliare queste apparenze con il
principio dei moti uniformi dei pianeti
lungo orbite circolari, Tolomeo ricorse a
una soluzione geometrica introdotta da
Apollonio di Perga (III sec. a.C.): il pianeta
si muove con velocità uniforme lungo un
cerchio minore (l’epiciclo), che è
contemporaneamente trascinato lungo la
Fig. 7 circonferenza maggiore (il deferente o
eccentrico) al cui centro è posta la Terra.
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento Il centro del complesso moto epiciclico non coincide
con il centro della Terra (eccentricità).
Un grande cerchio (eccentrico o deferente) è fisso
attorno alla Terra.
Lungo questo cerchio (eccentrico o deferente) si sposta
il centro di un cerchio più piccolo (epiciclo).
Il pianeta percorre questo cerchio più piccolo (epiciclo)
mentre questo si sposta attorno a quello più grande
(eccentrico o deferente).
Nella teoria epiciclica, i moti sono due: il periodo
siderale del Sole e il periodo siderale del pianeta.
Il moto sul cerchio più grande (eccentrico o deferente)
è più lento; quello sul cerchio più piccolo (epiciclo) è
più veloce.
Nel caso di un pianeta interno o inferiore, il cerchio più
grande (eccentrico o deferente) viene percorso col
periodo siderale del Sole
Nel caso di un pianeta esterno o superiore, il cerchio
Fig. 9 più grande (eccentrico o deferente) viene percorso col
periodo siderale del pianeta.
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento L’epiciclo [termine che deriva dal greco epíkyklos, composto da da epì che vuol dire “sopra” e kyklos
che vuol dire “cerchio”, quindi “cerchio che sta sopra”] è un cerchio piccolo sul quale si muove
ciascun pianeta.
L’eccentrico o deferente [termine che deriva dal
greco exxentron, composto da da ex che vuol
dire “fuori da” e xentron che vuol dire
“cerchio”, quindi “fuori dal cerchio”] è un
cerchio più grande tracciato e percorso dal
centro dell’epiciclo con velocità non uniforme
e il cui centro non coincide con il centro del
mondo (la Terra, luogo dell’osservazione).
L’eccentrico costituisce l’orbita del pianeta
visto dalla Terra e permette di spiegare il
fatto che la Terra, in un’ottica o visione
geocentrica, costituisce uno dei due fuochi
dell’orbita ellittica e non circolare dei pianeti.
L’equante è il punto diametralmente opposto
alla Terra rispetto al centro dell’eccentrico o
deferente; e rispetto al quale il centro
dell’epiciclo percorre l’eccentrico con velocità
uniforme. Fig. 8
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoEpiciclo dei pianeti inferiori o interni (Mercurio e Venere)
Fig. 9 Fig. 10
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoEpiciclo dei luminari (Sole e Luna)
Fig. 11 Fig. 12
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoEpiciclo dei pianeti superiori o esterni (Marte, Giove e Saturno)
Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoL’epiciclo, lungo il quale si muove il corpo del pianeta, permette di spiegare l’apparente
diversità di moto (diretto stazionario retrogrado stazionario diretto) che viene ad
assumere ogni pianeta osservato dalla Terra.
Il pianeta, quando si trova nella parte superiore dell’epiciclo (apogeo), percorre questo cerchio
(cioè l’epiciclo) in senso diretto (osservato dalla Terra, appare muovendosi da ovest a est,
ovvero nel senso della sequenza dei segni zodiacali, lungo i quali si muove l’eccentrico);
viceversa, quando si trova nella parte inferiore dell’epiciclo (perigeo), percorre questo cerchio
(cioè l’epiciclo) in senso inverso (osservato dalla Terra, appare muoversi da est a ovest, ovvero
in senso contrario alla sequenza dei segni zodiacali, lungo i quali si muove l'eccentrico).
L’anomalia dell’epiciclo ci mostra:
- i pianeti superiori muoversi ora con moto diretto e
veloce, quando sono prossimi alla congiunzione con
il Sole; ora con moto medio, quando sono in
quadratura con il Sole; ora con moto retrogrado,
quando sono acronici e opposti al Sole;
- i pianeti inferiori muoversi ora con moto diretto e
veloce, quando sono prossimi alla congiunzione
superiore con il Sole; ora con moto medio, quando
sono alla massima elongazione; ora con moto
retrogrado, quando sono prossimi alla congiunzione
inferiore con il Sole. Fig. 16
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoFig. 17
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoEPICICLO DEI PIANETI SUPERIORI
I pianeti superiori visibili sono Marte, Giove e Saturno.
La congiunzione o sinodo col Sole (c.d. σίνοδος o coniunctio)
costituisce il punto di partenza del ciclo sinodico. Il pianeta
superiore si trova all’apogeo (massima distanza dalla Terra),
ha moto diretto veloce e rapido, rimane invisibile, nascosto
dai raggi del Sole.
La levata o sorgere eliaco consiste nel fenomeno visivo
dell’emersione del pianeta dai raggi del Sole. Il pianeta
superiore riacquista visibilità e può essere osservato a
oriente prima del sorgere del Sole.
La linea del moto medio corrisponde al momento in cui il
pianeta ha un moto mediano fra la massima velocità diretta e
la prima stazione.
Fig. 18
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento La prima stazione mattutina, orientale o retrograda corrisponde al momento in cui il pianeta inverte il
suo moto passando da diretto a retrogrado.
Il sorgere acronico orientale o vespertino consiste nel fenomeno visivo del sorgere del pianeta a oriente ,
mentre il Sole sta per tramontare a occidente.
L’opposizione o diametro col Sole costituisce il punto a metà del ciclo sinodico. Il pianeta superiore si
trova al perigeo (minima distanza dalla Terra), ha moto retrogrado veloce e rapido, possiede la
massima visibilità.
Il tramonto acronico occidentale o mattutino consiste nel fenomeno visivo del tramonto del pianeta a
occidente, mentre il Sole sta per sorgere a oriente.
La seconda stazione vespertina, occidentale o diretta corrisponde al momento in cui il pianeta inverte il
suo moto passando da retrogrado a diretto.
La linea del moto medio corrisponde al momento in cui il pianeta ha un moto mediano fra la seconda
stazione e la massima velocità diretta della successiva congiunzione con il Sole.
Il coricarsi o tramonto eliaco consiste nel fenomeno visivo dell’immersione del pianeta nei raggi del
Sole. Il pianeta superiore perde visibilità e non può essere osservato a occidente dopo il tramonto del
Sole.
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento La congiunzione o sinodo col Sole è caratterizzata dal
freddo, poiché il pianeta superiore è totalmente
invisibile; e viene assimilato al solstizio d’Inverno,
istante nel quale si ha minore irraggiamento e
illuminazione del Sole.
L’opposizione o diametro col Sole è caratterizzata dal
caldo, poiché il pianeta è totalmente visibile; e viene
assimilato al solstizio d’Estate, istante nel quale si ha
maggiore irraggiamento e illuminazione del Sole.
Dalla levata eliaca fino alla stazione orientale prevale
l’umido.
Dalla stazione orientale al sorgere acronico orientale
prevale il calore.
Dal tramonto acronico occidentale alla stazione
occidentale prevale il secco.
Dalla stazione occidentale al tramonto eliaco prevale il
freddo. Fig. 19
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento L’arco di epiciclo compreso fra la seconda stazione o vespertina e quella prima o mattutina,
passando per la congiunzione o sinodo, prende il nome di arcus directionis, poiché il pianeta che si
trova in quest’arco ha moto diretto o additivo.
L’arco di epiciclo compreso fra la stazione mattutina o prima e quella vespertina o seconda,
passando per l’opposizione, prende il nome di arcus regressionis, poiché il pianeta che si trova in
quest’arco ha moto retrogrado o sottrattivo.
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoEPICICLO DEI PIANETI INFERIORI
I pianeti inferiori o interni sono Mercurio e Venere.
La congiunzione o sinodo (c.d. σίνοδος o coniunctio) superiore
che avviene quando il pianeta inferiore si trova al di la del
Sole, lungo la linea direttrice che passa fra il centro della
Terra, del pianeta e del Sole. Essa costituisce il punto di
partenza del ciclo sinodico dei pianeti inferiori. Il pianeta
inferiore si trova all’apogeo (massima distanza dalla Terra),
ha moto diretto veloce e rapido, rimane invisibile, nascosto
dai raggi del Sole.
La levata o sorgere eliaco occidentale o vespertino consiste nel
fenomeno visivo dell’emersione del pianeta inferiore dai
raggi del Sole dopo la congiunzione superiore. Il pianeta
inferiore riacquista visibilità e può essere osservato a
occidente dopo il sorgere del Sole.
Fig. 20
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento La linea del moto medio corrisponde al momento in cui il pianeta inferiore ha un moto mediano fra la
massima velocità diretta e la prima stazione.
La prima stazione vespertina, occidentale o retrograda corrisponde al momento in cui il pianeta inferiore
inverte il suo moto passando da diretto a retrogrado.
Il coricarsi o tramonto eliaco occidentale o vespertino consiste nel fenomeno visivo dell’immersione del
pianeta inferiore nei raggi del Sole prima della congiunzione o sinodo inferiore. Il pianeta inferiore
perde visibilità e non può essere osservato a occidente dopo il tramonto del Sole.
La congiunzione o sinodo (c.d. σίνοδος o coniunctio) inferiore col Sole che avviene quando il pianeta
inferiore si trova al di qua del Sole, lungo la linea direttrice che passa fra il centro della Terra, del
pianeta e del Sole. Il pianeta inferiore si trova al perigeo (minima distanza dalla Terra), ha moto
retrogrado veloce e rapido, rimane invisibile, nascosto dai raggi del Sole.
Il levarsi o sorgere eliaco orientale o mattutino consiste nel fenomeno visivo dell’emersione del pianeta
inferiore dai raggi del Sole prima dopo la congiunzione o sinodo inferiore. Il pianeta inferiore
riacquista visibilità e può essere osservato a oriente prima del sorgere del Sole.
La seconda stazione, orientale o diretta corrisponde al momento in cui il pianeta inferiore inverte il suo
moto passando da retrogrado a diretto.
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento La linea del moto medio corrisponde al momento in cui il pianeta ha un moto mediano fra la massima
velocità diretta e la prima stazione.
Il coricarsi o tramonto eliaco orientale o mattutino consiste nel fenomeno visivo dell’immersione del
pianeta inferiore nei raggi del Sole prima della congiunzione o sinodo superiore. Il pianeta inferiore
perde visibilità e non può essere osservato a oriente prima del sorgere del Sole.
La congiunzione o sinodo, sia superiore che inferiore, col
Sole è caratterizzata dal freddo, poiché il pianeta inferiore
è totalmente invisibile; e viene assimilato al solstizio
d’Inverno, istante nel quale si ha minore irraggiamento e
illuminazione del Sole.
Dal sorgere eliaco vespertino alla massima elongazione
occidentale e dal sorgere eliaco mattutino alla seconda stazione
prevale l’umido.
Dalla massima elongazione occidentale alla stazione
vespertina e dalla stazione mattutina alla massima elongazione
orientale prevale il caldo.
Dalla stazione vespertina al tramonto eliaco vespertino e
dalla massima elongazione orientale al tramonto eliaco
mattutino orientale prevale il secco.
Fig. 21
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento L’arco di epiciclo compreso fra la stazione mattutina e quella vespertina, passando per la
congiunzione o sinodo superiore, prende il nome di arcus directionis, poiché il pianeta che si trova in
quest’arco ha moto diretto o additivo.
L’arco di epiciclo compreso fra la stazione mattutina e quella vespertina, passando per l’opposizione,
prende il nome di arcus regressionis, poiché il pianeta che si trova in quest’arco ha moto retrogrado o
sottrattivo.
L’epiciclo dei pianeti inferiori si distingue da quello dei pianeti superiori per i seguenti motivi:
- l’epiciclo dei pianeti inferiori è caratterizzato da due congiunzioni o sinodi, uno superiore che
avviene in prossimità dell’apogeo (corrispondente alla congiunzione o sinodo dei pianeti superiori)
e uno inferiore che avviene in prossimità del perigeo (corrispondente all’opposizione dei pianeti
superiori);
- la prima stazione è vespertina (quella dei pianeti superiori è mattutina) e quella seconda è mattutina
(quella dei pianeti superiori è vespertina);
- i pianeti inferiori raggiungono una distanza rispetto al Sole (c.d. elongazione) che non permette
configurazioni come il sestile o esagono (60°), il quadrato (90°), il trigono (120°) e l’opposizione o
diametro (180°), diversamente da quanto avviene per i pianeti superiori.
L’epiciclo dei pianeti inferiori è caratterizzato da un doppio ciclo illuminativo poiché, a causa delle
loro orbite interne, realizzano due volte la congiunzione o sinodo con il Sole.
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento L’anomalia dell’epiciclo mostra:
- i pianeti superiori muoversi con moto diretto e veloce, quando sono prossimi alla
congiunzione con il Sole; con moto medio, quando sono in quadratura; stazionari, quando sono
in trigono con il Sole; con moto retrogrado, quando sono acronici e opposti al Sole;
- i pianeti inferiori muoversi con moto diretto e veloce, quando sono prossimi alla congiunzione
superiore con il Sole; con moto medio, quando sono alla massima elongazione; con moto
retrogrado, quando sono prossimi alla congiunzione inferiore con il Sole.
La rivoluzione sinodica che il pianeta compie intorno all’epiciclo si chiama anomalia epiciclica.
Questa anomalia è data dalla differenza fra il moto diurno medio del Sole e quello del pianeta.
[Esempio. Se vogliamo trovare l’anomalia epiciclica di Saturno,
sottraiamo il moto diurno medio di Saturno nello Zodiaco da quello
del Sole: 59’ 08’’,33 – 02’ 00’’,45 = 57’ 07’’,88]
Il raggio (R) dell’eccentrico è 60°. Per i pianeti inferiori,
moltiplicando questo valore per il semiasse maggiore espresso in
unità astronomica (U.A.), si ottiene il raggio (r) dell’epiciclo. Per i
pianeti inferiori, dividendo questo valore per il semiasse maggiore
espresso in unità astronomica (U.A.), si ottiene il raggio
dell’epiciclo.
Fig. 22
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento L’eccentrico costituisce l’orbita del pianeta visto dalla Terra e permette di spiegare il fatto
che la Terra, in un’ottica o visione geocentrica, costituisce uno dei due fuochi dell’orbita ellittica
e non circolare dei pianeti.
Ogni pianeta ha un proprio eccentrico (cioè il cerchio più grande percorso dal centro
dell’epiciclo) il cui centro, ruotando attorno alla Terra con un periodo diverso per ciascun
pianeta, permette di misurare il periodo della rivoluzione siderale del pianeta, in cui il pianeta
percorre l’intero Zodiaco (Saturno 29,45 anni, Giove 11,87 anni, Marte 1,88 anni, Sole 1 anno,
Venere 0,615 anni, Mercurio 0,241 anni).
Il movimento del centro dell'eccentrico attorno alla Terra è molto più lento di quello del centro
dell'epiciclo e ancora di più rispetto a quello del pianeta lungo l'epiciclo.
Il pianeta percorre sull’eccentrico la sua rivoluzione siderea e sull’epiciclo la sua rivoluzione
sinodica.
Dal momento che la rivoluzione siderea sull’eccentrico è più lenta di quella sull’epiciclo, le
variazioni di luce del pianeta sono graduali e lente quando percorre la sua rivoluzione siderea
sull’eccentrico; invece sono più repentine e rapide quando percorre la sua rivoluzione sinodica
sull’epiciclo.
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoLa Terra e il centro dell’eccentrico o
deferente si trovano allineati sulla linea degli
apsidi o absidi.
Apside o abside è il punto di maggiore o
minore distanza di un corpo celeste dal fuoco
nel quale si trova il corpo celeste attorno al
quale orbita.
Il punto che dista maggiormente dalla Terra
si chiama apogeo (greco) o auge (arabo);
viceversa, quello che dista di meno perigeo o
auge infima.
La distanza fra il centro dell’eccentrico e la
Terra varia da pianeta a pianeta e costituisce
il rapporto di eccentricità.
Nel loro moto in longitudine i pianeti
mostrano un’anomalia anche lungo
l’eccentrico, poiché si muovono con moto
veloce presso l’apogeo, con moto medio
presso i transiti medi e con moto lento presso Fig. 23
il perigeo.
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoQuando il centro dell’epiciclo di un pianeta o il pianeta stesso si trovano nell’arco sopra la linea
del moto medio [segmento GAH] (ovvero semi-arco GH passante per R), essendo più distante
dalla Terra [punto A], è più lento e meno luminoso. Viceversa quando il centro dell’epiciclo di
un pianeta o il pianeta stesso si trovano nell’arco sotto la linea del moto medio [segmento
GAH] (ovvero il semi-arco GH passante per S), essendo più vicino alla Terra [punto A], è più
veloce e più luminoso.
Inoltre, l’emiciclo dell’eccentrico compreso fra l’apogeo [punto R] e il perigeo [punto S] si dice
ascendente; quello compreso fra il perigeo [punto S] e l’apogeo [punto R] si dice discendente.
Con riferimento all’eccentrico la migliore condizione è quando il centro dell’epiciclo del pianeta
o il pianeta stesso si trovano nel quadrante compreso fra la linea del moto medio [punto G] e il
perigeo [punto S], poiché il pianeta aumenta il suo moto e la sua luce apparente.
Inoltre, l’emiciclo dell’epiciclo compreso fra l’apogeo [punto R] e il perigeo [punto S] si dice
ascendente e il moto vero del pianeta è maggiore di quello del centro del suo epiciclo (aucti
numero); invece quello compreso fra il perigeo [punto S] e l’apogeo [punto R] si dice
discendente e il moto vero del pianeta è minore di quello del centro del suo epiciclo (minuti
numero). Per questo motivo Cardano afferma: “I pianeti orientali rispetto al Sole si muovono
velocemente” [Gerolamo Cardano, Aphorismorum astronomicorum segmenta semptem, Sez. II, 88,
pag. 46].
Durante il loro percorso sull’eccentrico possiamo associare ai pianeti le quattro qualità primarie
attive (caldo e freddo) e passive (secco ed umido). Generalmente un pianeta all’apogeo è più
secco, mentre uno al perigeo è più umido.
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento I pianeti inferiori sono più forti quando sono occidentali al Sole (dal sorgere eliaco
vespertino fino alla stazione occidentale o vespertina); al contrario, i pianeti superiori sono
più forti quando sono orientali al Sole (dal sorgere eliaco fino alla stazione orientale o
mattutina).
Il motivo risiede nel fatto che in entrambi i casi i pianeti, con moto diretto, si allontanano dal
Sole divenendo sempre più luminosi.
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoFig. 24 Fig. 25
Un pianeta è sotto i raggi del Sole quando si trova entro 15° prima o dopo il Sole.
Quando il pianeta si trova sotto i raggi del Sole, possiamo distinguere tre condizioni:
- cuore del Sole (in corde Solis) [Fig. 24 ❶; Fig. 25 ❶ e ❾];
- combustione (combustio o adustio) [Fig. 24 ②⑯; Fig. 25 ②⑯ e ⑧⑩];
- sotto i raggi del Sole (sub radiis Solis) [Fig. 24 ③⑮; Fig. 25 ③⑮ e ⑦⑪].
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento Un pianeta è nel cuore del Sole (c.d. cazimi, termine che deriva dall’arabo samîn) quando si
trova in longitudine eclittica (λ) e in latitudine celeste (β) entro 59’ (secondo gli astrologi
ellenistici) o, più restrittivamente, entro 16’ (secondo gli astrologi arabi) dal Sole.
Questa fase indica una condizione molto favorevole per il pianeta, il cui influsso è
amplificato e potenziato dal Sole; e i suoi significati sono di prosperità e di cose buone.
Un pianeta è combusto (c.d. combustio o adustio) quando si trova compreso fra 59’ (secondo
gli astrologi ellenistici) o, più restrittivamente, fra 16’ (secondo gli astrologi arabi) e 7° dal
Sole [Fig. 24 ②⑯; Fig. 25 ②⑯ e ⑧⑩].
Questa fase indica una condizione di maggiore debolezza, nella quale il pianeta superiore
non è in grado di esprimere e manifestare le proprie qualità, sia positive che negative. Ne
consegue che se il pianeta superiore è benefico (Giove) diminuisce il suo essere benefico; se il
pianeta superiore è malefico (Marte e Saturno) diminuisce il suo essere malefico. L’influsso
del pianeta non viene completamente annullato, ma notevolmente attenuato, poiché “il male
del malefico è meno grave, il bene del benefico è mediocre”.
Nel caso in cui il pianeta combusto sia maschile, la combustione è meno dannosa; mentre nel
caso in cui il pianeta combusto sia femminile, la combustione è maggiormente invalidante.
La combustione che avviene nei gradi antecedenti il Sole è migliore di quella che avviene nei
gradi successivi al Sole, perché i gradi antecedenti al Sole sono stati già attraversati dal Sole
stesso; mentre quelli successivi devono essere ancora percorsi dal Sole.
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamento Un pianeta è sotto i raggi del Sole (c.d. sub radiis tantum) quando si trova compreso fra 7° e
15° dal Sole con questa distinzione: da 7° a 12° il pianeta è ancora assolutamente privo di forza;
mentre da 12° a 15° riacquista il suo potere [Fig. 24 ③⑮; Fig. 25 ③⑮ e ⑦⑪].
Secondo Guido Bonatti, il pianeta che si trova sotto i raggi prima della combustione è come una
persona anziana malandata e inferma; quando si trova sotto i raggi dopo la combustione è
come una persona molto giovane ancora in tenera età.
Un pianeta compie il sorgere o levarsi (apparizione) [Fig. 24 ③⑮; Fig. 25 ③⑮ e ⑦⑪] e il
tramontare o coricarsi (occultazione) quando, rispettivamente, esce o emerge dai raggi del Sole
oppure entra o s’immerge in tali raggi.
Queste due fasi sono molto importanti poiché, se alla luminosità di un corpo celeste si ricollega
la sua efficacia, ovvero la sua capacità di produrre effetti concreti e tangibili nel mondo sub-
lunare, la prima e l’ultima apparizione costituiscono gli estremi temporali entro i quali con
gradazioni variabili secondo le fasi dell’epiciclo il pianeta è suscettibile di manifestare i propri
significati e i conseguenti effetti.
Il sorgere o levarsi (apparizione) è il momento in cui un pianeta diviene visibile e riconoscibile
perché la sua luce è separata e distinta da quella propria del Sole. Questo momento non è
identico, ma varia in relazione alle coordinate del luogo geografico della Terra. Claudio
Tolomeo dichiara nella Sintaxis mathematica, conosciuto come Almagesto, che le apparizioni dei
pianeti dipendono dalla diversità della grandezza luminosa di ciascun pianeta (c.d.
magnitudo), da quella dell’angolo di inclinazione tra l’Eclittica e l’orizzonte del luogo e da
quella delle latitudini celesti (β) dei pianeti.
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoPer determinare quando un pianeta diviene visibile dobbiamo ricorrere alla nozione di arcus
visionis o fulsionis. L’arcus visionis è la quantità di altezza negativa (c.d. depressione) che il Sole
deve avere affinché un pianeta sull’orizzonte sia visibile. L’altezza (h) è negativa quando un
corpo celeste si trova sotto l’orizzonte del luogo geografico; in caso contrario, ovvero quando si
trova sopra quest’orizzonte, l’altezza è positiva.
Se η è l’elongazione eclittica di un pianeta dal Sole, ν l’angolo fra l’Eclittica e l’orizzonte del
luogo e β la latitudine celeste del pianeta, la formula per trovare l’arcus visionis è la seguente:
h* = η sin ν + β cos ν
dove h* è l’arcus visionis, η l’elongazione eclittica, ν l’angolo fra l’eclittica e l’orizzonte e β la
latitudine celeste del pianeta.
Il valore dell’arcus visionis dei pianeti è 12° per Mercurio, 5°
(per la prima visibilità mattutina e l’ultima vespertina,
ovvero presso la congiunzione inferiore, quando ha moto
retrogrado) e 7° (per la prima visibilità vespertina e l’ultima
mattutina, ovvero presso la congiunzione superiore, quando
ha moto diretto) per Venere, 14° 30’ per Marte, 9° per Giove
e 13° per Saturno [questi gradi non sono eclittici, bensì di
altezza (h)]. Fig. 26
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoUn pianeta è stazionario quando appare fermo prima di invertire il proprio moto. La stazione
può essere orientale o mattutina oppure occidentale o vespertina.
La stazione orientale o mattutina è quella che segna, per i pianeti superiori (Marte, Giove e
Saturno), il passaggio dal moto diretto a quello retrogrado e, per i pianeti inferiori (Mercurio e
Venere), il passaggio dal moto retrogrado a quello diretto.
La stazione occidentale o vespertina è quella che segna, per i pianeti superiori (Marte, Giove e
Saturno), il passaggio dal moto retrogrado a quello diretto e, per i pianeti inferiori (Mercurio e
Venere), il passaggio dal moto diretto a quello retrogrado.
La stazione che segna il passaggio dal moto diretto a quello retrogrado si chiama prima
stazione (c.d. prima statio) e quella che segna il passaggio dal moto retrogrado a quello diretto si
chiama seconda stazione (c.d. secunda statio).
Il pianeta stazionario significa o rappresenta una condizione di incertezza e sembra
indugiare nel realizzare i suoi significati o i propri effetti. Tuttavia l’interpretazione varia a
seconda che si tratti di prima oppure di seconda stazione. Infatti, mentre nella prima stazione
indicano un ritardo, un rinvio, un dilazionare i propri significati ed effetti; nella seconda
stazione indicano la possibilità concreta di realizzazione a breve di tali significati ed effetti non
appena il loro moto riprenda ad essere diretto.
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoUn pianeta acronico è quello che sorge oppure tramonta, contestualmente e rispettivamente,
al tramonto oppure al sorgere del Sole.
In particolar modo, quando il pianeta sorge contestualmente al tramonto del Sole prima della
fase dell’opposizione al Sole si verifica il sorgere acronico; invece quando tramonta
contestualmente al sorgere del sole dopo la fase dell’opposizione al Sole, si verifica il tramonto
acronico.
Il pianeta acronico si trova in una condizione simile a quella della congiunzione o sinodo il
Sole.
Questa condizione è ammessa solo per i pianeti superiori, poiché questi sono gli unici che
possono realizzare opposizione al Sole.
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoLe fasi dei pianeti nell’epiciclo sono utili e rilevanti ai fini dell’interpretazione.
Giuliano di Laodicea sinteticamente sostiene che i pianeti hanno affinità con:
- l'indugiare, quando sono stazionari (hoi stêrizontes);
- il ritardare e il recalcitrare, quando sono retrogradi (hoi anapodizontes);
- l'operare prestamente, quando hanno moto diretto (hoi euthyporountes);
- i profitti e gli acquisti utili all'esistenza, quando aumentano in luce e in moto (hoi tois phôsin kai
tois arithmois prostithentes);
- la sottrazione e il danno, quando diminuiscono in luce e in moto (hoi d’aphairountes);
- l'ignavia e la tardanza, quando sono di moto lento (hoi de bradeôs kinoumenoi);
- la sveltezza e l'esser sollecito, quando sono di moto lento (hoi de tacheôs).
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoPer quanto riguarda il corpo fisico, il pianeta significatore del corpo fisico:
- se si trova all’apogeo dell’epiciclo, indica un corpo alto;
- se si trova in luogo mediano fra l’apogeo e il perigeo, indica un corpo nella media;
- se si trova al perigeo dell’epiciclo, indica un corpo basso.
- se è diretto, indica un fisico magro;
- se si trova nella prima stazione, indica un fisico grasso ma non molto e resistente;
- se è retrogrado, indica un fisico grasso;
- se si trova nella seconda stazione, indica un fisico magro ma non troppo e debole.
Saturno è intrinsecamente freddo/secco; orientale è freddo/umido; occidentale è freddo/secco
Giove è intrinsecamente caldo/umido; orientale è caldo/umido; occidentale è umido
Marte è intrinsecamente caldo/secco; orientale è caldo/secco; occidentale è secco
Venere è intrinsecamente freddo/umido; orientale è umido; occidentale è freddo
Mercurio è intrinsecamente secco; orientale è caldo; occidentale è secco
La Luna è intrinsecamente freddo/secco
Il Sole è intrinsecamente caldo/secco (dipende dal quadrante stagionale: caldo/umido in
Primavera; caldo/secco in Estate; freddo/secco in Autunno; freddo/umido in Inverno).
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoPer quanto riguarda le qualità dell’animo, il pianeta significatore dell’animo:
- se si trova all’apogeo, indica un animo più spirituale; se si trova al perigeo, indica un animo
più materialista;
- se si trova al sorgere eliaco, per i pianeti superiori, o al sorgere eliaco vespertino , per i
pianeti inferiori, indica un animo nobile, vivace, chiaro;
- se si trova al tramonto eliaco, indica un animo timido, avaro, rozzo;
- se si trova nella prima stazione, indica un animo ambiguo, ma forte;
- se si trova nella seconda stazione, indica un animo ambiguo, ma debole e scoraggiato;
- se si trova nella retrogradazione prima dell’opposizione, indica un animo tenace, ma
ottimista e gagliardo;
- se si trova nella retrogradazione dopo l’opposizione, indica un animo tenace, ma pessimista.
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoAlbert Einstein
14 marzo 1879
11h 30m
Neuburg an der Donau
Nascita diurna con il Sole (luminare del
tempo) in Casa X (luogo culminante) e in
Pesci (segno di Giove)
La Luna (l’altro luminare) [DH: 04h 13m]
forma trigono nello spazio locale con il Sole
[DH: 00h 56m] in Casa X e si trova in
Sagittario (segno di Giove).
L’Oroscopo (AS) si trova in Cancro (segno
dell’esaltazione di Giove).
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoGiove è orientale al Sole e in fase di
levata eliaca (realizza la levata eliaca
entro 7 giorni, esattamente 3 giorni
dopo). La levata eliaca è una dignità
potente del pianeta che opera
efficacemente nel luogo in cui il
pianeta si trova.
Dal momento che Giove si trova
nella Casa IX, la levata eliaca di
questo pianeta promette
un'espansione (Giove) innovativa e
rivoluzionaria (Acquario) della
conoscenza (Casa IX).
Giove ricopre un ruolo importante
nella carta di nascita perché signore
del Sole e della Luna per domicilio e
dell’Oroscopo (AS) per esaltazione.
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoMercurio è occidentale al Sole e sta
realizzando la levata eliaca
vespertina. Esso indica un’anima
forte e molto adatta alle attività di
tipo intellettuale e un ingegno
notevolmente spiccato.
Mercurio, significatore dell’animo, è
dominato da Giove (per termine) e
richiama gli studi superiori, il
lontano e la speculazione mentale,
l’insegnamento, la ricerca, l’estero.
La congiunzione di Mercurio con
Saturno indica una mente profonda,
riflessiva che discrimina e discerne,
dotata di grande forza logica e
critica.
Massimiliano Gaetano
docente CIDA abilitato all’insegnamentoMassimiliano Gaetano docente CIDA abilitato all’insegnamento
Puoi anche leggere