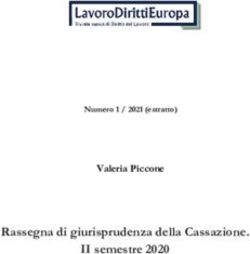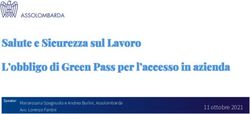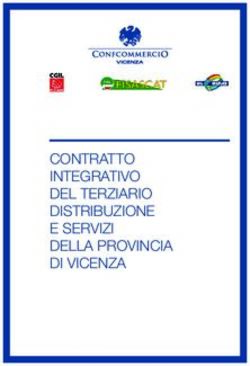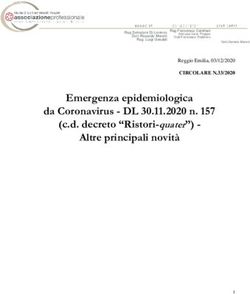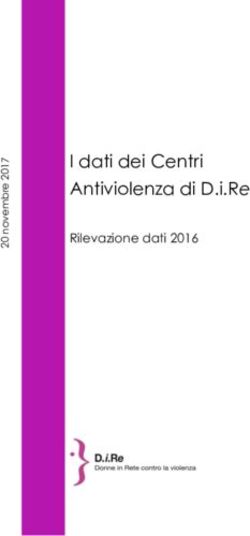DISPENSA DIRITTO DI SCIOPERO
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
http://www.abcdeidiritti.it/website/ https://www.fpcgil.it/?home
DISPENSA DIRITTO DI SCIOPERO
INDICE
Lo sciopero e teorie sociali
La disciplina giuridica dello sciopero
Lo sciopero come diritto
La titolarità del diritto di sciopero
Effetti dello sciopero sul rapporto di lavoro
Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali
I limiti all’esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali
La commissione di garanzia
Le sanzioni dello sciopero nei servizi pubblici essenziali
LO SCIOPERO E TEORIE SOCIALI
Lo sciopero è il principale strumento a disposizione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali per
sostenere le proprie rivendicazione.
Esso è l’astensione collettiva dal lavoro che comporta un danno economico e produttivo per l’imprenditore.
Lo sciopero chiama in causa diverse teorie della società lo sciopero è un istituto centrale del diritto del
lavoro.
Nella nostra Costituzione, l’obiettivo del superamento della subalternità dei lavoratori subordinati è stato
reputato talmente importante, da far conferire ai medesimi il diritto di accompagnare o di proseguire quelle
battaglie costituzionalismo sociale.
Ciò si denota anche al diritto di serrata non conferito all’imprenditore.
Una volta riconosciuto il diritto al conflitto sociale, difficile è istituzionalizzarlo.
Marx: lo sciopero, nella sua primigenia essenza di lotta qualificata dall’appartenenza a una classe, si è
inserito perfettamente nel paradigma marxiano, come inizio di ribellione della classe sfruttata, e quasi
come una prova tecnica dello sbocco rivoluzionario.
A partire dagli anni ’80, lo sciopero ha subito profonde mutazioni: lo sciopero ha perduto, nel bacino
dell’industria, una parte della propria importanza sociale. Per un verso, lo sciopero è aumentato di intensità
nel settore dei servizi essenziali, rendendo necessaria una legge adeguata a regolarlo.
LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLO SCIOPERO
1 Italia post-unitaria: «le intese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare e far rincarare il
lavoro senza ragionevole causa» erano sanzionate come reato, tranne che nell’ex-Granducato di
Toscana (Codice Leopoldino) (sciopero-reato).
Codice penale Zanardelli (1889): lo sciopero è divenuto un comportamento penalmente tollerato se
attuato senza violenza o minaccia, pur restando illecito (ergo, sanzionabile col licenziamento, oltre
che con il risarcimento danni) (sciopero-libertà).
Codice penale Rocco (1930): l’ideologia fascista, all’art. 502, proclama il reato di serrata e di sciopero
per fini contrattuali. (sciopero-reato).
Costituzione Repubblicana: l’art. 40 proclama lo sciopero come un diritto (sciopero-diritto).
LO SCIOPERO COME DIRITTO
L’art. 40 Cost.: «il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano»
Lo sciopero costituisce:
a) Un diritto soggettivo pubblico di libertà, che inibisce la legislazione penale di reprimere lo sciopero,
salvo in ipotesi estreme;
b) Un diritto soggettivo del lavoratore subordinato nei confronti del datore di lavoro, che consente nel
diritto di astenersi dal lavoro per sciopero, il cui esercizio, pur implicando la perdita della
retribuzione, vale ad escludere che l’astensione dia luogo a un inadempimento contrattuale.
Nella Carta di Nizza dell’UE, all’art. 28, si proclama il diritto…di azioni collettive, tanto ai lavoratori quanto ai
datori di lavoro, e alle rispettive organizzazioni, sebbene in conformità alle legislazioni e prassi nazionali
(clausola di conformità).
LA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI SCIOPERO
La direttrice dell’opera interpretativa sul diritto di sciopero ha preso in considerazione la sola area del
lavoratore subordinato, fatte salve circoscritte eccezioni caratterizzate dalla presenza di particolari esigenze
di ordine pubblico.
Tale equiparazione è venuta meno con la sent. 222/1975 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato
l’illegittimità della norma della serrata posta in essere dagli esercenti di piccole industrie privi di lavoratori
alle proprie dipendenze, ritenuta in contrasto con l’art. 40 proprio perché la sospensione dell’attività di
quei soggetti doveva in realtà qualificarsi come sciopero.
Ne è derivata una tendenza espansiva, che ha condotto la Cassazione sui medici convenzionati al SSN) a
riconoscere la titolarità del diritto di sciopero anche ai lavoratori parasubordinati, alla quale la Consulta ha
posto un freno, facendosi interprete della dottrina di riportare le astensioni dei lavoratori autonomi sotto
l’ombrello della libertà di associazione, come poi riconosciuto nella l. 146/1990.
A ridosso della Costituzione, ha prevalso l’idea per cui il titolare del diritto di sciopero dovrebbe essere
ritenuto non il lavoratore singolo, ma l’associazione sindacale. Oppure, il sindacato era ritenuto contitolare
del diritto di sciopero assieme al lavoratore.
Secondo la tesi che ha prevalso in dottrina, e affermatasi nella giurisprudenza e nella prassi, titolare del diritto
di sciopero è, invece, ciascun singolo lavoratore.
Lo sciopero è stato configurato, dunque, come diritto individuale ad esercizio necessariamente collettivo.
Ciò comporta l’estromissione dell’associazione sindacale dalla fattispecie giuridica dello sciopero, senza
togliere che la maggior parte degli scioperi sia preceduta dalla proclamazione da parte dei sindacati. Tale
proclamazione non è però indispensabile. Uno sciopero può essere proclamato, o attuato, anche a
prescindere da un sindacato, e quindi da parte di coalizioni occasionali di lavoratori, anche nel dissenso dei
sindacati.
Se il diritto appartiene a ciascun lavoratore, l’eventuale clausola contrattuale (di tregua sindacale) con la
quale un’associazione sindacale si impegna a non ricorrere per certi periodo allo sciopero, è di natura
meramente obbligatoria, e non normativa, dunque:
a) Non incide nella sfera giuridica dai singoli lavoratori (anche se affiliati al sindacato firmatario della
clausola in questione)
b) Vincola, ed espone a sanzioni soltanto il sindacato o i sindacati che l’hanno sottoscritta.
2Il TU Rappresentanza prevede che i contratti collettivi aziendali, approvati secondo la procedura prevista dal
TU che definiscono clausole di tregua sindacale e sanzionatorie, finalizzate a garantire l’esigibilità degli
impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante, oltre che per il datore di lavoro, per
tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori nonché per le associazioni sindacali espressioni delle
confederazioni firmatarie del presente accordo, o per le organizzazioni che ad esso abbiano formalmente
aderito, e non per i singoli lavoratori.
Peraltro, in nome del principio dell’esigibilità del contratto collettivo, le parti firmatarie e le rispettive
associazioni di categoria non debbono adottare iniziative in contrasto a un contratto collettivo approvato nel
rispetto della regola di maggioranza, e prefigura la previsione, da parte dei CCNL, di sanzioni (anche
pecuniarie) per le imprese e soprattutto per i sindacati in caso di violazione del divieto.
La legge 146/1990 ha creato le condizioni di un governo sindacale del conflitto, conferendo alle organizzazioni
sindacali il potere di stipulare accordi collettivi rivolti a individuare le prestazioni indispensabili, che debbono
essere garantite anche in caso di sciopero.
Tale tesi si scontra con la legge, ha confermato l’assunto della titolarità individuale con esercizio collettivo:
Art. 2 soggetti che proclamano lo sciopero;
Art. 3 soggetti che promuovono lo sciopero;
Art. 4 organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero;
Art. 8 soggetti che---proclamano l’astensione
La legge 146/1990 ha ritenuto possibile conferire alle parti sociali il potere di dettare norme regolatrici dello
sciopero.
Un modo di conciliare le diverse esigenze potrebbe essere quello di riconoscere la titolarità del diritto di
sciopero direttamente all’organizzazione sindacale.
Lo sciopero dovrebbe essere riletto, come un diritto a titolarità collettiva, cioè esercitabile da qualsiasi,
seppure elementare, organizzazione collettiva di lavoratori, così come da un’associazione sindacale, e a
esercizio individuale (liberà di partecipare o no).
EFFETTI DELLO SCIOPERO SUL RAPPORTO DI LAVORO
Il lavoratore che si astiene dal lavoro esercita il diritto di sospendere l’esecuzione della prestazione lavorativa,
per cui non è inadempiente, e non può patire conseguenze negative, né disciplinari né risarcitorie, sul piano
del rapporto di lavoro.
È pacifico che la partecipazione a uno sciopero comporta, in applicazione del principio di corrispettiva
sinallagmatica fra le prestazioni, la perdita della retribuzione.
La sospensione dell’obbligazione retributiva non è circoscritta alla parte di retribuzione immediatamente
compensativa della prestazione di lavoro, masi estende agli istituti retributivi differiti, come le mensilità
aggiuntive.
Il problema più discusso da giurisprudenza e dottrina è quello degli effetti dello sciopero articolato o parziale
nei confronti di lavoratori non scioperanti.
I non scioperanti potrebbero essere, nella realtà, sostanziali partecipanti all’azione di sciopero, pur essendo
in quel momento teoricamente disponibili ad adempiere; per cui la messa di libertà dei medesimi da parte
del datore di lavoro potrebbe mascherare una serrata di ritorsione nei confronti degli scioperanti. Oppure
potrebbe trattarsi di dipendenti effettivamente estranei allo sciopero.
La giurisprudenza affronta questa tematica separandola della valutazione sulla legittimità dello sciopero per
cui «quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a
una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta…» estinto il diritto del lavoratore, la cui
prestazione sia divenuta temporaneamente impossibile in conseguenza dello sciopero, di esigere la
corrispondente retribuzione.
La giurisprudenza tende a adottare un’accezione ampia di impossibilità, esonerando il datore di lavoro
dall’erogazione retributiva non soltanto nei casi di impossibilità assoluta della prestazione lavorativa, ma
anche in quelli di mera inutilizzabilità, o persino di non proficuità, della prestazione medesima.
Questo orientamento è stato oggetto di critiche dottrinali (il rifiuto di retribuzione sarebbe una sanzione di
fatto dello sciopero).
3LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Negli scioperi di servizi l’arma è anche il danno provocato all’utenza, in merito però anche a diritti altrettanto
o più importanti di quelli di sciopero.
Negli anni ’80 del secolo scorso questo settore è divenuto sindacalmente esplosivo, per la proliferazione di
nuovi sindacati, in genere “di mestiere” o “di professione”, inclini all’adozione di strategie fortemente
rivendicative e conflittuali.
La legge 146/1990 – elaborata con il sostanziale consenso politico dei sindacati confederali (e nel dissenso
di quelli minori) – ed è stata congegnata in modo da lasciare ampio spazio, nella fase di attuazione, alla
contrattazione collettiva, e dunque i sindacati stessi. Per bilanciare il sistema, è stata creata una Autorità
indipendente, la Commissione di Garanzia.
È stato altresì ridefinito più democraticamente il regime della precettazione.
I LIMITI ALL’ESERCIZIO DELLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Concetto guida: il diritto di sciopero, nell’ambito delle amministrazioni o delle imprese eroganti determinati
servizi pubblici essenziali, deve esercitarsi nel rispetto del contenuto essenziale di determinati diritti della
persona, tutelati costituzionalmente salvaguardia di un nucleo di diritti.
L’art 1 contiene l’elenco di questi diritti, costituenti limiti esterni al diritto di sciopero vita, salute, libertà,
sicurezza, libera circolazione, assistenza, previdenza sociale, istruzione, libertà di comunicazione.
Versante più importante è quella dell’identificazione dei servizi rivolti a garantire il soddisfacimento di tali
diritti.
L’art. 1 precisa che l’enumerazione dei servizi contenuti in esso non precluda di identificarne altri, là dove
siano funzionali al soddisfacimento dei diritti tutelati.
Sono menzionati: la sanità; l’igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta o lo smaltimento dei rifiuti
urbani e di quelli speciali; le dogane; l’amministrazione della giustizia; l’apertura al pubblico dei musei;
protezione ambientale e vigilanza culturale; libertà di circolazione; assistenza e previdenza sociale: servizi
di erogazione degli importi; istruzione quella pubblica, gli scrutini finali e gli esami superiori, gli
universitari per gli esami conclusivi del ciclo di istruzione.
Nell’ambito di applicazione così delineato, la direttiva della legge è per il bilanciamento fra diritto di sciopero
e diritti della persona.
Lo sciopero deve essere esercitato nel rispetto delle prestazioni indispensabili, tali da garantire l’effettiva
tutela del contenuto essenziale. Lo sciopero può essere regolato soltanto limitatamente a tali prestazioni
indispensabili.
Le parti prima di proclamare uno sciopero, debbono attivare le procedure di raffreddamento e di
conciliazione, finalizzate a una composizione pacifica del conflitto e previste dai contratti collettivi. Qualora
non intendano adottare le procedure previste da tali contratti, debbono essere esperite dinanzi a un soggetto
terzo (Prefetto, Ministro del Lavoro), a seconda del carattere del conflitto. Solo dopo tali procedure i soggetti
possono proclamare lo sciopero.
Deve esserci dunque una formale proclamazione, all’atto della quale debbono essere comunicati per iscritto,
col rispetto di un termine minimo di preavviso di 10 giorni rispetto alla data prevista per l’azione, la durata,
le modalità di attuazione, nonché le motivazioni dell’astensione collettiva del lavoro.
Il preavviso (almeno 5 giorni) è finalizzato al rispetto degli obblighi di predisporre le misure
indispensabili, tenute a garantire l’utenza, nonché comunicare tempestivamente l’elenco dei servizi garantiti.
Un’eventuale revoca spontanea dello sciopero, dopo che v’è già stata l’informazione all’utenza
(effetto annuncio) costituisce forma sleale di azione sindacale, valutata dalla Commissione per l’eventuale
irrogazione delle sanzioni previste.
Le disposizioni non si applicano:
Astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale;
Sciopero di protesta contro gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori
La legge stabilisce che le parti debbono indicare intervalli minimi fra l’effettuazione di uno sciopero e la
proclamazione di quello successivo «quando ciò sia necessario a evitare che, per effetto di sciopero
4proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o lo stesso
bacino di utenza sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all’art. 1»
Da alcune delibere della Commissione di garanzia, discendono due regole:
Rarefazione soggettiva: un sindacato che proclama uno sciopero non può proclamare un secondo
sciopero nel medesimo servizio, se non dopo che sia trascorso un lasso di tempo dalla effettuazione
del precedente;
Rarefazione oggettiva: gli scioperi proclamati in un servizio debbono essere distanziati da un lasso
di tempo, indipendentemente dal soggetto proclamante.
Fermo il rispetto delle regole illustrate, deve svilupparsi l’attività dei contratti collettivi, rivolta a individuare,
su rinvio della legge, le prestazioni indispensabili vere e proprie.
Spetta ai contratti collettivi «disporre l’astensione dello sciopero di quote strettamente necessarie
di lavoratori tenuti alle prestazioni e indicare le modalità per l’individuazione dei lavoratori
interessanti, ovvero […] forme di erogazione periodica dei servizi», nonché di indicare gli intervalli
minimi necessari per rispettare la regola della rarefazione, tanto soggettiva quanto oggettiva.
Il rinvio è – nel settore privato – ai contratti collettivi senza specificazioni di rappresentatività. Una volta che
i contratti collettivi in questione sono stati conclusi, le relative previsioni sono efficaci erga omnes a
prescindere dall’iscrizione ai sindacati firmatari.
LA COMMISSIONE DI GARANZIA
La normativa in esame ha istituito una Commissione di garanzia dell’attuazione della legge, investita
di importanti funzioni:
Favorire in ogni modo l’accordo fra le parti in conflitto, convocandole in apposite audizioni o
sollecitando le medesime a incontrarsi per confrontarsi sul problema oggetto della vertenza ed
eventualmente a differire l’agitazione per procedere a un ulteriore tentativo di mediazione;
Valutare l’idoneità dei contratti collettivi a proteggere i diritti dell’utenza;
Riempire il vuoto lasciato dalle parti o riparare le idoneità tramite la formulazione alle parti di una
proposta, con invito a recepire in un accordo collettivo i contenuti della stessa, nonché con
l’adozione, nel caso che le parti non seguano l’invito, di una regolamentazione provvisoria degli
scioperi nel settore, destinata a rappresentare l’unico parametro di individuazione delle prestazioni
indispensabili da parte della Commissione;
Segnalare in via preventiva le eventuali violazioni delle regole legali o contrattuali sullo sciopero,
che emergono già dall’atto di proclamazione. Tale potere è molto utilizzato dalla Commissione,
conoscendo gli errori nei quali sono incorse e di correggere la proclamazione, oppure di revocare lo
sciopero e procedere a una nuova proclamazione.
LE SANZIONI DELLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Le sanzioni individuali sono di carattere disciplinare. Debbono essere proporzionate alla gravità
dell’infrazione – art. 2016 c.c. – con esclusione di misure estintive del rapporto, cioè del licenziamento.
Deve trattarsi di sanzioni conservative, tali da non comportare mutamenti definitivi del rapporto, e da
irrogare nel rispetto della procedura e dei limiti di contenuto prescritti dall’art. 7 l. 300/1970.
L’art. 4 detta sanzioni collettive destinate alle organizzazioni che proclamano uno sciopero.
Nei confronti di esse sono previste:
1. La sospensione dei permessi sindacali retribuiti per la durata dell’astensione, tra un minimo di 2500€
e un massimo di 50000€, tenuto conto di vari elementi tra cui la gravità della violazione;
2. La sospensione, in alternativa a quella (a) o cumulativamente con essa per la durata dell’astensione,
3. della facoltà di riscuotere i contributi sindacali;
4. La possibile esclusione da qualunque trattativa sindacale per un periodo di almeno 2 mesi, a
decorrere dalla cessazione dello sciopero effettuato in violazione delle regole legali;
Sono previste sanzioni amministrative di carattere pecuniario per i rappresentanti legali delle P.A. che non
abbiano fatto il possibile per garantire l’osservanza della legge.
Se tutto ciò non funziona, esiste un rimedio estremo, la precettazione.
Questo è un provvedimento amministrativo, con forma di ordinanza, la cui adozione presuppone l’esistenza
5di un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente
tutelati.
È possibile precettare, cioè comandare al lavoro, quote di lavoratori, tramite l’emanazione di un
provvedimento del Presidente del Consiglio o di un Ministro, qualora il conflitto sia nazionale, o del Prefetto,
qualora esso abbia un rilievo esclusivamente locale.
L’attivazione di tale procedimento potrebbe avvenire soltanto a seguito di una indicazione in tal senso da
parte della Commissione di garanzia.
Nella prassi, l’autorità precettante procede spesso autonomamente, o sulla base della segnalazione
preventiva inviata dalla Commissione.
Qualora neppure la precettazione sia osservata, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, ma questa
volta di rilevante importo [min. 500€ max. 1000€ per giorno di mancata ottemperanza], a carico dei soggetti
inosservanti.
I soggetti che promuovono lo sciopero possono impugnare il provvedimento di precettazione, entro il
termine di 7 giorni dalla comunicazione dello stesso, davanti al Tribunale amministrativo regionale
competente per territorio, qualora si ravvisino limiti di legittimità.
http://www.abcdeidiritti.it/website/ https://www.fpcgil.it/?home
6Puoi anche leggere