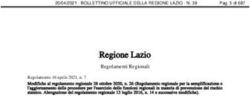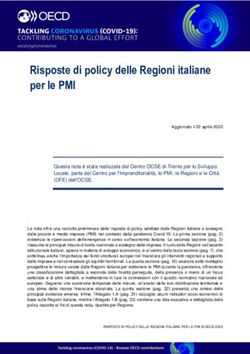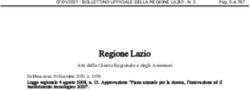Conferenza Episcopale Marchigiana - Convegno Ecclesiale ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Conferenza Episcopale Marchigiana
Archivio Storico
La trasmissione della fede
nelle Marche
attraverso stralci di Congressi, Convegni, Lettere Pastorali e Verbali
delle Riunioni dell’Episcopato Marchigiano
dal 1850 al 2011
Sintesi storica e
antologia di alcuni documenti d’archivioSigle e Abbreviazioni
Archivio della Conferenza Episcopale Marchigiana ACEM
REGIONE ECCLESIASTICA MARCHE, Verbali delle riunioni della Conferenza VER, Vol. I
Episcopale Marchigiana, 1850-1899, vol I, Pro-manuscripto, 2010.
REGIONE ECCLESIASTICA MARCHE, Verbali delle riunioni della Conferenza VER, Vol. II
Episcopale Marchigiana, 1900-1929, vol II, Pro-manuscripto, 2011.
REGIONE ECCLESIASTICA MARCHE, Verbali delle riunioni della Conferenza VER, Vol. III
Episcopale Marchigiana, 1930-1949, vol III, Pro-manuscripto, 2010.
REGIONE ECCLESIASTICA MARCHE, Verbali delle riunioni della Conferenza VER, Vol. VI
Episcopale Marchigiana, 1970-1979, vol VI, Pro-manuscripto, 2010.
REGIONE ECCLESIASTICA MARCHE, Verbali delle riunioni della Conferenza VER, Vol. VII
Episcopale Marchigiana, 1980-1989, vol VII, Pro-manuscripto, 2008.
REGIONE ECCLESIASTICA MARCHE, Verbali delle riunioni della Conferenza VER, Vol. VIII
Episcopale Marchigiana, 1990-1999, vol VIII, Pro-manuscripto, 2009.
REGIONE ECCLESIASTICA MARCHE, Verbali delle riunioni della Conferenza VER, Vol. IX
Episcopale Marchigiana, 2000-2004, vol IX, Pro-manuscripto, 2008.
REGIONE ECCLESIASTICA MARCHE, Verbali delle riunioni della Conferenza VER, Vol. X
Episcopale Marchigiana, 2005-2007, vol X, Pro-manuscripto, 2008.
REGIONE ECCLESIASTICA MARCHE, Notiziario della Conferenza Episcopale NOT, N° I
Marchigiana, N° I, Pro-manuscripto, 2007.
REGIONE ECCLESIASTICA MARCHE, Notiziario della Conferenza Episcopale NOT, N° II
Marchigiana, N° II, Pro-manuscripto, 2008.
REGIONE ECCLESIASTICA MARCHE, Notiziario della Conferenza Episcopale NOT, N° III
Marchigiana, N° III, Pro-manuscripto, 2009.
REGIONE ECCLESIASTICA MARCHE, Notiziario della Conferenza Episcopale NOT, N° IV
Marchigiana, N° IV, Pro-manuscripto, 2010.
REGIONE ECCLESIASTICA MARCHE, Notiziario della Conferenza Episcopale NOT, N° V
Marchigiana, N° V, Pro-manuscripto, 2011.
REGIONE ECCLESIASTICA MARCHE, Concili plenari della regione Marche 1850- CONC
1989, Andrea Livi Editore, Fermo 2011
2Premessa - Cenni Storici
L’8 dicembre 1849 il Papa Pio IX emanava l’Enciclica Nostis et nobiscum nella quale
raccomandava ai Vescovi: Perigite, ut iam instituistis, coetus habere inter vos. Con queste parole il
Pontefice li invitava a discutere e confrontarsi sui problemi comuni. Probabilmente il coetus cui si
riferisce Pio IX doveva essere considerato in relazione ai fatti rivoluzionari di quell’anno e alla
necessità di difendere i diritti e la libertà della Chiesa, tenendo informata la Santa Sede sul
succedersi degli avvenimenti nei vari ambiti nazionali.
Nel 1850 Egli autorizzava il Conventus Lauretanus dei Vescovi della Marca e della provincia
di Urbino che si svolse a Loreto dal 23 febbraio al 12 marzo. Furono trattati prevalentemente
argomenti riguardanti gli ecclesiastici e le attività pastorali, con particolare riguardo all’educazione
dei candidati al sacerdozio.
Il 24 agosto 1889 la Congregazione dei Vescovi e Regolari, emanò l’Istruzione “Alcuni
Arcivescovi” nella quale si davano disposizioni ai Presuli italiani affinché si riunissero sulla base di
raggruppamenti regionali per discutere temi di interesse comune tra le Diocesi della stessa area
geografica. La predetta Istruzione costituisce uno dei primi documenti veri e propri emanati dalla
Santa Sede per le riunioni dei Vescovi italiani che ebbe un esito positivo.
Si realizzò così nel 1892 il primo Conventus episcoporum delle Marche. Ancor prima di questa data
i Vescovi marchigiani si sono incontrati collegialmente nel 1863 promulgando la Nota Pastorale
“Sopra il Sacramento del Matrimonio”.
Il 15 febbraio 1919 la Sacra Congregazione Concistoriale, a seguito della pubblicazione del
Codice di Diritto Canonico, procedeva a una nuova definizione delle Regioni per la celebrazione
delle Assemblee dei Vescovi in Italia, mantenendo l’obbligo per le Conferenze Episcopali
Regionali di riunirsi con cadenza annuale.
L’8 maggio 1933 la Sacra Congregazione Concistoriale comunicava che la presidenza della
Conferenza Episcopale Regionale debba essere assunta dal Metropolita antiquior.
Il 29 novembre 1939 Pio XII, con suo Decreto, disponeva che a presiedere le Conferenze Regionali
fosse l’Arcivescovo della Diocesi sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale per le cause
matrimoniali.
Il 1 agosto 1954 la Santa Sede promulgava lo Statuto provvisorio della Conferenza
Episcopale Italiana, composta da Cardinali Vescovi residenziali in Italia, da una Segreteria generale
e dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali. Il 10 agosto 1967 la Sacra Congregazione
Concistoriale stabiliva che il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario venissero eletti
liberamente a tempo determinato dalla stessa Conferenza Episcopale Regionale.
Il 21 novembre 1981 nel discorso ai Vescovi della Campania in Visita ad Limina, il Beato
Giovanni Paolo II sottolineava l’utilità delle Conferenze Episcopale Regionali con queste parole: Ad
evitare dispersioni di energie, diversità di indirizzi nelle scelte, iniziative saltuarie e disarticolate,
si avverte sempre più la necessità di un autentico coordinamento unitario non solo a livello
diocesano, ma altresì a livello regionale. Occorre, per il bene della Chiesa, saper superare,
nell’unità e nella carità, un certo tipo di non bene intesa autonomia, che potrebbe manifestarsi, alla
prova dei fatti, o inutile o inefficiente.
Il 4 novembre 1994 veniva promulgato, da parte della Congregazione per i Vescovi, il
Decreto con il quale si riconosceva la personalità giuridica della Regione Ecclesiastica Marche con
proprio Statuto.
3Catechesi e formazione
Fare memoria della consolidata prassi dei Convegni e Congressi, soprattutto di quelli con
incidenza evangelizzatrice e degli innumerevoli frutti prodotti può essere di aiuto a tutte le persone
impegnate nella preparazione del Convegno Ecclesiastico Regionale del 2013. Per questo motivo
cercheremo di ripercorrere la loro storia avendo come punto di riferimento i Documenti dei Concili
Plenari Marchigiani e i Verbali della Conferenza Episcopale Marchigiana.
Dal 1850 al 1929.
Fin dagli inizi della sua esistenza, la Conferenza Episcopale Marchigiana ha posto una grande
attenzione all’aspetto pastorale della vita religiosa della nostra regione. Già con il Conventus
Lauretanus1 del 1850 i Vescovi, per la prima volta riuniti collegialmente, hanno deliberato
sull’unificazione dell’insegnamento nei seminari della regione. Tale provvedimento, esteso sia ai
Seminari Minori sia ai Seminari Maggiori, aveva come scopo principale la più agevole e migliore
possibile istruzione che doveva dare frutti nella loro educazione futura.2
In quella occasione hanno anche introdotto un aspetto innovativo nella vita dei giovani
sacerdoti, l’idea di istituire comunità di giovani sacerdoti3, che avrebbero dovuto continuare la loro
formazione sacerdotale (comunitaria, intellettuale e pastorale) sotto la guida di un sacerdote
“esperto” nominato dal Vescovo. Per l’attuazione di questa formidabile intuizione si è dovuto
attendere quasi 150 anni. Nelle Diocesi si è continuato di fatto a far vivere i sacerdoti novelli
all’interno del Seminario. Questa prassi era determinata dalle reali difficoltà economiche delle
Diocesi di poter istituire dette “case del clero”4.
1
CONC, pp. 1-57.
2
Ibidem., pp. 47-52.
3
Ibidem., pp. 46-47: «Non vi sarebbe al certo cosa tanto adatta a fare buoni operaii evangelici nella vigna del Signore
quanto l’istituire in ogni diocesi un convitto pei sacerdoti novelli. Doppio vantaggio ne verrebbe da siffatta istituzione
cioè dopo aver compiuto il corso degli studi in seminario trovarebbero in esso il modo di esercitarsi e perfezionarsi nelle
varie incombenze del loro ministero, in guisa che all’uopo ne uscirebbero quali adatti a sostenere l’incarico d’una
parrocchia, quali (…) per reggere una Cattedra, e quali portati ad ammaestrare il popolo dagli altari. Inoltre i sacerdoti
di ciascuna diocesi avrebbero in esso una casa di ritiro in cui fare per turno i SS. Esercizi una volta almeno per un
biennio. E avventurato sarebbe quel Vescovo che fornito tutto lì’occorrente il suo seminario potesse por mano ad
impresa così utile ed eccellente. Siccome però gravi ostacoli si paran d’innanzi perché siffatto utile divisamento non si
compia, e specialmente vengono meno mezzi che molti si addimandano pel buon impianto al mantenimento di questa
novella istituzione, così si crede bene di potere raggiungere se non in tutto, almeno in parte lo stesso scopo
appigliandosi al seguente partito. Si propone cioè in supplemento provvisorio.
1° Che a nessuno de sacerdoti novelli per qualsiasi ragione sia permesso di uscire di seminario prima di aver compiuto
l’intero corso degli studi.
2° che uscitine ancora per altri due anni si occupino assiduamente nel praticare i doveri del sacerdozio coadiuvando i
parrochi nelle varie incombenze del loro officio abilitandosi ad ascoltare le confessioni e facendo bene … dei discorsetti
morali ad istruzione del popolo.
3° Se poi in qualche seminario si vedessero fiorire dei giovanetti di straordinario ingegno, i quali col tempo render
potessero gran frutto al vantaggio del Clero e ad onore della Chiesa, allora per accordo già stabilito tra i VV di
un’istessa provincia dovranno esser mandati nel seminario di quella diocesi, in cui si conoscerà esservi professori idonei
a perfezionare questi chierici in quella scienza, in cui addimostrano speciali propensioni ed ivi lasciarli fino a tanto che
non si siano per modo istruiti da poterne addestrare gli altri pagandosi pel mantenimento di ciascuno l’annua dozzina di
36 più sopra determinata Ed ecco per tale espediente trovato il modo di formare in ciascuna diocesi zelanti sacerdoti ed
eccellenti maestri ed raggiunto in parte lo scopo, cui mirava l’istituzione di un convitto diocesano.».
4
Solamente nell’anno 2001, vengono istituite, dall’allora Vescovo di Macerata, due “comunità per giovani sacerdoti”,
la prima a Macerata nei locali dell’ex-Seminario e la seconda a Recanati inizialmente presso la Parrocchia
4Nell’anno 1863 i Vescovi radunati nell’annuale Congresso, dopo aver preso atto dell’iter
legislativo, presso il Parlamento Italiano di una legge che permettesse i matrimoni civili, si
accingono a formulare una “Istruzione Pastorale sopra il Sacramento del Matrimonio”5. Il
documento espone - in brevi paragrafi - la dottrina tradizionale sulla natura del matrimonio6, i
Diritti della Chiesa sul Sacramento del Matrimonio Cristiano7, l’assurdità del Matrimonio Civile8 e
le sue funeste conseguenze9, l’invito rivolto ai cristiani:
(…) avendo la Divina Provvidenza statuito nel cuore di queste fortunate contrade il centro della
cattolica unità, e il primo maestro della fede, e della morale non permetta mai che vi si barbichi la
mala pianta d’una istituzione corrompitrice della morte, e della fede. Noi intanto impugniamo con
tutte le nostre forze e solennemente, ed altamente protestiamo contro qualunque legge di civile
Matrimonio, e dichiariamo, che non insegneremo altra dottrina che quella della Chiesa, a’ cui
comandi vogliamo solo obbedire, in cosa ch’è tutta sacra e divina.
E qui sull’ultimo ritornando il nostro discorso a Voi, o carissimi, e dolcissimi nostri figli in Gesù
Cristo, noi vi preghiamo, e scongiuriamo di tenervi fermi nella Dottrina della Chiesa Cattolica
vostra tenera Madre; di udire docili i nostri insegnamenti, e di stare saldi, ed incontrollabili nei
principii di quella fede, e nei precetti di quella morale, che professarono, ed adoperarono per XIX
secoli i padri vostri e che sono indispensabili per conseguire l’eterna salvezza. 10
Nel verbale della riunione della Conferenza, tenutosi a Loreto, nel giugno 190411 S.E. Mons.
Cucchi, facendo riferimento alla riunione della Conferenza del 1901 12 dimostra la necessità
dell’introduzione di un testo unico per il Catechismo in tutta la Regione. Dopo un’animata
discussione viene deciso di rivolgersi al Pontefice per avere da Lui una parola autorevole al
riguardo. In attesa della risposta da parte della Santa Sede, i Vescovi concordano di adottare il
Catechismo del Ven. Bellarmino, lasciando aperta la possibilità di aggiornarlo con un’apposita
appendice.13
dell’Addolorata, poi trasferitasi nel complesso di Beato Placido. Successivamente sono sorte “comunità presbiterali”
nelle cinque Vicarie della diocesi.
5
VER., Vol. I, pp. 71-85.
6
Ibidem., p. 73.
7
Ibidem., p. 75.
8
Ibidem., p. 78.
9
Ibidem., p. 82.
10
Ibidem., p. 84
11
VER. Vol. II, pp. 29-46.
12
Ibidem., p. 3: «Si riconosce la convenienza, si espongono i vantaggi di un Testo unico di Catechismo nella Regione; e
tutti sono unanimi in tale apprezzamento. Si fa notare che i Vescovi della Liguria, della Lombardia e dell’Emilia sono
giunti a questo in base del Catechismo Casati con piccole modificazioni, e queste cosi lievi che il Catechismo
dell’Emilia poco o nulla si differenzia da quello adottato nelle nominate Regioni, e quindi è proposto che venga questo
adottato anche per le Marche, e ciò ancora per giungere più facilmente alla desiderata unita di Testo in tutta 1’Italia -
Dopo varie considerazioni in proposito si viene di unanime parere alle seguenti conclusioni: 1. Si ammette in massima il
Testo unico - 2. Si prenderà in considerazione e si assoggetterà ad esame il Catechismo in base Casati adottato
dall’Emilia - 3. Ciascun Vescovo della Regione ne avrà una copia su cui farà le osservazioni che crederà opportune, e
dentro l’anno in corso le rimetterà, in Ancona al Card. Presidente - 4. Una Commissione esaminerà le osservazioni fatte,
ed emetterà un definitivo giudizio sul Testo da adottarsi e ne curerà la stampa - 5. Viene eletta la Commissione, e si
dichiara esaurito il soggetto.».
13
Ibidem., p. 3: «La parola è a Mons. Cucchi il quale dimostra l’importanza di un testo unico pel Catechismo, non
dissimula le difficoltà che devono superarsi, come gl’inconvenienti che devono incontrarsi in un cambiamento, pure sa
che il congresso se né occupato molto nelle Conferenze dell’Avellana, (…) una commissione stabilita all’uopo, la quale
era al termine dei suoi lavori quando per particolare incidente dovette tutto sospendere. Nelle Conferenze dell’Avellana
si trattò del catechismo e fu’ unanime il parere che si procurasse un testo unico alla Regione adottando un Catechismo
che fosse già stato adottato da molte Diocesi, mentre così si sarebbe più facilmente ottenuto lo scopo di un testo unico
in tutta l’Italia. Fu’ proposto che le piccole modificazioni a questo giungero di Vescovi del Piermonte, della Liguria,
5In questi decenni i Vescovi ravvisano una costante necessità di promuovere, con ogni mezzo
ed a ogni costo, la formazione cristiana dei fanciulli e degli adulti. I Vescovi della Marca Inferiore
scrivendo, nel 1911, la “Lettera Pastorale al Venerabile Clero e Diletto Popolo delle loro
Diocesi”14, tracciano un quadro molto realistico della situazione nella quale versa l’insegnamento
della Dottrina, da parte dei sacerdoti:
(…) Basta l’occasione di una festa (e se ne fanno tante, troppe anzi!) magari d’una chiesupola (…)
basta che in questa o quella circostanza negli anni passati non siasi fatta la spiegazione del
catechismo, perché il Parroco si creda autorizzato a tralasciarla, trasgredendo così un dovere che
gli è ben chiaramente e gravemente imposto. Quando poi si faccia questa spiegazione del
catechismo agli adulti, pur troppo talvolta avviene di dover riconoscere ch’essa e per l’orario e per
il metodo e per la forma dell’esposizione sembri più atta, non diremo ad istruire, non diremo
nemmeno ad anoiare, ma ad indispettire i fedeli, ed in modo particolare gli uomini e le persone
anche mediocremente istruite della parrocchia.15
(…) è per questo che Noi prendemmo ben determinate disposizioni sia sulla spiegazione del santo
vangelo, sia sulla dottrina dei fanciulli ed il catechismo degli adulti: e nutriamo fiducia saranno di
tutti i nostri sacerdoti scrupolosamente osservate. Si ricordino i nostri amatissimi parroci che
questo è loro strettissimo e grave dovere di giustizia e di carità ad un tempo: e agli altri sacerdoti
rammentiamole grazie ricevute, i santi propositi fatti, l’ufficio a loro commesso nell’ordinazione
sacerdotale, né vogliamo seppellire, ne li scongiuriamo, il talento ricevuto, dimenticare i sacri
giuramenti fatti l’ufficio a loro commesso nell’ordinazione sacerdotale, né vogliamo nell’atto di
ascendere l’altare, tradire l’ufficio cui furono assunti dalla bontà del Signore. Pertanto se non sono
astretti da vincolo di giustizia, almeno per sentimento di carità, per sentimento di compassione per
questi cari fanciulli, per questo buon popolo avido della luce di verità e del fuoco santo del bene,
non si rifiutino mai di sedere al loro fianco, di schiudere il loro labro, e far loro da maestri. Oh!
carissimi sacerdoti, si dovrà dunque dire: «Pueri petierunt panem en non erat qui frangerer eis?!».
Non vi infastidisca la vivacità e talvolta la indisciplinatezza dei fanciulli; non vi scoraggi la poca
frequenza o disattenzione (forse più apparente che reale) dei fedeli: se persevererete nel vostro
ufficio con ordine, chiarezza prudenza, affidabilità ed amore, a poco a poco trionferete del cuore
dei fanciulli; essi anzi si affezioneranno a voi e vi compenseranno largamente colla loro bontà dei
della Lombardia e dell’Emilia in base al Catechismo Casali che poteva prendersi a base del Catechismo da adottare
nelle Marche. Dopo lunga discussione si stabilì che ciascun Vescovo ne avrebbe una copia e dentro l’anno avrebbe
mandato in Ancona le proprie osservazioni, queste sarebbero state esaminate unitamente al testo, e si sarebbe formulato
e dato alla stampa un Catechismo per tutti. La commissione era al termine dei propri lavori quando la notizia della
ristampa del Catechismo del Ven. Bellarmino per la Regione Romana con l’approvazione del S. Padre fa tutto
sospendere e rimettere alle attuali Conferenze. Si legge il verbale della commissione e la circolare con la quale,
consenzienti i vescovi, furono sospesi i lavori. Segue un animata discussione se debba proseguirsi il lavoro a base
Casali o non piuttosto adottarsi il Catechismo del Ven. Bellarmino. Si legge il Breve di Leone XIII col quale è
approvato per la Regione Romana, e raccomandato alle altre Regioni il Bellarmino. In questo, viene esposto, che per
alcune comunicazioni avute, si può sperare che il S. Padre voglia occuparsi del unificazione del Catechismo. Si legge in
proposito una comunicazione del Catechista Cattolico di Piacenza. In questo stato di cose sono tutti di parere che si
umilii al S. Padre una rispettosa dimanda in proposito, in cui si esponga il desiderio dei Vescovi delle Marche
dell’unificazione del Catechismo. Si accenni come se ne siano occupati nelle Conferenze, e che di fronte ad una
concepita speranza che voglia la Santità Sua nella Sua Apostolica sollecitudine occuparsene attendano una benigna
parola di conforto che sarebbe stata la norma delle loro decisioni in proposito. Si conviene facilmente che quando il
Pontefice dichiarasse di volersene occupare si sarebbe atteso il Catechismo che venisse da Lui proposto continuando
l’istruzione Religiosa con i Catechismi attualmente propri di ciascuna Diocesi, nel caso contrario fa proposta se si
dovranno continuare i lavori intrapresi in base del Catechismo Casali, o adottare piuttosto il Catechismo del Venerab.
Bellarmino adottato dalla Regione Romana. Dopo varie considerazioni in proposito per appello nominale tutti
convennero che fosse adottato il Catechismo del Ven. Bellarmino che si procurerebbe anche possibilmente con ristampe
tale quale fù adottato dalla Regione Romana. Si aggiunge di comune consenso che in seguito potrà aggiungersi ad esso
una breve appendice tale quale si crederà necessaria ed opportuna dai Vescovi all’uopo interpellati.».
14
VER., Vol. II, pp. 99-138.
15
Ibidem., p. 105.
6piccoli dispettucci di un giorno, quando non vi conoscevano ancora, né erano in grado di
apprezzare il bene che voi volevate loro.16
Come possiamo constatare da questi brevi cenni, la situazione, riguardante la trasmissione della
fede non era rosea, già allora c’erano tante difficoltà e problemi, la “svogliatezza” da parte di alcuni
sacerdoti, e l’eccessiva vivacità da parte dei bambini.
Nel 1914, a Loreto viene celebrato un Congresso dei Parroci Marchigiani, riguardante
proprio il problema della trasmissione della fede17. In una Lettera Pastorale18 del marzo 1916 i
Vescovi adempiono, con approvazione Pontificia, al voto scaturito dal Congresso del aprile 1914 e
istituiscono la Direzione Catechistica Marchigiana, che si proponeva di19:
facilitare il gravoso compito di organizzare il movimento catechistico regionale;
provvedere alla compilazione ed alle modifiche di un programma regionale unico per
l’insegnamento catechistico e di sceglierne i libri;
promuovere concorsi catechistici;
organizzare Congressi Regionali e Diocesani;
pubblicare un bollettino mensile catechistico.
Con questa lettera viene introdotta una novità epocale: “Resta definitivamente abolito in tutte le
parrocchie della regione il metodo esclusivamente mnemonico rettilineo; e deve sostituirsi il
metodo ciclico intuitivo in forma di vera scuola colla distinzione delle classi per ambedue i sessi.
(…) il catechismo ufficiale per tutta la nostra regione è quello che venne pubblicato dal Sommo
Pontefice Pio X (…) nell’anno 1912”.20
Proprio in questa occasione vengono istituiti i programmi particolareggiati dell’insegnamento
catechistico21. Tale programma, diviso in quattro anni, aveva come linee guida per ciascun anno i
seguenti argomenti:
del Simbolo Apostolico;
dei Comandamenti di Dio e della Chiesa;
dei Santissimi Sacramenti;
della Orazione e della Giustizia Cristiana.
In occasione della Pasqua del 1919, l’Episcopato Piceno, della Marca Inferiore, indirizza al
Clero un “Esercizio Spirituale”22 nel quale ancora una volta ribadisce la necessità, attraverso
Missioni, Esercizi e Conferenze di ritemprare la fede e la carità cristiana.23
16
Ibidem., p. 106.
17
Nell’archivio della CEM non ci sono documenti riguardanti questo incontro, le notizie a suo riguardo abbiamo dalla
L’Ora Presente. Lettera Pastorale degli Arcivescovi e Vescovi del Piceno, adunati a Fermo, il 20 marzo 1916.
18
L’Ora Presente. Lettera Pastorale degli Arcivescovi e Vescovi del Piceno, adunati a Fermo in VER., Vol. II, pp. 145-
187.
19
Cfr. Ibidem, p. 173.
20
Cfr. Ibidem, p. 184.
21
Cfr. Ibidem, pp. 176-183.
22
Esercizio Spirituale. Lettera Pastorale dell’Episcopato Piceno per la S. Pasqua del 1919, in VER. Vol. II, pp. 203-
237.
23
Ibidem, p. 203: «La S. Chiesa, sempre vigile madre e maestra, (…) ordinava sapientemente che prima di riprendere
gli amati ministeri e studi, avessero a fare un corso di Esercizi Spirituali, al fine di purificarsi dalla polvere mondana
potuta contrarre in ambienti tanto difformi dallo spirito ecclesiastico e risalire con lena alle pure sorgenti della propria
educazione sopranaturale. Sull’esempio del Supremo Pastore, non ci sarà, crediamo, Vescovo o Parroco zelante che non
desideri fare altrettanto, secondo la possibilità e le circostanze, con tutti i loro fedeli reduci dalle gloriose battaglie.
7Da queste brevi osservazioni si può vedere che dal 1850 al 1929 la preoccupazione
fondamentale dei Vescovi Marchigiani era rivolta alla formazione del clero e del popolo. Sarebbe
interessante mettere a confronto le lettere pastorali dei Vescovi della Marca Inferiore e della Marca
Superiore. I primi pongono l’accento sull’aspetto pastorale e catechetico, i secondi prevalentemente
sull’aspetto pastorale e normativo. Questa distinzione è ben visibile nelle lettere che essi scrivono al
clero delle loro diocesi in occasione della Pasqua del 1919. I primi si concentrano sull’esercizio
spirituale, che si snoda partendo dalle vie della ragione (nella prima parte)24 per poi ripartire dalle
vie della fede (nella seconda parte)25 e concludere con l’affidamento alla Vergine Maria26.
I secondi27 partono dal Codice di Diritto Canonico, appena entrato in vigore, per riproporre al clero
e attraverso i sacerdoti al popolo una normativa riguardane molteplici argomenti, tra i quali: vita
sacerdotale, Sacramento della Confermazione, Prima Comunione, Matrimonio, Custodia e culto
della SS. Eucarestia, Catechismo ai fanciulli, Catechismo agli adulti, SS. Missioni, ecc.
Queste due impostazioni non sono contrapposte o in antitesi, ma vanno coniugate tra di loro:
anche attraverso la legislazione canonica può manifestarsi lo slancio verso la trasmissione della fede
e la preoccupazione per la formazione.
Il Concilium Plenarium Picenum28, svoltosi a Loreto nel 1929, tratta all’interno del Capitolo
IV, all’Articolo I29 la questione dell’educazione catechetica, facendo particolare riferimento alla
normativa codiciale del CJC.
Missioni, Conferenze, Esercizi tutto si porrà in opera per ritemprare la fede e la carità del popolo cristiano, restaurare i
danni morali della guerra e aiutare con una vita intemerata, sia individuale che domestica, gli sforzi dei governanti e
degli studiosi tendenti a ravviare il mondo sulle vie della giustizia ed assicuragli il godimento della pace.».
24
Cfr. VER. Vol. II, pp. 205-218.
25
Ibidem, pp. 219-235.
26
Ibidem, p. 236.
27
Gli Arcivescovi e Vescovi della Marca Superiore al Venerabile Clero delle loro Diocesi, in VER., Vol. II, pp. 239-
257.
28
Concilium Plenarium Picenum (1929), in CONC., pp. 60-105.
29
Ibidem, pp. 95-96: «189. Meminerint animarum praesertim pastores, ad normam canonis 1329, proprio et gravissimo
officio teneri catecheticam sive puerorum, sive adultorum institutionem curandi.
190. Iidem, ad normam canonis 1330, singulis annis, tempore praesertim quadragesimae, pueros puellasque preparent:
a) per decem saltem dies continuos ad sacramenta Poenitentiae et Confirmationis rite suscipienda; b) per triginta saltem
dies continuos ad primam Communionem recipiendam.
191. §1. Praeterea diebus dominicis, vel alia die infra hebdomadam ab Ordinario determinanda, per integram horam, in
christiana doctrina uberius et perfectius ad normam canonis 1331, et, iuxta regulas in Appendice XV-a relatas, pueros, et
puellas instituant.
§2. Satagant ut haec catechetica institutio tradatur in sacellis quoque ruralibus, in Missa diebus festis celebratur.
192. Omnes sacerdotes, a proprio parocho invitati, ad normam canonis 1333, operam suam libenter praestent
catecheticae puerorum institutioni, memores etiam de hoc ministerio rationem habendam esse in beneficiorum
collatione; quod si illegittime recursaverint, sciant, se poenis, privationis quoque facultatis concionandi et confessiones
audiendi, a proprio Ordinario plecti posse
193. Ad mentem canonis 711 §2, in quavis paroecia, intra annum ab huius Concilii promulgatione, confraternitates seu
sodalitates SS. Sacramenti et doctrinae christianae, si nondum exstent, a loci Ordinario instituantur (Append. XV-b).
194. In qualibet schola catechetica magistri in apposito libro adnotent puerorum frequentiam et profectum, et de iisdem,
periculo facto in anni fine, ratio habeatur in sollemni praemiorum distributione.
195. Curent locorum Ordinarii ut, praesertim apud pia vel religiosa Instituta, scholae magistri catechismi formentur et,
periculo facto, idoneitatis diplomate donentur.
196. §1. Parochi, concionatores et confessarii ne omittant parentes aliosque, ad quos spectet, ad normam canonum 1113,
1335 et 1372, monere de gravi qua adstringuntur obligatione instituendi in doctrina christiana pueros sibi subiectos vel
commendatos.
§2. Edoceant praeterea poenitentes, qui hoc munus graviter negligant, neque se illud impleturos serio promittant, esse
absolutione indignos.
8Dal 1930 al 1940.
Nella riunione della Conferenza30, tenutasi il 30 novembre 1931 ad Ancona, i Vescovi, in
riferimento al Coordinamento dell’azione degli Uffici Catechistici Diocesani 31, hanno ritenuto
“superflua” la figura dell’incaricato regionale. Questo avviene dopo l’istituzione dell’Ufficio
Catechistico Centrale presso la Sacra Congregazione Concistoriale.32
Nella festa della Purificazione della Beata Maria Vergine dell’anno 1933, l’Episcopato
marchigiano indirizza al Clero Secolare, Regolare e ai dilettissimi fedeli una Lettera Pastorale33,
con lo scopo di invitare i fedeli al sacro raccoglimento, alla preghiera e alla penitenza34. Trattano
dei diversi disordini nel campo morale: bestemmia, mancata santificazione delle feste, problema dei
matrimoni, moda precoce e impudente. Dopo aver invitato il lettore alla penitenza, i Vescovi
esprimono il più vivo compiacimento per l’annuncio fatto da Pio XII di indire, per la domenica di
Passione dell’anno 1934, un Giubileo Straordinario35. In conclusione di questa pastorale, viene
annunciato il prossimo Congresso Eucaristico Regionale da tenersi a Macerata.36
Ancora per due volte i Presuli ritorneranno sull’argomento del Congresso Eucaristico Regionale e
dei Comitati Organizzatori37.
197. §1. Parochi magistros, qui in scholis publicis institutionem religiosam pueris tradunt, speciali benevolentia
prosequantur, eosque consilio et opera adiuvent, ut ad mentem canonis 1373, suum munus obire valeant.
§2. Iidem iuxta canonem 469, invigilent, ne quid contra fidem et mores praesertim in scholis tradatur; quod si id
contigerit rem Ordinario referant.
198. Deputati ad inspectionem prae oculis habeant rationem institutionis religiosae in qualibet schola, et iuxta S. Sedis
praescripta, relationem scriptam ad proprium Ordinarium mittant.
199. Parochi aliique animarum curatores ad normam canonis 1332, tempore quo maior populi concursus in ecclesia
haberit poterit, diebus dominicis aliisque festis de praecepto, per dimidiam explanent, iuxta schema in Appendice XVI
relatum.
200. Animarum curatores qui, causa a proprio Ordinario non probata, catecheticas institutiones puerorum vel adultorum
habitualiter omittant, graviter puniantur etiam sospensione a divinis.».
30
VER., Vol. III, pp. 9-14.
31
Auspicati dal Congresso dei Parroci del 1914, e approvati dal Concilio Plenario Piceno del 1929.
32
«Nella Appendice XV. del Concilio P.P. è detto che per tale coordinamento la Conferenza nominerà persona di sua
fiducia, ecc. e fu di fatto nominato Mons. Giovanni Antonietti di Pergola, il quale ora chiede se e come possa compiere
l’ufficio suo. La Conferenza, considerando che poi fu costituito presso la S.C. del Concilio un ufficio Catechistico
centrale, e che gli Uffici Catechistici Diocesani, tenuti da precise disposizioni di mandare al Centrale relazioni annuali e
triennali, ritiene sia divenuta superflua l’opera di uno speciale incaricato regionale: molto più che un ispettore regionale
è riconosciuto dalla stessa S.C. del Concilio nella persona di Mons. Recanatini di Ancona, in rapporto allo
insegnamento religioso nelle scuole pubbliche.» in VER., Vol III, pp. 12-13.
33
Lettera Pastorale collettiva degli Arcivescovi e Vescovi delle Marche per la Quaresima 1933, in VER., Vol. III, pp.
25-32.
34
Ibidem., p. 25.
35
Ibidem., p. 29.
36
«In questa confidenza ci conferma il pensiero del VI Congresso Eucaristico della Regione, che avrà luogo a Macerata
nel venturo Settembre e al quale vi invitiamo a partecipare largamente; poiché tra i frutti di bene che è destinato a
portare, dovrà rendere più fervida ed efficace la buona volontà di profittare dei tesori spirituali a tutti aperti nell’Anno
Santo.» Ibidem., p. 29.
37
Nella riunione del 20 maggio 1936: «S. E. Mons Ferri, Presidente dei Congressi Eucaristici Regionali, fa notare agli
Ecc.mi presenti che col 1938 si compiono venticinque anni dall’inizio del movimento eucaristico nella nostra Regione.
Propone di celebrare la data con un nuovo Congresso Eucaristico Marchigiano, da tenersi in OSIMO. La proposta è
unanimemente accolta.» in Ibidem., p. 62. Nella riunione del 19 maggio 1938, Mons. Ferri propone di celebrare il 25°
anniversario dei Congressi Eucaristici nelle Marche ad Urbino: «S. E. Mons. Ferri propone che il Congresso
Eucaristico, che l’anno venturo si celebrerà ad Urbino, sia cambiato da Diocesano in Regionale, in commemorazione
del 25° anniversario del I° Congresso della Regione, celebrato precisamente in quella città; così dalla medesima
ricomincerebbe il turno. S. E. l’Arcivescovo Mons. Tani, mentre apprezza giustamente il pensiero, oppone varie
difficoltà (…), delle quali l’Episcopato si rende pienamente conto (…).» in Ibidem., p. 79.
9Dal 1941 al 1949.
È molto importante evidenziare il fatto che anche durante la guerra i nostri Vescovi hanno
continuato ad riunirsi con la cadenza annuale, ad eccezione del 1943 e del 1944.
Nel settembre del 1941 i Vescovi decidono di scrivere al Clero della nostra regione una Lettera
Pastorale38. Facendo memoria del 1° Congresso Catechistico Marchigiano del 1914, scrivevano:
(…) non è la prima volta che l’Episcopato Marchigiano si occupa collettivamente del
grande problema. È una gioia della nostra Regione il 1° Congresso Catechistico Marchigiano che
si tenne a Loreto nell’Aprile 1914. In quel Congresso, al quale parteciparono personalità
competentissime, si venne a conclusioni così sagge ed opportune che furono poi adottate anche in
altre Regioni, ed alcune di esse si trovano ripetute anche nel citato Decreto Pontificio.
Un altro atto collettivo dell’Episcopato Marchigiano in fatto di Catechismo è l’articolo
«De catechetica institutione» del Concilio Plenario Piceno dell’anno 1929. Le norme in esso
contenute sono un piccolo trattato fatto con grande criterio pratico e, nel suo genere, completo.
Questo nostro nuovo atto collettivo ha lo scopo di aggiornare i precedenti, disponendo
l’introduzione nei nostri catechismi parrocchiali di tutte quelle sapienti norme che il Decreto
«Provido sane», che è come il Codice completo di tutta la legislazione catechistica, ci fornisce. 39
La questione della catechesi viene presentata prendendo come punto di riferimento l’opera di S.
Agostino “De catechizandis rudibus”:
La Chiesa e il Catechismo40;
Il Decreto “Provido sane”41;
Necessità del Catechismo42;
A chi spetta procurare ai fanciulli l’insegnamento del Catechismo43;
Confraternita della Dottrina Cristiana44;
Scuole Catechistiche Parrocchiali45;
Gli Insegnanti e la loro formazione46;
38
Lettera collettiva dell’Episcopato Marchigiano sul Catechismo Parrocchiale, a norma del Decreto “Provido sane
Consilio” in VER., Vol. III, pp. 97-114.
39
Ibidem., pp. 98-99.
40
Ibidem., pp. 97-98.
41
Ibidem., pp. 98-99.
42
Ibidem., pp. 99-100.
43
Ibidem., pp. 100-102. In questa occasione viene evidenziato in maniera forte anche il ruolo dei genitori: «Da ultimo il
Decreto si rivolge ai genitori «i quali sono gravissimamente obbligati a procurare, secondo le loro forze, l’educazione
sia religiosa e morale, che fisica e civile della loro prole». Queste parole, che il Decreto cita ad litteram dal Can. 1113
del Codice, sono l’espressione concreta del grave dovere che ad essi incombe sia in forza della legge di natura che in
forza della loro professione cristiana. Purtroppo non sempre i genitori hanno piena coscienza di questo dovere; voi
stessi, venerati Confratelli, lo avete mille volte lamentato. Lo stesso lamento ripeteva il Sommo Pontefice Pio XI nella
sua memoranda Enciclica sulla educazione della gioventù, dove notava che molti genitori moderni si interessano di tutto
ciò che riguarda i figli meno che della loro educazione «quod profecto, dice il grande Papa, caut est officii patris
familias».» in Ibidem., p. 101.
44
Ibidem., pp. 102-104.
45
Ibidem., pp. 104-105.
46
A riguardo dei catechisti è opportuno notare: «La distinzione delle classi richiede la pluralità degli Insegnanti. (…) i
Parroci devono tenere la presidenza della loro scuola catechistica. È quindi assai opportuno che essi - se appena è
possibile - non si leghino ad insegnare nell’una o nell’altra classe (…). Una loro visita in ogni classe, mentre si
impartisce l’insegnamento, conserverà alla scuola quel senso di disciplina e di serietà che facilmente perderebbe se i
fanciulli ed i maestri non si sentissero continuamente sotto l’occhio affettuosamente vigile dei loro Parroci. Occorrono
dunque tanti Insegnanti quante sono le classi. La loro formazione costituisce senza dubbio una grave difficoltà che però
dobbiamo ad ogni costo superare. Gli Insegnanti devono essere convenientemente preparati alla loro missione per la
conoscenza della Religione, devono avere qualche nozione di Pedagogia Catechistica e soprattutto devono grandemente
amare la causa a cui si dedicano. Il Parroco è il loro naturale Maestro. Nessuna cosa gli deve stare tanto a cuore quanto
la loro preparazione spirituale e culturale, poiché i Catechisti saranno i suoi più preziosi collaboratori nel compito arduo
10Il metodo e il testo47;
Il Calendario48;
I locali49;
Sussidi didattici50;
Il Catechismo agli adulti51;
e delicato del suo ministero. Vi sia dunque in ogni Parrocchia la Scuola per i Catechisti che si svolga secondo il
programma che ciascun Vescovo darà per la sua Diocesi. A corso compiuto coloro che l’avranno diligentemente
frequentato potranno avere, dopo un esame sostenuto dinanzi ad un rappresentante dell’Ufficio Catechistico Diocesano,
il Diploma di Catechisti. I catechisti si devono reclutare fra i migliori elementi della Parrocchia. «I primi scelti, dice il
Decreto «Provide sane», saranno tutti quelli che sono iscritti all’Azione Cattolica. Sono queste Associazioni che hanno
già fatto tanto anche in questa materia, e in modo veramente lodevole». È tanto desiderabile che i catechisti non
vengono reclutati solo fra l’elemento femminile; vi sono anche degli ottimi giovani che sanno apprezzare questa nobile
missione e compierla egregiamente. Essi sono i maestri più indicati per le scuole maschili. A quanti vi presteranno la
loro opera esprimete, dilettissimi Confratelli, tutto il nostro plauso, assicurateli della nostra particolare benevolenza. E
più della nostra, assicurateli della benevolenza di Colui che considera fatto a Sé quanto si fa per i fanciulli.» in Ibidem.,
pp. 105-106.
47
Su questo argomento sono interessanti, anche a distanza dei anni, le considerazioni dei Vescovi: «(…)
l’insegnamento catechistico si svolga secondo un metodo prescritto. (…) Quale sarà dunque il metodo da seguire nei
nostri catechismi? Quello che meglio risponderà al fine dell’istruzione religiosa, il qual fine ci viene indicato da S.
Agostino in alcune note espressioni: «quid quid narra ita narra, ut ille cui loqueris audiendo credat, credendo speret,
sperando amet». Voi vedete da queste parole del grande Dottore che il Catechismo deve essere dato in modo vivo,
cercando di illuminare l’intelligenza del fanciullo e di disporla all’atto di fede; elevando il pensiero a Dio nella
speranza, e finalmente eccitando il suo piccolo cuore buono e generoso all’amore divino. Lo stesso S. Agostino
suggeriva al Diacono Deogratias di servirsi molto, per raggiungere questo fine, della S. Scrittura, scegliendo i brani più
salienti e più confacenti all’argomento che si tratta e traendone quegli insegnamenti e quegli affetti che la verità è atta a
suscitare. Per rendere vivo ed efficace l’insegnamento serviranno molto spesso anche le cose sacre, gli abiti ed i vasi
liturgici, il battistero, l’altare, il confessionale, i quadri che si trovano nelle Chiese. Potranno anche servire le bellezze
della natura, un fiore, un frutto, un episodio della vita quotidiana dei fanciulli. Così faceva Nostro Signore, il quale dalle
più umili scene della vita dei suoi discepoli, traeva i più sublimi insegnamenti. (…) Sono stati pubblicati anche molti
testi, alcuni dei quali assai pregevoli. Fra questi noi abbiamo pensato di sceglierne uno che dovrà essere adottato col
prossimo anno catechistico in tutte le scuole parrocchiali della nostra Regione Ecclesiastica, ed è il testo edito
dall’Azione Cattolica. (…)I testi per le elementari sono fatti con sistema ciclico, e danno ogni anno al fanciullo un’idea
completa, sempre più vasta, della religione; gli altri sono redatti con sistema continuativo o rettilineo e dividono il
programma in vari anni. Ogni lezione porta una figura tolta generalmente dalla S. Scrittura e su di essa si impernia tutta
la spiegazione che viene data con criterio di sano attivismo per stimolare le facoltà del fanciullo, interessarlo e fargli più
piacevolmente comprendere e più profondamente ritenere le verità imparate. Le lezioncine contengono le formule che il
fanciullo deve apprendere a memoria, perché in un insegnamento dogmatico, qual’è il nostro, se si abbandonasse lo
studio a memoria della formula, si esporrebbe il fanciullo a farsi idee imprecise ed erronee. Alla fine di ogni lezioncina,
specialmente nelle classi superiori, vi sono domande a cui il fanciullo dovrà rispondere, meglio se anche in iscritto, e la
indicazione di qualche lavoro che deve fare per esprimere con i suoi mezzi le verità apprese.» in Ibidem., pp. 106-108.
48
«(…) vi sia una lezione ordinaria di catechismo in tutti i giorni di domenica, od in altro giorno fra la settimana da
determinarsi dall’Ordinario, ed inoltre due corsi straordinari ogni anno; uno di dieci giorni in preparazione ai
Sacramenti della Penitenza e della Confermazione, l’altro di trenta giorni in preparazione alla Prima Comunione. (…)»
in Ibidem., pp. 108-109.
49
Ibidem., p. 109.
50
Ibidem., pp. 109-110.
51
Questo argomento è stato trattato dal Concilio Piceno del 1929: «Parochi aliique animarum curatores ad normam
canonis 1332, tempore quo maior populi concursus in ecclesia haberit poterit, diebus dominicis aliisque festis de
praecepto, per dimidiam explanent, iuxta schema in Appendice XVI relatum.» in CONC., p. 96. «(…) La gravità del
dovere (…) si fa evidente altresì dalla dolorosa condizione di molte anime le quali, mancando di convinzioni religiose
solidamente stabilite sulla chiara conoscenza delle verità della fede, posseggono una religiosità assai superficiale che le
spinge a qualche esteriore manifestazione, ma non costituisce affatto l’intima regola della loro vita. Per combattere
questo male non bastano le predicazioni ordinarie, non basta nemmeno la spiegazione del Vangelo dei giorni festivi,
perché essa non può contenere quella metodica esposizione delle verità cristiane di cui le anime abbisognano. (…) Per
togliere al popolo l’impressione che a santificare la festa bastano le funzioni del mattino, si eviti di impartire la
benedizione col SS. mo Sacramento nelle ore antimeridiane e si riservi al pomeriggio. Alla benedizione vespertina
accorre sempre un discreto numero di persone: esse formeranno un primo nucleo di ascoltatori delle istruzioni
catechistiche, e vogliamo confidare che coll’insistenza nel ripetere gli inviti e col buon esempio che verrà dato dai più
11La giornata catechistica52;
I Sacerdoti Visitatori53;
Altre forme del Catechismo54;
Relazione annuale55;
i Vescovi concludono la loro Lettera Pastorale citando le parole di S. Pio X, invitando i sacerdoti a
procurare ed ottenere che la cristiana dottrina pervada gli animi di tutti56.
Nella riunione della Conferenza del 08/10 aprile 1946 viene deciso di continuare ad usare
nella Regione il Catechismo dell’Azione Cattolica57.
L’avvicinarsi delle elezioni politiche, del aprile 1948, spinge l’Episcopato Marchigiano ad
emanare una “Notificazione al Clero”58 nella quale si impartiscono le direttive relative a:
Cosa devono imparare i fedeli “dell’insegnamento Ufficiale dall’altare”59;
Il comportamento del sacerdote nell’amministrare il Sacramento della Confessione60;
Richiesta ai sacerdoti di mettersi a capo di una crociata di preghiera, mobilitando in essa i
Monasteri, le Congregazioni Religiose, l’Azione Cattolica, le Confraternite, ecc.61
Nella riunione, svoltasi nell’aprile del 1949, i Vescovi inseriscono all’ordine del giorno il
problema dell’allontanamento dei fedeli dalla pratica religiosa. Tale allontanamento viene
individuato nell’ignoranza in materia di religione e di morale62, vengono segnalati diversi modi per
combattere tale ignoranza, tra di essi sono di particolare rilievo: il quinquiennio della Prima
buoni, e specialmente dagli iscritti alle Associazioni, il gruppo si renderà sempre più numeroso. È superfluo osservare,
venerati Confratelli, che queste nostre istruzioni catechistiche devono essere preparate accuratamente per riuscire brevi,
chiari ed efficaci. Raccomandiamo vivamente anche ai Religiosi di seguire la stessa norma relativa alle benedizioni del
mattino, e di non lasciar mancare mai, ai fedeli che frequentano le loro Chiese, l’istruzione catechistica vespertina.», in
VER., Vol. III, pp. 110-111.
52
Ibidem., pp. 111-112.
53
Ibidem., p. 112.
54
Ibidem., pp. 112-113.
55
Ibidem., p. 113.
56
Ibidem., pp. 113-114.
57
Ibidem., p. 128.
58
Notificazione al Clero, in VER., Vol. III, pp. 133-136.
59
Ibidem., p. 133.
60
«(…) i Sacerdoti si rifacciano alle regole generali della morale, che si possono ridurre ai seguenti punti (…) a) un
penitente chiede al confessore se può iscriversi al Comunismo - la risposta è ovvia: No, assolutamente; b) un penitente
in mala fede dichiara di appartenere al comunismo. Lo si avverta che non può essere assolto, se non abbandona il
comunismo. E ciò a più forte ragione se ne fosse un propagandista. c) Un penitente in buona fede dichiara di
appartenere al comunismo. Il Confessore deve illuminarlo efficacemente e imporgli di abbandonarlo. Se non vuole
ubbidire, per sé non può essere assolto. Se però può supporsi che sia ancora in buona fede e si teme che, rimandato,
non torni più, sarà bene assolverlo, purché però prometta di astenersi da ogni propaganda e da tutto ciò che è
intrinsecamente male. (…) Del resto i Sacerdoti ricordino che, per parte loro, debbono cercare di portare i penitenti che
si accusano colpevoli circa dottrine condannate dalla Chiesa, all’assoluzione dei peccati, con l’eccitare in essi quelle
disposizioni (pentimento del male commesso, proposito di astenersene), che possono ottenere la loro assoluzione.
Trattare con paternità e bontà, con comprensione del disorientamento attuale delle menti, fare in modo di riordinare la
coscienza di chi si confessa, di dargli la grazia di Dio, che lavorerà poi nel segreto come luce per l’intelligenza e forza
per la volontà: ecco la nostra missione di Confessori. Se poi a questo non si può addivenire, responsabile sarà il
penitente del rifiuto di un’assoluzione che gli si darebbe tanto volentieri. (…)» in Ibidem., pp. 134-135.
61
Ibidem., pp. 135-136.
62
Verbale della riunione del 06-07 Aprile 1949, in VER, Vol. III, pp. 137-139.
12Comunione, una conveniente preparazione catechistica e spirituale, una maggiore cura spirituale
rivolta verso le associazioni, ecc.63
Dal 1950 al 1969.
A seguito della riunione del 27/30 marzo 1950, i Vescovi inviano alla Congregazione del
Concilio una relazione riguardante l’insegnamento religioso nella Regione Marche64. In questa
occasione viene evidenziata la necessità ed utilità di rilanciare la Festa della Dottrina Cristiana e si
consiglia di istituire, almeno nei centri maggiori, le Commissioni di Padri di Famiglia65. Viene
anche trattato l’argomento della separazione della S. Cresima dalla Prima Comunione66, tale
argomento viene inoltre trattato anche nella riunione del 14 aprile 1951.
Nella riunione svoltasi nel novembre dello stesso anno, vengono istituite le Commissioni per
la preparazione del nuovo Concilio Plenario Piceno67, che viene celebrato a Loreto, dal 5 al 9 aprile
1956, i decreti saranno promulgati nel giugno del 1958, dopo la recognitio della Congregazione del
Concilio.
I Decreti68 seguono lo schema fissato dal Codice di Diritto Canonico, ma la preoccupazione
più grande dei Presuli marchigiani, si evince dal discorso di apertura del Concilio, pronunciato dal
Legato Pontificio, Mons. Perini. Dal suo discorso di apertura si desume la necessità di adeguare la
legislazione vigente, in modo da favorire una prassi pastorale unica, in netta contrapposizione a
tutto ciò che è contrario alla chiesa e all’annuncio evangelico69.
63
«(…) Mezzi di apostolato più efficaci per ricondurre alla vita cristiana tante anime che si allontanano. Poiché molto si
deve alla ignoranza in materia di religione e di morale si segnalano come mezzi efficaci: il quinquennio ed anche
decennio della Prima Comunione, con una conveniente preparazione catechistica e spirituale. - Catechismo e
Conferenze per i fidanzati, per i padrini della Cresima. - Conferenze, specialmente nell’inverno, in forma catechistica
per adulti e giovani. - La predicazione della Quaresima e del Mese Mariano sia trattata in forma di catechesi. - Ritiri di
perseveranza. - Maggior cura spirituale degli associati in AC, Confraternite, Pie unioni. - Diffondere tra i sacerdoti ed
anche tra gli intellettuali il libro dell’Ecc.mo Agrisani sul Comunismo. - Propaganda catechistica spicciola per la
campagna, curando molto l’istruzione catechistica nelle Cappellanie, specialmente se tenute da religiosi.» in Ibidem., p.
138.
64
La notizia è riportata all’interno del Verbale della riunione del 27/30 Marzo 1950, in ACEM (Fondo: Verbali - Note
Pastorali, Serie: Verbali, Fasc.: 2, Doc.: 19).
65
Ibidem. «(…) Viene proposto anche che nei centri maggiori si istituisse le Commissioni di Padri di Famiglia che si
interessino della Scuola e dei propri figli: si faccia qualche corso speciale per le Giovani dell’Istituto Magistrale,
rilasciando alla fine un Diploma di Abilitazione all’Insegnamento della Religione. Si insista anche maggiormente sulla
festa della Dottrina Cristiana da tenersi in Settembre o ai primi di Ottobre, con invito dei Genitori.».
66
Ibidem.: «Il problema per le Marche è molto delicato e grave: piuttosto che una Disposizione Collettiva
dell’Episcopato (…), si procuri di insistere presso i Parroci, onde con la persuasione preparino così il clima per la
ventura disposizione.».
67
Verbale della riunione del 28 Novembre 1950, in ACEM (Fondo: Verbali - Note Pastorali, Serie: Verbali, Fasc.: 2,
Doc.: 20).
68
CONC., pp. 107-202.
69
Ibidem., p. 196: «(…) urge il Comunismo, che noi consideriamo dal punto di vista teologico e condanniamo come
sintesi di eresie, avente a base la negazione di tutto ciò che non è materia. Di là s’insinua il Protestantesimo; e l’uno e
l’altro tentano di forzare l’argine potente e verdeggiante e fiorito che la Madonna, quasi a difesa e ad ornamento, ha
elevato, intorno al suo Santuario, centro spirituale e cuore vivo delle Marche. Il pericolo dall’interno è la diminuita
cognizione delle verità religiose nei nostri fedeli. Proprio oggi diminuisce lo studio delle eterne verità, quando le menti
reclamano non formule ma convinzioni; quando le tradizioni si svuotano, se non sono nutrite di sode motivazioni, e
quando tutto converge a stemperare, in questo esoterismo fastoso e spensierato, ciò che c’è di più sostanziale nella vita:
la verità e l’onestà, la religione e la morale (…)».
13Tutta la parte quarta, intitolata De magisterio ecclesiastico70, viene dedicata all’istruzione
catechetica, ai discorsi sacri, alla professione di fede e la sua tutela, ai Seminari, all’Azione
Cattolica e all’azione politica e sociale.
Nel Capitolo primo71 viene trattata in modo capillare l’istruzione catechetica che, in sintesi
possiamo così descrivere:
Uffici catechetici necessari in ogni Diocesi72;
Necessità di una scuola diocesana per la formazione dei catechisti73;
Necessità di impartire la formazione religiosa74;
Prescrizione dell’organizzazione della festa annuale del catechismo, dei concorsi e congressi
catechistici, uniformazione del testo da utilizzare75;
Viene stabilito a chi e in che modo, deve essere impartito, in modo particolare
l’insegnamento76;
Vengono date le prescrizioni riguardanti la prima confessione e comunione77;
nonché sull’insegnamento nelle scuole primarie e secondarie78;
Opportunità di riservare una particolare attenzione evangelizzatrice a determinati ambiti dei
fedeli79.
70
Ibidem., pp. 172-182.
71
Ibidem., pp. 172-175.
72
Cfr. Ibidem., p. 172: «In unaquaque dioecesi, vigeat “Officium Catechisticum dioecesanum”».
73
Cfr. Ibidem.: «Curent locorum Ordinarii ut saltem in episcopali civitate schola magistralis instituatur quae diplomata
conferat de idoneitate ad catecheticam doctrinam tradendam. Optandum est ut huiusmodi scholae, Ordinario favente,
etiam in maioribus pagis dioecesis et apud pia instituta oriantur tum pro laicis tum pro religiosis foeminis.».
74
Cfr. Ibidem., pp. 172-173: «Ad normam cann. 1333 et 1334 C.J.C. parochis et Ordinariis libere quaerentibus libenter
auxilium praestent sive religiosi sive clerici sive pii laici, praesertim si actioni catholicae inscripti sint. (…) Parochi,
concionatores et confessarii saepe saepius moneant parentes, vel qui parentum locum tenent, et patrinos de gravi qua
adstringuntur obligatione instruendi in doctrina christiana sibi subiectos.».
75
Cfr. Ibidem., p. 173: «(…) Singulis annis in omnibus paroeciis celebrandam praecipimus diem catecheticam, quam
vocant. (…) Valde commendamus concursus et congressus catecheticos, tum dioecesanos, tum vicariales, tum
paroeciales. (…) Textum commendamus qui ab Ordinario approbatus est pro dioecesi. Pro adultis edocendis parochus
saepius prae manibus habeat aureum illum «Catechismus ad Parochos» qui post Concilium Tridentinum. Zelo maxime
S. Caroli, in lucem prodiit.».
76
Cfr. Ibidem.: «(…) Officium fideles docendi, de quo can. 1329 C.J.C. loquitur, rite adimpletum haberi nequit, nisi
catechetica instructio ad omnes coetus et ad singulos fideles paroeciae perveniat. (…) Catechetica proinde instructio
tota sic dirigatur: pro pueris in genere a prima schola ad 14 annum et pro pueris ad confessionem, ad communionem et
ad confirmationem praeparandis; pro pueris qui scholas primarias frequentant; pro alumnis scholarum secundariorum;
pro iuvenibus in genere; pro peculiaribus coetibus. (…) Pro pueris in genere, parochi unaquaque die de praecepto vel
alia opportuniore in hebdomada lectionem habeant catecheticam in forma vere scholastica, id est cum distinctione sexus
et aetatis, cum libris et regestis et apparatu ex quo austeritas scholae eruitur.».
77
Cfr. Ibidem., pp. 173-174: «(…) a) Primis puerorum confessionibus anteponatur congrua catechetica instructio
necnon immediata praeparatio quae facile reddat examen conscientiae et adiuvet pueros ad eliciendos, pro captu, actus
necessarios. b) Pro primam communionem recepturis imponimus instructionem quotidianam saltem duorum mensium,
qua pueri perveniant ad cognitionem quam can. 854 C.J.C. requirit. Curent Parochi ut haec maxime instructio, non
solam mentem, sed et cor afficiat et voluntatem puerorum, et resumantur paucis diebus sacrae recollectionis, immediate
ante diem primae communionis. c) Pro sacra confirmatione imponimus instructionem quotidianam unius mensis, qua,
puer fusius discat principia seu praecepta divini illius Ducis cuius per confirmationem efficitur miles.».
78
Cfr. Ibidem., p. 174: «(…) Pro scholis primariis debent parochi vel sacerdotes ad id deputati: invigilare ut institutio
tradita a magistris laicis ab Ordinario adprobatis omnino sana sit quoad praecepta moralia et recta quoad dogma; binas
visitationes unicuique classi facere, alteram ineunte, alteram exeunte anno; tradere, vel per se vel per alium sacerdotem,
viginti lectiones quas italica lex concedit in superioribus tribus annis. (…) Pro scholis secundariis, quas vocant,
eligantur in magistros sacerdotes scientia, pietate et omnimoda ratione praeclari, qui se sciant, non tantum ad docendas
veritates mancipatos, sed etiam ad christianae vitae praxim iuvenibus suadendum, immo et ad totius scholae mores recte
conformandos (…)».
79
Cfr. Ibidem., pp. 174-175: «(…) Probrum omnino censemus et periculis plenum quod religiosa instructio criticae illi
aetati desit in qua quisque vias arripit a quibus, etiam cum senuerit, non recedet. Ne tanta fiat jactura, valde
14Puoi anche leggere