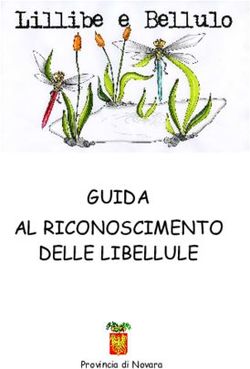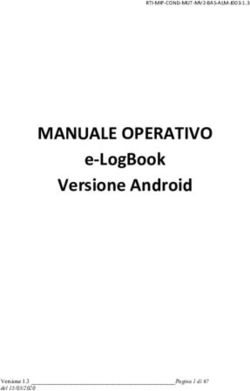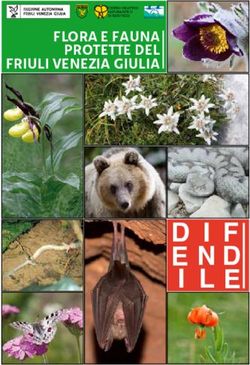Litorali sabbiosi e organismi animali
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
63 Litorali sabbiosi e organismi animali PAOLO AUDISIO ■ Condizioni di vita negli habitat costieri sabbiosi Come abbiamo già accennato nei capitoli introduttivi, le coste sabbiose costi- tuiscono degli ambienti che per loro natura mettono a dura prova la sopravvi- venza degli organismi animali. I naturali fattori di stress che governano la sopravvivenza delle zoocenosi costiere sono molteplici, ma i più rilevanti pos- sono essere così sintetizzati: ● La natura mobile del substrato, spesso effimera e variabile nello spazio e nel tempo, con la sabbia che, sospinta dal vento, tende frequentemente a ricoprire gli organismi animali più minuti e le loro potenziali risorse trofiche ● L’aridità del substrato a livello degli ambienti dunali e di spiaggia emersa, soprattutto nella stagione estiva, legata all’incapacità dei granelli di sabbia di trattenere significativamente l’umidità di origine meteorica, di per sé già limitata ● La povertà di nutrienti di norma presenti nei substrati di spiagge e dune sabbiose, in grado quindi di sostenere comunità relativamente limitate sia di produttori primari che di consumatori ● La salsedine, intesa sia come tenore salino dell’acqua circolante o imbiben- te i terreni, le sabbie umide e gli accumuli di detriti organici di origine marina, sia come presenza di cloruri che si trovano in vario modo in sospensione nella bassa troposfera, per azione dell’areosol marino, o cristallizzati al suolo per effetto della disidratazione superficiale, almeno fino al dilavamento e alla dilui- zione operati dalle piogge ● L’insolazione spesso molto marcata, specialmente nella stagione estiva, combinata con substrati superficiali di norma a bassa capacità termica, ovve- ro caratterizzati da grande facilità di surriscaldarsi e raffreddarsi rapidamente; questa condizione aumenta gli stress termici e le variazioni termiche circadia- ne a carico delle zoocenosi costiere ● L’elevata ventosità e l’esposizione alle mareggiate, che può portare alla fre- quente e continua rimozione fisica di molti organismi animali dai loro microha- bitat naturali, sia in direzione marina che in direzione terrestre, con conse- guente aumento della mortalità e diminuzione delle potenzialità riproduttive ● La tipica frammentazione di questi habitat costieri, sia naturale (dovuta all’alternanza di tipologie costiere differenti), sia indotta dall’uomo, e la loro caratteristica disposizione spaziale estremamente allungata lungo un solo Impronte di coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) sulle dune di Pachino (Sicilia)
64 asse, parallelo alla linea di separazione mare/terra; queste condizioni compor- ● L’azione del moto ondoso e delle 65
tano ovvie difficoltà nelle attività riproduttive e nella diffusione di molte specie, mareggiate e quella, spesso associata,
soprattutto quelle più specializzate, con minori capacità di dispersione attiva, delle alluvioni fluviali, che consentono
e con più ridotte dimensioni delle popolazioni, rendendole in definitiva più apporti di materiali organici di varia
facilmente esposte a fenomeni di locale estinzione. natura (seppure ad andamento pulsan-
D’altra parte, alcuni altri fattori abiotici degli habitat costieri risultano favorevo- te e di scarsa predittibilità), assai
li alla vita animale e contribuiscono invece a mitigarne le dure condizioni gene- cospicui in alcuni settori, in particolare
rali o a consentirne un arrichimento delle comunità biotiche, quali ad esempio: quelli prossimi alle foci dei grandi fiumi
● La grande capacità termica delle masse idriche marine, che permette di o ad estese praterie marine a Posido-
mitigare in modo rilevante sia le eccessive temperature e aridità estive, sia le nia. Gli sferoidi di posidonia sono il
basse temperature invernali, consentendo quindi a molti organismi animali di frutto dello sfilacciamento dei residui
raggiungere sia verso Sud che verso Nord latitudini atipiche, grazie al microcli- fibrosi delle foglie che circondano il
ma costiero termicamente più favorevole e stabilizzato. Ad esempio, molte grosso rizoma; una volta staccatisi,
specie termofile a gravitazione mediterranea sono in grado di penetrare attiva- questi, movimentati dalla risacca lungo
mente anche in aree costiere dell’Italia Settentrionale grazie all’azione termo- la spiaggia sommersa, formano a poco
regolatrice del mare che le lambisce, mentre non potrebbero sopravvivere in a poco degli agglomerati sferici o ovali
aree più interne, a clima invernale troppo rigido. Parallelamente, elementi tipi- di colore marrone chiaro e di consi-
ci di biocenosi planiziarie mesofile e igrofile di tipo medioeuropeo (di norma stenza feltrosa, detti tecnicamente Rizoma di posidonia
stabilitesi durante periodi glaciali del Quaternario recente) riescono tuttora a egagropili. In queste condizioni posso-
sopravvivere qua e là anche a latitudini relativamente basse lungo la penisola no essere sostenute comunità animali, almeno a livello di invertebrati, anche di
e le grandi isole in zone costiere alle foci dei fiumi perenni, dove godono dei una certa consistenza e diversità, in termini di numero di specie e di struttura-
benefici termoregolatori estivi delle masse marine, combinati con quelli igrore- zione di ruoli trofici.
golatori delle stesse foci fluviali. ● Il già ricordato “effetto siepe” rappresentato dai cordoni dunali e dalle
spiagge per molti organismi terrestri trasportati passivamente o semi-passiva-
mente su ampi bracci di mare dalle correnti marine, dai venti, da alluvioni, spe-
cialmente durante tempeste ed eventi metereologici eccezionali. Questi feno-
meni hanno certamente permesso a molte specie di diffondersi e adattarsi
negli ambienti di spiagge, dune e lagune costiere italiani anche da distanze
relativamente grandi (ad esempio dal Nord Africa) con queste modalità. Un
discorso a parte va fatto per le aree di spiaggia a ridosso delle foci fluviali,
dove, dopo ogni grande alluvione, soprattutto nei mesi primaverili e in quelli
autunnali, un altissimo numero di specie di invertebrati terrestri e ripicoli viene
trasportato verso il mare, e spiaggiato lungo i limitrofi litorali, dove in genere
trova rifugio sotto i detriti vegetali arenati, per qualche giorno o qualche setti-
mana. Qualche specie particolarmente euriecia è talora in grado di sopravvi-
vere a lungo, e riesce perfino a riprodursi in situ, entrando più o meno stabil-
mente a far parte delle locali biocenosi costiere, ma la stragrande maggioran-
za di questi “naufraghi” soccombe o, quando possibile, semplicemente si
disperde attivamente e progressivamente nell’entroterra.
Molti biologi hanno sovente sottolineato le notevoli similitudini che accomuna-
Accumulo di sferoidi di posidonia (egagropili) no gli ambienti litoranei sabbiosi con quelli desertici. In effetti, è vero che la66 necessità di resistere ad alte temperature diurne e di muoversi in substrati 67
mobili, esposti ai venti e poveri di nutrienti, costituiscono pressioni adattative
comuni a queste due tipologie ambientali. Va peraltro notato come, malgrado
l’azione addizionale negativa della salinità (peraltro veramente importante solo
nei settori più umidi a ridosso della battigia o in quelli pianeggianti più arretra-
ti verso l’entroterra che subiscono periodiche inondazioni marine), altri fattori
quali la mitigazione del clima su scala temporale circadiana e annuale, le mag-
giori predittibilità microclimatiche e trofiche, una più accessibile disponibilità di
copertura vegetale almeno parziale e una maggiore umidità relativa, rendano
comunque gli ambienti litoranei sabbiosi assai meno ostili rispetto a quelli
desertici.
■ Reti trofiche degli habitat costieri sabbiosi
Prima di passare all’esame delle zoocenosi degli ambienti costieri sabbiosi, è
opportuno fare un cenno sull’insieme delle relazioni trofiche che legano gli Accumulo di nicchi calcarei di Theba pisana
organismi animali con gli altri elementi degli ecosistemi litorali. In figura sono
schematicamente sintetizzati i principali rapporti che interconnettono animali, Come si può notare, le relazioni sono relativamente semplificate, con tre prin-
piante e microorganismi del suolo, in un ipotetico sistema spiaggia-duna. cipali catene trofiche interconnesse. Un primo nodo di scambi trofici avviene
tra ambiente marino e terrestre a livello della battigia, associato essenzialmen-
te ai materiali organici di origine marina che vengono spiaggiati sul litorale, e
TERRAFERMA che costituiscono una delle fonti primarie di risorse trofiche dell’intero ecosi-
stema. La complessità strutturale aumenta sensibilmente secondo una diret-
trice perpendicolare alla linea di battigia, in direzione dell’entroterra, via via
che la vegetazione dunale tende a diventare più diversificata e si associa a
suoli stabilizzati. Sull’intera fascia che va dalla battigia al retroduna avvengono
VEGETAZIONE DUNALE poi gli scambi trofici con l’entroterra, legati essenzialmente alle incursioni di
PASCOLATORI grossi predatori (soprattutto uccelli e mammiferi) che regolarmente o occasio-
RADICI SEPOLTE
LETTIERA
nalmente pattugliano gli arenili e le dune a caccia di materiale organico spiag-
PREDATORI giato e dei piccoli invertebrati che lo colonizzano stabilmente. Un importante
riciclo di materiale organico è costituito dai resti degli organismi fitofagi, che
DETRITIVORI forniscono nutrienti e sostanze minerali al suolo, in alcuni casi con biomasse
FAUNA INTERSTIZIALE
anche rilevanti (ad esempio alcuni molluschi polmonati e i loro nicchi calcarei).
DUNE
■ Adattamenti degli organismi animali di habitat costieri sabbiosi
Come stretta conseguenza delle comunque difficili e particolari condizioni
SPIAGGIA
micro- e macroclimatiche degli ambienti litoranei sabbiosi, molti invertebrati
DETRITI MARINI · INVERTEBRATI INTERTIDALI
sabulicoli e dunali sono stati spinti, come vedremo più avanti, verso particola-
ri adattamenti eco-etologici. I più tipici di questi sono una risposta al problema
MARE
del sovente eccessivo irraggiamento solare e sono costituiti dallo sviluppo68 marcato di attività fossorie (scavo di gallerie) nei substrati che lo consentono 69
(sabbiosi umidi, sabbioso-terrosi o limoso-sabbiosi) da parte di molte specie,
spesso con paralleli adattamenti e modificazioni morfologiche degli organi di
scavo, tra gli artropodi coincidenti di norma con le zampe anteriori. Oppure
dallo spostamento di buona parte dei cicli circadiani di attività nelle ore nottur-
ne (specialmente nei mesi più caldi). Alcune specie sabulicole ad attività diur-
na (ad esempio alcuni ortotteri acrididi), particolarmente adattate al microcli-
ma caldo e secco delle assolate dune litoranee, necessitano al contrario di
infossarsi parzialmente o quasi totalmente nella sabbia proprio durante le ore
notturne, sia per minimizzare gli effetti dell’abbassamento della temperatura,
sia per sfuggire ai numerosi predatori notturni che vagano lungo le dune.
Molte specie meno termofile spostano il proprio ciclo riproduttivo annuale in
periodi invernali-primaverili o autunnali, con ampi periodi di estivazione (ossia
di diapausa e totale inattività nei mesi più caldi); altre effettuano migrazioni tro-
fiche circadiane o stagionali tra la battigia e le dune consolidate, per ottimiz-
zarne su scala temporale giornaliera o annuale i vantaggi in termini di prote-
zione o di disponibilità di risorse trofiche.
Molte specie perseguono strategie atte a minimizzare il contatto con i substra-
ti più surriscaldati dal sole, come lo sviluppo di arti sottili e allungati, la deam-
bulazione veloce, lo sviluppo negli insetti di capacità di volo veloce e radente
(per meglio contrastare l’influenza dei forti venti marini), o, al contrario, la per-
dita totale delle capacità di volo negli stessi, con fenomeni di brachitterismo e
atterismo (cioè di riduzione o scomparsa totale delle ali portanti). Molti coleot-
teri dunicoli presentano infine un addome più o meno globoso, associato ad
ampie cavità sottoelitrali, che svolgono importanti funzioni termo- e igrorego-
latrici. Molti di questi adattamenti sono non a caso identici a quelli messi a
punto da molti invertebrati e piccoli vertebrati eremici (cioè legati ad ambienti
desertici), nei quali, come abbiamo già segnalato, alcuni comuni fattori di
stress climatico e idrico, e di relazione con il substrato, hanno prodotto effetti
evolutivi spiccatamente convergenti. Altri adattamenti particolari, più stretta-
mente associati a condizioni alobie, si trovano poi in molti artropodi (special-
mente in insetti) di origine terrestre, sotto forma di modificazioni fisiologiche
degli apparati escretori, legate all’esigenza di sopravvivere in ambienti ad ele-
vato tenore salino, di norma estremamente ostili, se non inaccessibili, per
organismi non specializzati. Ancora, sono frequenti anche dei semplici adatta-
menti tegumentari (peli e setole idrofughe, rivestimenti cerosi, ecc.), atti a pro-
teggere ali e altre strutture delicate dalla parziale e più o meno frequente
immersione in acqua salata. Ve ne sono esempi in molti piccoli ditteri e coleot-
teri di svariate famiglie, capaci di uscire praticamente asciutti da brevi immer-
sioni nei flutti frangenti. Un’altra strategia adattativa particolarmente diffusa è
Scarites buparius infine quella del criptismo o mimetismo omocromico, ovvero la capacità di70 molte specie di assumere colorazioni che le rendano quanto più possibile con- 71
fuse con il colore di sfondo dell’ambiente; in questo senso sono molto diffuse
colorazioni con microscopiche macchie gialle, bianche, grigie e nerastre, alter-
nate confusamente, che simulano, talvolta in modo spettacolare, il colore del-
le sabbie litoranee colonizzate da queste specie.
■ Tipologie di habitat e zonazione delle comunità animali associate alle
coste sabbiose
extralitorale
Nello scenario appena delineato, passiamo ora ad analizzare le principali
tipologie di habitat e zoocenosi riconoscibili negli ambienti litoranei di coste
sabbiose. sopralitorale
Va subito notato come ci troviamo a trattare di ambienti piuttosto particolari,
che includono da un lato quelle parti del dominio bentonico marino, dall’altro
quei settori degli habitat marcatamente terrestri o dulcacquicoli, che si trova- eulitorale
no per loro natura all’interfaccia tra ambiente marino e ambiente terrestre. In
queste situazioni ci aspetteremo dunque di trovare popolamenti e organismi intertidale
animali di duplice origine, compenetrati e largamente sovrapposti, con ele-
menti terrestri o dulcacquicoli (sia di acque stagnanti che di falda o interstizia- Zonazione delle comunità animali
li), adattati a vivere in acque salmastre, a sopportare periodiche immersioni di ambienti litoranei sabbiosi
nell’acqua di mare o all’affossamento in detriti iperalini, e all’opposto con ele-
menti marini bentonici o interstiziali ugualmente adattati a vivere in acque sal- parallelle o subparallele all’andamento della costa e la cui ampiezza è misura-
mastre, o a sopportare periodiche esposizioni all’aria e al sole, seppure in con- bile lungo assi ortogonali a queste. Preferiamo il termine “fascia” a quello di
dizioni di elevata umidità relativa. “piano”, usato dai biologi marini, per il semplice fatto che “piano” è tradizio-
Malgrado la lodevole tendenza dei biologi marini a schematizzare e formaliz- nalmente più in accordo con una zonazione ecologica verticale, piuttosto che
zare in piani e orizzonti ben distinti i diversi popolamenti animali del dominio con una zonazione essenzialmente orizzontale come quella degli ambienti lito-
bentonico, inclusi quelli di interfaccia marino/terrestre, non è in realtà facile ranei sabbiosi, che presentano di norma escursioni altimetriche o batimetriche
riunire e distribuire univocamente in “piani” o “zone” l’eterogeneo insieme trascurabili o comunque ridotte.
degli organismi animali che si affacciano negli ambienti litoranei, soprattutto in 1. Una prima fascia, nei nostri mari di norma piuttosto ristretta, di ampiezza
quelli a substrato sabbioso o limoso-sabbioso, caratterizzati da comunità che variabile da pochi decimetri ad alcuni metri, è quella intertidale (o intercotida-
spesso tendono a compenetrarsi e a sovrapporsi ampiamente sotto l’influen- le) di riva sabbiosa, ovvero quella compresa tra il livello minimo della bassa
za di fattori abiotici locali di varia natura, e a causa della spesso notevole vagi- marea di sizigia e quello massimo dell’alta marea di sizigia. Nel Mediterraneo
lità (ossia mobilità) circadiana o stagionale di molte specie. l’escursione di livello tra alta e bassa marea è modesta, di norma nell’ordine di
Sfogliando l’abbondante letteratura sulla fauna e sulle comunità biotiche degli una trentina di centimetri (poche le marcate eccezioni, come ad esempio l’area
ambienti costieri, non ci si deve dunque stupire del fatto che biologi marini, del Golfo di Gabès in Tunisia, dove si possono raggiungere i 2 m di escursio-
zoologi di faune terrestri e botanici, abbiano fatto uso di termini differenti per ne, o in Italia alcuni settori dell’Alto Adriatico, dove localmente può essere
indicare esattamente le stesse tipologie ambientali, oppure (fatto perfino più superato il metro), e quindi l’ampiezza della zona intertidale è di solito legata
destabilizzante) abbiano indipendentemente utilizzato un medesimo termine soprattutto alla pendenza dell’area di spiaggia. Più la spiaggia è pendente, più
per indicare differenti tipologie ambientali o differenti aspetti di queste. la fascia sarà ristretta, più la spiaggia è appiattita e largamente degradante
Per prima cosa, possiamo osservare che abbiamo a che fare con delle zone o verso il mare, più la fascia intertidale sarà ampia, come possiamo notare
fasce che possiamo tentare di distinguere tramite delle linee di demarcazione soprattutto nelle aree costiere dell’Alto Adriatico. In condizioni di comparabi-72 lità rispetto ad altri fattori bioclimatici e biogeografici, le comunità animali del- 73
la zona intertidale sono ovviamente più stabili, ricche e diversificate dove tale
zona è molto ampia, mentre saranno più povere ed effimere, o quasi del tutto
assenti, dove questa sia particolarmente ridotta. Non a caso relativamente più
ricche e stabili comunità intertidali sono ad esempio quelle della Manica o del
Mare del Nord, dove l’escursione tra i livelli della bassa e dell’alta marea può
raggiungere alcuni metri, in combinazione con profili molto pianeggianti dei
litorali. Questa zona corrisponde pienamente al piano mediolitorale (o interti-
dale) su substrati sabbiosi considerato tradizionalmente dai biologi marini.
Questi habitat sono caratterizzati da materiale organico di deposito marino
continuamente fluitato o rimosso in superficie dalla risacca e dalle maree, e
dall’essere ovviamente del tutto privi di vegetazione terrestre. Vi sono insedia-
te a varie profondità sotto la superficie importanti ma elusive comunità di
microinvertebrati interstiziali (mesopsammon; come già accennato, trattando-
si di comunità complesse, associate ad ambienti esclusivamente acquatici,
benché di interfaccia terrestre/marino, non verranno trattate diffusamente in
questo volume; ad esse è stata tuttavia dedicata la finestra di pag. 74-75). Le
comunità superficiali della fascia intertidale, in habitat prevalentemente sab- Banquettes a Posidonia
bioso-fangosi o negli strati più superficiali di quelli sabbiosi, sono invece rap-
presentate soprattutto da animali scavatori, che vivono a spese delle sostanze quindi trascinato più a fatica verso terra dai frangenti. Nel secondo si trova
organiche fluitate in questi substrati mobili, e che spesso tendono a spostarsi invece il materiale a basso peso specifico, ma più grossolano e/o a bassa resi-
seguendo in genere le variazioni del livello delle maree. stenza idrodinamica (tipicamente tronchi, rami e ceppi lignei trasportati a mare
2. La seconda fascia è quella eulitorale, compresa tra il limite superiore (ver- dalle alluvioni fluviali). In questo secondo settore più interno della fascia eulito-
so terra) dell’intertidale e quello inferiore (verso mare) della terza fascia, quella rale si possono trovare con una certa frequenza, soprattutto durante il periodo
sopralitorale. L’eulitorale interessa quello che nella letteratura italiana ed euro- tardo-invernale e primaverile, germogli di alcune piante pioniere della fascia
pea più tradizionale è l’orizzonte inferiore (verso il mare) del sopralitorale su seguente, quella sopralitorale, che durante l’avanzare della stagione sono
substrati sabbiosi. Anche l’ampiezza della fascia eulitorale è naturalmente però quasi sempre spazzati via dalle mareggiate, o muoiono per le caratteristi-
legata alla pendenza dell’area di spiaggia e alla tipologia del profilo costiero. che fortemente stressanti del substrato. Occorre ricordare, per dovere di chia-
La fascia eulitorale è associata a rive sabbiose nude dove le sabbie di varia rezza, che il termine eulitorale è stato utilizzato in passato da alcuni biologi
granulometria sono raggiunte solo da maree eccezionali o dalle mareggiate, marini anche come semplice sinonimo di mediolitorale e intertidale, e il suo più
lasciandovi detriti animali, vegetali o algali di varia natura, origine e quantità, in recente e presente uso in un’altra accezione non deve quindi generare confu-
aree sabbiose di media pendenza e di norma del tutto spoglie, prive di vege- sioni. L’insieme della fascia intertidale di riva sabbiosa e di quella eulitorale di
tazione terrestre. Questa fascia può essere convenzionalmente suddivisa in riva sabbiosa nuda, caratterizzate dalla presenza di tutti quegli elementi più
basso (verso il mare) ed alto (verso terra) eulitorale. Nel primo si può rinvenire tipicamente adattati alle rive sabbiose stabilmente o frequentemente bagnate
la maggior parte del materiale organico spiaggiato più minuto e a basso peso dal mare e senza vegetazione, può essere convenientemente identificato con
specifico, avente massa modesta (generalmente da pochi grammi a pochi il termine operativo di cintura sabbiosa madolitorale (dal latino madidus,
ettogrammi) e quindi dotato di inerzia di moto limitata, quando fluitato dai flut- bagnato, umido).
ti frangenti di tempesta (ad esempio foglie laminari di monocotiledoni marine, Le comunità della fascia eulitorale di riva sabbiosa nuda sono rappresentate
piccoli frammenti lignei, ciottoli di pietra pomice, ecc.), insieme a materiale più essenzialmente da piccoli invertebrati associati agli accumuli di detriti organici
grossolano (come grosse alghe brune o cadaveri di vertebrati o invertebrati spiaggiati: “banquettes” di foglie laminari di fanerogame marine come Posido-
marini) con più elevato peso specifico o maggiore resistenza idrodinamica, nia o Zostera, resti di grandi alghe brune, cadaveri e resti di animali marini,74 75
Il mesopsammon Paolo Audisio
Con il termine di mesopsammon si che si trovano poco lontano dalla linea di organici filtrati dalle sabbie o di alghe (dagli strati più superficiali a quelli più
intende genericamente l’insieme della battigia (quelle a cavallo della fascia unicellulari (soprattutto diatomee); alcuni profondi o viceversa) in relazione al varia-
fauna acquatica interstiziale, costituita da intertidale) siano spesso tra le più ricche sono invece predatori di altri microorga- re delle condizioni di temperatura, salinità
organismi animali minuti o minutissimi, e diversificate in termini di numero asso- nismi microfagi. e concentrazione di ossigeno.
adattati a vivere in un ambiente tipica- luto sia di specie presenti, che di phyla Le connessioni tra il mesopsammon degli L’elemento condizionante in genere più
mente lacunare, nell’acqua che lenta- rappresentati. ambienti intertidali e i molteplici fattori fisi- restrittivo è però dato dalla granulometria
mente filtra e transita tra i microscopici La quasi totalità degli animali che com- ci, chimici e mineralogici che ne condizio- delle sabbie e dalla rispettiva natura
interstizi presenti tra i granelli di sabbia o pongono il mesopsammon è accomuna- nano la presenza sono alquanto comples- mineralogica; molte specie sono infatti
di ghiaia fine. Per definizione, il meso- ta da marcati adattamenti che spesso se. I parametri che determinano più forte- esclusive di sabbie calcaree, altre di
psammon è rintracciabile quasi ovunque comportano la notevole riduzione delle mente le condizioni ambientali sono la spiagge silicee, e le dimensioni dei singo-
siano presenti depositi sabbiosi, sia sui dimensioni corporee (la maggior parte ha granulometria del substrato, la sua com- li granuli e dei relativi interstizi possono
bassi fondali marini, sia all’interfaccia una taglia compresa tra 0,1 e 0,5 mm), la posizione mineralogica, la temperatura determinare rigidamente la presenza di
mare/terra delle aree litoranee sabbiose, presenza di un corpo sottile e più o meno media dell’acqua filtrante, la sua salinità, molti organismi caratteristici. Al di sopra
sia lungo le sponde dei laghi o le rive dei allungato, spesso appiattito (anche in il tenore di O2 disciolto, la natura e la o al di sotto di granulometrie comprese
fiumi, che al di sotto degli stessi letti flu- quei gruppi che normalmente hanno for- concentrazione delle sostanze organiche tra 0,05 e 2 mm (quelle tipiche delle sab-
viali; è insomma un tipo di ambiente me totalmente differenti), la riduzione o la provenienti da contigui bacini fluviali o bie), quindi quando le sabbie sono sosti-
“invisibile” e poco noto, ma di fatto quasi totale assenza di apparati sensoriali ocu- dalle acque di falda, il grado di imbibizio- tuite da silt o da argille, oppure da ghiaie,
sconfinato. Cambiano però in modo dra- lari, l’assenza di pigmentazione, la pre- ne delle sabbie nei suoi vari strati, e la di norma l’intera comunità scompare
stico le percentuali relative dei rispettivi senza in non pochi casi di papille adesi- relazione delle stesse con l’irraggiamento completamente, per l’inadeguatezza del
“protagonisti tassonomici” di queste fau- ve, utili per ancorarsi ai granelli di sabbia, solare dello strato superficiale. substrato. Soprattutto quando l’ambien-
ne, in funzione della presenza esclusiva e altre modificazioni più o meno peculiari. L’intersecarsi di tutti questi fattori, soprat- te interstiziale sia caratterizzato da gra-
fra gli interstizi di acque marine (in mare) Sotto l’azione delle comuni pressioni tutto a livello di salinità e temperatura, nulometria delle sabbie relativamente più
o di acque dolci (lungo laghi o fiumi inter- selettive (legate alle necessità di soprav- determina la natura spesso fortemente grossolana e ove sussistano le necessa-
ni). Nel primo caso troveremo soprattutto vivere in un substrato così particolare), si eurialina ed euriterma di molti organismi rie condizioni idrogeologiche, si assiste in
gruppi esclusivamente o prevalentemen- possono quindi osservare sconcertanti del mesopsammon intertidale; questi molti casi a scambi e interconnessioni tra
te marini, come turbellari, policheti, convergenze morfologiche e dimensio- organismi sono infatti in grado di tollerare la fauna interstiziale e quella degli altri
nemertini e chinorinchi, con presenze nali che coinvolgono sia metazoi (quindi spesso forti variazioni sia circadiane che ambienti acquatici sotterranei.
sorprendenti anche di phyla come cnida- veri animali, multicellulari) che protisti stagionali o comunque periodiche nella Il mesopsammon intertidale è spesso
ri, poriferi, briozoi, molluschi, o altre qua- unicellulari, come i Ciliati. quantità di cloruri disciolti in acqua, e nel- costituito da organismi di grande interes-
si sconcertanti come quelle di alcuni Pur nella ripartizione naturale dei rispetti- la temperatura della stessa. Importanti se faunistico e biogeografico, per la
microscopici echinodermi o di cordati vi ruoli trofici all’interno di una qualsiasi migrazioni e spostamenti sono del resto capacità di molte specie di riflettere nella
ascidiacei; nel secondo caso troveremo comunità animale, la maggior parte degli effettuati da molte specie interstiziali sia in loro storia evolutiva le variazioni delle
più abbondantemente rappresentati organismi che compongono il meso- senso trasversale (dal mare verso l’entro- linee di costa, delle falde freatiche e del
gruppi prevalentemente dulcacquicoli psammon si nutre di microscopici detriti terra o viceversa), sia in senso verticale paleoclima, per la presenza di numerose
come oligocheti, tardigradi, gastrotrichi e specie con areale relitto e frammentato, e
idracari, oltre a forme minute di stadi per- per gli adattamenti morfologici ed eco-
lopiù preimaginali di insetti acquatici. In etologici spesso spettacolari che li coin-
entrambe le tipologie idriche sono poi volgono. Anche l’analisi dell’andamento
presenti un gran numero di protisti, della biodiversità di questi organismi,
soprattutto ciliati, nematodi, e numero- seppure in uno stadio ancora incompleto
sissimi crostacei, appartenenti a gruppi e frammentario degli studi, promette di
sia marini che dulcacquicoli (soprattutto fornire elementi di notevole interesse nel-
copepodi arpacticoidi, isopodi, anfipodi, la lettura degli ecosistemi costieri medi-
mistacocaridi, ostracodi e altri minori). terranei e italiani. Un motivo in più per
Come ovvio, gli ambienti litoranei sab- salvaguardare le spiagge litoranee e le
biosi attingono componenti faunistiche loro acque sotterranee dal degrado
Gastrotrico del genere Thaumastoderma in Copepode arpatticoide del genere Amphiascus,
rappresentative di entrambe le tipologie, visione ventrale (foto al microscopio elettronico visione laterale (foto al microscopio elettronico a indotto soprattutto, in questo caso, dal-
e non deve quindi stupire che le sabbie a scansione, SEM) scansione, SEM) l’inquinamento marino e fluviale.76 materiale ligneo derivante da alluvioni fluviali, grandi ciottoli, accumuli di ciot- 77
toli di pietra pomice, resti di animali terrestri trascinati in mare, ecc. A livello del
basso eulitorale, quindi della parte più esterna (verso mare) della spiaggia
emersa e fino al limite interno della battigia di alta marea, questo settore è fre-
quentato soprattutto da invertebrati saprofagi, detritivori e dai loro sovente
specializzati predatori. Alle foci dei fiumi, in particolare, si assiste in queste
comunità ad ampie trasgressioni bidirezionali di faune, con penetrazioni verso
il mare di elementi psammofili ripicoli, tipici delle ampie rive dei fiumi e dei
bacini lacustri continentali, parallelamente ad ampie penetrazioni verso l’inter-
no, lungo le rive sabbiose dei fiumi, di elementi psammoalofili litoranei.
3. La terza fascia è quella sopralitorale, dove si possono operativamente
distinguere almeno due tipologie ben differenziate, una su substrati sabbiosi in
più o meno marcata salita verso terra, un’altra su substrati limoso-sabbiosi lar-
gamente pianeggianti o leggeremente depressi. Nel primo caso possiamo par-
lare di sopralitorale asciutto di spiaggia sabbiosa, corrispondente alla fascia
dell’anteduna (quella delle così dette dune embrionali), con vegetazione
psammofila pioniera, ovvero quella zona corrispondente alla più o meno
ampia estensione sabbiosa, di norma asciutta, che va dalle estreme berme di Duna a santolina delle spiagge (Othantus maritimus)
tempesta fino alle prime dune, ove compare la prima vegetazione erbacea
costiera sparsa, spesso a prevalenza di ravastrello marittimo (Cakile maritima) vivono preferenzialmente o esclusivamente in ambienti limoso-fangosi), sia
nei tratti contigui con l’alto eulitorale, e più verso l’interno con calcatreppola detritivori che predatori. Queste ultime comunità hanno di norma notevoli simi-
(Eryngium maritimum), vilucchio marittimo (Calystegia soldanella) e gramigna litudini e punti di contatto con quelle extralitorali delle rive limoso-sabbiose
delle spiagge (Elytrigia juncea). Qualche spruzzo di onde frangenti vi può arri- degli ambienti umidi delle depressioni retrodunali e delle lagune costiere,
vare solo in casi di mareggiate eccezionali. Nel secondo caso avremo invece a caratterizzate dal ristagno di acque sia salmastre che dolci.
che fare con un sopralitorale umido di spiaggia limosa, dove limo, fango, o 4. L’insieme di tutte le altre tipologie ambientali litoranee più ”interne”, è infine
sabbie fangose a granulometria finissima e con elevato tenore salino si esten- riferibile ad un’ampia ed eterogenea fascia, detta fascia extralitorale, che
dono di norma piuttosto profondamente in aree costiere pianeggianti o persi- comprende le prime dune mobili, le dune consolidate, il retroduna, e gli even-
no leggermente depresse; qui troviamo frequente ristagno di acque salate o tuali stagni costieri delle depressioni retrodunali o interdunali. La prima zona
salmastre legato a periodiche inondazioni marine, spesso in corrispondenza di della fascia extralitorale è quella extralitorale di dune bianche, più o meno
foci di fiumi o lagune costiere limitrofe, di norma caratterizzate dalla presenza mobili e instabili, facilmente rimodellabili dai venti più forti, in genere dominate
di bassa vegetazione con dominanza di chenopodiacee (Salicornia, Suaeda) e dallo sparto pungente (Ammophila littoralis). Quindi la zona extralitorale di
giuncacee (Juncus) alofile e igrofile. dune grigie consolidate, con locale e variabile prevalenza e commistione di
Nelle comunità della fascia sopralitorale di dune embrionali prevalgono i fitofa- Crucianella maritima, camomilla marittima (Anthemis maritima), ginestrino del-
gi e antofagi più o meno specializzati, dunicoli indiretti specializzati (ovvero le spiagge (Lotus commutatus), santolina delle spiagge (Othantus maritimus),
associati a piante strettamente psammo-alobie), insieme a detritivori e preda- elicrisio (Helychrysum spp.), Silene spp., Scabiosa maritima, cisti (Cistus spp.),
tori, sia dunicoli diretti specializzati, in quanto loro stessi psammo-alobi spe- ginepro (Juniperus oxycerdus), e talora efedra (Ephedra fragilis, E. distachya),
cializzati ed esclusivi, o dunicoli diretti ubiquisti, in quanto psammofili genera- rosmarino (Rosmarinus officinalis), Teucrium spp., tamerici (Tamarix spp.) e
listi, largamente diffusi in ambienti sabbiosi anche non litoranei. Le comunità Ononis spp., oltre a vari altri elementi della macchia bassa, distribuiti sia sulla
della fascia sopralitorale di spiaggia limosa, su substrati limoso-sabbiosi, con sommità della duna, sia nei tratti più aperti del retroduna.
popolamenti associati di norma a più o meno estese pianure o depressioni L’insieme della fascia sopralitorale di dune embrionali, della zona extralitorale
costiere, comprendono invece soprattutto invertebrati alofili e lutobi (ossia che di dune bianche, e della zona extralitorale di dune grigie consolidate, si posso-78 no convenientemente riunire in una cintura sabbiosa siccolitorale (dal latino 1. Le comunità madolitorali, intese come l’insieme di quelle intertidali del 79
siccus, asciutto). Segue quindi l’eventuale zona extralitorale boscata di retro- mediolitorale, di quelle eulitorali di riva sabbiosa associate ai detriti spiaggiati,
duna, spesso a Juniperus phoenicea, leccio (Quercus ilex), pini (Pinus spp.) o e di quelle dei settori più esterni, spesso asciutti, ma ancora privi di vegetazio-
con boscaglie di carattere più mesofilo. ne terrestre, delle spiaggie emerse sabbiose, fino alle dune embrionali escluse
Poiché le zoocenosi di questa zona sono costituite in genere da popolamenti 2. Le comunità psammofile siccolitorali, intese come l’insieme di quelle
ibridi e scarsamente connotati, in parte di macchia mediterranea, in parte di comunità, essenzialmente xerofile e psammofile, associate alle dune embrio-
boschi xerofili o mesofili planiziari, non verranno trattati specificamente in que- nali, alle dune mobili e a quelle consolidate, ai cespuglieti e alle macchie bas-
sta sede, se non a livello di quegli elementi più frequenti e trasgressivi che se retrodunali e alle dune fossili sabbiose
almeno occasionalmente abbondano nei settori più aperti dei sistemi dunali. 3. Le comunità lutobie sopralitorali delle ampie spiagge limoso-fangose
Può essere presente la zona extralitorale delle dune fossili (o paleodune), (salicornieti) e quelle extralitorali ripicole psammo-lutobie degli stagni e del-
ovvero di quei sistemi di tomboli originariamente litoranei, ora in gran parte le lagune salmastre delle depressioni retro- e interdunali.
spianati dall’erosione eolica e meteorica, che lunghe fasi di successivo accu-
mulo di sedimenti in direzione marina hanno appunto dislocato verso l’interno, ■ La fauna: gli invertebrati
traslando in parallelo anche di diverse centinaia di metri o di alcuni chilometri
verso l’esterno l’originaria linea di costa. Passiamo ora ad analizzare, suddivise grossolanamente nelle tre tipologie
Infine, vi può essere l’eventuale zona extralitorale delle depressioni retroduna- appena definite, le più caratteristiche comunità ad invertebrati degli ambienti
li, a ridosso delle sponde sabbiose, limoso-sabbiose o fangose delle lagune o costieri sabbiosi italiani; per fare ciò, ovviamente senza alcuna pretesa di com-
degli stagni costieri, con l’associata vegetazione igrofila. pletezza, ci serviremo soprattutto di alcuni gruppi tassonomici particolarmen-
Tratteremo in questa sede solo quei popolamenti delle rive sabbiose degli sta- te significativi, o semplicemente meglio studiati, utilizzando la presenza di
gni costieri, più strettamente affini a quelli dei già citati salicornieti sopralitora- generi o specie peculiari e bene adattati ai vari habitat costieri analizzati, o che
li. Nelle comunità animali extralitorali delle dune bianche, insieme a quelle del- almeno vi risultino particolarmente frequenti e abbondanti. La ricorrente pre-
le dune grigie consolidate, prevalgono nettamente i fitofagi (soprattutto rizofa- senza di elementi di interesse naturalistico tra questi gruppi-guida nelle varie
gi, fillofagi e antofagi, dunicoli indiretti più o meno specializzati), ma sono regioni ci sarà infatti utilissima per delineare il panorama faunistico qualitativo
discretamente rappresentati anche i detritivori e i predatori, di norma dunicoli dei diversi settori costieri sabbiosi italiani, e poi per formulare suggerimenti
diretti e perlopiù psammo-alobi specializzati, mentre scarsi e spesso solo operativi di tutela e conservazione di singole specie, comunità ed ecosistemi.
occasionali sono ovviamente i coprofagi, i necrofagi e i fitosaprofagi. Le comu-
nità psammofile extralitorali delle dune fossili comprendono, a fianco natural-
mente di molti elementi meso-xerofili, legati alla variabile copertura vegetale
dominante di questi habitat (pinete, leccete, sugherete o cespuglieti xerofili Bledius graellsi
sublitoranei), soprattutto elementi psammobi o psammofili diretti e più o meno
specializzati, di diverso ruolo trofico (specialmente saprofagi, coprofagi e rizo- Myosotella myosotis
Orchestia gammarella
fagi). Tra questi, spesso è rilevabile una componente significativa di elementi
relitti a livello sia ecologico che di distribuzione geografica, con alcune specie
uova di Bledius
endemiche ad areale molto ristretto e a rischio di estinzione.
Per semplicità e comodità di trattazione, e dovendo comunque tenere in con- Talitrus saltator
siderazione sia la notevole vagilità di molti invertebrati psammo-alofili sia la Tylos ponticus
complessità e la sovente ampia sovrapposizione naturale di alcuni popola-
menti (nelle diverse regioni dell’Italia spesso già di per sé difficilmente compa-
rabili in situazioni geomorfologiche, geografiche e bioclimatiche differenti),
tenteremo di raggruppare le comunità appena elencate in sole tre tipologie, Tylos europaeus
discusse nel dettaglio nel capitolo seguente:80 curculionidi e dei rari scarabeoidei del 81
Invertebrati: parte tassonomica Paolo Audisio
genere Calicnemis), mentre al calare delle
tenebre inizia una forsennata attività
prevalentemente notturna, in prossimità
della battigia, a caccia di talitridi.
■ Le comunità di battigia e di spiaggie Abbastanza comune in Italia fino a pochi
emerse sabbiose umide (madolitorali) decenni or sono lungo buona parte delle
coste tirreniche e pugliesi, così come in
Crostacei Sicilia e Sardegna, questa specie è
● Anfipodi. Tipici colonizzatori del litorale andata incontro ad una progressiva ma
“umido” all’interfacccia della linea di rapida rarefazione, legata in parte
battigia sono soprattutto gli anfipodi Eurynebria complanata all’inquinamento marino, che influenza
talitridi, in particolare il comune Talitrus negativamente il ciclo biologico delle sue
saltator, un crostaceo che occupa rappresentativo degli ambienti litoranei prede, ma principalmente al disturbo
abitualmente dei canalicoli scavati nella sabbiosi, sia in termini di numero di delle spiagge apportato dalle attività di
sabbia umida a pochi centimetri di specie (almeno mezzo migliaio di specie balneazione, con il continuo calpestio dei
profondità. Altri talitridi comuni lungo le Talitridi sulle oltre 12.000 italiane possono essere substrati sabbiosi e la rimozione dei
spiagge sono le orchestie (Orchestia considerate esclusive, tipiche, o grossi residui lignei (tronchi e ceppi
gammarella, O. montagui, ciottoli e in sabbie a granulometria più comunque caratteristiche di questi trasportati dalle alluvioni fluviali e
O. mediterranea e altre), localmente grossolana. Questi crostacei manifestano habitat), sia in termini di numero di depositati nei settori più prossimi al mare
abbondanti sotto i cumuli di alghe e di migrazioni trofiche notturne verso le individui. I tegumenti di norma rigidi e delle spiagge emerse) da parte di
lamine di posidonia spiaggiate. Tutti i dune, con comportamento analogo a resistenti che li caratterizzano operatori di spiaggia o di turisti.
talitridi alofili, soprattutto se disturbati, quello mostrato dai citati Anfipodi del rappresentano del resto un ottimo La specie è così divenuta molto rara e
compiono caratteristici balzi tra i detriti genere Talitrus. Sotto i detriti spiaggiati “preadattamento” per sopravvivere con localizzata nel nostro Paese, e limita
lasciati dai flutti nelle sabbie al limite sono presenti con una certa frequenza successo in questi ambienti terrestri ormai la sua presenza con popolazioni
della risacca, e per questo sono noti anche parecchi altri isopodi saprofagi e ostili, consentendo loro di fronteggiare significative quasi solo a poche località
anche con il suggestivo nome di “pulci di microfagi a più o meno ampia con maggiore facilità sia l’usura operata tirreniche (soprattutto toscane) almeno
mare”. I talitridi in realtà si possono distribuzione italiana e mediterranea, dalla sabbia, sia la necessità di ridurre al parzialmente protette dalle attività di
spostare anche di parecchio dalla linea di alcuni dei quali dai nomi molto simbolici, massimo la dispersione idrica. balneazione e di “manutenzione” delle
battigia per procurarsi il cibo; durante le come Halophiloscia zosterae e le ● Carabidi. Tra i carabidi, la grande spiagge da parte dell’uomo.
ore notturne Talitrus saltator, ad esempio, congeneri H. tyrrhena e H. ischiana, Eurynebria complanata è da considerare Tra i carabidi scaritini tipici delle spiagge
può raggiungere anche le dune interne Armadilloniscus litoralis, Buchnerillo forse il più significativo “marcatore” della umide sono caratteristici ancora alcuni
consolidate a molte decine di metri dal litoralis e Trichoniscus halophilus. qualità biotica degli ecosistemi italiani di piccoli Dyschirius, in particolare
mare, utilizzando un interessante sistema ● Decapodi. Anche alcuni granchi spiaggia sabbiosa. Questo coleottero, D. numidicus, specie alobionte
di orientamento astronomico per i suoi (decapodi brachiuri) frequentano con una distribuito lungo le coste sabbiose del
spostamenti. certa regolarità la battigia, soprattutto Mediterraneo occidentale e di quelle
● Isopodi. I talitridi sono sovente all’imbrunire e nelle giornate nuvolose o atlantiche dell’Europa occidentale, vive
accompagnati da altri crostacei fossori, piovose, in particolare il comune e perlopiù a livello dei settori più
come gli isopodi Tylos europaeus e adattabile Carcinus mediterraneus, stabilmente emersi e arretrati delle
alcuni congeneri, sovente distribuiti in peraltro molto più frequente lungo i spiagge emerse (talvolta anche a ridosso
modo differenziale lungo le spiagge, in litorali rocciosi e su scogliere naturali e delle dune mobili), ed è un attivo
funzione della diversa granulometria del artificiali presso i porti e le foci dei fiumi, predatore di talitridi (in particolare di
materiale incoerente sabbioso-ghiaioso. come tipico abitatore del piano intertidale Talitrus saltator). Durante il giorno si
Ad esempio, Tylos europaeus, ad ampia (piano mediolitorale). rinviene quasi esclusivamente sotto
distribuzione euro-mediterranea, tronchi e materiale ligneo spiaggiato
colonizza di solito le sabbie più fini, Coleotteri. I coleotteri costituiscono di (entro il quale, come vedremo più avanti,
mentre T. ponticus è presente sotto gran lunga il gruppo faunistico più possono svilupparsi le larve di alcuni Parallelomorphus laevigatus82 mediterranea occidentale ampiamente ambientali, sono testimoni di habitat specie italiane tipiche frequentatrici di 83
diffusa lungo le coste sabbiose di quasi localmente poco disturbati e in grado di cadaveri e resti spiaggiati di piccoli
tutta Italia, e soprattutto Parallelomorphus svolgere un ruolo essenziale come vertebrati sia terrestri che marini
laevigatus (spesso citato in passato come indicatori biologici della qualità degli (specialmente pesci), ma attratti anche
Scarites laevigatus). Si tratta di uno ecosistemi litoranei. dagli escrementi di mammiferi (inclusi
scaritino di medie dimensioni (16-22 mm), In Italia il loro regresso ha purtroppo quelli umani). In Italia le specie più
associato a spiagge almeno di discreta ormai assunto i connotati di un vero e frequenti sono Hypocaccus rugifrons,
qualità ambientale, dove vaga anche nelle proprio population crash. H. brasiliensis, e soprattutto H. dimidiatus,
ore diurne, predando principalmente ● Stafilinidi. Con i talitridi e i Tylos sono tutti ad ampia distribuzione.
crostacei talitridi, come Eurynebria spesso frequenti molti piccoli coleotteri Se particolarmente abbondanti, questi
complanata, ma rispetto a questa stafilinidi predatori dei generi Cafius, coleotteri possono persino risultare
colonizzando stabilmente i settori di Lophyridia littoralis Gabrius, Remus, Phytosus, Medon e fastidiosi, atterrando e prendendo il volo
spiaggia ben più prossimi al mare e più Heterothops, il più frequente dei quali è in continuazione e camminando sulla cute
umidi (basso eulitorale). mesi primaverili ed estivi, con centinaia di norma Cafius xantholoma, che persiste dei bagnanti che prendono il sole sulle
Un altro carabide caratteristico della di esemplari anche di specie diverse che anche in situazioni di marcata spiagge. Un altro isteride specializzato
battigia e della spiaggia umida è il si producevano in repentini e brevi voli antropizzazione. Altri piccoli stafilinidi, psammo-alobionte, abbastanza
cicindelino Cylindera trisignata, a radenti al passaggio di occasionali come alcune specie dei generi frequente sulle nostre spiagge, e che
distribuzione essenzialmente atlanto- visitatori (non a caso da Linneo questi Polystomota ed Emplenota, sono invece colonizza soprattutto gli accumuli di
mediterranea, un tempo più frequente splendidi coleotteri sono stati ricordati in noti come parassitoidi di ditteri alofili, monocotiledoni marine spiaggiate del
lungo molte spiagge sabbiose italiane, una celebre definizione come entro i cui pupari si sviluppano. Come i genere Zostera, è Halacritus punctum
soprattutto in corrispondenza di foci di “Insectorum Tigrides veloces”), è spesso crostacei dei generi Talitrus e Tylos prima (vedi disegno), uno dei più piccoli
fiumi o almeno di piccoli corsi d’acqua, e un ricordo sbiadito anche per la maggior ricordati, anche alcuni stafilinidi scavano coleotteri italiani (lungo poco più di
ormai divenuta assai rara e localizzata. parte dei naturalisti e degli entomologi. In gallerie verticali di varia profondità nelle mezzo millimetro).
Questo velocissimo predatore di quasi tutte le regioni italiane, imbattersi in sabbie umide delle spiagge, tra cui ● Idrenidi. Negli accumuli di detriti
artropodi alofili è stato infatti soggetto, un sito litoraneo ancora massicciamente poche specie del genere Bledius, lunghe vegetali bagnati dall’acqua del mare
come quasi tutti i rappresentanti frequentato dalle cicindele è evento meno di un centimetro, armate nei sono frequenti anche alcuni piccolissimi
talassofili italiani della sottofamiglia, a ormai così sporadico da colpire maschi di molte specie di curiosi (1-2 mm) coleotteri idrenidi (la maggior
drastiche riduzioni di areale e di immediatamente la nostra attenzione, processi spiniformi su pronoto e capo, parte delle specie della famiglia vivono
dimensioni delle popolazioni; fenomeni con scoraggianti confronti, almeno per che si cibano di microalghe e che come lapidicole bentoniche in acque
dovuti, anche in questo caso, soprattutto quelli tra noi più avanti negli anni, con i depongono le uova in cellette laterali correnti) adattati anche alle acque
al disturbo antropico prodotto sullo ricordi giovanili nelle stesse aree magari delle loro gallerie; questi piccoli salmastre e iperaline, benché non
sviluppo delle larve dalle attività di riferibili ad appena venti o trenta anni coleotteri, soprattutto a livello delle ben strettamente specializzati a vivere in
balneazione, dalle attività estrattive di prima. Le larve di queste cicindele, più numerose specie lutobie (quelle ambienti esclusivamente litoranei; tra
sabbia alle foci dei fiumi, e predatrici anch’esse di piccoli associate ad ambienti limoso-fangosi; ne questi alcuni Ochthebius (O. muelleri,
dall’inquinamento marino. Un’altra specie invertebrati sabulicoli, cacciano discuteremo più avanti a proposito delle O. viridis, O. marinus, e altri), che insieme
di cicindelino, più ampiamente diffusa semiseppellite all’interno di brevi gallerie comunità di invertebrati dei ad altre specie sono ben più
negli stessi ambienti, ma capace di verticali praticate nella sabbia umida; si salicornieti e delle rive delle frequenti, come vedremo più
colonizzare anche le dune e il retroduna, possono facilmente immaginare le lagune retrodunali), sono avanti, nei salicornieti e
e di risalire lungo le rive sabbiose dei conseguenze di un esteso calpestio da frequentemente predati da lungo le rive degli stagni
corsi d’acqua anche per molti chilometri parte dei bagnanti, o, peggio, del alcune specie di piccoli carabidi costieri, dove consumano
verso l’interno, e a ben più ampia passaggio di un mezzo meccanico per la scaritini fossori del genere fitoplancton.
distribuzione paleartica, è Lophyridia ripulitura delle spiagge, su organismi con Dyschiriodes. ● Elateridi. Questa famiglia
littoralis, ancora presente con la queste peculiari e delicate abitudini di ● Isteridi. Molto frequenti, tra i include in Italia un paio di
sottospecie mediterranea littoralis lungo vita. Al pari di Eurynebria anche le saprofagi, i piccoli coleotteri centinaia di specie, in gran
molte spiagge italiane. Lo spettacolo cicindele, quindi, come specie predatrici isteridi sabulicoli del genere parte radicivore o
delle cicindele in caccia lungo le spiagge stenoecie, antropofobe e sensibili spesso Hypocaccus (lunghi un paio detritivore, caratterizzate
marine sabbiose nelle calde giornate dei anche a minime compromissioni di mm o poco più), con svariate dalla capacità di “saltare”84 facendo scattare repentinamente strettamente o tendenzialmente eulitorale, quindi più a ridosso della linea 85
un’apposita muscolatura toracica. Una psammofile, non poche delle quali sono di battigia, pur trovando rifugio durante il
sola specie ad attività notturna, il caratteristiche o persino esclusive delle giorno prevalentemente in settori più
pomachilino circum-mediterraneo Isidus spiagge marine. L’elemento più tipico è il interni dell’avanduna o della duna.
moreli, di colore giallo pallido e lungo comunissimo Anthicus fenestratus, ● Scarabaeoidei. Tra gli scarabeoidei, che,
poco più di un centimetro, si rinviene con presente sulle spiagge sabbiose e sulle come vedremo tra breve, sono invece
una certa frequenza da adulto sotto i prime dune di tutte le coste italiane, dove numerosi e molto interessanti soprattutto
detriti vegetali spiaggiati della fascia vaga in gran numero alla ricerca di detriti negli ambienti di duna, pochissimi e
eulitorale, soprattutto nei mesi estivi, spiaggiati e residui organici, ma che scarsamente specializzati sono i detritivori
mentre le larve si sviluppano tra gli tuttavia, come molti altri anticidi, mostra associati con una certa frequenza ai detriti
apparati radicali di graminacee della duna. una certa antropofobia e tende a rarefarsi marini spiaggiati. Tra questi, alcuni afodidi
● Meliridi. I meliridi, in senso lato (meliridi o perfino a scomparire lungo le spiagge Phaleria acuminata del genere Rhyssemus, alcuni
+ malachidi + dasitidi) sono un cospicuo più antropizzate e frequentate. Psammodius e poche specie dei generi
gruppo di coleotteri cleroidei che spesso Da ricordare, tra gli altri Anthicus, almeno di Phaleria, di piccole dimensioni, a Pleurophorus, Platytomus e Diastictus,
frequentano i fiori di una grande quantità A. brunneipennis, endemita litoraneo prevalente attività notturna, e di norma di che si rinvengono specialmente lungo
di vegetali erbacei ed arbustivi. Tra le sardo-corso, e il raro A. genei, a colore giallastro, alcune delle quali spiagge sabbiose umide nelle vicinanze di
specie legate alle spiagge, una delle più distribuzione Mediterranea, ma esclusivo sintopiche (ovvero coabitanti nella foci di fiumi, lungo le rive sabbiose dei
caratteristiche e specializzate è il di piccoli archi sabbiosi in aree di costa medesima località) nelle sabbie litoranee, quali sono infatti ben più frequenti.
malachide Brachemys brevipennis, un rocciosa. Analoghe abitudini psammofile e dove si affollano soprattutto intorno a ● Curculionoidei. Sempre tra i detriti
piccolo coleottero nero e privo di ali talassofile hanno i rappresentanti del piccoli ammassi di detriti e ai resti di spiaggiati, almeno tre sono le specie di
funzionali, con elitre accorciate fornite di genere Mecynotarsus, dalle zampe animali spiaggiati, spesso insieme ad coleotteri curculionoidei tipiche di questi
una caratteristica macchia bianca, e allungatissime, come il comune e alcune specie di Xanthomus, quali microhabitat: la prima è il curioso
zampe lunghe e sottili che lo fanno velocissimo M. serricornis, o il ben più X. pallidus e X. pellucidus, e ad Styphloderes exculptus, specie
somigliare ad una formica. Associato alla raro e sporadico M. fausti. Altre specie Halammobia pellucida. Sono qui talora mediterranea occidentale che predilige le
battigia di spiagge sia sabbiose che sono invece tipiche degli accumuli di spazialmente affiancate, più spesso alghe disseccate; la seconda e la terza
sassose, è in grado persino di farsi detriti vegetali spiaggiati, quali in peraltro a livello del sopralitorale e sono rispettivamente Mesites
sommergere indenne dai flutti; si trova particolare il raro Amblyderus scabricollis, dell’avanduna, anche da altri tenebrionidi, pallidipennis, specie allungatissima dal
anche ai margini delle lagune salmastre e specie Ovest-Mediterranea che raggiunge questi però ad attività diurna, come le curioso colore rossastro, e
nei salicornieti. È specie ampiamente le spiagge di Calabria, Sicilia e Sardegna, Tentyria, le Pimelia e gli Erodius. Molte Aphannommata filum (citata in passato
diffusa in quasi tutto il Mediterraneo. Il dove pare convivere con l’affine specie sopralitorali ed extralitorali di come Brachytemnoides filum) ugualmente
congenere e molto più raro Brachemys A. brunneus, probabile endemita questa famiglia, come altri artropodi allungata ma di colore nerastro, che
peragalloi, con colorazione più vivace (ha calabro-siculo. Anche alcune Endomia, sabulicoli, manifestano comunque frequentano soprattutto il materiale ligneo
il protorace rosso) vive in ambienti simili, come la comune E. tenuicollis, sono marcata vagilità notturna, che li porta a spiaggiato, nel quale si sviluppano come
ma è tipico di una fascia costiera molto frequenti sotto detriti vegetali e residui spostarsi nottetempo anche nella fascia xilofagi (ossia divoratori di legno).
più ristretta (Liguria occidentale e algali spiaggiati, ma prediligono gli
Provenza meridionale), ed è da accumuli disseccati dal sole. Ortotteroidei. Gli ortotteroidei, come
considerare specie a rischio. Altre specie ● Tenebrionidi. Tra i numerosi coleotteri vedremo più avanti, sono decisamente
note come frequentatrici di spiagge, detritivori “specialisti” delle spiagge più numerosi nelle zone litorali più interne,
spesso rinvenibili sotto detriti spiaggiati a troviamo anche alcuni tenebrionidi, una dove la presenza di vegetazione più o
livello dell’eulitorale, sono altri malachidi famiglia che annovera tra le sue file un meno stabilizzata consente la
come Colotes punctatus e Apalochrus enorme numero di specie adattate a sopravvivenza di numerose specie
flavolimbatus, o i dasitidi Dolichosoma vivere in ambienti ostili sabbiosi, in fillofaghe e radicivore. Alcuni sono
lineare e Psilothryx viridicoerulea. particolare nelle aree desertiche e comunque in grado di colonizzare anche
● Anticidi. Tra i coleotteri “corridori” delle subdesertiche, e che troveremo le spiagge umide. Molto caratteristici
spiagge sabbiose non possono essere ovviamente ben più numerosi negli sono poi gli “affogamenti di massa” di
dimenticati i piccoli coleotteri anticidi, che ambienti di duna. A livello dell’eulitorale, in centinaia o migliaia di grossi acrididi
comprendono un gran numero di specie Italia troviamo soprattutto svariate specie Erodius siculus (locuste), sia nostrani che di originePuoi anche leggere