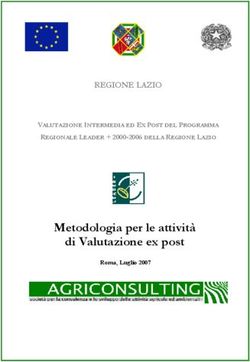Sviluppo del linguaggio in soggetti affetti da Cri-du-Chat
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
R I C E R C H Sviluppo
E del linguaggio in soggetti affetti da Cri-du-Chat
Sviluppo del linguaggio
in soggetti affetti
da Cri-du-Chat
Laura Piccardi (Università Roma «La Sapienza» e I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia, Roma)
Maria Rosa Pizzamiglio (I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia, Roma)
Cecilia Guariglia (Università Roma «La Sapienza» e I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia, Roma)
La sindrome Cri-du-Chat (CdC) è un raro disturbo genetico, le cui caratteristiche cliniche in-
cludono un pianto acuto, microcefalia, dismorfismi facciali e un grave ritardo mentale con deficit
di apprendimento e ridotte abilità verbali. È stata descritta una dissociazione tra una compren-
sione preservata e una produzione deficitaria. L’analisi dello sviluppo linguistico di 7 bambini CdC,
confrontato con quello di soggetti normali di pari età mentale, ha evidenziato una prestazione dei
CdC superiore alla loro età mentale e una lieve asimmetria tra produzione e comprensione.
1. Introduzione
La sindrome Cri-du-Chat (CdC) è un raro disturbo genetico dovuto a
una delezione del braccio corto del cromosoma 5 (5 p–), con un’inciden-
za di circa 1/50000 (Niebuhr, 1978; Udwin e Dennis, 1995) o 1/37000
(Higurashi, Oda, Iijima, Iijima, Takeshita, Watanabe e Yoneyama, 1990).
L’ampiezza della delezione può interessare la sola banda 5p15 fino a tut-
to il braccio corto del cromosoma. Alla variabilità citogenetica equivale
una variabilità clinica e fenotipica. Alcuni autori hanno individuato la pre-
senza di una «regione critica» situata nella banda 5p15.2 e individuato ul-
teriori bande responsabili di altre caratteristiche fenotipiche (Neibuhr,
1978; Overhauser, Huang, Gersh, Wilson, McMahoton, Bengtsson, Rojas,
Meyer e Wasmuth, 1994; Gersh, Goodart, Pasztor, Harris, Weiss e Ove-
rhauser, 1995; Church, Bengtsson, Nielsen, Wasmuth e Niebuhr, 1995;
Cerruti Mainardi, Perfumo, Calì, Coucorde, Pastore, Cavani, Zara, Ove-
rhauser, Pierluigi e Dagna Bricarelli, 2001). La causa della delezione è
spesso sconosciuta e in circa l’85% de novo, nella maggior parte dei
casi avviene con una traslocazione reciproca tra il cromosoma 5 e un al-
tro cromosoma parentale (Nuzzo, 1978; VanBuggenhout, Pijkels, Holvoet,
Schaap, Hamel e Fryns, 2000; Cornish, Bramble, Munir e Pigram, 1999).
Il sito dell’Associazione Italiana Bambini con Sindrome Cri-du-Chat è www.criduchat.it ed è
sorto per divulgare informazioni e notizie utili ai genitori e ai professionisti che si trovano ad
operare in quest’ambito.
PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO / a. IX, n. 1, aprile 2005 117L. Piccardi, M.R. Pizzamiglio, C. Guariglia
Le caratteristiche cliniche includono dismorfismi facciali, malforma-
zioni viscerali, microcefalia, disturbi fonatori e un pianto dalla tonalità acu-
ta e monotona simile al miagolio del gatto. Lo sviluppo è caratterizzato
da un ritardo psicomotorio grave (Neibuhr, 1978).
Poco è noto sull’aspetto cognitivo e comportamentale dei soggetti
CdC. I primi lavori hanno suggerito una triade di caratteristiche: grave ri-
tardo dello sviluppo psicomotorio, abilità verbali minime, profonde difficol-
tà di apprendimento conseguenti al grave ritardo mentale; è anche de-
scritta la presenza di auto ed etero-lesionismo (Cornish et al., 1999).
Sebbene i soggetti CdC abbiano abilità verbali ridotte, Wilkins, Brown
e Wolf (1980) hanno trovato che ben il 50% del loro campione era in gra-
do di usare il linguaggio in produzione per esprimere i propri bisogni e
emozioni. In particolar modo, il 17% dei soggetti (di età cronologica su-
periore ai 10 anni) aveva sviluppato un vocabolario di cento parole e pro-
duceva frasi composte da tre o più parole; il 37% aveva un lessico più ri-
dotto e usava parole passe-partout. Cornish et al. (1999) sottolineano la
disomogeneità del profilo neuropsicologico, evidenziando una dissociazio-
ne tra capacità ricettive preservate rispetto a quelle espressive grave-
mente deficitarie.
La presenza di disturbi fonatori nella sindrome Cri-du-Chat associata a
un sostanziale ritardo nell’acquisizione del linguaggio parlato, spesso non
predicibile dal livello cognitivo generale, suggerisce l’importanza di un’inda-
gine sull’acquisizione del repertorio fonetico (Sohner e Mitchell, 1981).
Sohner e Mitchell (1981) hanno condotto uno studio longitudinale su
una bambina CdC (K.S.) osservandola dagli 8 ai 26 mesi. L’osservazione,
che avveniva in situazioni di gioco libero, evidenziava un notevole ritardo
nello sviluppo della lallazione: a 13 mesi emergeva la lallazione duplicata,
che normalmente compare tra i 9 e gli 11 mesi; a 25 mesi la lallazione di
K.S. si collocava tra la fine del terzo e l’inizio del quarto stadio sensomo-
torio (8 mesi circa) delle Scale di Sviluppo Psicomotorio per l’Infanzia (Uz-
giris-Hunt, 1975 in Sohner e Mitchell, 1981).
Uno studio di Cerruti Mainardi, Guala, Pastore, Pozzo, Dagna Brica-
relli e Pierluigi (2000) ha analizzato i dati di un campione di 84 bambini e
adulti italiani con CdC attraverso la somministrazione del test di Denver
(Frankenburg, Dodds, Archer, Shapiro e Bresnick, 1992). Gli autori hanno
riportato che la comprensione di un comando verbale si verificava nel
50% dei casi dopo i due anni, così come la produzione di prime parole,
mentre la combinazione di due parole e la comprensione di preposizioni
avvenivano nel 50% dei casi dopo i cinque anni. L’indicazione di parti del
corpo su comando verbale si verificava verso i 3 anni nel 50% dei sog-
getti, a differenza dell’indicazione di due figure su comando verbale che
avveniva nel 50% dei casi verso i quattro anni. Questi dati mettono in luce
118Sviluppo del linguaggio in soggetti affetti da Cri-du-Chat
sia la presenza di una grande variabilità individuale dei soggetti affetti da
sindrome CdC che le eventuali potenzialità non ancora esplorate nell’am-
bito della ricerca sui CdC.
Wilkins et al. (1980) hanno anche sviluppato una lingua dei segni di
base per 16 bambini che non utilizzavano il linguaggio in produzione e ben
il 69% era stato in grado di apprenderla ed utilizzarla per comunicare.
Anche Cornish e Pigram (1996) osservano l’uso spontaneo del gesto
e l’apprendimento della lingua dei segni in 23 soggetti su 27 con ridotte
capacità espressive.
Un lavoro recente di Pizzamiglio, Piccardi e Guariglia (2002) eviden-
zia un’effettiva asimmetria nel profilo neuropsicologico a vantaggio di un
più alto livello di sviluppo nelle abilità sociali, rispetto a capacità di coordi-
nazione occhio-mano e di abilità spaziali ridotte.
Quest’ultimo dato sembra evidenziare come in questi soggetti l’inten-
to comunicativo sia presente e rimane vivo il desiderio di mettersi in rela-
zione con l’adulto nonostante la produzione verbale sia molto limitata; inol-
tre, la valutazione del profilo linguistico attraverso prove standardizzate
che richiedono al soggetto anche altre risorse (es. esplorazione visiva de-
gli stimoli riportati su un foglio, l’uso della mano per indicare, ecc...) pone
qualche problema nella reale comprensione delle abilità in questo dominio
di soggetti CdC, perché anche le tappe dello sviluppo motorio, sia grosso-
lano che fine, sono sensibilmente rallentate (es., afferrare un oggetto tra
gli 8 e 16 mesi, stare in piedi da solo intorno ai 2 anni, la deambulazione
autonoma verso i 2-4 anni, ecc.). Pertanto, si è voluto realizzare uno stu-
dio che approfondisse l’aspetto linguistico di questa sindrome.
Lo scopo del nostro lavoro è di descrivere lo sviluppo linguistico in 7
soggetti italiani CdC, confrontandolo con quello di soggetti normali di pari
età mentale. Il confronto con un gruppo di soggetti normali rende possibi-
le discriminare in maniera più attendibile le eventuali differenze presenti
nel profilo comunicativo-linguistico.
L’uso di uno strumento come il «Primo Vocabolario del Bambino» di
Caselli e Casadio (1995), con una taratura italiana raccolta su un campio-
ne di 315 bambini, ci ha permesso di valutare la comunicazione linguisti-
ca nei suoi diversi aspetti con lo stesso strumento, comparando in parti-
colar modo la comprensione e la produzione verbale attraverso una valu-
tazione indiretta delle competenze dei soggetti.
Come già descritto in precedenza altri studi sono stati condotti su
soggetti CdC di lingua inglese che hanno evidenziato un’asimmetria all’in-
terno dello sviluppo linguistico (Cornish e Munir, 1998).
Abbiamo voluto quindi verificare su un gruppo italiano l’esistenza di
questa asimmetria.
119L. Piccardi, M.R. Pizzamiglio, C. Guariglia
2. Metodo
2.1. Soggetti
In questo studio sono stati osservati 7 soggetti (1 maschio e 6 fem-
mine). Le informazioni socio-demografiche sono riportate in tabella 1. A li-
vello cromosomico, tutti i soggetti hanno una delezione terminale del
braccio corto del cromosoma 5 che coinvolge la regione critica. Oltre
alla delezione del cromosoma 5, il caso 1 presenta una trisomia del cro-
mosoma 7. Tutti i soggetti erano affetti da microcefalia e nessuno di essi
mostrava deficit visivi. L’età mentale (E.M.) dei bambini è stata determina-
ta con le scale per lo sviluppo mentale di Bayley (1993). I genitori dei
partecipanti sono stati informati dettagliatamente sul metodo e sugli
obiettivi dello studio e hanno dato il loro consenso.
TAB. 1. Dati socio-demografici. Età cronologica (E.C.) riportata in anni; Età menta-
le (E.M.) riportata in mesi e determinata con le Scale per sviluppo menta-
le di Bayley
Soggetti Sesso E.C. E.M.
(anni) (mesi)
Caso 1 (GC) M 5 11
Caso 2 (LDJ) F 6 12
Caso 3 (IF) F 8 13
Caso 4 (FF) F 3 13
Caso 5 (FV) F 5 14
Caso 6 (FS) F 2 16
Caso 7 (OA) F 11 17
2.2. Procedura
Lo studio del linguaggio è stato effettuato tramite il Primo Vocabola-
rio del Bambino (Caselli et al., 1995), che consiste in un questionario che
viene compilato dai genitori. Al momento della consegna il questionario
viene spiegato brevemente alla famiglia, alla quale viene richiesto di os-
servare il comportamento verbale del proprio bambino per qualche gior-
no. I genitori devono compilare il questionario entro una settimana per
evitare che i risultati dell’osservazione siano inficiati da probabili cambia-
menti, che potrebbero avvenire in un tempo più lungo. Al momento della
restituzione, l’operatore rivede insieme ai genitori il protocollo compilato.
120Sviluppo del linguaggio in soggetti affetti da Cri-du-Chat
Il questionario viene usato per valutare la comunicazione e il linguag-
gio nei primi anni di vita, o per valutare bambini che si trovano in una fase
di sviluppo inferiore a quella corrispondente alla loro età cronologica.
Le competenze comunicative e linguistiche indagate riguardano la
comprensione delle prime semplici frasi in situazioni familiari e contestua-
lizzate, la produzione di azioni e gesti di diverso tipo (deittici e referenzia-
li), il repertorio lessicale, l’emergere della grammatica e delle prime com-
binazioni.
Esso offre l’opportunità di valutare i soggetti nelle prime fasi di svi-
luppo, proprio nel momento in cui è difficile utilizzare prove più struttura-
te.
Nello studio di Cornish e Munir (1998) gli autori utilizzavano altri stru-
menti linguistici, quali il British Picture Vocabulary Test (Dunn, Dunn, Whet-
ton e Pintilie, 1982), il TROG (Bishop, 1983) e l’RDSL-R (Reynell, 1985). A
parte l’RDSL-R, gli altri test valutano la comprensione del vocabolario e
della grammatica a partire, il primo dai 2 anni e il secondo dai 4 anni. Nel
nostro studio abbiamo privilegiato l’età mentale dei soggetti CdC rispetto
all’età cronologica, in quanto consente di valutare le prestazioni in funzio-
ne del reale sviluppo cognitivo del bambino. Per questa ragione abbiamo
scelto il questionario MacArthur.
Al momento della prima consegna vengono chiariti gli item e al mo-
mento della restituzione le risposte del genitore vengono riviste insieme
all’esaminatore. Il questionario è composto da due schede distinte «Gesti
e parole» e «Parole e frasi». Vengono valutati sia i primi segnali di com-
prensione che la comprensione di parole e frasi. In produzione vengono
annotati sia i primi gesti comunicativi, che il lessico posseduto e le prime
combinazioni di parole in frasi. Nel nostro studio, data l’E.M. dei bambini
partecipanti allo studio, è stata utilizzata solo la prima scheda, che valuta
la prestazione di bambini di età compresa dagli 8 ai 17 mesi, e consente
un confronto tra produzione e comprensione, mentre tale confronto non è
possibile nella seconda scheda (dai 18 ai 30 mesi) che indaga approfon-
ditamente solo l’aspetto produttivo.
I questionari sono stati consegnati ai genitori, che hanno osservato i
figli per alcuni giorni prima di compilarlo. L’esaminatore ha chiarito le
istruzioni e ricontrollato i questionari al momento della restituzione.
3. Risultati
L’età mentale dei soggetti CdC valutata con le scale per sviluppo
mentale di Bayley (1993) evidenziava la presenza di un ritardo mentale
grave (vedi tab. 1).
121L. Piccardi, M.R. Pizzamiglio, C. Guariglia
TAB. 2. Prestazioni dei soggetti CdC al questionario MacArthur e prestazioni me-
die e deviazione standard dei corrispondenti gruppi di controllo (C)
Soggetti Produzione Produzione Comprensione Comprensione
di gesti di parole di parole di frasi
Caso 1 21 0 108 21
C11 17 (7) 2 (5) 53 (47) 10 (5)
Caso 2 47 13 281 27
C12 29 (8) 8 (9) 109 (57) 17 (6)
Caso 3 46 16 185 26
C13 29 (8) 8 (9) 109 (57) 17 (6)
Caso 4 30 10 346 28
C13 29 (8) 8 (9) 109 (57) 17 (6)
Caso 5 44 19 233 26
C14 37 (10) 16 (17) 141 (71) 19 (6)
Caso 6 49 10 123 12
C16 40 (9) 32 (40) 186 (85) 22 (6)
Caso 7 52 6 279 24
C17 40 (9) 32 (40) 186 (85) 22 (6)
C11 = campione di bambini di 11 mesi di età cronologica
C12 = campione di bambini di 12 mesi di età cronologica
C13 = campione di bambini di 13 mesi di età cronologica
C14 = campione di bambini di 14 mesi di età cronologica
C16 = campione di bambini di 16 mesi di età cronologica
C17 = campione di bambini di 17 mesi di età cronologica
Per quanto riguarda l’aspetto linguistico, le prestazioni dei soggetti
CdC al questionario MacArthur (Caselli e Casadio, 1995) sono state con-
frontate con quelle del campione normativo della taratura italiana del que-
stionario MacArthur (prima scheda: gesti e parole), realizzata su 315
bambini di età compresa tra gli 8 e i 17 mesi. A tale scopo sono stati
usati come punto di riferimento la media e la deviazione standard del
gruppo di controllo della taratura italiana. La prestazione viene considera-
ta patologica quando si colloca al di sotto di almeno due deviazioni stan-
dard dalla media del gruppo di controllo e viene considerata ai limiti infe-
riori della norma quando rientra all’interno del range di 1-2 deviazioni
standard al di sotto della media.
– I soggetti CdC mostravano una produzione di gesti e parole corri-
spondente alla loro età mentale e spesso al di sopra della media. Nella
produzione di gesti tutti i soggetti hanno prestazioni al di sopra della me-
dia, i casi 1, 4 e 5 sono al di sopra di una deviazione standard, i casi 6 e
7 sono al di sopra di 2 deviazioni standard, mentre la prestazione dei casi
2 e 3 si colloca al di sopra della terza deviazione standard dalla media.
– Nella produzione di parole 4 soggetti (casi: 2, 3, 4 e 5) hanno avuto
122Sviluppo del linguaggio in soggetti affetti da Cri-du-Chat
5
4
3
2
1
0
-1
-2
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5
Caso 6
Caso 7
Soggetti
Produzione gesti Produzione parole
Comprensione parole Comprensione frasi
FIG. 1. Prestazioni dei soggetti CdC al questionario MacArthur «gesti e parole»
espresse in punti z.
prestazioni entro la prima deviazione standard sopra la media, mentre i
casi 1, 6 e 7 si sono collocati entro 1 deviazione standard sotto la media.
– Nella comprensione di parole tutti i soggetti eccetto il caso 6 sono
stati ampiamente sopra la media. I casi 1, 3, 5 e 7 hanno avuto presta-
zioni entro la seconda deviazione standard, mentre il caso 2 si è colloca-
to alla quarta deviazione standard sopra la media e il caso 3 alla quinta
deviazione standard sopra la media. Il caso 6 ha mostrato invece 1 pre-
stazione entro la prima deviazione standard al di sotto della media.
– Nella comprensione di frasi tutti i soggetti, eccetto il caso 6 che si
è collocato entro la prima deviazione standard sotto la media, sono am-
piamente sopra la media. I casi 2, 3, 4 e 5 sono stati entro la seconda
deviazione standard sopra la media, mentre il caso 1 è stato entro la ter-
za deviazione standard sopra la media e il caso 7 entro la prima deviazio-
ne standard sopra la media (vedi fig. 1 e tab. 2).
123L. Piccardi, M.R. Pizzamiglio, C. Guariglia
TAB. 3. Medie e deviazioni standard dei valori espressi in punti zeta per variabile
Soggetti Media Deviazione
standard
Produzione di gesti 1.158 0.796
Produzione di parole 0.035 0.585
Comprensione di parole 1.618 1.562
Comprensione di frasi 1.005 1.317
Un t-test (paired) è stato eseguito sui punteggi espressi in scarti stan-
dardizzati (punti zeta). L’analisi mette in evidenza una differenza significati-
va tra produzione di gesti e produzione di parole (T = 4.126; p < 0.0062)
e tra produzione di parole e comprensione di parole (T = –3.091; p <
0.0214). In tabella 3 sono riportate le medie e le deviazioni standard per
variabile (vedi tab. 3).
Un’analisi qualitativa sulla produzione di parole mette in evidenza che
la maggior parte dei soggetti CdC è in grado di produrre il verso degli
animali, di utilizzare i suoni onomatopeici (per es: brum brum Æ automo-
bile, scchh! Æ stai zitto), di dire i nomi delle persone più care (ad es.
mamma, papà, nonno, nonna, zia) e di nominare oggetti di uso comune
(ad es. acqua, mela, pappa, occhiali). Solo un paziente, il caso 4 è in gra-
do di produrre forme colloquiali di saluto e di assenso e/o dissenso.
4. Conclusioni
Le prestazioni dei soggetti CdC al questionario sono in linea con gli
studi condotti finora che usano altri strumenti di valutazione linguistica
(vedi Cornish e Munir, 1998) per quanto riguarda la differenza tra com-
prensione e produzione. Nel linguaggio parlato, infatti, quasi tutti i sog-
getti mostrano delle prestazioni migliori in comprensione rispetto alla pro-
duzione (casi: 1, 2, 3, 4, 5 e 7). Tutti i bambini CdC tendono ad usare
spontaneamente il linguaggio gestuale, infatti producono più gesti rispet-
to alla media dei soggetti di controllo di pari età mentale.
Nel lavoro di Cerruti Mainardi et al. (2000) i soggetti CdC osservati
mostravano il raggiungimento di alcune tappe fondamentali del linguaggio
dopo i 4-5 anni di età cronologica. In linea con questo studio anche noi
abbiamo osservato la comprensione di un comando verbale e la produzio-
ne di prime parole in oltre il 50% del nostro campione dopo i due anni di
età cronologica.
Come negli studi descritti finora, emerge un’asimmetria tra produ-
124Sviluppo del linguaggio in soggetti affetti da Cri-du-Chat
zione e comprensione. Infatti, un’analisi statistica condotta sugli scarti
standardizzati mette in evidenza come vi sia una differenza significativa
tra la produzione e la comprensione di parole. Le medie e le deviazioni
standard riportate in tabella 3 mostrano come i bambini CdC del nostro
campione producono molte meno parole rispetto a quelle che compren-
dono.
Infatti, i valori attesi per età mentale in relazione alla comprensione di
parole sono migliori in 6 soggetti CdC rispetto ai controlli, mentre per la
produzione solo in 4 soggetti. È anche vero che il livello, sia di produzio-
ne che di comprensione linguistica dei bambini CdC, sebbene molto infe-
riore a quanto atteso per la loro età cronologica, è senz’altro migliore di
quanto ci si possa attendere da bambini con la stessa età mentale o,
quando non lo è, rientra nella deviazione standard.
Questa osservazione fa ipotizzare che non esista un deficit linguisti-
co specifico, ma che piuttosto le ridotte capacità verbali siano imputabili
al grave ritardo cognitivo generale che caratterizza la maggior parte dei
CdC. Questo risultato non è nuovo in studi che hanno indagato la relazio-
ne tra linguaggio e intelligenza in altre patologie. Infatti, Mein e O’Connor
(1960) hanno confrontato il vocabolario di pazienti subnormali gravi istitu-
zionalizzati con quello di bambini normali raccolto da Burroughs (1957) e
hanno notato che i normali avevano una maggiore varietà di parole a loro
disposizione, mentre i pazienti mostravano un vocabolario relativo alla
vita quotidiana più ampio. I pazienti usano generalmente una maggiore
percentuale di nomi che di verbi rispetto ai bambini normali di pari età
mentale (O’Connor e Hermelin, 1981). Questo è vero anche nel nostro
caso: i bambini CdC sono in grado di produrre i nomi di oggetti comuni,
in particolar modo utili ad esprimere bisogni primari.
È ipotizzabile che la dissociazione tra produzione e comprensione di-
venti più marcata con il procedere dello sviluppo, dove l’esperienza con-
solida un vocabolario più grande in comprensione, ma ridotto in produzio-
ne ai bisogni primari, coadiuvato anche dall’uso di gesti che nel bambino
di pari età mentale tendono a scomparire soppiantati da una sempre più
vasta produzione. Inoltre, è possibile che la presenza di specifici deficit di
coordinazione motoria (evidenziati ad es. da Pizzamiglio, Piccardi e Guari-
glia, 2002) influisca negativamente sull’acquisizione di maggiori compe-
tenze di produzione verbale portando con il progredire dello sviluppo al-
l’emergere di una sempre più evidente asimmetria, non mostrata da bam-
bini di età inferiore. È altresì possibile che il neuro-sviluppo delle aree de-
putate alla produzione linguistica sia maggiormente affetto dalla delezio-
ne 5p– di quanto lo sia quello delle aree deputate alla comprensione. In
questo caso è ipotizzabile che l’osservazione di ridotte capacità di produ-
zione sia ancor più evidente in soggetti di età maggiore.
125L. Piccardi, M.R. Pizzamiglio, C. Guariglia
Un’analisi dei singoli soggetti CdC del nostro studio evidenzia una
prestazione leggermente diversa del caso 6 e del caso 7, questa diffe-
renza è imputabile alla diversa età cronologica dei due casi. Infatti en-
trambi sono quelli che si discostano maggiormente dal campione. Il caso
7 è cronologicamente il più grande e il caso 6 è quello più piccolo.
Il caso 7 potrebbe essere considerato un’esempio delle considerazio-
ni riportate precedentemente riguardo alle modificazioni che avvengono
nel fenotipo. È quindi possibile che alcune differenze si evidenziano mag-
giormente nel corso dello sviluppo, rendendo più evidente le asimmetrie
descritte in letteratura.
Per quanto riguarda il caso 6, la diagnosi tardiva (8 mesi di età cro-
nologica) ha fatto sì che non usufruisse di un trattamento precoce. L’ipe-
rattività caratteristica della sindrome ha influito sullo stile cognitivo della
bambina più pronta ad agire e quindi a produrre, che a comprendere
quello che le viene richiesto.
I dati descritti in questo studio, infine, dimostrano l’importanza di
strumenti valutativi idonei sia al livello cognitivo che a specifiche disabilità
caratteristiche di questa sindrome (deficit di coordinazione e deficit visuo-
spaziali). Uno strumento diagnostico attento a queste problematiche con-
sente di mettere in luce punti di forza su cui è possibile lavorare a livello
riabilitativo. D’altra parte, questi dati suggeriscono la necessità di allarga-
re lo studio ad una popolazione più ampia e di età cronologica maggiore.
Lo studio delle capacità linguistiche comparato a quello che si può atten-
dere sulla base dell’età mentale dei soggetti può infatti chiarire le inter-
pretazioni delle difficoltà linguistiche presentate dai CdC e fornire nuovi
suggerimenti per l’intervento.
5. Riferimenti bibliografici
Bayley, N. (1993). The Bayley Scales of Infant Development. New York:
Psychological Corporation.
Bishop, D.V.M. (1983). Test of the reception of grammar. London: Medi-
cal Research Council.
Burroughs, G.E.R. (1957). A study of the vocabulary of young children.
Birmingham University Monographss. 1. Edinburgh: Oliver & Boyd.
Caselli, M.C., Casadio P. (1995). Il Primo vocabolario del bambino. Gui-
da all’uso del Questionario MacArthur per la valutazione della comu-
nicazione e del linguaggio nei primi due anni di vita. Milano: Franco
Angeli.
Cerruti Mainardi, P., Guala, A., Pastore, G., Pozzo, G., Dagna Bricarelli, F.,
Pierluigi, M. (2000). Psychomotor development in Cri du Chat syndro-
me. Clinical Genetics, 57, 459-461.
126Sviluppo del linguaggio in soggetti affetti da Cri-du-Chat
Cerruti Mainardi, P., Perfumo, C., Calì, A., Coucorde, G., Pastore, G., Ca-
vani, S., Zara, F., Overhauser, J., Pierluigi, M., Dagna Bricarelli, F.
(2001a). Clinical and molecular characterisation of 80 patients with
5p deletion: genotype-phenotype correlation. Journal of Medical Ge-
netics, 38, 0-7.
Church, D.M., Bengtsson, U., Nielsen, K.V., Wasmuth, J.J., Niebuhr, E.
(1995). Molecular definition of deletions of different segments of di-
stal 5p that result in distinct phenotypic features. American Journal
of Human genetics, 56, 1162-1172.
Cornish, K.M., Bramble, D., Munir, F., Pigram, J. (1999). Cognitive func-
tioning in children with typical cri du chat (5p–) syndrome. Develop-
mental Medicine & Child Neurology, 41, 263-66.
Cornish, K.M., Munir, F. (1998). Receptive and expressive language skills
in children with Cri du Chat syndrome. Journal of Communication Di-
sorders, 31, 73-81.
Cornish, K.M., Pigram, J. (1996). Developmental and behavioural cha-
racteristics of Cri du Chat syndrome. Archives of Disease in Childho-
od, 75, 448-450.
Dunn, L., Dunn, P., Whetton, C., Pintilie, D. (1982). British picture vocabu-
lary scale. Windsor: NFER-Nelson.
Frankenburg, W.K., Dodds, J., Archer, P., Shapiro, H., Bresnick, B.
(1992). The Denver II: A major revision and restandardization of the
Denver Developmental Screening Test. Pediatrics, 89/1, 91-97.
Gersh, M., Goodart, S.A., Pasztor, L.M., Harris, D.J., Weiss, L., Overhau-
ser, J. (1995). Evidence for a distinct region causing a cat-like cry in
patients with 5p deletions. American Journal of Human Genetics, 56,
1404-1410.
Higurashi, M., Oda, M., Iijima, K., Iijima, S., Takeshita, T., Watanabe, N.,
Yoneyama, K. (1990). Livebirth prevalence and follow-up of malfor-
mation syndromes in 27,472 newborns. Brain and Development, 12,
770-773.
Mein, R., O’Connor, N. (1960). A study of the oral vocabularies of seve-
rely subnormal patients. Journal of Mental Deficiency Research, 4,
130-143.
Niebuhr, E. (1978). The Cri du Chat syndrome. Epidemiology, cytogene-
tics and clinical features. Human Genetics, 44, 227-275.
Nuzzo, F. (1978). Il cariotipo umano normale e patologico. Quaderni di
Biologia, diretti da L. De Carli. Bologna: Piccin.
O’Connor, N., Hermelin, B. (1981). Linguaggio e pensiero nel subnormale
grave. Roma: Armando Armando.
Overhauser, J., Huang, X., Gersh, M., Wilson, W., McMahoton, J., Bengts-
son, U., Rojas, K., Meyer, M., Wasmuth, J.J. (1994). Molecular and
phenotypic mapping of the short arm of chromosome 5: Sublocaliza-
tion of the critical region for the Cri du Chat syndrome. Human Mole-
cular Genetics, 3, 247-252.
Pizzamiglio, M.R., Piccardi, L., Guariglia, C. (2002) Asymmetries in neu-
127L. Piccardi, M.R. Pizzamiglio, C. Guariglia
ropsychological profile in Cri-du-Chat syndrome. Euresco Conference.
Brain Development and Cognition in Human Infants. Emergence of
Social Communication: Hands, Eyes, Ears, Mouth. Acquafredda Di
Maratea, 7-12 June.
Reynell J.K. (1985) Reynell Developmental Language Scales. Windsor:
NFER-Nelson.
Sohner, L., Mitchell, P. (1981). Phonatory and phonetic characteristics of
prelinguistic vocal development in Cri du Chat syndrome. Journal of
Communication Disorders, 24, 13-20.
Udwin, O., Dennis, J. (1995). Psychological and behaviour phenotypes in
generally determined syndromes: A review of research findings. In G.
O’Brien e W. Yules (a cura di), Behavioural phenotypes. London: Mac-
Keeith Press, pp. 90-208.
Uzgiris, I., Hunt, J. (1975). Assessement in infancy: Ordinal scales of
psychological development. Urbana, IL: University of Illinois Press.
VanBuggenhout, G.J.C.M., Pijkels, E., Holvoet, M., Schaap, C., Hamel,
B.C.J., Fryns, J.P. (2000). Cri du Chat syndrome: Changing phe-
notype in older patients. Americam Journal of Medical Genetics, 90,
203-215.
Wilkins, L.E., Brown, J.A., Wolf, B. (1980). Psychomotor development in
65 home-reared children with Cri du Chat syndrome. Journal of Pe-
diatrics, 97, 401-405.
Language development in Cri-du-Chat children
Summary. Cri-du-Chat syndrome (CdCS) is a rare genetic disorder characterised by a dele-
tion of chromosome 5. Clinical features include high-pitched cry, microcephaly, facial dysmor-
phisms and a severe mental delay characterised by learning disabilities and reduced verbal abili-
ties. It has been described a strength in receptive language skills compared with expressive lan-
guage skills. Aim of this study was to analyse the linguistic development of 7 Italian subjects with
CdCS to reveal asymmetries comparing to normal subjects matched for mental age. CdCS’ per-
formance was better than their mental age and a slight asymmetry between production and com-
prehension was present.
Per corrispondenza: Laura Piccardi, Dipartimento di Psicologia, Università degli
studi di Roma «La Sapienza», Via dei Marsi 78, 00185 Roma. E-mail:
laura.piccardi@uniroma1.it
128Puoi anche leggere